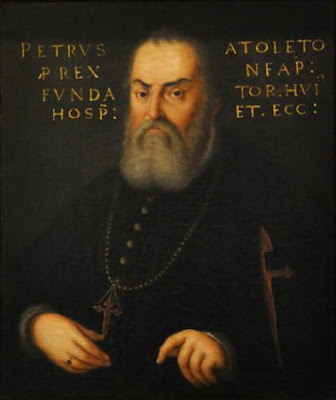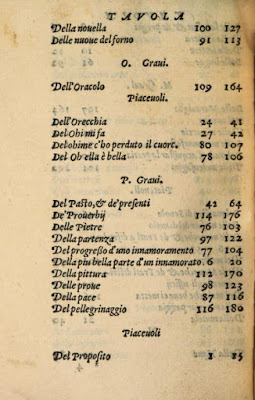Eleonora Alvarez de Toledo e i suoi tempi - Un periodo ricco di manifestazioni di altissima cultura ma anche di gravi atti nei confronti delle donne ..La morte di Maria de' Medici, Isabella de' Medici, Leonor Alvarez de Toledo, ecc. - Enciclopedia Delle Donne - VIII Parte
Indice:
1.
Eleonora di Toledo;
2.
Bianca “Bia” dei Medici;
3. Il Duca Cosimo de’ Medici ed
Eleonora Alavrez di Toledo; La Famiglia Alvarez – L’Eleganza di Eleonora
4. La vita – Le Ville Medicee – I Palazzi
- Il Figlio Antonio de’ Medici;
5. La Figlia Maria de’ Medici – Il suo
ritratto – La sua morte misteriosa: Uccisa dal padre ?
6. La Figlia Lucrezia – La sua morte
per Tubercolosi;
7. La Morte di Eleonora di Toledo e
degli altri figli: Giovanni, Garzia
La
Discendenza
8. Francesco I de’ Medici;
9. Leonora Alvarez de Toledo, nuora e
nipote di Eleonora di Toledo, fu uccisa da Pietro de’ Medici ?
10. Isabella de’ Medici – Le sue
residenze – Le Passioni: la musica, l’arte – Il Marito Paolo Giordano I Orsini,
duca di Bracciano – L’amante Troilo Orsini
- Madalena Casulana, la prima compositrice e cantante donna della storia
- Video :
Concerto delle Donne – I rapporti (lettere) con il marito Paolo
Orsini;
11. Giovanna d’Austria (D’Asburgo)
sposa Francesco I de’ Medici – Le feste per il matrimonio;
12. Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
de’ Medci – Un amore contrastato – L’uccisione da parte di Cosimo I di Sforza
Almeni - Il palazzo Almeni e le sue
opere d’arte;
13. La gravidanza di Giovanna d’Austria
– Isabella de’ Medici e gli Speziali;
14. Camilla Martelli e Cosimo I de’
Medici – Il quadro di Camilla Martelli (?) a Saint Louis – Camilla sposa Cosimo
I – La figlia Virginia – Casa Martelli e i suoi segreti – I Bardini;
15. La Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca – I simboli del potere;
16. La Spedizione in Oriente;
17. Francesco I de’ Medici, Giovanna d’Austria
e.... Bianca Cappello; Il Santuario di Loreto;
18. La Congiura Pucci contro i Medici;
19. 1575, Nuova Congiura contro i
Medici da parte di Orazio Pucci – Il carnevale del 1575 e i suoi canti – Video; I Canti del 1400 (Angelo Branduardi e Camerata
Mediolanense) – Le Pasquinate su
Isabella;
20. Isabella nel 1574 – 1576 – I rapporti con Troilo – Troilo, condannato da Francesco I, si rifugiò in Francia – la morte della cugina di Isabella, Leonora di Toledo (uccisa dal marito ?) – Leonora di Toledo moglie di Pietro I de’ Medici;
21. L’uxoricidio di Leonora;
22. Isabella dopo la morte di Leonora –
La morte di Isabella ? – Fu uccisa dal
marito ? – Le ricerche - Due dei tanti
delitti “d’onore” del tempo ?
23. L’uccisione di Troilo, raccontato
dal sicario Tremazzi da Modigliana;
24. Giovanna d’Austria – La nascita di
Filippo e la tragica morte della madre per una caduta dalle scale, morì anche
il bambino che aveva in grembo;
25. Francesco I sposa Bianca Cappello –
Bianca Cappello a corte – Gli orti Orcellari
- Il palazzo di Bianca Cappello e il cunicolo sotterraneo – La Magia
26. L’Accoglienza del primo
ambasciatore d’Oriente;
27. Bianca Cappello e il suo desiderio di avere un
erede;
28. Francesco I e l’Alchimia – Uno studio
condiviso dalla moglie ? – La ricerca di un antidoto contro il veleno degli
scorpioni (aveva 10.000 scorpioni);
29. La morte di Francesco I e Bianca
Cappello – Furono avvelenati ? – Le ricerche tossicologiche –
................
1.
Eleonora
di Toledo
Cosimo I de’
Medici
(Firenze, 12
giugno 1519; Firenze, 21 aprile 1574)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31
maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607)
Datazione: ?
Pittura: Olio su tavola
Misure: (86
x 65) cm – Collocazione: ?
2. Bianca “Bia” de’ Medici
Intorno al 1536 nacque Bianca,
soprannominata “Bia”, figlia naturale di una relazione di Cosimo I de’ Medici
con una dama fiorentina di cui non si conosce il nome. Una bambina avuta prima
del matrimonio del Eleonora di Toledo.Nella sua vita Cosimo I ebbe ben 16
figli in 55 anni: tre figli naturali, undici da Eleonora di Toledo e due dalla
seconda Camilla (o Cammilla) Martelli.
Un aspetto da mettere in rilievo è legato all’amore che il padre riservò a
tutti i figli a prescindere dalla loro nascita naturale o meno.Bianca fu la primogenita di Cosimo e
la sua immagine fu scoperta durante il restauro del ritratto di Maria Salviati
(1499 – 1543) madre di Cosimo I.Nell’operazione di sverniciatura del
dipinto risaltò la figura di una piccola bambina.
Maria Salviati ritratta con Bianca
(secondo alcuni storici si tratterebbe di Giulia de’
Medici o
Cosimo I de’ Medici)
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
Maria Salviati tiene delicatamente con la sua mano
destra la mano (destra) della bambina che la critica storica ha spezzo identificato con un
bambino.La piccola figura è vestita da bambina ed ha un acconciatura
che è tipica degli anni trenta e quaranta del 1500, con piccoli riccioli che le
circondano il viso.La bambina poteva essere una delle nipoti della
Salviati: Bia, Maria, nata nel 1540 e Isabella nata nel 1542. Le ultime due
figlie nate dal matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo.La nonna Salviati morì nel dicembre 1543 e Maria ed
Isabella erano troppo giovani rispetto alla figura che appare nel quadro dato che
Maria aveva solo tre anni ed Isabella un anno d’età. Esaminando la figura della
piccola bambina si potrebbe proporre un’età di cinque o sei anni.Edward S. King nel 1940 identificò la piccola figura
del quadro con Cosimo I de’ Medici da bambino. Ci fu subito una critica da
parte di Bernhard (Bernard) Berenson secondo il quale la figura era quella di
una bambina. Il quadro apparteneva a Riccardo Riccardi e nel 1955 Herbert
Keutner trovò in un inventario dei beni del Riccardi, risalente al 1612, la
seguente voce:"Un
dipinto di una braccia e mezza della signora Donna Maria Medici con una
bambina, per mano di Jacopo da Puntormo". Questa
importante fonte storica, anche se non riportava una descrizione dettagliata,
non fece cambiare a Edward S. King e ad
altri storici come Janet Cox-Rearich la loro tesi secondo la quale la piccola
figura era quella di un bambino ed esattamente di Cosimo I.Maria
Salviati è raffigurata nel ritratto come una signora anziana e non come una
giovane donna di circa 25 anni (Alla nascita del figlio Cosimo I, la donna era
ventenne). Non sarebbe
stata raffigurata come una vedova poiché non ave ancora perduto il marito,
Giovanni de’ Medici delle Bande Nera.La piccola
figura ha i capelli rossi, una piccola bocca con le labbra piene e imbronciate
e un delicato naso rotondo. Cosimo I aveva una bocca ampia, composta da due
labbra sottili e “un naso aquilino con il suo profilo curvo prominente.
Perché Cosimo I raffigurato con un abitino femminile ?”
Cosimo I
de’ MediciN Nel 2006 Gabrielle Langdon
identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici
(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,
1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e
fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da
Maria Salviati.
Fu legittimata dal casato dei Medici
e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela
lontano per essere ricordato in un quadro.
C’è da dire che il duca Alessandro de’
Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il
Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio
de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).
Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto
una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta
da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina
romana.
La prima versione sembrerebbe la più
accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era
soprannominato “Il Moro”.
Alessandro
de’ Medici “Il Moro”Arista:
Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x
12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze
Giulia de’ Medici ereditò dal padre
i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore
sottile e quello inferiore pieno.
Giulia de’
Medici
Giulia de’
Medici
Arista:
Alessandro Allori
Pittura:
Olio su tavola – Datazione: 1559
Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze
Sempre la storica Gabrielle
Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse
quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.
Bia secondo
la storica Langdon
La sua tesi sarebbe legata all’abito
di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di
grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin
dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella
pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora
era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella
del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era
infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei
Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:
- - Il ginepro
non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di
ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto
nei ritratti delle vedove;
- - L’ermellino
non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della
dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,
affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un
legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava
moltissimo.
In una delle sue lettere la stessa
Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio
1540:"Nessuna notizia da riferire ...
[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".
Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei
possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il
viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una
rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542
e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la
perdita di Bia
...............................
3. Cosimo ed Eleonora
Cosimo I de’ Medici era alla ricerca
di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello
stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la
mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato
dal cugino Lorenzaccio.
Margherita d’Austria. figlia di
Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri
progetti matrimoniali.
L’imperatore non volle inimicarsi
Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di
Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti
della penisola.
Don Pedro
Alvarez de Toledo(Ritratto –
Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:
Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:
Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Il vicerè
operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al
Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei
suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari
rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -
Monte Nuovo
Napoli - Palazzo del Vicerè
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Maria Salviati ritratta con Bianca
(secondo alcuni storici si tratterebbe di Giulia de’
Medici o
Cosimo I de’ Medici)
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
Maria Salviati tiene delicatamente con la sua mano
destra la mano (destra) della bambina che la critica storica ha spezzo identificato con un
bambino.La piccola figura è vestita da bambina ed ha un acconciatura
che è tipica degli anni trenta e quaranta del 1500, con piccoli riccioli che le
circondano il viso.La bambina poteva essere una delle nipoti della
Salviati: Bia, Maria, nata nel 1540 e Isabella nata nel 1542. Le ultime due
figlie nate dal matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo.La nonna Salviati morì nel dicembre 1543 e Maria ed
Isabella erano troppo giovani rispetto alla figura che appare nel quadro dato che
Maria aveva solo tre anni ed Isabella un anno d’età. Esaminando la figura della
piccola bambina si potrebbe proporre un’età di cinque o sei anni.Edward S. King nel 1940 identificò la piccola figura
del quadro con Cosimo I de’ Medici da bambino. Ci fu subito una critica da
parte di Bernhard (Bernard) Berenson secondo il quale la figura era quella di
una bambina. Il quadro apparteneva a Riccardo Riccardi e nel 1955 Herbert
Keutner trovò in un inventario dei beni del Riccardi, risalente al 1612, la
seguente voce:"Un
dipinto di una braccia e mezza della signora Donna Maria Medici con una
bambina, per mano di Jacopo da Puntormo". Questa
importante fonte storica, anche se non riportava una descrizione dettagliata,
non fece cambiare a Edward S. King e ad
altri storici come Janet Cox-Rearich la loro tesi secondo la quale la piccola
figura era quella di un bambino ed esattamente di Cosimo I.Maria
Salviati è raffigurata nel ritratto come una signora anziana e non come una
giovane donna di circa 25 anni (Alla nascita del figlio Cosimo I, la donna era
ventenne). Non sarebbe
stata raffigurata come una vedova poiché non ave ancora perduto il marito,
Giovanni de’ Medici delle Bande Nera.La piccola
figura ha i capelli rossi, una piccola bocca con le labbra piene e imbronciate
e un delicato naso rotondo. Cosimo I aveva una bocca ampia, composta da due
labbra sottili e “un naso aquilino con il suo profilo curvo prominente.
Perché Cosimo I raffigurato con un abitino femminile ?”
Cosimo I
de’ MediciN Nel 2006 Gabrielle Langdon
identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici
(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,
1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e
fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da
Maria Salviati.
Fu legittimata dal casato dei Medici
e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela
lontano per essere ricordato in un quadro.
C’è da dire che il duca Alessandro de’
Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il
Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio
de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).
Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto
una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta
da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina
romana.
La prima versione sembrerebbe la più
accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era
soprannominato “Il Moro”.
Alessandro
de’ Medici “Il Moro”Arista:
Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x
12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze
Giulia de’ Medici ereditò dal padre
i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore
sottile e quello inferiore pieno.
Giulia de’
Medici
Giulia de’
Medici
Arista:
Alessandro Allori
Pittura:
Olio su tavola – Datazione: 1559
Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze
Sempre la storica Gabrielle
Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse
quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.
Bia secondo
la storica Langdon
La sua tesi sarebbe legata all’abito
di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di
grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin
dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella
pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora
era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella
del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era
infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei
Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:
- - Il ginepro
non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di
ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto
nei ritratti delle vedove;
- - L’ermellino
non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della
dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,
affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un
legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava
moltissimo.
In una delle sue lettere la stessa
Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio
1540:"Nessuna notizia da riferire ...
[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".
Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei
possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il
viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una
rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542
e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la
perdita di Bia
...............................
3. Cosimo ed Eleonora
Cosimo I de’ Medici era alla ricerca
di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello
stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la
mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato
dal cugino Lorenzaccio.
Margherita d’Austria. figlia di
Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri
progetti matrimoniali.
L’imperatore non volle inimicarsi
Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di
Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti
della penisola.
Don Pedro
Alvarez de Toledo(Ritratto –
Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:
Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:
Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Il vicerè
operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al
Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei
suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari
rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -
Monte Nuovo
Napoli - Palazzo del Vicerè
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
N Nel 2006 Gabrielle Langdon
identificò la bambina del quadro con Giulia de’ Medici
(Firenze, 5 novembre 1535 – Firenze,
1588 circa), figlia naturale del Duca Alessandro de’ Medici (1511 – 1537). Nacque due anni prima della morte del padre e
fu allevata prima nel monastero di san Clemente a Firenze e successivamente da
Maria Salviati.
Fu legittimata dal casato dei Medici
e malgrado sia stata accudita dalla Salviati, c’era un rapporto di parentela
lontano per essere ricordato in un quadro.
C’è da dire che il duca Alessandro de’
Medici era figlio naturale di Lorenzo II de’ Medici, nipote di Lorenzo il
Magnifico (alcuni storici considerano Alessandro figlio del cardinale Giulio
de’ Medici che successivamente sarebbe diventato papa Clemente VI).
Lorenzo II de’ Medici avrebbe avuto
una relazione con una serva mulatta di casa Medici, identificata come Simonetta
da Collevecchio (Collevecchio in Sabina), secondo altre fonti con una contadina
romana.
La prima versione sembrerebbe la più
accreditata dato che il duca Alessandro per la sua carnagione era
soprannominato “Il Moro”.
Alessandro
de’ Medici “Il Moro”Arista:
Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x
12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze
Giulia de’ Medici ereditò dal padre
i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore
sottile e quello inferiore pieno.
Giulia de’
Medici
Giulia de’
Medici
Arista:
Alessandro Allori
Pittura:
Olio su tavola – Datazione: 1559
Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze
Sempre la storica Gabrielle
Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse
quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.
Bia secondo
la storica Langdon
La sua tesi sarebbe legata all’abito
di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di
grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin
dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella
pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora
era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella
del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era
infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei
Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:
- - Il ginepro
non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di
ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto
nei ritratti delle vedove;
- - L’ermellino
non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della
dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,
affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un
legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava
moltissimo.
In una delle sue lettere la stessa
Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio
1540:"Nessuna notizia da riferire ...
[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".
Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei
possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il
viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una
rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542
e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la
perdita di Bia
...............................
3. Cosimo ed Eleonora
Cosimo I de’ Medici era alla ricerca
di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello
stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la
mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato
dal cugino Lorenzaccio.
Margherita d’Austria. figlia di
Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri
progetti matrimoniali.
L’imperatore non volle inimicarsi
Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di
Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti
della penisola.
Don Pedro
Alvarez de Toledo(Ritratto –
Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:
Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:
Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Il vicerè
operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al
Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei
suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari
rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -
Monte Nuovo
Napoli - Palazzo del Vicerè
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Alessandro
de’ Medici “Il Moro”Arista:
Bottega del Bronzino (1503 – 1572)Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1565/1569Misure (16 x
12,5) cm – Collocazione: Uffizi- Firenze
Giulia de’ Medici ereditò dal padre
i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore
sottile e quello inferiore pieno.
Giulia de’
Medici
Giulia de’
Medici
Arista:
Alessandro Allori
Pittura:
Olio su tavola – Datazione: 1559
Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze
Sempre la storica Gabrielle
Langdon sostenne che il ritratto di Bia fosse
quello eseguito da Agnolo Bronzino nel 1545.
Bia secondo
la storica Langdon
La sua tesi sarebbe legata all’abito
di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di
grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin
dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella
pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora
era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella
del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era
infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei
Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:
- - Il ginepro
non aveva nessun collegamento con il nome di Ginevra. In tutto il Medioevo e il Rinascimento l’albero di
ginepro era considerato il simbolo del dolore e del lutto e fu spesso aggiunto
nei ritratti delle vedove;
- - L’ermellino
non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della
dinastia napoletana di Aragona. Bia era una bambina molto vivace,
affettuosa ed allegra, amata da tutti anche dai funzionari di corte. Aveva un
legame molto forte con la nonna Maria Salviati che l’adorava e l’amava
moltissimo.
In una delle sue lettere la stessa
Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio
1540:"Nessuna notizia da riferire ...
[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".
Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei
possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il
viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una
rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542
e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la
perdita di Bia
...............................
3. Cosimo ed Eleonora
Cosimo I de’ Medici era alla ricerca
di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello
stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la
mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato
dal cugino Lorenzaccio.
Margherita d’Austria. figlia di
Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri
progetti matrimoniali.
L’imperatore non volle inimicarsi
Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di
Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti
della penisola.
Don Pedro
Alvarez de Toledo(Ritratto –
Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:
Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:
Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Il vicerè
operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al
Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei
suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari
rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -
Monte Nuovo
Napoli - Palazzo del Vicerè
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Giulia de’ Medici ereditò dal padre i capelli neri scuri e aveva una bocca molto ampia con un labbro superiore sottile e quello inferiore pieno.
Giulia de’
Medici
Arista:
Alessandro Allori
Pittura:
Olio su tavola – Datazione: 1559
Misure: - Collocazione: Uffizi – Firenze
La sua tesi sarebbe legata all’abito di raso bianco e alla collana di perle metafore del nome Bianca.La collana di grandi perle bianche era uno dei principali simboli del casato dei Medici fin dal 1540. Molte donne del Casato dei Medici sono infatti raffigurate nella pittura con vistose collane di perle. Secondo alcuni storici una sola metafora era usata per un nome femminile nel Medioevo e nel Rinascimento ed era quella del fiore della Margherita da cui derivata il nome di Margaret. Il fiore era infatti ricamato sugli abiti o faceva parte dei gioielli della dinastia dei Valois in Borgogna e degli Asburgo nei Paesi Bassi spagnoli. Altri esempi:
- - L’ermellino non aveva nessun collegamento con il nome “ Gallerani” ed era il simbolo della dinastia napoletana di Aragona.
In una delle sue lettere la stessa Maria Salviati scrisse al figlio Cosimo I, che si trovava ad Arezzo, nel luglio 1540:
"Nessuna notizia da riferire ...
[L] a Lady Bia è il conforto di questa Corte".
Nel 1542 Cosimo I fece un nuovo viaggio ad Arezzo, città che rientrava nei
possedimenti fiorentini, e volle con sé la figlia prediletta. Durante il
viaggio di ritorno la bambina s’ammalò. Una febbre che si fece via via sempre più grave, che la portò a una
rapida morte. Aveva cinque anni...chiuse i suoi piccoli occhi l’uno marzo 1542
e venne sepolta nella basilica di San Lorenzo. Tutti a corte piansero la
perdita di Bia
...............................
3. Cosimo ed Eleonora
Cosimo I de’ Medici era alla ricerca
di una sposa in grado di riuscire a dare una discendenza al casato e nello
stesso tempo in grado di rafforzare la sua posizione politica. Aveva chiesto la
mano di Margherita d’Austria, vedova del duca Alessandro de’ Medici assassinato
dal cugino Lorenzaccio.
Margherita d’Austria. figlia di
Carlo V d’Asburgo, mostrò delle reticenze e il padre aveva per lei altri
progetti matrimoniali.
L’imperatore non volle inimicarsi
Cosimo I e gli propose in matrimonio una delle figlie del ricchissimo vicerè di
Napoli, Don Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga, uno dei personaggi più importanti
della penisola.
Don Pedro
Alvarez de Toledo(Ritratto –
Autore: Sconosciuto – Datazione: XVI secolo ?Pittura:
Olio su tela – Misure: (80 x 66) cmCollezione:
Museo Nazionale Certosa di San Martino – Napoli)
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Il vicerè
operò la ricostruzione di Pozzuoli devastata dall’eruzione del Monte Nuovo.Oltre al
Palazzo Vicereale di Napoli edificò, nel Rione Terra, una edificio cheabitava nei
suoi momenti di riposo. Una costruzione che, nel tempo, ha subitovari
rimaneggiamenti a causa di crolli.Pozzuoli -
Monte Nuovo
Napoli - Palazzo del Vicerè
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Il motto
latino degli Alvarez de Toledo
Tu in ea et ego pro ea
Tu in lei e io per lei / Dio
nella patria e io per la patria
Don
Pedro Alvarez de Toledo con le insegne dell’Ordine di Santiago
(Ritratto
– Autore: Tiziano
Tiziano
Vecellio di Gregorio conosciuto come Tiziano
Pieve
di Cadore – Belluno, 1477/1490; Venezia, 27 agosto 1576)
Pittura:
Olio su tela – Datato: 1542 – Misure: (139,5 x 117,5) cm
Collezione:
Pittura Statale Bavarese- Monaco di Baviera - Germania
Il Palazzo/Torre
di Don Pedro Alvarez e della sua famiglia a Pozzuoli (Napoli)
Achille
Vianelli (1803 – 1894)
Veduta di
Pozzuoli con la Torre di Don Pedro Alvarez
Matita su
carta (23,3 x 34) cm – datato 27 marzo 1824
Napoli –
Museo di San Martino
Achille
Vianelli (1803 – 1894) - Pozzuoli
Veduta del
Palazzo/Torre di Don Pedro Alvarez dal Largo della Malva
Datato: 1820
circa – Matita e inchiostro su carta (23,3 x 34) cm
Napoli –
Museo di San Martino
Pozzuoli -
Monte Nuovo
Il vicerè, informato da Carlo V,
propose in moglie a Cosimo I de’ Medici la figlia primogenita Isabella Alvarez
de Toledo y Osorio. La dote richiesta
dal padre di Isabella era troppo onerosa e il diplomatico mediceo Niccolini
descrisse Isabella comeBrutta e
notoriamente sciocca
per cui l’idea matrimoniale svanì.
La giovane Isabella si sposò quindi con Giovan Battista Spinelli, Duca di Castrovillari
e Conte di Cariati. Il cuore e il pensiero di Cosimo I
de’ Medici erano rivolti alla figlia minore di Don Pedro, Eleonora. Il suo volto,
la sua dolcezza e raffinatezza erano rimasti impressi nel cuore di Cosimo
durante quella fortunata visita diplomatica. Castana e con gli occhi nocciola, aveva il viso di un ovale perfetto, i lineamenti dolci e pieni di un'innata maestà, come d'altronde traspare anche dai suoi ritratti. Quattro anni dopo, il 29 marzo 1539,
Eleonora allora diciassettenne, si stipulò il matrimonio per procura con la
consegna dell’anello.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora di ToledoRitratto del Bronzino
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la
collocava lontano dal gusto italiano e
fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il
grande artista Bronzino, (Agnolo
di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ;
Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che
gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Firenze – Basilica
della SS. Annunziata
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.

Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della
duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il
matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne
celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Firenze - Porta al Prato
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le
stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal
marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare
l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per
indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
L'abito appare come un velluto operato,
broccato, su un fondo di raso di seta bianco, con i grandi motivi a melagrana
in broccato d’oro a bouclé, uno dei quali perfettamente composto al centro del
corpetto, quasi come un emblema. La melagrana, simbolo di fertilità, allude alla sua fecondità, ma è emblema
anche della unione di una famiglia, così come per Isabella di Spagna, consorte
dell’imperatore Carlo V.Un ritratto ufficiale all’ennesima potenza, frutto di uno studiato disegno
politico e soprattutto, un incredibile pubblicità per l’industria fiorentina
della seta, in grande ripresa in quegli anni.
Ma
stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo
squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con
la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola,
maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni
ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del
suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo
nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal
funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre
nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È
conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che
presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del
fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
O Oltre
al disegno, innovativo per l’epoca, con dettagli arabescati desunti dal
repertorio turco, la qualità della lavorazione era significativa delle capacità
manifatturiere fiorentine, che dovevano essere evidenziate grazie alle precise
pennellate del pittore. Secondo
gli studi della Dott.ssa Isabella Chiappara Soria, Eleonora indossava nel
quadro una sottana così ricca da fare dimenticare che il capo era nato nel
primo ‘500 come abito di sotto.
Le
sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra
parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia
è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della
Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo,
sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è
anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile
il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si
tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento,
broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era
un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro
così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che
preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro
che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come
l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di
impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di
perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti
patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto
per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una
immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la
ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed
ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla
bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso
stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora
oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Eleonora giunse a
Napoli e l’11 giugno salpò dalla città accompagnata da fratello Garcia
con sette galere al seguito. Sbarcò a
Livorno la mattina del 22 giugno 1539 con un elegante vestito nero di raso “
tutto pieno di gran punti d’oro, così in testa et col colletto”, e incontrò
Cosimo I a Pisa (o vicino la città).
Eleonora manifestava un’eleganza austera che la collocava lontano dal gusto italiano e fiorentino di quegli anni in cui la manifattura tessile era in crisi. Fu il grande artista Bronzino, (Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino - Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572), che l’immortalò nei suoi meravigliosi dipinti che gli valsero l’entrata come artista della Corte Medicea.
Dettaglio del
ritratto del Bronzino
Nell’opera “Trinità”
del pittore Alessandro Allori
(Cappella di San
Luca – Basilica della SS. Annunziata – Firenze
Cappella di San
Luca – Basilica SS Annunziata – Firenze
Fu il frate
servita e scultore Giovanni Angelo Montorsoli a suggerire a
Vincenzio Borghini
e Giorgio Vasari di dare nuova vita alla
Compagnia del
Disegno, con il beneplacito di Cosimo I de’ Medici.
L’antico Capitolo
del convento fu adibito a sacello e luogo di
preghiera della
risorta Compagnia sotto il titolo di
Compagnia e
Accademia del Disegno.
Qui vennero
sepolti numerosi artisti, da Pantormo a Cellini,
dallo stesso
Montorsoli ad Andrea Sansovino. L’ultimo fu
Lorenzo Bartolini
nel 1848.
Il vecchio altare della Cappella di San Luca presenta la
tela della SS. Trinità di Alessandro Allori (1571).
Il quadro presenta, in basso, due ritratti di accademici: Pontormo, a
sinistra, e
il Bronzino, a destra. L’Allori volle dedicare il quadro a questi
due grandi maestri e in particolare al Bronzino che considerava come
padre adottivo. Questi ritratti,
come gli altri affreschi, furono rovinati da
antiche scritte e graffiti
L’eleganza di Eleonora di Toledo era lontana dal gusto
italiano.
Lucrezia Panciatichi
Autore – Il Bronzino
Ritratto – Pittura: olio su tavola – datazione: 1540 circa
Misure: (102 x 85 ) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
Dettaglio
Donna Lucrezia è rappresentata con un sontuoso vestito rosso che è
ornato da pizzi, nella parte superiore, e da una cintura con pietre
preziose.
Le maniche hanno un gonfio sbuffo arricciato nella parte superiore
mentre in quella inferiore sono aderenti e, com’era abitudine,
estraibili e tenute da lacci.
Indossa due collane ed una di queste reca la scritta:
“amour dure san fin”
Le cui parole si sviluppano in modo che possono essere lette da
una parte all’altra, senza interruzioni….. facendo assumere al motto
una sua continuità:
Dure sans fin amour.. Sans fin amour dire
Dopo un breve soggiorno a Pisa, Eleonora e Cosimo partirono per Firenze fermandosi alcuni
giorni alla Villa di Poggio a Caiano.
I Il 29 giugno (domenica) ci fu l’ingresso solenne della duchessa Eleonora Alvarez de Toledo Firenze dalla Porta al Prato e il matrimonio ufficiale fu celebrato nella Chiesa di San Lorenzo con una solenne celebrazione seguita da sfarzosi festeggiamenti.
Nel suo ingresso nella città indossava un elegante vestito color cremisi ricamato a
filo d’oro. Un abito che esaltava la sua carnagione colore alabastro.
Il matrimonio, malgrado la sua fredda origine
politica, fu d’amore. Una coppia molto
affiatata, unita da passioni comuni ed anche equilibrata nei comportamenti.
Eleonora nella sua vita coniugale badava
all’abbigliamento del marito, dei figli, dei vari dipendenti che lavoravano per
i Medici, alla cura e il rinnovamento degli arredi nelle varie residenze.
Naturalmente il ricco e raffinato abbigliamento richiedeva l’uso di stoffe di vario tipo che
venivano scrupolosamente registrare dai funzionari del Guardaroba che
riportavano nei registri le loro quantità,
provenienze e destinazioni. Un registro che era anche sotto il controllo
di Eleonora.
Le stoffe erano la grande passione della donna e
l’importante centro manufatturiero di Firenze era in grado di rispondere ai
suoi desideri e domande.
Una figura importante nella città che diede prestigio
all’attività manufatturiera che aveva perduto negli anni l’antica importanza.
Dal
punto di vista storico nelle varie corti, alla “donna di casa” spettava il compito di scegliere le stoffe per
l’abbigliamento della famiglia e anche della servitù. E nella grande Firenze e
nel Granducato, l’eleganza era una delle tante manifestazioni di ricchezza
sociale e nello stesso tempo era un modo
di pubblicizzare il benessere del commercio fiorentino.
Il
guardaroba di Donna Eleonora doveva quindi rispondere alle diverse esigenze
della vita politica di corte secondo le stagioni.
Le varietà e i tessuti adoperati da Donna Eleonora ?
Come testimoniano le fonti i colori preferiti era il
grigio, il tanè (un marrone dorato), il bianco oltre ad altri colori che s’accompagnavano
a ricami in oro e argento.
Gli abiti di colore rosso, molto vivo, erano quelli più numerosi nel suo guardaroba.
Un abito colore rosso cremisi )o chermisi) (colore rosso
vivo prodotto dalle cocciniglie), simbolo di regalità, le fu confezionato
subito dopo il parto di don Garzia, nel 1547 ed usato per occasioni ufficiali e
di rappresentanza.
Scriveva nel Cinquecento Monsignor della Casa nel suo “Galateo”:
“Et
sappi che in molte città pure delle migliori non si permette per le leggi che
il ricco possa gran fatto andare più splendidamente vestito che non può il
povero: perciò che a’poveri pare di ricevere oltraggio quando altri, eziandio
pure nel sembiante, dimostri sopra la loro maggioranza”.
Giovanni
della Casa
(Monsignor
Della Casa/Monsignor Dellacasa)
(Borgo
San Lorenzo, 28 giugno 1503; Montepulciano, 14 novembre 1556)
Letterato,
Scrittore e Arcivescovo cattolico)
(Artista:
Pontormo; 1494 – 1557)
(Pittura;
olio su tavola – Datazione: 1541/1544 – Misure: (78.9 x 102)cm;
Collocazione:
National Gallery Art of Washington – USA)
A
Firenze vennero promulgate leggi “Suntuarie” sin dal 1546, proprio da
Cosimo I.
“Rinovatione
della provisione sopra la prohibitione delle perle gioie, canutiglie, e ricami,
Firenze, 1602”.
Rinnovava
un analogo provvedimento emesso a Firenze il 30 luglio 1593 e precedenti.
Le Leggi Suntuarie
erano dei dispositivi legislativi che avevano lo scopo di
limitare il consumo
legato all’ostentazione del lusso, in particolare alla moda
maschile e
femminile. Regolava anche l’abbigliamento di determinati gruppi sociali
obbligandoli ad
indossare spesso dei segni distintivi.
A Firenze sin dal
1330 furono emanate dalla Repubblica diverse leggi
Suntuarie per giungere al 19 ottobre 1546 con la legge
“Sopra il vestire
abiti et ornamento delle donne ed uomini della città di Firenze”.
Leggi che furono
emanate proprio da Cosimo I de Medici per combattere
il lusso
eccessivo.
Esistevano guardie
delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare
nelle case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle
donne, bersaglio preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita
protesta, a volte di furbi accomodamenti, come quando nascondevano lo strascico
con spille per poi scioglierlo alla prima occasione favorevole.
Leggi che decaddero
negli anni successivi soprattutto nel Settecento
Le stoffe erano la grande passione di Eleonora, probabilmente anche condivisa dal marito Cosimo I, a tal punto che scommetteva su di loro. Singolare l’avvenimento in cui si misero pezzi di raso o di broccati come premio per indovinare la nascita di un futuro bambino/a.
“ Dalla
Signora Duchessa una pezza di teletta d’argento con opera…disse haver
guadagnata al Luccino a’mastio et femina più mesi sono…”
È
una nota del 1555 che riporta come Donna Eleonora vinse un drappo di stoffa
pregiato per aver indovinato il sesso di un nascituro/a.
Questa
sua passione determinò la nascita in un laboratorio di tessitura a palazzo
Vecchio di Firenze che controllava personalmente. Naturalmente
c’erano degli impiegati, maestranze che avevano nella città una lunga
tradizione culturale. Il
laboratorio era diretto da una donna, madonna Francesca di Donato,
Probabilmente
la presenza delle leggi suntuarie impedì, per certi versi, a Donna Eleonora di
vestire secondo i suoi desideri. Nella vita quotidiana, di tutti i giorni,
vestiva con abiti non troppo sfarzosi mentre
alla presenza degli ambasciatori o di personalità straniere,
l’abbigliamento mostrava ricche stoffe fiorentine con colori brillanti. Un abbigliamento che doveva dimostrare la
ricchezza della famiglia e la grandezza del Granducato. Tessuti
che non dovevano essere a tinta unita per cui si ricorreva a stoffe pregiate e
dotate di una grande manifattura che nasceva dal laboratorio del Palazzo.
La
veste indossata da Eleonora nel famoso ritratto del Bronzino è un documento
unico di questo genere di ufficialità, dove la personalità di Eleonora è quasi
in ombra per sottolineare il suo rango e la sua forza. Una testimonianza
incredibile delle pregiatissime stoffe fiorentine, lavorate con tecniche sopraffine
e realizzate nella metà del Cinquecento.
Donna Eleonora di
Toledo con suo figlio Giovanni de’ Medici
(Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23
novembre 1572
Ritratto datato:
1544/1545 – Olio su tavola – Misure (115 X 96) cm
Collezione: Uffizi
- Firenze
Scheda della
Dott.ssa Marina Minelli
Nel catalogo della
mostra che nel 2010 Palazzo Strozzi ha dedicato al pittore
Bronzino – Analisi
del dipinto
Ma stranamente Eleonora questo abito non lo ha mai avuto.
Il modello è un classico modello alla spagnola del suo guardaroba, con scollo squadrato, con rete dorata per le spalle e ornata di perle in abbinamento con la reticella dei capelli, Un modello realizzato da una “tessitora” spagnola, maniche con tagli per intravedere la camicia di seta bianca a sbuffi e disegni ad arabeschi. Ma la stoffa con il quale è realizzato non faceva parte del suo guardaroba, come si evince dai documenti, dove nessun broccato con pelo nero, colore non amato da lei, appare.
Con molta probabilità al Bronzino fu consegnata dalla stessa Eleonora, o dal funzionario del Guardaroba, una pezza di stoffa broccata che doveva ritrarre nel dipinto e rappresentare ufficialmente la migliore produzione cittadina
È conservato nel museo del Bargello di Firenze un drappo di velluto operato, che presenta lo stesso disegno di quello ritratto da Bronzino, a testimonianza del fatto che fosse ritenuto uno dei più bei tessuti mai realizzati a Firenze.
Le sue maniche aderenti e staccate lo provano indiscutibilmente.
D'altra parte a testimoniare la decisa predilezione della Duchessa per questa tipologia è la sua presenza massiccia nei "Giornali di entrata ed uscita" della Guardaroba che, redatti dal 1544, documentano esaustivamente il suo gusto. La sottana del ritratto è realizzata in un tessuto rarissimo e preziosissimo, sicuramente realizzato dalle manifatture fiorentine, e del quale forse c'è anche traccia in una nota di acquisto dello stesso Cosimo per un drappo simile il 31 gennaio 1543 per la considerevolissima somma di 296 doppioni d'oro. Si tratta di un tessuto di velluto controtagliato nero su teletta d'argento, broccato di ricci d'oro e d'argento che presenta il classico motivo della cosiddetta “melograna”. Un tessuto che era un vanto per le manifatture cittadine, le sole in grado di realizzare un lavoro così difficile e complesso, ma anche armonioso ed elegante, oltre che preziosissimo per l'altissima qualità dei materiali usati. Un vero capolavoro che la Duchessa ostenta anche in nome e per conto dei suoi sudditi, così come l'enorme diamante tagliato a tavola che le pende da una collana di impareggiabili perle di inusitata grandezza. Il diamante, come le collane di perle e la ricchissima cintura a rosario, tutti gioielli che sarebbero rimasti patrimonio famigliare, sono il primo esempio, non solo di un rinnovato gusto per il gioiello ricco e vistoso, ma anche di quel suo uso strumentale ad una immagine di apparato di Stato che ne caratterizza la presenza in tutta la ritrattistica dinastica di antico regime. Ma tutto il ritratto trasuda lusso ed ostentazione, nel quale tutto partecipa a darci un senso di alterità: dalla bellezza algida della Duchessa, a quel materiale pittorico che sembra esso stesso fatto di pietre dure, a quella levigatezza delle superfici che ancora oggi incanta chi lo ammira agli Uffizi.
Poiché sappiamo che Eleonora, per le cerimonie ufficiali, non amava indossare
broccati con effetto di pelo, come quello del ritratto, possiamo una volta di
più sottolineare l’interesse che la granduchessa ha avuto per incrementare ed
aiutare la produzione manifatturiera fiorentina, anche in occasione di questo
stupendo ritratto.
Nell’estate del 1545, con il caldo che possiamo immaginare in quel di Poggio a
Caiano, fra Prato e Firenze, la granduchessa Eleonora si fece strumento
politico e commerciale, diventando immagine del potere, rigidamente
imprigionata in quel suntuoso abito, che era soggetto del dipinto quanto lei e
suo figlio Giovanni.
Inoltre, sono da lei indossati gioielli bellissimi, realizzati da importanti
artisti dell’epoca, come Benvenuto Cellini, che probabilmente elaborò la
stupenda cintura d’oro decorata da una nappa di perle, come lui stesso ci narra
nella sua autobiografia.
La
moda era un vero “instrumentum regni”, per la capacità di comunicazione
immediata, ed Eleonora seppe sempre usare questo mezzo nel migliore dei modi,
riuscendo ad elevare la giovane corte fiorentina al livello delle più
importanti e antiche d’Europa.
Calze di Eleonora
di Toledo, 1562
Galleria del
Costume – Firenze
Le calze sono lavorate in filato di seta con una grande varietà di punti diversi, indicando il lavoro di un abile professionista. La magliaia che riforniva la corte crebbe notevolmente di numero durante la seconda metà del secolo, parallelamente alla crescente richiesta di calze a maglia, molto più comode, in termini di vestibilità ed elasticità, di quelle di tessuto.
"Particolare della lavorazione a maglia sopra e sotto
le gambe delle calze."
la
pavoncella con i pulcini.
4.
La Vita
Cosimo
I de’ Medici, da poco avuto il potere, non aveva molti contatti politici e
nemmeno fondi economici e il matrimonio fu per lui un sollievo perché gli
permise di entrare in possesso di un immenso patrimonio e di avere importante
contatti con la parentela del vicere.Vicerè
che, grazie alla sua onestà e fedeltà nei confronti di Carlo V, ottenne il
rinnovo della carica viceregia fino alla sua morte avvenuta nel 1553.La
coppia fissò la residenza nel Palazzo Medici di via Larga, oggi Palazzo Medici
Riccardi, e ben presto si trasferì nel Palazzo Vecchio che, grazie alla loro
presenza, fu ingrandito e ristrutturato.
Firenze – Palazzo Medici Riccardi
Come
già accennato, fu un grande matrimonio d’amore e i cronisti del tempo ( e le
numerose lettere) diedero molto risalto al loro legame sentimentale. La
loro unione fu anche fedele? Eleonora fu molto fedele e vicina la marito. Lo
stesso comportamento di vita contraddistinse
Cosimo I. In una città come Firenze, una sua “scappatella” non sarebbe
mai passata inosservata dato che era sempre al centro dell’attenzione. Cosimo I
ebbe anche dei figli naturali ma risalivano al periodo prematrimoniale e a
quello di vedovanza. Melò periodo prematrimoniale si dovrebbe collocare la
figlia Bianca e al periodo seguito alla morte della moglie si devono collocare:
una bambina di cui non si conosce il nome e neppure quello della madre;
Giovanni avuto da Elenora degli Albizzi e Virginia da Camilla Martelli,
entrambi legittimati. Donna Eleonora era
molto legata al marito a tal punto che i cronisti dell’epoca riferirono di un
episodio in merito ad un viaggio del duca. Donna Eleonora non poteva
accompagnarlo e alcuni cortigiani videro la donna, in preda all’ira, piangere e
strapparsi i capelli.
In
merito alle lettere, quando Cosimo I era assente, la moglie ne pretendeva almeno due al giorno…
Era
l’unica persona che aveva un certo ascendente sul carattere, burrascoso,
introverso e sui frequenti sbalzi d’umore del marito che accettava i suoi
consigli.
Dieci
anni dopo il matrimonio (1549), Eleonora aveva già partorito nove dei suoi
undici figli/e (Maria, Francesco, Isabella, Giovanni, Lucrezia, Piero
“Piedricco”, Garzia, Antonio, Ferdinando), fu ultimata la costruzione del
palazzo Pitti che diventò la nuova residenza dei Signori Firenze e con i soldi
di Donna Eleonora furono comprati i terreni vicini che entreranno a fare parte
del Giardino di Boboli.
Eleonora
aveva subito la perdita di troppi figli e aveva bisogno di una zona più salubre.
A
quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al
1549. Un ritratto eseguito dalla Bottega del Bronzino evidenziava la donna con
il volto molto sciupato, scavato, segni della pericolosa malattia.
Il
grande giardino di Boboli, (Oltrarno), con il suo ambiente incontaminato, era
in grado di offrire i rimedi per i problemi di salute che affliggevano la sua
famiglia. A
quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al
1549. Dei ritratti eseguiti dalla Bottega del Bronzino e da Alessandro Allori
(verso il 1560) riescono ad evidenziare la donna con il volto molto sciupato, scavato,
segni della pericolosa malattia.Gli
erano morti da poco i figli:Piero
“Piedricco” (7 agosto 1546 – 9 giugno 1547
- 306 giorni)Antonio (1548, 1548; morto alla nascita) (?)Alcune
storici collocarono Antonio come nato
nel 1548 e morto alla nascita.Un
dato è certo e cioè la data della sua morte. Non
esistono delle fonti scritte sul bambino.
L’unica fonte su questo sfortunato bambino è legata ad un dipinto.
Quando
la sorella Maria morì, nel 1557, l’ultimo ritratto del bambino fu aggiunto al
suo.
Cosimo
I doveva essere molto affezionato a questo bambino dal cui volto traspare un
infinità dolcezza che ben sì pone vicino alla figura della sorella dal volto ricco di sensibilità e d’infinita
tristezza.
Un
bambino dai capelli biondo rossicci e dalla sua piccola bocca dalle labbra
carnose.
Osservando
il quadro il bambino dovrebbe avere un età tra i quattro o cinque anni.
In
base a questa analisi sarebbe nato tra
il 1543 o 1544.
Giovanni
de’ Medici nacque nel settembre del 1543 quindi Antonio sarebbe nato nel 1544 e
11 mesi dopo nacque la sorella Lucrezia.
Antonio
era, stranamente, il fratello prediletto di Francesco I forse per la sua
vivacità che traspare dal suo volto.
Francesco I chiamò Antonio l’unico figlio
avuto dalla seconda moglie Bianca Cappello e di cui non si è sicuri sulla
maternità.
Antonio de’ Medici
da bambino
(Artista: Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura: tempera
su tavola – Datazione: fine 1545
Misure (58 x 45)
cm
L’uccellino in
mano è un Carduelis carduelis (Cardellino)
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Antonio De’ Medici
(da bambino)
Artista:
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo – Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Datazione : 1550 circa
Misure
(48 x 38) cm – Collocazione: Museo del Prado, Madrid
(Il
bambino tiene nella mano destra un fiore e sulla sinistra un
piccolo
gioiello come amuleto)
I
fiorentini non l’amavano per il suo carattere visto, in modo errato, come
altezzoso anche perché non abituati all’alterigia della corte spagnola. Non
girava mai a piedi per la città ma sempre a cavallo o su una lettiga che lei
stessa aveva fatto decorare con raso verde all’interno e di velluto, sempre
dello stesso colore, all’esterno.
Stava
sempre chiusa in quella lettiga senza mai spostare le tendine neanche per guardare l’ambiente circostante.
Eppure
era molto vicina alla gente, soprattutto nei confronti degli ultimi a cui
elargiva abbondanti elemosine. Aiutava le fanciulle bisognose a costituirsi una
dote e. sosteneva il piccolo clero. Tutti aiuti che nascevano dal suo forte
patrimonio. Amava molto gli animali e secondo le fonti aveva un cagnolino, un
gatto e un pappagallo.
Mostrava
un scrupolosa e assidua presenza alle funzioni religiose e a quanto sembra le
piacevano il gioco, le scommesse, la passione per la corsa dei cavalli.
Aveva
una grande passione per l’abbigliamento molto raffinato ed anche per i gioielli
che numerosi amava indossare.
Nel
1553 nacque Anna (19 marzo 1553 – 1 agosto 1553) che morì dopo 135 giorni e nel
1554 Pietro , il 3 giugno, che riuscirà a sopravvivere malgrado la salute
precaria di Donna Eleonora, morendo il
25 aprile 1604 all’età di 49 anni.Il
19 novembre 1557 perdeva la figlia diciasettenne Maria morta a Livorno forse a
causa della malaria.
............................
5.
Maria de’ Medici – Il suo ritratto - Il Mistero sulla sua morte
Nacque
il 3 aprile 1540, nel Palazzo Medici in Via Larga, e fu battezzata all’Opera di
Santa Maria del Fiore con il nome di “Maria et
Lucretia”.
Firenze - Palazzo
Medici – Via Larga
Prese
il nome di entrambe le nonne, Maria Salviati e Maria Pimentel y Osorio.
Per
Cosimo fu il grande amore della sua vita, la sua figlia prediletta che veniva
descritta come la madre Eleonora di Toledo dai contemporanei:
una
"bellezza mozzafiato" o "rara bellezza”
"...
era già così bella nel 1550 che il vescovo Jacopo Cortesi commentò che la
natura aveva fatto di tutto per prodigarle una tale bellezza e fascino da farla
sembrare un angelo ".
Secondo
Giorgio Vasari “la Signora Maria .. una ragazza
grandissima e veramente bella”. Come
la sua bellissima bisnonna, la celebre Caterina Sforza (1463-1509), e suo
padre. Maria era “un’amante della vita all’aria
aperta”.
Maria da bambina
Artista: Bronzino (Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino)
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 - Firenze, 23 novembre 1572)
Pittura: Olio su
tavola – Datazione: 1545 circa
Misure (58 x 46,5)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
Amava
molto la caccia e i suoi contemporanei riferirono nei loro scritti che non solo era bella ma anche gentile, affascinante,
graziosa, decorosa, umana, elegante, colta e molto intelligente...”...” il
tutore dei bambini avrebbe incaricato maria di aiutare suo fratello
Francesco... quando ha lottato con il suo greco”...”aveva una bella ciocca di
capelli e un viso delicato e pallido”.Il
ritratto di Maria da bambina fino alla prima metà del XX secolo gli fu
correttamente attribuito, nei due libri
di GF Young sui Medici, stampati nel 1909 e nel 1930, c’era un commento su
ritratto di Maria..” sua figlia maggiore (di
Cosimo) Maria... il cui ritratto, all’età di circa dieci anni, del bronzino,
alla Galleria degli Uffizi è ben noto”.Verso
il 1950 il ritratto di Maria de’ Medici fu
ridefinito come ritratto della sorellastra naturale Bianca (Bia).Il
responsabile di questo cambiamento nel nome del ritratto fu lo storico
dell’arte Detlef Heikamps. Lo storico trovò una fonte storica risalente al
1550/51 che affermava come il “maggiore-domo di Cosimo, Pierfrancesco Rccio, chiamò il
pittore di corte Agnolo Bronzino a Pisa nel dicembre 1550 per fare un ritratto
del bambino di sette anno Giovanni de’ Medici,
il futuro cardinale, che dovrebbe essere inviato a papa Giulio III in
dono”.Il
ritratto di Giovanni de’ Medici fu solo il primo di una serie di ritratti dei
figli di Cosimo I ed Eleonora di Toledo che il Bronzino eseguì. Dopo aver terminato il successivo ritratto
della bambina di dieci anni Maria, completato entro il 27 gennaio 1551, il
Bronzino scrisse al maggiore-domo Pierfrancesco Riccio da Pisa.Questa
fonte storica del 1550/51 non riportava descrizione dei ritratti di Giovanni,
Maria, Garzia e Francesco ( sui loro
costumi, sullo sfondo, ecc.) ed esprimeva soltanto come il pittore di corte di corte dei Medici
avesse eseguito i quattro ritratti dei figli di Cosimo nel 1551.. Nessuno ritratto
riportava però la datazione e nel 1955 Detlef Heikamp identificò i questi
ritratti sebbene nessuno fosse datato.Identificò,
come opere realizzate da Agnolo Bronzino nel 1551, i ritratti di:-
Maria
de’ Medici..in realtà raffigura Virginia
de’ Medici (1576/78)
Maria De’ Medici –
Virginia de’ Medici
(3 aprile 1540 –
19 novembre 1557)
(Arista; Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto: olio su
tela ? – Datazione: 1551
Misure (52,5 x 38)
cm
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Detlef Heikamp sostenne come il quadro fosse un
ritratto di Maria de’ Medici mentre in realtà è quadro d’identificazione. La
doppia fila avrebbe un preciso significato come figlia di un secondo
matrimonio. Virginia è l’unica figlia sopravvissuta al secondo matrimonio di
Cosimo I cioè con Camilla Martelli. Indossa un abito che era di moda negli anni
‘70/ ’80 del XVII secolo. A quel tempo la sorellastra Maria era già morta da
almeno 13anni. Nel quadro Virginia avrebbe un’età di circa 8/10 anni e quindi
il quadro fu realizzato tra il 1576 ed il 1578. Il pittore non può essere
Agnolo Bronzino che morì nel 1572. Fu probabilmente uno dei suoi allievi, forse
Alessandro Allori, che a differenza del suo maestro, amava decorare i suoi
ritratti con simboli o oggetti dei Medici.
-
Francesco
de’ Medici all’età di otto - dieci anni e quindi realizzato tra il 1549 /1551
Eleonora di Toledo
con il figlio Francesco I
Artista: Bronzino
Il Bronzino -
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Datazione: 1549
Collocazione:
Museo Nazionale del Palazzo reale, Pisa
- Giovanni de’ Medici (realizzato ..1570/71 circa) ... in realtà si tratta
del figlio naturale di Cosimo I, Giovanni de’ Medici dai caratteristici capelli
ricci. Il ritratto mostra un ragazzo di sette/otto anni
-
Garzia
de’ Medici (1549/59)
Maria morì quando aveva
17 anni e di lei c’è un quadro che la raffigura all’età di circa quindici anni.
Maria de’ Medici e suo fratello Antonio
Artista: Bronzino
-
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Misure (9,95 x 7,6) cm -
Collocazione: National Gallery of Art – Washington
Provenienza:
forse al barone Achille Seillière, Parigi fino al 1873
(probabilmente per eredità a Jeanne Marquerite Seillière,
Principessa di Sagan
In seguito Duchessa de Talleyrand-Perigord – Parigi, dal 1873
al 1896
Venduta nel 1905 a Peter AB Widener, Lynnewood Hall, Elkins
Park, Pennsylvania
(tramite Cottier e Co. Londra e New York ?)
Eredità da Estate di Peter AB Widener per dono tramite potere
di nomina di
Joseph E. Widener, Elkins Park, Pennsylvania
Regalo nel 1942 National
Gallery of Art Washington
Maria de Medici
A sinistra- all’età di cinque anni
A destra – all’età di circa 15 anni
Confrontando i
lineamenti del volto, dei bellissimi occhi, del suo delicato naso e soprattutto
della bocca, molto caratteristica perchè
presenta il labbro superiore più piccolo
rispetto al labbro inferiore, sembrerebbe di trovarsi di fronte alla stessa
persona ripresa in due momenti diversi della sua tragica vita: da bambina e all’età di circa sedici anni.I suoi capelli sono
diventati più scuri durante l’adolescenza.Altro aspetto importante
è legato alla collana che indossa.Una collana che
indossava anche la madre Eleonora di Toledo in uno dei suo ritratti eseguiti dal Bronzino.
Eleonora da Toledo
Artista: Bronzino – 1539
Maria de’ Medici
Nel ritratto originale
Maria de’ Medici era ritratta sa sola e solo dopo la morte del fratello
Antonio, deceduto all’età di quattro anni, fu aggiunto al suo ritratto.
La stessa cosa accadde nel
quadro di Maria Salviati eseguito sempre dal Bronzino. Alla morte della cara
nipotina Bianca avvenuta nel marzo del 1542, la piccola fu aggiunta al quadro
della nonna.
Maria Salviati da solaArtista: BronzinoMaria
de’ Medici era stata promessa in sposa al primogenito del duca Ercole II d’Este
di Ferrara, Alfonso II nel 1554. La ragazza morì di febbre il 19 novembre 1557
nel castello dei Medici di Livorno. Gli storici del tempo
diedero l’immagine di un padre inconsolabile per la morte de3lla ragazza e la
pianse amaramente. La sua morte fu definita come uno degli eventi più tristi
della sua vita. Fino alla sua morte tenne uno dei suoi ritratti nella sua
stanza..
Spesso fissando per ore e ore l’unico quadro sul muro, un ritratto della sua amata figlia Maria
Sulla
vita della principessa si sa molto poco e nella storiografia ci sono due
versioni sulla sua morte all’età di 17 anni: omicidio o morte naturale ?
In
un documento di Francesco Settimanni,
fiorentino e cavaliere di San Sepolcro si legge: “Addì XIX di Novembre 1557, Circa 8 ½ di notte la Sig.ra
Donna Maria primogenita del Duca morì di veleno statole dato per ordine del
Padre e privatamente fu sepolta nella chiesa di San Lorenzo”.È
difficile credere ad una simile storia dopo
quello che ho scritto sul felice rapporto coniugale dei genitori della
ragazza.Il
duca avrebbe fatto uccidere la figlia con il veleno perché fu avvisato, da un
informatore di corte, della sua relazione con un paggio figlio del marchese
Jacopo Malatesta. I due ragazzi erano stati più volti in atteggiamenti amorosi
nelle stanze delle damigelle. Il
padre Cosimo I s’adirò moltissimo perché la ragazza era stata già promessa in
moglie ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara. Per questo motivo diede l’ordine di
somministrare il veleno che le avrebbe procurato la morte le giro di pochi
giorni.Successivamente
avrebbe ordinato anche l’uccisione del paggio che scomparve in pochissimo
tempo.Il
luogo della sepoltura di Maria fu sempre oggetto d’indagine fin dai tempi
antichi e fu Filippo Baldinucci
(Firenze, 1624 – Firenze, 10 gennaio 1696) (storico dell’arte, politico e
pittore) a raccogliere notizie importanti sui depositi della basilica di San
Lorenzo.
Nelle
sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito,
una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
e
nella successiva pubblicazione del 1947 scrisse in maniera più dettagliata
che.....
"La Maria Medici venne sepolta , nell'oratorio del Castello, che dopo
molti anni prese il nome di Chiesa di S. Antonio. Sopra la parete della chiesa
si trovava una lapide che ricordava Maria e ne segnava la sepoltura; ma nel
bombardamento tedesco del 1944 la Chiesa andò distrutta e si è perduta ogni
traccia dell'epigrafe e della tomba".
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora
di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia
che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena
e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7.
la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Come già accennato, fu un grande matrimonio d’amore e i cronisti del tempo ( e le numerose lettere) diedero molto risalto al loro legame sentimentale. La loro unione fu anche fedele? Eleonora fu molto fedele e vicina la marito. Lo stesso comportamento di vita contraddistinse Cosimo I. In una città come Firenze, una sua “scappatella” non sarebbe mai passata inosservata dato che era sempre al centro dell’attenzione. Cosimo I ebbe anche dei figli naturali ma risalivano al periodo prematrimoniale e a quello di vedovanza. Melò periodo prematrimoniale si dovrebbe collocare la figlia Bianca e al periodo seguito alla morte della moglie si devono collocare: una bambina di cui non si conosce il nome e neppure quello della madre; Giovanni avuto da Elenora degli Albizzi e Virginia da Camilla Martelli, entrambi legittimati. Donna Eleonora era molto legata al marito a tal punto che i cronisti dell’epoca riferirono di un episodio in merito ad un viaggio del duca. Donna Eleonora non poteva accompagnarlo e alcuni cortigiani videro la donna, in preda all’ira, piangere e strapparsi i capelli.
In
merito alle lettere, quando Cosimo I era assente, la moglie ne pretendeva almeno due al giorno…
Era
l’unica persona che aveva un certo ascendente sul carattere, burrascoso,
introverso e sui frequenti sbalzi d’umore del marito che accettava i suoi
consigli.
Dieci
anni dopo il matrimonio (1549), Eleonora aveva già partorito nove dei suoi
undici figli/e (Maria, Francesco, Isabella, Giovanni, Lucrezia, Piero
“Piedricco”, Garzia, Antonio, Ferdinando), fu ultimata la costruzione del
palazzo Pitti che diventò la nuova residenza dei Signori Firenze e con i soldi
di Donna Eleonora furono comprati i terreni vicini che entreranno a fare parte
del Giardino di Boboli.
Eleonora
aveva subito la perdita di troppi figli e aveva bisogno di una zona più salubre.
A
quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al
1549. Un ritratto eseguito dalla Bottega del Bronzino evidenziava la donna con
il volto molto sciupato, scavato, segni della pericolosa malattia.
Il
grande giardino di Boboli, (Oltrarno), con il suo ambiente incontaminato, era
in grado di offrire i rimedi per i problemi di salute che affliggevano la sua
famiglia. A
quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al
1549. Dei ritratti eseguiti dalla Bottega del Bronzino e da Alessandro Allori
(verso il 1560) riescono ad evidenziare la donna con il volto molto sciupato, scavato,
segni della pericolosa malattia.Gli
erano morti da poco i figli:Piero
“Piedricco” (7 agosto 1546 – 9 giugno 1547
- 306 giorni)Antonio (1548, 1548; morto alla nascita) (?)Alcune
storici collocarono Antonio come nato
nel 1548 e morto alla nascita.Un
dato è certo e cioè la data della sua morte. Non
esistono delle fonti scritte sul bambino.
L’unica fonte su questo sfortunato bambino è legata ad un dipinto.
Quando
la sorella Maria morì, nel 1557, l’ultimo ritratto del bambino fu aggiunto al
suo.
Cosimo
I doveva essere molto affezionato a questo bambino dal cui volto traspare un
infinità dolcezza che ben sì pone vicino alla figura della sorella dal volto ricco di sensibilità e d’infinita
tristezza.
Un
bambino dai capelli biondo rossicci e dalla sua piccola bocca dalle labbra
carnose.
Osservando
il quadro il bambino dovrebbe avere un età tra i quattro o cinque anni.
In
base a questa analisi sarebbe nato tra
il 1543 o 1544.
Giovanni
de’ Medici nacque nel settembre del 1543 quindi Antonio sarebbe nato nel 1544 e
11 mesi dopo nacque la sorella Lucrezia.
Antonio
era, stranamente, il fratello prediletto di Francesco I forse per la sua
vivacità che traspare dal suo volto.
Francesco I chiamò Antonio l’unico figlio
avuto dalla seconda moglie Bianca Cappello e di cui non si è sicuri sulla
maternità.
Antonio de’ Medici
da bambino
(Artista: Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura: tempera
su tavola – Datazione: fine 1545
Misure (58 x 45)
cm
L’uccellino in
mano è un Carduelis carduelis (Cardellino)
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Antonio De’ Medici
(da bambino)
Artista:
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo – Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Datazione : 1550 circa
Misure
(48 x 38) cm – Collocazione: Museo del Prado, Madrid
(Il
bambino tiene nella mano destra un fiore e sulla sinistra un
piccolo
gioiello come amuleto)
I
fiorentini non l’amavano per il suo carattere visto, in modo errato, come
altezzoso anche perché non abituati all’alterigia della corte spagnola. Non
girava mai a piedi per la città ma sempre a cavallo o su una lettiga che lei
stessa aveva fatto decorare con raso verde all’interno e di velluto, sempre
dello stesso colore, all’esterno.
Stava
sempre chiusa in quella lettiga senza mai spostare le tendine neanche per guardare l’ambiente circostante.
Eppure
era molto vicina alla gente, soprattutto nei confronti degli ultimi a cui
elargiva abbondanti elemosine. Aiutava le fanciulle bisognose a costituirsi una
dote e. sosteneva il piccolo clero. Tutti aiuti che nascevano dal suo forte
patrimonio. Amava molto gli animali e secondo le fonti aveva un cagnolino, un
gatto e un pappagallo.
Mostrava
un scrupolosa e assidua presenza alle funzioni religiose e a quanto sembra le
piacevano il gioco, le scommesse, la passione per la corsa dei cavalli.
Aveva
una grande passione per l’abbigliamento molto raffinato ed anche per i gioielli
che numerosi amava indossare.
Nel
1553 nacque Anna (19 marzo 1553 – 1 agosto 1553) che morì dopo 135 giorni e nel
1554 Pietro , il 3 giugno, che riuscirà a sopravvivere malgrado la salute
precaria di Donna Eleonora, morendo il
25 aprile 1604 all’età di 49 anni.Il
19 novembre 1557 perdeva la figlia diciasettenne Maria morta a Livorno forse a
causa della malaria.
............................
5.
Maria de’ Medici – Il suo ritratto - Il Mistero sulla sua morte
Nacque
il 3 aprile 1540, nel Palazzo Medici in Via Larga, e fu battezzata all’Opera di
Santa Maria del Fiore con il nome di “Maria et
Lucretia”.
Firenze - Palazzo
Medici – Via Larga
Prese
il nome di entrambe le nonne, Maria Salviati e Maria Pimentel y Osorio.
Per
Cosimo fu il grande amore della sua vita, la sua figlia prediletta che veniva
descritta come la madre Eleonora di Toledo dai contemporanei:
una
"bellezza mozzafiato" o "rara bellezza”
"...
era già così bella nel 1550 che il vescovo Jacopo Cortesi commentò che la
natura aveva fatto di tutto per prodigarle una tale bellezza e fascino da farla
sembrare un angelo ".
Secondo
Giorgio Vasari “la Signora Maria .. una ragazza
grandissima e veramente bella”. Come
la sua bellissima bisnonna, la celebre Caterina Sforza (1463-1509), e suo
padre. Maria era “un’amante della vita all’aria
aperta”.
Maria da bambina
Artista: Bronzino (Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino)
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 - Firenze, 23 novembre 1572)
Pittura: Olio su
tavola – Datazione: 1545 circa
Misure (58 x 46,5)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
Amava
molto la caccia e i suoi contemporanei riferirono nei loro scritti che non solo era bella ma anche gentile, affascinante,
graziosa, decorosa, umana, elegante, colta e molto intelligente...”...” il
tutore dei bambini avrebbe incaricato maria di aiutare suo fratello
Francesco... quando ha lottato con il suo greco”...”aveva una bella ciocca di
capelli e un viso delicato e pallido”.Il
ritratto di Maria da bambina fino alla prima metà del XX secolo gli fu
correttamente attribuito, nei due libri
di GF Young sui Medici, stampati nel 1909 e nel 1930, c’era un commento su
ritratto di Maria..” sua figlia maggiore (di
Cosimo) Maria... il cui ritratto, all’età di circa dieci anni, del bronzino,
alla Galleria degli Uffizi è ben noto”.Verso
il 1950 il ritratto di Maria de’ Medici fu
ridefinito come ritratto della sorellastra naturale Bianca (Bia).Il
responsabile di questo cambiamento nel nome del ritratto fu lo storico
dell’arte Detlef Heikamps. Lo storico trovò una fonte storica risalente al
1550/51 che affermava come il “maggiore-domo di Cosimo, Pierfrancesco Rccio, chiamò il
pittore di corte Agnolo Bronzino a Pisa nel dicembre 1550 per fare un ritratto
del bambino di sette anno Giovanni de’ Medici,
il futuro cardinale, che dovrebbe essere inviato a papa Giulio III in
dono”.Il
ritratto di Giovanni de’ Medici fu solo il primo di una serie di ritratti dei
figli di Cosimo I ed Eleonora di Toledo che il Bronzino eseguì. Dopo aver terminato il successivo ritratto
della bambina di dieci anni Maria, completato entro il 27 gennaio 1551, il
Bronzino scrisse al maggiore-domo Pierfrancesco Riccio da Pisa.Questa
fonte storica del 1550/51 non riportava descrizione dei ritratti di Giovanni,
Maria, Garzia e Francesco ( sui loro
costumi, sullo sfondo, ecc.) ed esprimeva soltanto come il pittore di corte di corte dei Medici
avesse eseguito i quattro ritratti dei figli di Cosimo nel 1551.. Nessuno ritratto
riportava però la datazione e nel 1955 Detlef Heikamp identificò i questi
ritratti sebbene nessuno fosse datato.Identificò,
come opere realizzate da Agnolo Bronzino nel 1551, i ritratti di:-
Maria
de’ Medici..in realtà raffigura Virginia
de’ Medici (1576/78)
Maria De’ Medici –
Virginia de’ Medici
(3 aprile 1540 –
19 novembre 1557)
(Arista; Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto: olio su
tela ? – Datazione: 1551
Misure (52,5 x 38)
cm
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Detlef Heikamp sostenne come il quadro fosse un
ritratto di Maria de’ Medici mentre in realtà è quadro d’identificazione. La
doppia fila avrebbe un preciso significato come figlia di un secondo
matrimonio. Virginia è l’unica figlia sopravvissuta al secondo matrimonio di
Cosimo I cioè con Camilla Martelli. Indossa un abito che era di moda negli anni
‘70/ ’80 del XVII secolo. A quel tempo la sorellastra Maria era già morta da
almeno 13anni. Nel quadro Virginia avrebbe un’età di circa 8/10 anni e quindi
il quadro fu realizzato tra il 1576 ed il 1578. Il pittore non può essere
Agnolo Bronzino che morì nel 1572. Fu probabilmente uno dei suoi allievi, forse
Alessandro Allori, che a differenza del suo maestro, amava decorare i suoi
ritratti con simboli o oggetti dei Medici.
-
Francesco
de’ Medici all’età di otto - dieci anni e quindi realizzato tra il 1549 /1551
Eleonora di Toledo
con il figlio Francesco I
Artista: Bronzino
Il Bronzino -
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Datazione: 1549
Collocazione:
Museo Nazionale del Palazzo reale, Pisa
- Giovanni de’ Medici (realizzato ..1570/71 circa) ... in realtà si tratta
del figlio naturale di Cosimo I, Giovanni de’ Medici dai caratteristici capelli
ricci. Il ritratto mostra un ragazzo di sette/otto anni
-
Garzia
de’ Medici (1549/59)
Maria morì quando aveva
17 anni e di lei c’è un quadro che la raffigura all’età di circa quindici anni.
Maria de’ Medici e suo fratello Antonio
Artista: Bronzino
-
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Misure (9,95 x 7,6) cm -
Collocazione: National Gallery of Art – Washington
Provenienza:
forse al barone Achille Seillière, Parigi fino al 1873
(probabilmente per eredità a Jeanne Marquerite Seillière,
Principessa di Sagan
In seguito Duchessa de Talleyrand-Perigord – Parigi, dal 1873
al 1896
Venduta nel 1905 a Peter AB Widener, Lynnewood Hall, Elkins
Park, Pennsylvania
(tramite Cottier e Co. Londra e New York ?)
Eredità da Estate di Peter AB Widener per dono tramite potere
di nomina di
Joseph E. Widener, Elkins Park, Pennsylvania
Regalo nel 1942 National
Gallery of Art Washington
Maria de Medici
A sinistra- all’età di cinque anni
A destra – all’età di circa 15 anni
Confrontando i
lineamenti del volto, dei bellissimi occhi, del suo delicato naso e soprattutto
della bocca, molto caratteristica perchè
presenta il labbro superiore più piccolo
rispetto al labbro inferiore, sembrerebbe di trovarsi di fronte alla stessa
persona ripresa in due momenti diversi della sua tragica vita: da bambina e all’età di circa sedici anni.I suoi capelli sono
diventati più scuri durante l’adolescenza.Altro aspetto importante
è legato alla collana che indossa.Una collana che
indossava anche la madre Eleonora di Toledo in uno dei suo ritratti eseguiti dal Bronzino.
Eleonora da Toledo
Artista: Bronzino – 1539
Maria de’ Medici
Nel ritratto originale
Maria de’ Medici era ritratta sa sola e solo dopo la morte del fratello
Antonio, deceduto all’età di quattro anni, fu aggiunto al suo ritratto.
La stessa cosa accadde nel
quadro di Maria Salviati eseguito sempre dal Bronzino. Alla morte della cara
nipotina Bianca avvenuta nel marzo del 1542, la piccola fu aggiunta al quadro
della nonna.
Maria Salviati da solaArtista: BronzinoMaria
de’ Medici era stata promessa in sposa al primogenito del duca Ercole II d’Este
di Ferrara, Alfonso II nel 1554. La ragazza morì di febbre il 19 novembre 1557
nel castello dei Medici di Livorno. Gli storici del tempo
diedero l’immagine di un padre inconsolabile per la morte de3lla ragazza e la
pianse amaramente. La sua morte fu definita come uno degli eventi più tristi
della sua vita. Fino alla sua morte tenne uno dei suoi ritratti nella sua
stanza..
Spesso fissando per ore e ore l’unico quadro sul muro, un ritratto della sua amata figlia Maria
Sulla
vita della principessa si sa molto poco e nella storiografia ci sono due
versioni sulla sua morte all’età di 17 anni: omicidio o morte naturale ?
In
un documento di Francesco Settimanni,
fiorentino e cavaliere di San Sepolcro si legge: “Addì XIX di Novembre 1557, Circa 8 ½ di notte la Sig.ra
Donna Maria primogenita del Duca morì di veleno statole dato per ordine del
Padre e privatamente fu sepolta nella chiesa di San Lorenzo”.È
difficile credere ad una simile storia dopo
quello che ho scritto sul felice rapporto coniugale dei genitori della
ragazza.Il
duca avrebbe fatto uccidere la figlia con il veleno perché fu avvisato, da un
informatore di corte, della sua relazione con un paggio figlio del marchese
Jacopo Malatesta. I due ragazzi erano stati più volti in atteggiamenti amorosi
nelle stanze delle damigelle. Il
padre Cosimo I s’adirò moltissimo perché la ragazza era stata già promessa in
moglie ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara. Per questo motivo diede l’ordine di
somministrare il veleno che le avrebbe procurato la morte le giro di pochi
giorni.Successivamente
avrebbe ordinato anche l’uccisione del paggio che scomparve in pochissimo
tempo.Il
luogo della sepoltura di Maria fu sempre oggetto d’indagine fin dai tempi
antichi e fu Filippo Baldinucci
(Firenze, 1624 – Firenze, 10 gennaio 1696) (storico dell’arte, politico e
pittore) a raccogliere notizie importanti sui depositi della basilica di San
Lorenzo.
Nelle
sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito,
una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
e
nella successiva pubblicazione del 1947 scrisse in maniera più dettagliata
che.....
"La Maria Medici venne sepolta , nell'oratorio del Castello, che dopo
molti anni prese il nome di Chiesa di S. Antonio. Sopra la parete della chiesa
si trovava una lapide che ricordava Maria e ne segnava la sepoltura; ma nel
bombardamento tedesco del 1944 la Chiesa andò distrutta e si è perduta ogni
traccia dell'epigrafe e della tomba".
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora
di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia
che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena
e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7.
la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
A quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al 1549. Un ritratto eseguito dalla Bottega del Bronzino evidenziava la donna con il volto molto sciupato, scavato, segni della pericolosa malattia.
Il grande giardino di Boboli, (Oltrarno), con il suo ambiente incontaminato, era in grado di offrire i rimedi per i problemi di salute che affliggevano la sua famiglia. A quanto sembra Donna Eleonora aveva contratto la tubercolosi proprio intorno al 1549. Dei ritratti eseguiti dalla Bottega del Bronzino e da Alessandro Allori (verso il 1560) riescono ad evidenziare la donna con il volto molto sciupato, scavato, segni della pericolosa malattia.
Cosimo
I doveva essere molto affezionato a questo bambino dal cui volto traspare un
infinità dolcezza che ben sì pone vicino alla figura della sorella dal volto ricco di sensibilità e d’infinita
tristezza.
Un
bambino dai capelli biondo rossicci e dalla sua piccola bocca dalle labbra
carnose.
Osservando
il quadro il bambino dovrebbe avere un età tra i quattro o cinque anni.
Giovanni de’ Medici nacque nel settembre del 1543 quindi Antonio sarebbe nato nel 1544 e 11 mesi dopo nacque la sorella Lucrezia.
Antonio era, stranamente, il fratello prediletto di Francesco I forse per la sua vivacità che traspare dal suo volto.
Francesco I chiamò Antonio l’unico figlio avuto dalla seconda moglie Bianca Cappello e di cui non si è sicuri sulla maternità.
Antonio de’ Medici
da bambino
(Artista: Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura: tempera
su tavola – Datazione: fine 1545
Misure (58 x 45)
cm
L’uccellino in
mano è un Carduelis carduelis (Cardellino)
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Antonio De’ Medici
(da bambino)
Artista:
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo – Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Datazione : 1550 circa
Misure
(48 x 38) cm – Collocazione: Museo del Prado, Madrid
(Il
bambino tiene nella mano destra un fiore e sulla sinistra un
piccolo
gioiello come amuleto)
I
fiorentini non l’amavano per il suo carattere visto, in modo errato, come
altezzoso anche perché non abituati all’alterigia della corte spagnola. Non
girava mai a piedi per la città ma sempre a cavallo o su una lettiga che lei
stessa aveva fatto decorare con raso verde all’interno e di velluto, sempre
dello stesso colore, all’esterno.
Stava
sempre chiusa in quella lettiga senza mai spostare le tendine neanche per guardare l’ambiente circostante.
Eppure
era molto vicina alla gente, soprattutto nei confronti degli ultimi a cui
elargiva abbondanti elemosine. Aiutava le fanciulle bisognose a costituirsi una
dote e. sosteneva il piccolo clero. Tutti aiuti che nascevano dal suo forte
patrimonio. Amava molto gli animali e secondo le fonti aveva un cagnolino, un
gatto e un pappagallo.
Mostrava
un scrupolosa e assidua presenza alle funzioni religiose e a quanto sembra le
piacevano il gioco, le scommesse, la passione per la corsa dei cavalli.
Aveva
una grande passione per l’abbigliamento molto raffinato ed anche per i gioielli
che numerosi amava indossare.
Nel
1553 nacque Anna (19 marzo 1553 – 1 agosto 1553) che morì dopo 135 giorni e nel
1554 Pietro , il 3 giugno, che riuscirà a sopravvivere malgrado la salute
precaria di Donna Eleonora, morendo il
25 aprile 1604 all’età di 49 anni.Il
19 novembre 1557 perdeva la figlia diciasettenne Maria morta a Livorno forse a
causa della malaria.
5.
Maria de’ Medici – Il suo ritratto - Il Mistero sulla sua morte
Nacque
il 3 aprile 1540, nel Palazzo Medici in Via Larga, e fu battezzata all’Opera di
Santa Maria del Fiore con il nome di “Maria et
Lucretia”.
Prese
il nome di entrambe le nonne, Maria Salviati e Maria Pimentel y Osorio.
Per
Cosimo fu il grande amore della sua vita, la sua figlia prediletta che veniva
descritta come la madre Eleonora di Toledo dai contemporanei:
una
"bellezza mozzafiato" o "rara bellezza”
"...
era già così bella nel 1550 che il vescovo Jacopo Cortesi commentò che la
natura aveva fatto di tutto per prodigarle una tale bellezza e fascino da farla
sembrare un angelo ".
Secondo Giorgio Vasari “la Signora Maria .. una ragazza grandissima e veramente bella”. Come la sua bellissima bisnonna, la celebre Caterina Sforza (1463-1509), e suo padre. Maria era “un’amante della vita all’aria aperta”.
Maria da bambina
Artista: Bronzino (Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino)
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 - Firenze, 23 novembre 1572)
Pittura: Olio su
tavola – Datazione: 1545 circa
Misure (58 x 46,5)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
Amava
molto la caccia e i suoi contemporanei riferirono nei loro scritti che non solo era bella ma anche gentile, affascinante,
graziosa, decorosa, umana, elegante, colta e molto intelligente...”...” il
tutore dei bambini avrebbe incaricato maria di aiutare suo fratello
Francesco... quando ha lottato con il suo greco”...”aveva una bella ciocca di
capelli e un viso delicato e pallido”.Il
ritratto di Maria da bambina fino alla prima metà del XX secolo gli fu
correttamente attribuito, nei due libri
di GF Young sui Medici, stampati nel 1909 e nel 1930, c’era un commento su
ritratto di Maria..” sua figlia maggiore (di
Cosimo) Maria... il cui ritratto, all’età di circa dieci anni, del bronzino,
alla Galleria degli Uffizi è ben noto”.Verso
il 1950 il ritratto di Maria de’ Medici fu
ridefinito come ritratto della sorellastra naturale Bianca (Bia).Il
responsabile di questo cambiamento nel nome del ritratto fu lo storico
dell’arte Detlef Heikamps. Lo storico trovò una fonte storica risalente al
1550/51 che affermava come il “maggiore-domo di Cosimo, Pierfrancesco Rccio, chiamò il
pittore di corte Agnolo Bronzino a Pisa nel dicembre 1550 per fare un ritratto
del bambino di sette anno Giovanni de’ Medici,
il futuro cardinale, che dovrebbe essere inviato a papa Giulio III in
dono”.Il
ritratto di Giovanni de’ Medici fu solo il primo di una serie di ritratti dei
figli di Cosimo I ed Eleonora di Toledo che il Bronzino eseguì. Dopo aver terminato il successivo ritratto
della bambina di dieci anni Maria, completato entro il 27 gennaio 1551, il
Bronzino scrisse al maggiore-domo Pierfrancesco Riccio da Pisa.Questa
fonte storica del 1550/51 non riportava descrizione dei ritratti di Giovanni,
Maria, Garzia e Francesco ( sui loro
costumi, sullo sfondo, ecc.) ed esprimeva soltanto come il pittore di corte di corte dei Medici
avesse eseguito i quattro ritratti dei figli di Cosimo nel 1551.. Nessuno ritratto
riportava però la datazione e nel 1955 Detlef Heikamp identificò i questi
ritratti sebbene nessuno fosse datato.Identificò,
come opere realizzate da Agnolo Bronzino nel 1551, i ritratti di:-
Maria
de’ Medici..in realtà raffigura Virginia
de’ Medici (1576/78)
Maria De’ Medici –
Virginia de’ Medici
(3 aprile 1540 –
19 novembre 1557)
(Arista; Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto: olio su
tela ? – Datazione: 1551
Misure (52,5 x 38)
cm
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Detlef Heikamp sostenne come il quadro fosse un
ritratto di Maria de’ Medici mentre in realtà è quadro d’identificazione. La
doppia fila avrebbe un preciso significato come figlia di un secondo
matrimonio. Virginia è l’unica figlia sopravvissuta al secondo matrimonio di
Cosimo I cioè con Camilla Martelli. Indossa un abito che era di moda negli anni
‘70/ ’80 del XVII secolo. A quel tempo la sorellastra Maria era già morta da
almeno 13anni. Nel quadro Virginia avrebbe un’età di circa 8/10 anni e quindi
il quadro fu realizzato tra il 1576 ed il 1578. Il pittore non può essere
Agnolo Bronzino che morì nel 1572. Fu probabilmente uno dei suoi allievi, forse
Alessandro Allori, che a differenza del suo maestro, amava decorare i suoi
ritratti con simboli o oggetti dei Medici.
-
Francesco
de’ Medici all’età di otto - dieci anni e quindi realizzato tra il 1549 /1551
Eleonora di Toledo
con il figlio Francesco I
Artista: Bronzino
Il Bronzino -
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Datazione: 1549
Collocazione:
Museo Nazionale del Palazzo reale, Pisa
- Giovanni de’ Medici (realizzato ..1570/71 circa) ... in realtà si tratta
del figlio naturale di Cosimo I, Giovanni de’ Medici dai caratteristici capelli
ricci. Il ritratto mostra un ragazzo di sette/otto anni
-
Garzia
de’ Medici (1549/59)
Maria morì quando aveva
17 anni e di lei c’è un quadro che la raffigura all’età di circa quindici anni.
Maria de’ Medici e suo fratello Antonio
Artista: Bronzino
-
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Misure (9,95 x 7,6) cm -
Collocazione: National Gallery of Art – Washington
Provenienza:
forse al barone Achille Seillière, Parigi fino al 1873
(probabilmente per eredità a Jeanne Marquerite Seillière,
Principessa di Sagan
In seguito Duchessa de Talleyrand-Perigord – Parigi, dal 1873
al 1896
Venduta nel 1905 a Peter AB Widener, Lynnewood Hall, Elkins
Park, Pennsylvania
(tramite Cottier e Co. Londra e New York ?)
Eredità da Estate di Peter AB Widener per dono tramite potere
di nomina di
Joseph E. Widener, Elkins Park, Pennsylvania
Regalo nel 1942 National
Gallery of Art Washington
Maria de Medici
A sinistra- all’età di cinque anni
A destra – all’età di circa 15 anni
Confrontando i
lineamenti del volto, dei bellissimi occhi, del suo delicato naso e soprattutto
della bocca, molto caratteristica perchè
presenta il labbro superiore più piccolo
rispetto al labbro inferiore, sembrerebbe di trovarsi di fronte alla stessa
persona ripresa in due momenti diversi della sua tragica vita: da bambina e all’età di circa sedici anni.I suoi capelli sono
diventati più scuri durante l’adolescenza.Altro aspetto importante
è legato alla collana che indossa.Una collana che
indossava anche la madre Eleonora di Toledo in uno dei suo ritratti eseguiti dal Bronzino.
Eleonora da Toledo
Artista: Bronzino – 1539
Maria de’ Medici
Nel ritratto originale
Maria de’ Medici era ritratta sa sola e solo dopo la morte del fratello
Antonio, deceduto all’età di quattro anni, fu aggiunto al suo ritratto.
La stessa cosa accadde nel
quadro di Maria Salviati eseguito sempre dal Bronzino. Alla morte della cara
nipotina Bianca avvenuta nel marzo del 1542, la piccola fu aggiunta al quadro
della nonna.
Maria Salviati da solaArtista: BronzinoMaria
de’ Medici era stata promessa in sposa al primogenito del duca Ercole II d’Este
di Ferrara, Alfonso II nel 1554. La ragazza morì di febbre il 19 novembre 1557
nel castello dei Medici di Livorno. Gli storici del tempo
diedero l’immagine di un padre inconsolabile per la morte de3lla ragazza e la
pianse amaramente. La sua morte fu definita come uno degli eventi più tristi
della sua vita. Fino alla sua morte tenne uno dei suoi ritratti nella sua
stanza..
Spesso fissando per ore e ore l’unico quadro sul muro, un ritratto della sua amata figlia Maria
Sulla
vita della principessa si sa molto poco e nella storiografia ci sono due
versioni sulla sua morte all’età di 17 anni: omicidio o morte naturale ?
In
un documento di Francesco Settimanni,
fiorentino e cavaliere di San Sepolcro si legge: “Addì XIX di Novembre 1557, Circa 8 ½ di notte la Sig.ra
Donna Maria primogenita del Duca morì di veleno statole dato per ordine del
Padre e privatamente fu sepolta nella chiesa di San Lorenzo”.È
difficile credere ad una simile storia dopo
quello che ho scritto sul felice rapporto coniugale dei genitori della
ragazza.Il
duca avrebbe fatto uccidere la figlia con il veleno perché fu avvisato, da un
informatore di corte, della sua relazione con un paggio figlio del marchese
Jacopo Malatesta. I due ragazzi erano stati più volti in atteggiamenti amorosi
nelle stanze delle damigelle. Il
padre Cosimo I s’adirò moltissimo perché la ragazza era stata già promessa in
moglie ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara. Per questo motivo diede l’ordine di
somministrare il veleno che le avrebbe procurato la morte le giro di pochi
giorni.Successivamente
avrebbe ordinato anche l’uccisione del paggio che scomparve in pochissimo
tempo.Il
luogo della sepoltura di Maria fu sempre oggetto d’indagine fin dai tempi
antichi e fu Filippo Baldinucci
(Firenze, 1624 – Firenze, 10 gennaio 1696) (storico dell’arte, politico e
pittore) a raccogliere notizie importanti sui depositi della basilica di San
Lorenzo.
Nelle
sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito,
una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
e
nella successiva pubblicazione del 1947 scrisse in maniera più dettagliata
che.....
"La Maria Medici venne sepolta , nell'oratorio del Castello, che dopo
molti anni prese il nome di Chiesa di S. Antonio. Sopra la parete della chiesa
si trovava una lapide che ricordava Maria e ne segnava la sepoltura; ma nel
bombardamento tedesco del 1944 la Chiesa andò distrutta e si è perduta ogni
traccia dell'epigrafe e della tomba".
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora
di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia
che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena
e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7.
la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Maria De’ Medici –
Virginia de’ Medici
(3 aprile 1540 –
19 novembre 1557)
(Arista; Il
Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto: olio su
tela ? – Datazione: 1551
Misure (52,5 x 38)
cm
Collocazione:
Uffizi – Firenze
Detlef Heikamp sostenne come il quadro fosse un ritratto di Maria de’ Medici mentre in realtà è quadro d’identificazione. La doppia fila avrebbe un preciso significato come figlia di un secondo matrimonio. Virginia è l’unica figlia sopravvissuta al secondo matrimonio di Cosimo I cioè con Camilla Martelli. Indossa un abito che era di moda negli anni ‘70/ ’80 del XVII secolo. A quel tempo la sorellastra Maria era già morta da almeno 13anni. Nel quadro Virginia avrebbe un’età di circa 8/10 anni e quindi il quadro fu realizzato tra il 1576 ed il 1578. Il pittore non può essere Agnolo Bronzino che morì nel 1572. Fu probabilmente uno dei suoi allievi, forse Alessandro Allori, che a differenza del suo maestro, amava decorare i suoi ritratti con simboli o oggetti dei Medici.
-
Francesco
de’ Medici all’età di otto - dieci anni e quindi realizzato tra il 1549 /1551
Eleonora di Toledo
con il figlio Francesco I
Artista: Bronzino
Il Bronzino -
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli di
Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Datazione: 1549
Collocazione:
Museo Nazionale del Palazzo reale, Pisa
-
Garzia
de’ Medici (1549/59)
Maria de’ Medici e suo fratello Antonio
Artista: Bronzino
-
Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Misure (9,95 x 7,6) cm -
Collocazione: National Gallery of Art – Washington
Provenienza:
forse al barone Achille Seillière, Parigi fino al 1873
(probabilmente per eredità a Jeanne Marquerite Seillière,
Principessa di Sagan
In seguito Duchessa de Talleyrand-Perigord – Parigi, dal 1873
al 1896
Venduta nel 1905 a Peter AB Widener, Lynnewood Hall, Elkins
Park, Pennsylvania
(tramite Cottier e Co. Londra e New York ?)
Eredità da Estate di Peter AB Widener per dono tramite potere
di nomina di
Joseph E. Widener, Elkins Park, Pennsylvania
Regalo nel 1942 National
Gallery of Art Washington
Maria de Medici
A sinistra- all’età di cinque anni
A destra – all’età di circa 15 anni
Confrontando i
lineamenti del volto, dei bellissimi occhi, del suo delicato naso e soprattutto
della bocca, molto caratteristica perchè
presenta il labbro superiore più piccolo
rispetto al labbro inferiore, sembrerebbe di trovarsi di fronte alla stessa
persona ripresa in due momenti diversi della sua tragica vita: da bambina e all’età di circa sedici anni.I suoi capelli sono
diventati più scuri durante l’adolescenza.Altro aspetto importante
è legato alla collana che indossa.Una collana che
indossava anche la madre Eleonora di Toledo in uno dei suo ritratti eseguiti dal Bronzino.
Eleonora da Toledo
Artista: Bronzino – 1539
Maria de’ Medici
Nel ritratto originale
Maria de’ Medici era ritratta sa sola e solo dopo la morte del fratello
Antonio, deceduto all’età di quattro anni, fu aggiunto al suo ritratto.
La stessa cosa accadde nel
quadro di Maria Salviati eseguito sempre dal Bronzino. Alla morte della cara
nipotina Bianca avvenuta nel marzo del 1542, la piccola fu aggiunta al quadro
della nonna.
Maria Salviati da solaArtista: BronzinoMaria
de’ Medici era stata promessa in sposa al primogenito del duca Ercole II d’Este
di Ferrara, Alfonso II nel 1554. La ragazza morì di febbre il 19 novembre 1557
nel castello dei Medici di Livorno. Gli storici del tempo
diedero l’immagine di un padre inconsolabile per la morte de3lla ragazza e la
pianse amaramente. La sua morte fu definita come uno degli eventi più tristi
della sua vita. Fino alla sua morte tenne uno dei suoi ritratti nella sua
stanza..
Spesso fissando per ore e ore l’unico quadro sul muro, un ritratto della sua amata figlia Maria
Sulla
vita della principessa si sa molto poco e nella storiografia ci sono due
versioni sulla sua morte all’età di 17 anni: omicidio o morte naturale ?
In
un documento di Francesco Settimanni,
fiorentino e cavaliere di San Sepolcro si legge: “Addì XIX di Novembre 1557, Circa 8 ½ di notte la Sig.ra
Donna Maria primogenita del Duca morì di veleno statole dato per ordine del
Padre e privatamente fu sepolta nella chiesa di San Lorenzo”.È
difficile credere ad una simile storia dopo
quello che ho scritto sul felice rapporto coniugale dei genitori della
ragazza.Il
duca avrebbe fatto uccidere la figlia con il veleno perché fu avvisato, da un
informatore di corte, della sua relazione con un paggio figlio del marchese
Jacopo Malatesta. I due ragazzi erano stati più volti in atteggiamenti amorosi
nelle stanze delle damigelle. Il
padre Cosimo I s’adirò moltissimo perché la ragazza era stata già promessa in
moglie ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara. Per questo motivo diede l’ordine di
somministrare il veleno che le avrebbe procurato la morte le giro di pochi
giorni.Successivamente
avrebbe ordinato anche l’uccisione del paggio che scomparve in pochissimo
tempo.Il
luogo della sepoltura di Maria fu sempre oggetto d’indagine fin dai tempi
antichi e fu Filippo Baldinucci
(Firenze, 1624 – Firenze, 10 gennaio 1696) (storico dell’arte, politico e
pittore) a raccogliere notizie importanti sui depositi della basilica di San
Lorenzo.
Nelle
sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito,
una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
e
nella successiva pubblicazione del 1947 scrisse in maniera più dettagliata
che.....
"La Maria Medici venne sepolta , nell'oratorio del Castello, che dopo
molti anni prese il nome di Chiesa di S. Antonio. Sopra la parete della chiesa
si trovava una lapide che ricordava Maria e ne segnava la sepoltura; ma nel
bombardamento tedesco del 1944 la Chiesa andò distrutta e si è perduta ogni
traccia dell'epigrafe e della tomba".
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora
di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia
che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena
e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7.
la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Eleonora da Toledo
Artista: Bronzino – 1539
Maria de’ Medici
Nel ritratto originale
Maria de’ Medici era ritratta sa sola e solo dopo la morte del fratello
Antonio, deceduto all’età di quattro anni, fu aggiunto al suo ritratto.
La stessa cosa accadde nel
quadro di Maria Salviati eseguito sempre dal Bronzino. Alla morte della cara
nipotina Bianca avvenuta nel marzo del 1542, la piccola fu aggiunta al quadro
della nonna.
Maria de’ Medici era stata promessa in sposa al primogenito del duca Ercole II d’Este di Ferrara, Alfonso II nel 1554. La ragazza morì di febbre il 19 novembre 1557 nel castello dei Medici di Livorno. Gli storici del tempo diedero l’immagine di un padre inconsolabile per la morte de3lla ragazza e la pianse amaramente. La sua morte fu definita come uno degli eventi più tristi della sua vita. Fino alla sua morte tenne uno dei suoi ritratti nella sua stanza..
Spesso fissando per ore e ore l’unico quadro sul muro, un ritratto della sua amata figlia Maria
Sulla vita della principessa si sa molto poco e nella storiografia ci sono due versioni sulla sua morte all’età di 17 anni: omicidio o morte naturale ?
In
un documento di Francesco Settimanni,
fiorentino e cavaliere di San Sepolcro si legge: “Addì XIX di Novembre 1557, Circa 8 ½ di notte la Sig.ra
Donna Maria primogenita del Duca morì di veleno statole dato per ordine del
Padre e privatamente fu sepolta nella chiesa di San Lorenzo”.È
difficile credere ad una simile storia dopo
quello che ho scritto sul felice rapporto coniugale dei genitori della
ragazza.Il
duca avrebbe fatto uccidere la figlia con il veleno perché fu avvisato, da un
informatore di corte, della sua relazione con un paggio figlio del marchese
Jacopo Malatesta. I due ragazzi erano stati più volti in atteggiamenti amorosi
nelle stanze delle damigelle. Il
padre Cosimo I s’adirò moltissimo perché la ragazza era stata già promessa in
moglie ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara. Per questo motivo diede l’ordine di
somministrare il veleno che le avrebbe procurato la morte le giro di pochi
giorni.Successivamente
avrebbe ordinato anche l’uccisione del paggio che scomparve in pochissimo
tempo.Il
luogo della sepoltura di Maria fu sempre oggetto d’indagine fin dai tempi
antichi e fu Filippo Baldinucci
(Firenze, 1624 – Firenze, 10 gennaio 1696) (storico dell’arte, politico e
pittore) a raccogliere notizie importanti sui depositi della basilica di San
Lorenzo.
Nelle
sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito,
una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
e
nella successiva pubblicazione del 1947 scrisse in maniera più dettagliata
che.....
"La Maria Medici venne sepolta , nell'oratorio del Castello, che dopo
molti anni prese il nome di Chiesa di S. Antonio. Sopra la parete della chiesa
si trovava una lapide che ricordava Maria e ne segnava la sepoltura; ma nel
bombardamento tedesco del 1944 la Chiesa andò distrutta e si è perduta ogni
traccia dell'epigrafe e della tomba".
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora
di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia
che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena
e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7.
la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Nelle sue ricerche nell’archivio trovò su un documento, del ventiseiesimo deposito, una strana correzione che riportava la scritta:
"1557
Sig(no)ra Ma"
come
se qualcuno avesse modificato la dicitura.Ci
sarebbero altre fonti che darebbero per certa la sepoltura di Maria in San
Lorenzo.Una
fonte si trova in una pagina del “Libro Nero de’ morti” degli Ufficiali di
Grazia, sulla quale compare una scritta con inchiostro nero che recita:
"Signora
Maria fiola dello ill.mo s.re Duca di Firenze rip.a in San L.zo alli
22" la sepoltura di Maria il 22 di novembre nella basilica di san
Lorenzo."
L’altra
fonte si presente nello “Spoglio dei Morti 1501 – 1600” dell’Archivio di San
Lorenzo:
"Ill.ma
S. Vegna Maria di Messere Cosimo de Medici Duca di Firenze morì adì 19 di 9bre
1557"
"
1557 Vegna Maria del Duca Cosimo la primogenita sep.ta quì".
Ma
dove si trova la sepoltura ?Nella
Basilica di San Lorenzo non c’è alcuna traccia della sepoltura di Maria così
come nelle cappelle dei Principi. C’è anche un’altra versione sulla morte e
successiva sepoltura della giovane principessa che fu riportata dallo storico e
profondo conoscitore della storia della famiglia Medici, Guglielmo Enrico Saltini....
"
Intanto la corte in quaresima andossene a Pisa e poi in autunno a Livorno... e
fu appunto in questa città, in sul cadere dell'ottobre, che la principessa
Maria venne sorpresa da una gravissima infermità di febbri, le quali presto si
scopersero petecchiali e senza cadere a rimedio alcuno, prima le tolsero
miseramente la conoscenza e infine la spensero a' 19 di novembre 1557".
Proseguì
nel suo racconto:
"
Il duca, la duchessa e i fratelli la piansero amaramente... Cosimo in que'
giorni della disgrazia, perduta quasi la sua consueta costanza, non sapendo
frenare il cocentissimo affanno, si serrava talora, tutto solo, sopra un
terrazzo del castello (in Livorno) sfogando con un lungo e disperato pianto la
passione del cuore".......
...
" Non si fecero alla principessa Maria solenni esequie, non comportandolo,
secondo il cerimoniale d'allora, la sua giovanile età, ne si recò il suo
cadavere alla capitale (Firenze) per
deporlo in San Lorenzo; ma venne privatamente sepolta in Livorno nell'oratorio
del Castello."
Per
Saltini la principessa fu quindi sepolta a Livorno e un altro studioso
condivise la sua tesi.Gaetano Pieraccini
ne, suo testo del 1924, “La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo” riportò in maniera
sintetica che "La Maria venne sepolta a
Livorno, nell'oratorio del Castello",
In
realtà, secondo altre fonti, nel 1935 fu deciso di demolire la Chiesa di
Sant’Antonio e i relativi lavori iniziarono nel 1942. La guerra diede il colpo
di grazia perché fu completamente distrutta nei bombardamenti.
Lo
storico Pieraccini rimase convinto della sua tesi, relativa alla distruzione
della chiesa nel 1944, e scrisse una lettera al parroco del Duomo di Livorno
invitandolo a trovare conferme per poter confermare la sua tesi. Non si sa se
il parroco rispose alla sua lettera. In
un documento datato 1773 furono citate tutte le sepolture livornesi e non
appare la sepoltura di Maria de’ Medici all’interno della chiesa di
Sant’Antonio e nemmeno della sua lapide. Il seppellimento di una figura così
importante avrebbe dovuto lasciare qualche segno. Neanche i documenti originali
del tempo scritti da Andrea Pagni, segretario di Cosimo I, non svelarono il
mistero.
Ci
sono due lettere inviate dal segretario il 15 e il 17 novembre 1557 da Firenze
a Pisa al diplomatico Bartolomeo Conticini per sapere della condizioni di
salute della ragazza ma non venne citata la città dove si trovava.
Quale
fu la fine della ragazza ? E’ rimasto un mistero che forse non verrà mai svelato....
..Eleonora di Toledo, il 21 aprile 1561, perdeva un’altra figlia, la sedicenne Lucrezia che si era sposata con Alfonso d’Este ed era quindi duchessa di Ferrara, Modena e Reggio. Morì di tubercolosi
Lucrezia
De’ Medici
(14
febbraio 1545; 21 aprile 1561)
Artusta: Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo
Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Dipinto:
Olio su tavola – Datazione: 1560
Misure
?
Collocazione:
North Carolina Museum of Art
6,
Lucrezia De’ Medici
Nel
1557 la pace tra Ercole II d’Este e
Filippo II di Spagna decideva che il principe di Ferrara, Alfonso, avrebbe
dovuto sposare Maria de’ Medici primogenita di Cosimo I de’ medici e di
Eleonora di Toledo. Con la morte di Maria, a causa della malaria (?), fu deciso che il matrimonio sarebbe avvenuto
con la sorella minore Lucrezia. Il principe Alfonso fece il suo ingresso
solenne a Firenze il 18 maggio 1558 e il 3 luglio vennero celebrate le nozze
con Lucrezia in una cappella del Palazzo
Vecchio.
Nel
contratto di matrimonio era presente un importante condizione. La duchessa
Eleonora di Toledo pretese di avere con sè la figlia, ancora non sessualmente
matura data la sue età (tredicenne), fino a quando non sarebbe diventata donna.
Tre giorni dopo le nozze Alfonso lasciò
Firenze e Lucrezia continuò a vivere con la madre e la sorella Isabella a Firenze, isolata
quasi dal resto del mondo.
Alfonso
II d’Este
(Ferrara,
22 novembre 1533 – Ferrara, 27 ottobre 1597)
Artista:
Girolamo da Carpi
(Ferrara,
1501 – Ferrara, 1 agosto 1556)
Pittore
ed architetto
Datazione:
XVI secolo
Pittura:
Olio su tela – Misure ?
Collocazione:
Museo del Prado - Madrid
Alla
morte del duca Ercole II (3 ottobre 1559), Alfonso diventò duca di Ferrara, Modena e Reggio con
il nome di Alfonso II d’este e Lucrezia diventò quindi duchessa consorte. La
giovane donna lasciò la famiglia e il 17 febbraio 1560 fece il suo ingresso
trionfale a Ferrara. Per la giovane
sedicenne si preparava una vita d’isolamento e dopo meno di un anno morì di tubercolosi. Gli
ultimi due mesi furono per la ragazza terribili a causa delle sofferenze che il
male le procurava. A nulla valsero le cure di un medico fiorentino che il padre
Cosimo aveva inviato a Ferrara.
Morì
il 21 aprile 1561 e fu sepolta nel
Monastero del Corpus Domini di Ferrara.
Tomba di Lucrezia
de’ Medici
In
realtà sulla morte della giovane donna circolarono delle voci su un suo
avvelenamento da parte del marito per sposare Barbara d’Austria, un matrimonio
politicamente più prestigioso. La
coppia non aveva avuto figli e il duca si risposò altre due volte per avere un
erede.Nel
1565 sposò infatti l’arciduchessa Barbara d’Asburgo e nel 1579 Margherita
Gonzaga. Non ebbe figli da nessuna moglie e la sua morte decretò la fine del
dominio estense sul Ducato di Ferrara che fu inglobato dallo Stato Pontificio. Lucrezia
appare nella letteratura nel monologo drammatico in versi di Robert Browing “My
Last Duchess” (L’Ultima Duchessa) nella raccolta “Liriche Drammatiche” del
1842 e nel 1845 nella raccolta “Dramatic Romances and Lyrics” (Liriche e
monologhi drammatici)
............................
7. la morte di Eleonora di Toledo e dei suoi figli Giovanni e Garzia
Eleonora
nel 1560 era una donna molto
provata dalla malattia e dai dolori per
le perdite continue dei suoi figli, eppure sempre vicina al marito con forza e
coraggio.
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Il ritratto della
Bottega del Bronzino (1560 circa)
Eleonora
di Toledo
Datazione: 1560/1562
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre
1607)
Pittura: olio su legno di pioppo – Misure (52 x 42) cm
Collocazione: Gemaldegalerie. Berino
Eleonora
di Toledo
Datazione:
1560
Artista;
Bronzino
(Agnolo
di Cosimo, Agnolo Bronzino o “Il Bronzino”
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 – Firenze,
23 novembre 1572
Pittura:
Olio su tavola – Misure (86,4 x 65,1) cm
Collocazione:
National Gallery of Art. Washington
Provenienza
William
Beckford [1760-1844], Fonthill Abbey, Wiltshire e Bath, Inghilterra
Alexander
Hamilton, decimo duca di Hamilton [1767-1852], Hamilton Palace, Strathclyde,
che sposò la figlia di Beckford, Susan Euphenia [m. 1859], probabilmente per
eredità
William
Alexander Anthony Archibald Douglas [1811-1863], 11 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
William
Alexander Louis Stephen Douglas-Hamilton [1845-1895], 12 ° Duca di Hamilton,
Hamilton Palace, Strathclyde, Scozia, suo figlio per eredità
1893
forse l'On. Francis Barry
1906
venduto a (Colnaghi, Londra e New York) per conto congiunto con (M. Knoedler
& Co., Londra e New York)
Thomas
Glen Arthur [1857-1907], Ayr, Strathclyde, Scozia
1910
venduta a Victor G. Fischer, Washington, D.C.
1912
rivenduta a (Colnaghi, Londra e New York), forse per conto congiunto con (M.
Knoedler & Co., Londra e New York)
1926
ceduta a (Conte Alessandro Contini-Bonacossi, Roma e Firenze)
1954:
acquistato da Samuel H. Kress Foundation, New York
Nell’ottobre
1562 seguì Cosimo I in un viaggio verso la Maremma per verificare i lavori
sulla bonifica che lo stesso marito aveva avviato.Dalla
Maremma sarebbero dovuti andare in
Spagna per trovare il figlio primogenito Francesco Maria che da circa un anno
si trovava nel paese iberico.
Francesco Maria De’ Medici
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Livorno - Castello
di Rosignano
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Eleonora
soffriva da tempo di emorragie polmonari e i medici le avevano consigliato di
passare l’inverno in un centro costiero con un clima mite.
Eleonora
e Cosimo I si recarono in Maremma con i
loro tre figli: Giovanni, Garzia e Ferdinando. Un viaggio pericoloso perché la
zona era colpita dalla malaria.
Durante
una sosta nel castello di Rosignano avvenne l’incredibile… il destino avverso.
Durante
la breve sosta nel castello di Rosignano,
Giovanni e Garzia si sentirono male e
furono colpiti da forti febbri.Giovanni
(diciannovenne) morì dopo qualche
settimana.

Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese
il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto
di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella
caccia, musica e collezionare antichità.
Amavano trascorrere più tempo
possibile insieme. Nella
nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato
alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e
arcivescovo di Pisa nel 1561. I
suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di
buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci
sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette
anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il
bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica
rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare
la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe
quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Giovanni De’
Medici
(28/29 settembre
1543; 20 novembre 1562)
(Cardinale di
Santa Romana Chiesa,
Nominato il 31
gennaio 1560 da papa Pio IV)
Giovanni
prese il nome del nonno paterno Giovanni delle Bande Nere. Era il fratello prediletto di Isabella de’ Medici dato che avevano anche gli stessi interessi nella caccia, musica e collezionare antichità. Amavano trascorrere più tempo possibile insieme. Nella nobiltà del tempo era consuetudine come il figlio secondogenito fosse destinato alla carriera ecclesiastica diventò sacerdote nel 1550, cardinale nel 1560 e arcivescovo di Pisa nel 1561. I suoi contemporanei lo descrivevano come “bello con begli occhi, gentile, di buon carattere, allegro, socievole, giocoso e amante del divertimento. Ci sono almeno tre ritratti che lo raffigurano all’età di circa due anni, di sette anni e all’età di 17 o 18 anni quando era già cardinale.
Giovanni con la
madre Eleonora di Toledo
Artista: Bronzino
Datazione: 1545 -
Galleria degli Uffizi, Firenze
Il bambino è senza dubbio il secondogenito di Cosimo, Giovanni. La fonte storica rinvenuta dalla dott.ssa Luisa Becherucci nel 1944 gli permise di fare avanzare la tesi secondo la quale la figura di Giovanni, posto accanto alla madre, sarebbe quella del bambino ritratto nel dipinto che segue.
In
realtà il bambino, raffigurato con un cardellino in mano e disegnato dal
Bronzino,non
sarebbe né Giovanni e nemmeno Garcia, ma Antonio, figlio sempre di Cosimo I ed
Eleonora di Toledo. Un quadro eseguito verso il 1546.La
fonte storica sarebbe legata ad una lettera mandata da Pierfrancesco Riccio,
maggiore domo di Cosimo I, a Lorenzo Pagni all’inizio di maggio 1545: Il
Bronzino ha perfettamente terminato il ritratto del principe Giovanni ed è
veramente realistico. Questa
falsa attribuzione del bambino, con il cardellino in mano, a Giovanni fu legata
anche ad un'altra fonte storica dove un
certo Cristiano Pagni, forse parente del precedente Lorenzo, scrisse al
maggiore domo Pierfrancesco Riccio il 28 agosto 1545:Sono
pieno di stupore e di estasi ogni volta che mi capita di contemplare il Signore
Giovanni, quella sua somiglianza allegra, soave e regale, e bel volto; quindi
quanto deve essere più grande il vostro piacere, signore, che così spesso può
vederlo e festeggiarlo.In
nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al
bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che
addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti
gli storici erano concordi con
l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò
la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia,
fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio
(1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
In nessuna delle due fonti storiche si fa menzione del cardellino in mano al bambino, magistralmente dipinto dal Bronzino, e del suo ampio sorriso che addirittura fa vedere i due dentini nella mascella inferiore. Infatti non tutti gli storici erano concordi con l’identificare le due figure a quella di Giovanni. Negli ultimi anni s’avanzò la tesi secondo la quale il bambino, con il cardellino in mano, fosse Garzia, fratello minore di Giovanni mentre in realtà si tratta del fratello Antonio (1544 – 1548).
Cardinale Giovanni
de’ Medici
Datazione: 1560/62
Firenze: Palazzo
Pitti
Questo
ritratto fu realizzato tra il 1560 e il 1562 quando don Giovanni era già
cardinale.
Per
oltre quattro secoli questo dipinto fu considerato un ritratto di Giovanni de’
Medici.
Oggi,
invece, il soggetto è erroneamente
indentificato con Camillo Pamphilj,
nominato cardinale nel 1644. La nuova identificazione fu legata ad un errata
attribuzione del dipinto a
Justus
Suttermans, vissuto dal 1597 al 1681. L’artista nacque ben 37 anni dopo la
morte del cardinale Giovanni e quindi non potè eseguire un quadro tra il 15560
ed il 1562. I numerosi ritratti dei vari cardinali eseguiti nel XVI secolo si
nota come siano seduti su una sedia sempre diversa. Nessuna ha usato la sedia
di un altro cardinale nel proprio ritratto, ad eccezione del cardinale Giovanni
de’ Medici.
Il
cugino del cardinale Giovanni de’ Medici, Cardinale Carlo de’ Medici (1596 –
1666), terzo figlio di Ferdinando I (fratello di Giovanni de’ Medici), sedeva
sulla stessa sedia quando i pittori di corte dei medici lo raffigurarono.
Cardinale Carlo de’ Medici
Justus Sustermans
Datazione: 1630
Firenze, Palazzo
Pitti, Galleria Palatina
Lo
stretto rapporto familiare tra i due cardinali sarebbe quindi legato alla
presenza della stessa sedia quindi il soggetto rappresentato del dipinto
sarebbe proprio Giovanni de’ Medici.Il
20 novembre 1562 Giovanni or’ quindi di febbre malarica tra le braccia del
padre Cosimo I a Livorno. Aveva solo 19 anni.Il
padre mandò una lettera al figlio maggiore Francesco I, scritta proprio nello
stesso giorno della morte del figlio:"Nella
prima di queste [lettere], datato 20 ° novembre 1562, egli
[Cosimo I] dice a suo figlio [Francesco] che il 15 °Giovanni
era stato assalito da febbre maligna a Rosignano, che si erano prontamente
trasferiti di lì a Livorno [Livorno], ma che peggiorò, ed era morto lì alla
data della lettera; che anche Garzia e Ferdinando avevano la febbre, ma
meno grave, e che il giorno dopo li avrebbe portati a Pisa, dove si sperava si
riprendessero; e che questo tipo di febbre eccezionalmente maligno era
molto grave in tutta la parte del paese che stavano attraversando”Eleonora
fu colpita da una struggente disperazione e anche lei s’ammalò e morì, dopo
circa un mese, a Pisa… aveva 42 anni. I
medici le avevano consigliato di stare lontana dalle zone colpite dalla malaria.
Tra le patologie anche quella dovuta ad una forte carenza di calcio.Era
il 17 dicembre 1562 e in punto di morte, per non farla soffrire, le fu nascosta
l’avvenuta morte del figlio Garzia (quindicenne) scomparso sei giorni prima. La
duchessa fu sepolta nella cappella Medicea della Basilica di San Lorenzo.
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito
molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza
maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente
non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto
realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo
Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................
Abito funebre di
Eleonora di Toledo
Fu rinvenuto nel 1947 quando furono aperte le
tombe medicee
Per le ricerche
scientifiche di Gaetano Pieraccini (?)
Un abito
semplice senza decorazioni..
Desidero dare un
ulteriore immagine su quest’ anima che s’intendeva
di politica;
madre severa e
molto affettuosa e soprattutto amata.
La stilistica
americana in un intervista sulla moda, disse molti secoli la morte di Eleonora:
La moda è la maniera di dire
chi sei senza dover parlare.
Uno con corpetto e gonna in raso bianco con fascia
marrone velluto sfondato ricamato in oro e argento con sottile treccia d’oro.
Fu
consegnato nell’agosto del 1562, quattro mesi circa prima della sua morte.
Non fu
riportato nell’elenco dell’inventario eseguito dopo la morte di Eleonora ed
È quindi
probabile che quest’abito sia stato proprio destinato in ambito funebre.
Eleonora
di Toledo –
Olio su
Tavola – 1556 – Museo Bardini - Firenze
L'abito è
realizzato in raso di seta bianco o giallo chiaro con velluto marrone e
finiture metalliche. Il rivestimento è sopravvissuto ai secoli molto
meglio della fragile seta e ha preservato le linee stilistiche del
capo. Il corpetto sembra essere senza maniche in quanto non sono state
trovate maniche quando l'abito è stato recuperato dalla tomba. Il
corpetto, che si presenta come completamente separato dalla gonna, allaccia in
due file lungo la schiena tramite occhielli originariamente rinforzati con
anelli di rame (che si sono disintegrati).
L'immagine sopra raffigura Eleonora in un abito molto simile a quello in cui fu sepolta. Così simile, essendo forse anche senza maniche, che si potrebbe mettere in dubbio la data del 1556 e che fosse lo stesso vestito. Ovviamente non lo sapremo mai, forse ha semplicemente preferito lo stile e ha fatto realizzare diversi abiti simili.
Il disegno dell’abito realizzato da Janet Arnold
Nel quadro
che la raffigura con il figlio Francesco I, opera del grande artista Bronzino,
presenta
un eleganza lontana dall’eccesso. Il suo abito evidenzia una raffinata
ricercatezza del tessuto prezioso e accuratamente lavorato. Il tutto naturalmente
accompagno da gioielli di grande fattura e da un acconciatura rigorosa che le
incorniciano il suo bellissimo volto illuminato dagli splendidi occhi.
Museo Palazzo Reale – Pisa
Questo abito fu confezionato in velluto rosso tagliato
unito ad un corpo in seta e si trova
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Pisa. Il busto ha una scollatura
squadrata alta che avvolge le spalle con delle bretelle sottili, la
passamaneria divide lo spazio simmetricamente in due con una decorazione a
fascia formata da cordoncini rossi e in oro filato che guidano lo sguardo
rapidamente, ma non distrattamente, dalla parte centrale attraverso la
lunghezza della gonna, accompagnandolo al termine di questa e
proseguendo in una corsa lungo tutto il diametro per poi
restituire la stessa simmetria sul retro. Le lunghe
maniche sagomano il naturale andamento delle braccia, larghe sulle
spalle e più strette ai polsi, qui si chiudono con un bottone piccolo e un
asola in cordella. L’andamento decorativo longitudinale della manica divide la
superfice in quattro parti ognuna delle quali divisa nuovamente a metà da
dodici piccoli tagli. La manica, così riccamente
decorata, presenta piccoli anelli in passamaneria nella parte alta che
“crestano” elegantemente le spalle e accompagnano le cordelle in seta che si
legano alle esili spalline. La gonna è arricciata
all’altezza della vita e sagomata a punta sul davanti si divide poi in quattro
teli con gheroni (stoffe triangolari ai lati che servono per aumentare
l’ampiezza). Questa presenta un leggero strascico che era stato ripiegato
all’interno durante il periodo in cui l’abito fu utilizzato come vestimento per la statua dell’Annunziata previa
donazione della duchessa Eleonora. L’indumento infatti proviene dal convento pisano di San Matteo, contiguo al palazzo in cui
Cosimo e la Granduchessa soggiornavano per lunghi periodi, soprattutto
d’inverno, approfittando del clima mite di Pisa.
L’abito nel ritratto è parzialmente coperto dalla
classica giacca spagnola che la figlia del viceré tanto amava indossare:
la zimarra, questo però non nasconde alla vista la
somiglianza tra i due vestiti. Il dilemma su cui
concentrarci, però, è un altro:
quest’abito è realmente appartenuto ad Eleonora di Toledo ?
La studiosa del costume Thessy Schoenholzer Nicholson ha
notato una forte somiglianza con un altro vestito
di Eleonora: l’abito funebre della Granduchessa. Il
confronto è tra le due sottane che
risultano simili nella forma, nella guarnizione del busto e nel taglio della
gonna stessa. Purtroppo nei documenti che
descrivono il guardaroba della moglie di Cosimo, sebbene non manchino abiti
rossi cremisi, non c’è una descrizione adeguata che ci riconduca direttamente
al nostro abito. Una probabilità da non sottovalutare è che questo possa essere
il vestito di una delle sue tredici dame. La
Granduchessa Eleonora infatti, durante i viaggi cerimoniali a Siena e a Roma,
nel 1560 portò con se le sue dame abbigliate con sottane
rosso cremisi. Queste vesti uscirono dalla bottega di mastro Agostino che era solito utilizzare le
stesse tecniche sartoriali per tutti i capi femminili importanti di corte. Se
questo abito sia stato indossato da lei in persona o da una delle sue dame poco
importa, ma ciò che è realmente importante è il documento che
fornisce ai contemporanei sulla moda del tempo.
............................................
Garzia
(Garcia)Garzia
nacque il 5 luglio 1547 e prese il nome da un fratello della madre Eleonora da
Toledo, Garzia di Toledo (1514 – 1577).Il
bambino era il figlio prediletto di Eleonora
Garzia de’ Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1549/50
Collocazione: Palazzo Mansi – Lucca
Un
vecchio cronista riportò: Lo amava come i suoi
occhi
Secondo
una consuetudine in vigore nel XVI secolo, Garzia essendo figlio minore di
Cosimo I era destinato alla carriera militare. Nell’ottobre del 1560 papa Pio
IV gli conferì il titolo di Comandante della Flotta Pontificia. Garzia diventò,
come suo fratello maggiore Giovanni e sua madre Eleonora di Toledo, vittima
dell’epidemia di febbre malarica che imperversò in tutta Italia per l’anno
l’autunno e l’inverno del 1562. Gli
ultimi giorni di vita del giovane e sfortunato Garzia furono descritti in una
lettera che il padre inviò al figlio maggiore Francesco I
Questa
è seguita da una seconda lettera da Cosimo al figlio maggiore, datato
18 ° di dicembre [1562], scritto in mezzo a tutto il dolore per la
morte di quel giorno di sua moglie Eleonora 62 , in cui ha racconta
Francesco [Francesco] che la febbre di Garzia era aumentato dopo il loro arrivo
a Pisa, che, dopo una grave malattia di ventuno giorni era morto il
12 °Dicembre, e che sua madre, stremata dai suoi sforzi per allattarlo
mentre lei era anche lei malata, era morta sei giorni dopo ...
Don Giovanni e
Garzia de’ Medici (?)
Artista: Giorgio
Vasari
Affresco -
Datazione: 1556/1558
Misure (90 x 70) cm
- Comune di Firenze
Garzia de’ Medici
(?)
Artista: Adriaen
Haelwegh
Datazione: prima
1691
Incisione su carta
vegetale – Misure (35,3 x 37,1) cm
Abiti Funebri di
Don Garzia de’ Medici
Giubbone con Braconi
Manifattura
Fiorentina
Datazione: 1562 –
Museo: Palazzo Pitti, Firenze
Collezione: Museo
della Moda e del Costume
Garzia venne
sepolto nelle Cappelle Medicee nella basilica di S. Lorenzo.
Nel 1857 venne
compiuta una prima ricognizione delle salme dei
Medici e fu quindi
redatta una relazione che descriveva lo stato della di
Don Garzia:
“[...]
Il cadavere dell’infelice giovanetto trovammo ridotto in ossa, con un berretto
di velluto sul teschio. È vestito di un giubbetto di raso rosso ornato di piccole
righe fatte con filo d’oro, e su quello ha una sopraveste con maniche, composta
della medesima stoffa e ornata di velluto dello stesso colore. I calzoni sono
fatti secondo il costume spagnolo, ma le strisce, che un dì furono legate
insieme, vi pendono scucite […]”
Quanto descritto,
insieme agli abiti di Cosimo ed Eleonora, giunse nel 1983 alla Galleria del
Costume come un indistinto ammasso di tessuti informi e divenne oggetto di un
complesso intervento di restauro.
Il giubbone in
raso cremisi, con guarnizioni in cordoncino dorato e accenno d’imbottitura
sull’addome, insieme ai calzoni di velluto, hanno consentito di ricostruire
l’abito in forma tridimensionale. Così come l‘intervento di restauro del cappotto, dal collo montante
con le grandi maniche aperte verso l’interno, ha permesso il recupero del prezioso
tessuto in damasco. Il cappotto è guarnito da una doppia banda in velluto con
tagli decorativi. L’abito era corredato anche da un berretto in velluto nero.
...........................................................Il
solo Ferdinando si salvò diventando successivamente prima cardinale e poi
granduca.
Ferdinando
de Medici (da bambino)(?)
(Artista:
Il Bronzino- 1503/1572
Pittura:
Olio su latta – Datazione: 1555/1565
Misure
(15 x 12) cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
8.
La Discendenza
Nel
corso degli anni, gli avversari esuli fiorentini di Cosimo I De’ Medici diffusero un racconto secondo la quale Garzia
avrebbe pugnalato il fratello Giovanni durante una battuta di caccia. Il padre
Cosimo, venuto a conoscenza dell’accaduto, avrebbe pugnalato ed ucciso in preda
all’ira GarziaLa
madre Eleonora, venuta a conoscenza del duplice e terribile omicidio, sarebbe
morta dal dolore. Un dolore terribile anche per la morte, avvenuta poco prima,
della figlia Lucrezia.Molti
documenti, tra cui alcune lettere private di Cosimo I al figlio Francesco
Maria, provano l’avvenuta morte di Eleonora e dei suoi figli a causa della
malaria. Anche lo studio paleopatologico
dei resti scheletrici di Eleonora, Garzia e Giovanni, effettuati nel corso del
“Progetto Medici” nel 2004-2006 dimostrarono la morte per malaria perniciosa da
“Plasmodium falciparum”.La
discendenza quindi non fu molto fortunata. Maria (1557), Giovanni (1562) e
Garzia (1562), tutti giovanissimi morirono di febbri malariche; Pedricco, Antonio ed Anna, morirono
ancora in fasce. Morti misteriose invece per la figlia Lucrezia, sedicenne,
anche se le notizie parlarono di un decesso causato dalla
tubercolosi e del figlio primogenito
Francesco I.Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
(ariista: Bronzino)
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Francesco
I de’ Medici
La
vita di Francesco I fu molto complessa. Il suo nome sarebbe legato ad un voto
fatto da Eleonora di Toledo in occasione di un pellegrinaggio al santuario
Francescano della Verna.
Santuario della
Verna
Chiusi della Verna
– Arezzo
Francesco I de’
Medici, giovinetto
(Artista: Bronzino
– v.s.
Ritratto – Tempera
su tavola – Datazione: 1551
Misure: (58,5 x
41,5) cm
Collezione: Uffizi
– Firenze
Francesco I de
Medici
Artista: Bronzino
Datazione: 1556/57
Collocazione:
Uffizi Firenze
Dal
1564 fu reggente del Granducato di Firenze al posto del padre Cosimo I.Il
18 dicembre 1565 sposò Giovanna d’Austria (1548-1578), figlia di Ferdinando I
d’Asburgo. Dopo la morte della moglie si risposò con Bianca Cappello nel 1579.La
coppia ebbe un figlio, Antonio (20 agosto 1576 – 2 maggio 1621). Secondo alcune
fonti Antonio fu invece adottato dalla coppia.
Il figlio fu osteggiato da suoi familiari e venne escluso dalla
successione. La granduchessa Cappello fu sempre non accettata dalla corte e
anche dal fratello di Francesco I, il cardinale Ferdinando I de Medici.L’improvvisa
morte della coppia, a distanza di appena un giorno l’uno dall’altra, fece
subito pensare per lungo tempo ad un possibile avvelenamento che sarebbe stato
ordinato dal cardinale Ferdinando. Le cronache del tempo parlarono invece di
cause legate ad una “malattia fulminante”.Entrami
morirono a Poggio a Caiano; Francesco I il 19 ottobre 1587 e Bianca Cappello il
20 ottobre 1587. Francesco
I, come il padre Cosimo I, non era favorevole al dispotismo e rispetto al padre
non seppe mantenere l’indipendenza del Granducato di Firenze. Agì sempre come
un vassallo del suocero Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano
Impero.Impaurito
dalla congiura di Orazio Pucci, Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini
avvenuta nl 1575, fu spietato con i rivoltosi e anche con chi dava loro degli
appoggi.Riuscì
ad architettare l’omicidio di due donne
di casa Medici che avevano rapporti col il partito antimediceo: la sorella
Isabella de’ Medici e la cognata Leonora Alvarez de Toledo che furono uccise
dai rispettivi mariti a distanza di meno
di una settimana l’una dall’altra e in circostanze molto simili.
Leonora
Alvarez de Toledo y Colonna, detta Dianora
(Firenze,
1552; Firenze, 9 luglio 1576)
Moglie
di Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora de Toledo.
Venne
strangolata dal marito per gelosia.
(Ritratto
– Arista. Scuola di Alessandro Allori, 1535/1607
Pittura
– datazione: 1571/1576
Collezione
– Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo
Era figlia di
Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, fratello di Eleonora di Toledo, e di
Vittoria di
Ascanio Colonna. Si sposò nel 1571 con Pietro de’ Medici che
era suo cugino da
parte di madre. Pietro aveva un carattere violento e amava
la compagnia di
donne di malaffare. Aveva avuto due figli naturali in Spagna,
da Antonia
Caravajal e Maria della Ribera (?),
dove era stato
inviato come ambasciatore.
Don Pietro de’
Medici
Artista: Scuola
Alessandro Allori (XVI secolo)
Trascurava spesso
la moglie che finì nel trovare come confidente
Bernardo Antinori
esponente di una nobile famiglia fiorentina.
Iniziò tra i due
una lunga relazione ma furono traditi da alcune lettere
intercettate. Venuto a conoscenza della storia, Pietro ebbe
una violenta
reazione e decise
di liberarsi della moglie che era un ostacolo alla sua
vita dissoluta e
motivo di infamia. Scelse un modo brutale per uccidere
la moglie. Rimasto
solo nella Villa di Cafaggiolo, in un momento lontano
da occhi
indiscreti, soffocò la moglie con un “asciugatoio” come
riportano i documenti
dell’epoca. La coppia aveva avuto un figlio, Cosimo,
che morì di
malattia un mese dopo l’uccisione della madre, nell’agosto del 1576
aveva tre anni.
L’Antinori morì in
prigione dopo essere stato arrestato con un
pretesto
qualsiasi.
Villa di Cafaggiolo
Barberino di
Mugello (Firenze)
Altre fonti citano
che Leonor fu uccisa dal marito con numerose pugnalate e che
l’Antinori fu
decapitato nel cortile del Bargello.
Dopo il delitto il
cadavere della donna fu portato a Firenze e sepolto in gran
segreto nella
Cappella Medicea di san Lorenzo.
Resta il dato che
il fantasma di Diadora, sfortunata donna innamorata,
aleggia tra le
stanze della villa, aprendo porte che prima erano chiuse,
facendo suonare
campanelli a cui sono stati tagliati i fili…..
………………..
10.
ISABELLA DE’ MEDICI
Isabella
de’ Medici (da bambina)
Artista:
Il Bronzino - Agnolo di Cosimo / Agnolo Bronzino
Monticelli
di Firenze, 17 novembre 1503 ; Firenze, 23 novembre 1572
Pittura:
olio su Tavola – Datazione: ?
Misura(
44 x 36) cm – Collocazione: Museo Nazionale di Stoccolma
Isabella Romola
de’ Medici
Figlia di Cosimo I
de’ Medici e di Eleonora di Toledo
(Firenze, 31
agosto 1542; Cerreto Guidi, 16 luglio 1576)
(Ritratto –
Artista: Alessandro Allari, 1535/1607;
Olio su tavola;
Datazione: 1550 -1555
Misure: (99 x 70)
cm – Collocazione: Uffizi – Firenze
La
sua nascita venne accolta con grade gioia da parte di Cosimo I e di Eleonora.
Terzogenita, ebbe un infanzia a Firenze
a Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Nel 1553, a soli undici anni, i suoi
genitori stipularono per lei un contratto di nozze a Roma con Paolo Giordano I
Orsini, duca di Bracciano e membro della famosa famiglia Orsini.
Una
donna colta, intelligente, capace di conquistare il cuore di tutti e per questo
alla morte della madre Eleonora, fu lei a sostituirla negli affari di corte con
il sostegno del padre Cosimo I che riponeva in lei la massima fiducia.
Parlava
correttamente diverse lingue, amava la poesia e la musica.
Nel
1556 sposò all’età di quattordici anni il quindicenne Paolo Giordano I Orsini.
Un “matrimonium o sponsalia” secondo le
antiche consuetudini che vigevano prima del Concilio di Trento.
(Lo
sponsalia si attuava attraverso lo “sponsio” cioè un atto formale per mezzo del
quale il pater familias prometteva il proprio figlio/a in marito/moglie. Gli
sponsalia si svolgevano in presenza degli amici
e dei familiari dei due fidanzati che svolgevano la funzione di
testimoni dell’impegno matrimoniale. Quest'ultimo era preso secondo le forme
della stipulatio, in base alla quale sia il pater della donna sia il fidanzato
s'impegnavano a garantire il compimento delle nozze. Presi gli accordi
giuridici, c'era la consuetudine - ma non era un atto necessario - che i due
fidanzati si scambiassero un bacio casto, che non offendeva le antiche
tradizioni. In tal caso la cerimonia degli sponsalia era
definita “osculo interveniente”. Seguiva, quindi, lo scambio dei doni -
solitamente arredi ed abbigliamento - che costituivano il "pegno"
delle future nozze, dopodiché l'uomo regalava alla fidanzata un anello,
l'anulus pronubus sul quale vi sono diverse testimonianze. Quest'
anello, infatti, non era un semplice regalo, bensì svolgeva una funzione
simbolica ben precisa. Era una sorta di "catena" simbolica attraverso
cui lo sposo legava a sé la sposa, rivendicandone il pieno possesso. Di
conseguenza, una volta infilato l'anulus al dito, la ragazza manifestava
concretamente il suo impegno a rispettare il patto di fedeltà nei confronti del
fidanzato. Non è un caso, infatti, che l'anulus fosse infilato al penultimo
dito della mano sinistra, detto appunto anularius, da cui si credeva
partisse una vena che giungeva dritta al cuore. Inizialmente, come ricorda
anche Plinio il Vecchio, l'anulus doveva essere un semplicissimo cerchietto
di ferro e solo in seguito fu realizzato in oro. Dopo aver firmato il
contratto nuziale, nel quale erano stabiliti la natura e l'ammontare della dote
della sposa, e fissata la data delle nozze, la cerimonia
degli sponsalia giungeva al suo termine. Seguiva, quindi, un banchetto
al quale partecipavano tutti i presenti.
La
cerimonia solenne (solemnitas nuptiarum) fu celebrata nel 1558
Paolo Giordano I Orsini
(Artista: Autore
anonimo
Olio su tela :
Datazione; 1560
Collocazione
(Castello Orsini – Odelaschi – Bracciano)
Castello Orsini – Sala delle Armi
Paolo
Giordano Orsini (Bracciano, 1 gennaio
1541 – Salò, 13 novembre 1585)
era figlio di
Girolamo e Francesca Sforza. Era nipote di Felice della Rovere, figlia
naturale di papa Giulio
I; di Gian Giordano Orsini; di Bosio Sforza e di Costanza
farnese, figlia
naturale di papa Paolo III. Dopo una condanna dello zio Francesco, i beni
degli Orsini
furono devoluti a Paolo Giordano I.
Nel
1558, lei quindicenne e l’Orsini
diciasettenne, si sposarono.In
realtà Isabella non lascerà mai Firenze a causa dei tanti impegni politici,
delle esigenze della corte medicea, dei problemi di salute e di diversi
contrattempi, legati al comportamento del marito Tutti fattori che si
susseguirono negli anni.Aveva
un carattere differente rispetto alla
madre perché molto più spigliata, disinvolta e per questo comportamento fu
molto “chiaccherata”. S’era
legata ad un uomo, principe di Bracciano appartenente alla grande casata degli “Orsino”
(la stessa famiglia che diede i natali a Clarice Orsini moglie di Lorenzo il Magnifico) che la critica storica definì
come impulsivo, cinico, spendaccione. Fu
trascurata a causa delle lunghe assenze del marito legate ai viaggi e “sorvegliata” da Troilo Orsini, cugino del
marito.A
quanto sembra esiste un carteggio in cui la stessa Isabella rivelò rapporti più
che affettuosi tra i due in quali non perdevano un’occasione per stare vicini.Quando
Isabella e Paolo G. Orsini si sposarono, dovettero subito affrontare dei gravi problemi economici.Tutte
le spese associate al mantenimento di Palazzo Medici (cavalli, cani, domestici,
ecc.) ricadevano sotto la responsabilità di Paolo Giordano.Ma
dove abitava la coppia dato che i de’ Medici avevano molte proprietà immobiliari
sia a Firenze che fuori ?L’Orsini
trascorreva solo alcuni periodi dell’anno a Firenze e nel 1536 la coppia decise
d’insediarsi in una residenza a loro riservata, separata dal resto della
famiglia.La
costruzione dei nuovi Uffizi aveva reso disponibile una proprietà di grande
prestigio, il Palazzo Medici di Via Larga, che aveva fino allora ospitato
alcuni uffici del nuovo stabile.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Firenze – Palazzo
Medici (Riccardi)
Alla seconda metà
del Cinquecento Giovanni Stradano
(Bruges, 1523 –
Firenze, 22 febbraio 1605) vide il palazzo riportandolo nella sua litografia.
La strada si chiamava “Via Larga” ed era molto affollata da fiorentini
e forestieri
per vedere la contesa equestre della
Giostra del Saracino.
Corsa che veniva
ancora eseguita a Firenze attorno al 1900 nella
Piazza Santa Maria
Novella. Il Palazzo nella seconda metà del Seicento
venne venduto dal
Granduca Ferdinando II, che risiedeva nel
Palazzo Pitti, ad una
ricca famiglia di
banchieri, i Riccardi. Famiglia che aveva reso al
granduca degli
importanti servizi pubblici tanto da ricevere il titolo di marchesi.
Il fedele marchese
Gabriello Riccardi acquistò per la somma di 40.000 scudi
il palazzo che
prese il nome del nuovo proprietario.
Malgrado
la sua presenza irregolare a Firenze, l’Orsini fu favorevole al desiderio di
Isabella di stabilirsi a Palazzo Medici. Una residenza separata dai familiari
avrebbe permesso all’Orsini di essere indipendente dal suocero e cercò quindi
di fare il possibile per ottenere quel privilegio. Le proprietà immobiliari
entro le mura erano sempre ambite a causa delle esigue dimensioni del centro
cittadino. Persino le persone importanti
potevano essere costrette a condividere una stanza con altri e c’erano decine di
ambasciatori, funzionari e dignitari stranieri che erano disposti a pagare a
caro prezzo, anche con mezzi diversi dal denaro, per occupare il vecchio
palazzo mediceo. L’Orsini sollecitò con insistenza Cosimo I che, a quanto
sembra, non aveva però alcuna fretta di prendere una decisione. Deluso, si
rivolse al cognato Giovanni, prima che morisse, dal quale non ebbe molto aiuto.
Il cardinale Giovanni scrisse a Giannozzo Cepparello, agente che Cosimo I de’
Medici aveva incaricato di agire per conto di Paolo Orsini a Firenze:Noi
abbiamo parlato al Signor Duca nostro padre della casa vecchiadi
Via Larga, che il Signor Paolo desidererebbe per alloggiamento disua
famiglia, et parimente delle stanze in Palazzo per la persona sua.Sua
Ecc. ci ha risposto averli fatto intendere per sue lettere, quantooccorre
così nell’uno, come nell’altro caso. Però Noi abbiamoda
dirvene altro, rimettendoci a quanto Sua Ecc. possa aver ordinato”.Giovanni
non era particolarmente ansioso che il padre cedesse al cognato una residenza
così ambita e destinata a diventare una base fiorentina dove la cara sorella
avrebbe dovuto risiedere allontanandosi da lui.Cosimo
I finì con assecondare la richiesta dell’Orsini e permise quindi che il vecchio
palazzo fosse riservato alla coppia.All’indomani
della morte del fratello Giovanni, Isabella era molto interessata alla
disponibilità di disporre di una residenza privata. Prima desiderava sempre
stare vicino al fratello a cui era
particolarmente affezionata.Il
Palazzo Medici diventò quindi il palazzo di Isabella soprattutto durante le
lunghe assenze del marito. Affascinata dal prestigio del vecchio palazzo era
per lei anche un ponte privilegiato con il passato perchè gli permetteva di avere sempre
contatti con il suo passato, con i suoi cari..
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
La
coppia prese possesso non solo del palazzo Medici ma anche del vicino Palazzo Antinori. La famiglia
Antinori era alleata ai Medici e aveva
creato la propria residenza seguendo il modello architettonico del palazzo dei
vicini.
Una
porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I
Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con
sé.
Le
spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori
erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di
contabilità
Il
compito della contabilità era affidato a Gian Battista Capponi, la cui famiglia
era una sostenitrice di Isabella de’ Medici.
Nei libri vi erano riportate una miriade di spese come le migliorie alle
strutture del Palazzo, “amigliorando del Palazzo Medici”, in merito anche alla stuccatura ed
all’imbiancatura delle stanze personali di Isabella che erano contigue al
cortile e al giardino del palazzo.
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Firenze – Palazzo
Medici Riccardi
Una porzione considerevole del Palazzo Antinori fu affittata a Paolo Giordano I Orsini per permettere l’alloggio della sua servitù che regolarmente portava con sé.
Le spese, sia per il mantenimento di Palazzo de’ Medici sia per Palazzo Antinori erano coperte dall’Orsini anche quando si trovava fuori città.
La
relativa contabilità veniva registrata nei “Libri di entrate ed uscite”
con il sistema a partita doppia che i banchieri di famiglia avevano diffuso un
secolo prima.
Simone Crisogono
“”Mercante
arricchito del perfetto quaderniere,
ovvero Specio
Lucidissimo, nel quale si scopre ogni questione,
che desiderar si
possa per imparare perfettamente a tenere
libro doppio –
1664
Libri di contabilità
Palazzo Medici Riccardi - Giardino
Sempre
sotto la stessa voce furono riportati i pagamenti di Alberto Fiorentino, natapharo…
un esperto pulitore di pozzi che fu ingaggiato per pulire il pozzo della cucina
dove era caduto un gatto.Altre
spese riguardavano la fornitura d’acqua documentate dalle botti che erano
portate con regolarità dall’Arno per il bagno di Isabella.C’è
anche una spesa per Francesco della Camilla,
scultore … incaricato di rimettere in funzione le fontane del
giardino del Palazzo.Quando
la coppia si trasferì nel Palazzo dovettero acquistare dei mobili che furono
scelti da Isabella come alcuni letti a baldacchino, delle panche per la signora
(sotto la voce spese per sedie e poltrone) e quattro sedie basse tappezzate di
velluto turchese.Vennero
acquistati anche dei servizi da trentadue di stoviglie.Rappresentava
un’ulteriore spesa il trasferimento dei beni, come la biancheria, sedie
pieghevoli ed arazzi, quando isabella si spostava in una delle numerose ville
di famiglia.Una
voce particolare era la “spesa d’arme”
ovvero la protezione dell’edificio.Una
voce che comprendeva l’acquisto di balestre, archibugi, lance, spade. La
struttura esterna del palazzo sembrava quasi una cassaforte ed era sicura solo
se presidiata da uomini armati. Alessandro de’ Medici fu ucciso proprio in
questo palazzo che era scarsamente presidiato.La
“spesa del vestire” prevedeva
gli acquisti di seta gialla per le
“vesti” di Paolo Orsini, scarpe di seta rossa o un cappello fatto di piume di
pavone e pennacchi argentati, rivestito in taffettà ed acquistato presso il
ricco mercante Andrea Cortesi.Sembra
che l’Orsini abbia avuto un debole per i cappelli stravaganti, come testimoniò
la prostituta Camilla durante il processo. Comprava camicie dalle suore
domenicane del vicino convento di Santa Caterina da Siena che era posto lungo
la stessa Via Lunga.In
queste spese rientrava anche l’abbigliamento dei domestici costituito, ad
esempio, da livrea per i valletti.Sulla
qualità dei tessuti non si faceva attenzione alla spesa. Numerosi metri e metri
di seta e velluto rossi e gialli, taffetà rossa striata di giallo, tutti tessuti
che venivano acquistati per vestire i
domestici della casa.Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Enea Silvio
Bartolomeo Piccolomini, papa Pio II,
incoronato poeta
dall’Imperatore Federico III d’Asburgo.
(Artista:
Bernardino di Betto Betti, noto come il
Pinturicchio o
Pintoricchio – Perugia, 1452 circa ; Siena, 11 dicembre 1513
Il soprannome
Pintoricchio (“piccolo pintor” – pittore) derivava dalla sua
corporatura
minuta. Termine che adottò per firmare i suoi capolavori artistici.
Affresco –
Datazione: 1502/1507 – Cattedrale di Siena
Vicino al trono
dell'Imperatore, in primo piano, si vede un giovane paggio, il cui costume è
ricco ed elegante. Porta una clamide di color giallo cangiante in
azzurrognolo nelle
ombre ed è affibbiata sulla spalla destra.
Il farsetto, le cui
maniche sono assai larghe superiormente, è di un rosso di lacca.
Tiene
nella destra un berretto scarlatto, ornato di un bottone d'oro e sormontato da
una piuma giallastra: posa la sinistra sul pomo dorato di un ricco pugnale.
Veste lunghi e stretti calzoni la sua cintura è violetta, le scarpe sono rosse
e terminano con una di quelle punte assai comuni nei secoli XIV. e XV. Questi calzari aveva una lunghezza talvolta
così esagerata, che per poter muovere il passo bisognava legarle al ginocchio
per mezzo di una piccola catena.
Tra i numerosi paggi si
notano i due posti sulla destra della scena.
Uno ha la mano destra appoggiata ad un bastone,
tiene in testa un berretto nero ornato di un nodo rosso e con bottoni dorati.
Il giubbone è aperto sul petto e lascia vedere la camiciuola: il suo colore è
quello delle larghe maniche che arrivano fino al gomito, è giallo; il restante
del braccio fino al polso è coperto di una manica nera: i lunghi calzoni sono
rossi, ed incominciando dalla cintura, ornati di liste verdi, le quali
terminano sulle coscie con alcuni fiocchetti tramischiati d'oro: le scarpe sono
nere. L'altro paggio ha in testa un cappello verde: porta una specie di tunica
assai corta, color di piombo, ed inferiormente guernita di velluto nero
ricamato in oro: il farsetto è listalo di giallo e nero: i calzoni sono gialli.
…………………
I
paggi, sempre più numerosi di giorno in giorno, indossavano livree di costo
velluto blu.
Erano
figli adolescenti della nobiltà fiorentina, le cui famiglie facevano a gara per
“piazzarli” al servizio de’ Medici. Era questo infatti il modo migliore per
ottenere un’entrata a corte o un avanzamento di posizione sociale.
Per
Isabella e Paolo era questo un modo per potersi assicurare la lealtà delle
nuove generazioni.
Non era
una spesa di poco conto sfamare e vestire questo esercito di ragazzini per non
parlare della quotidiana cura dei loro ricchi abiti.
C’era
una lavandaia, di nome Caterina, che era impiegata a tempio pieno a corte e che figurava
nei libri contabili.
Mentre
le spese per i paggi figuravano in modo regolare nei libri contabili, c’era un
altro esercito di servi che restava praticamente invisibile e costituito dagli
schiavi.
Altra
spesa era legata alle carrozze ed anche ad un mezzo di trasporto molto solenne
e non meno vistoso come “la lettiga o lettica”.
Una
lettiga che Isabella aveva fatto foderare con un ricco velluto e broccato blu
reale. Le lettighe era in genere usate dalle donne in stato di gravidanza o
malate. Era un modo molto comodo per essere condotti in città piuttosto che
montare a cavallo o ancora spostarsi in carrozza.
Isabella, secondo i resoconti medici, tendeva
sempre ad esagerare i suoi malanni fisici e a renderli noti nei minimi
particolari. Le sue otiti, molto frequenti, figuravano sempre nei dispacci di
corte e a quanto sembra questi fastidi non le impedivano mai di andare a caccia
e di frequentare le feste. Allora
ventenne era un modo di esprimere in
pubblico la sua posizione permettendole di osservare con tranquillità il mondo
circostante con le sue piccole e grandi sfumature.
Queste
sono solo alcune delle spese che figuravano nei libri contabili di Casa
Medici-Orsini. Altre voci, non meno importanti ed altrettanto ingenti,
determinarono il sorgere di una grave e preoccupante crisi economica che avrà
avuto i suoi effetti sulla vita sentimentale della coppia.
Gli
schiavi ai tempi di Cosimo I de’ Medici erano presenti nel tessuto sociale tanto che diverse storie ci furono tramandate
sulle loro triste esperienze di vita..Dalla
schiava russa Ekaterina, al garzone Francesco, dalla serva Ghita alla
prostituta Hysa.Ekaterina
fu resa schiava con un inganno perché venduta dal padre. Era una ragazza forte
e nonostante le botte e le umiliazioni non perse mai la sua dignità. Un inno ai
sogni e alla speranza di una vita migliore.Altro
esempio la disputa processuale tra Lusanna e Giovanni della Casa. Per la prima
volta una donna non nobile accusò un uomo di bigamia e immoralità. Una donna che voleva fare sapere alla
Firenze del tempo che non era una cortigiana e che Giovanni della Casa l’aveva
sposata. Antonio Pietrozzi, priore del convento di San Marco, si schierò in
favore della donna contro l’usura e l’immoralità dei fedeli. Non si pronunciò
contro quello che era un costume sociale… la schiavitù femminile. Molte
fanciulle dell’Est erano rese schiave per i lavori domestici nelle case dei
ricchi, nei bordelli, come balie dei bambini, nelle case degli anziani per
accudirli. Dai
libri contabili si rilevò che le uscite superavano di gran lunga le entrate e Paolo
Orsini era quasi abituato a convivere con i debiti. A quindici anni era stato
obbligato a cedere parte della sua
proprietà ai Brandini, mercanti di Firenze, per fare fronte ad un debito
esorbitante di ben 14.000 scudi.Malgrado
i suoi debiti s’avventurava sempre in nuovo spese. Per la nobiltà questa pratica non era un
disonore dato che le credenziali offerte dal suo nome e dalla sua moralità
erano delle ottime garanzie.Ma
c’era un aspetto che lo differenziava dagli altri nobili ed era legato alla
necessità di vendere porzioni delle sue proprietà, più o meno estese, per
pagare i creditori. Un comportamento che non reputava vergognoso. Tante spese
folli, come l’acquisto di speroni d’oro sia per sé che per tutto il suo
seguito. Fu spesso costretto a monetizzare i suoi preziosi tra cui i gioielli
che Benvenuto Cellini aveva disegnato per le nozze della madre. Era
pronto a sacrificare oggetti di fattura
pregiata per acquistare una miriade di oggetti di minore valore.Un
pendenti entrovi uno smeraldo, e rubino, con una perlae un
diamante a faccetteproveniente
dalla sua eredità venne messo in vendita al prezzo di 12.000 scudi.Ma
la sua spesa più forte era quella sostenuta per i cavalli che per il Conte
Orsini erano quasi un ossessione.Uno
dei suoi contabili romani un giorno gli disse, con grande sincerità, che le
proprietà degli Orsini non sarebbero state così gravemente indebitate se
non fusse la superflua e dannosa spesa di Bracciano,della
quale la maggior parte o quasi tutta dipende daquella
benedetta stalla. Però se gli piace di restringerla a cinque osei
cavalli…. e di dar via i cavalli spesa superflua e dannosa”. Il duca Paolo trascurava spese fondamentali come l’alimentazione deidomestici per destinare
il denaro all’acquisto di articoli stravaganti. Un domestico dell’Orsini nel
dicembre del 1563 scrisse che:qui si fa un grandissimo lavorare di mettere in ordine
archi trionfali,giostre, caccia et feste et livree… ma pe noi altri
cortigiani per ancora non
tocca niente d’amaneggiare, se non fatiche in metterin ordine il Palazzo et similia. La proprietà di
Bracciano era gravata dai debiti anche per la cattiva gestione dell’azienda da
parte del “fattore” Giulio Folco che fu spedito in prigione con l’accusa di
appropriazione indebita. Per ragioni del tutto personali, che non si sono
riusciti a chiarire, il duca Paolo Orsini insistette per il rilascio del Folco
e addirittura dichiarò che il suon nome era stato ingiustamente infangato e lo
riprese quindi alle sue dipendenze.La moglie Isabella
de’ Medici non si fidava del Folco e non si preoccupò di nascondere le sue idee
in una delle lettere, inviate al marito, in merito ad alcuni oggetti importanti
che il fattore avrebbe dovuto acquisire per suo conto:“oggi cosa potrei, ma il vedermi da voi continuamente
sarebbe cosa per il mio stomaco di troppa mala digestione però
vi dicho che io non sono avezza a essere burlata et che mi sia mostra il biancho per il nero et son avezza a trattar con
gente che sempre mi mostrano le cose chiare e non con mille bugie et
strattagemmi come fate professione mostrarmi o farmi ad interder
voi. Ho visto quanto scrivete a Gianozzo (Cepparello, il curatore Patrimoniale di Isabella) della provisione di
Napoli a che vi dicho che mi rimettiate subito i denari et non mi diate più
parole….. et non vi imaginate che io mi contenta con pocha di
paroline et non essendo questa mia per altro, mi vi raccomando
mandare misubito la copia del contratto delle poste et scrivermi
dov’è il mio gioiello”. Folco era stato nominato dallo zio dell’Orsini, il
cardinale Guido Ascanio Sforza, fratello
della madre Francesca Sforza. La famiglia Medici aveva dei sospetti sul
cardinale ritenendolo capace di essersi appropriato di ingenti risorse
economiche del nipote. Grazie a queste sottrazioni, che potremo definire
“indebite”, il cardinale si permise di assumere l’architetto Michelangelo per
la costruzione della cappella in Santa Maria Maggiore. Quando il cardinale
morì, Isabella scrisse al marito con molta franchezza:Non dicho altro ma solo vi voglio dire le sue peccati
non meritavano minor punitione. Li commenti sono
infiniti….ma sopra ciò non dichi altro….. perché adesso il sonno
mi assassina. Isabella sapeva che il padre, a cui era molto legata,
l’avrebbe aiutata coprendo i debiti. Nel febbraio e nell’aprile del 1567,
Cosimo I cedette un totale di 4000 scudi da corrispondere alli creditori della S.ra Isabella de’ Medici,
figliuola di Sua Ecc.III”.Nella lista i creditori erano:Marcho Giachini la cui doveva un totale di 70 scudiCostanzo Gavezzeni e compagni, velettai, scudi 200 di
moneta;Giovambattista Bernardi e compagni, battilori (battere l’oro), sc. 200 di m.ta;Maestro Vicenzo di Maestro Carlo tiraloro (lavorazione dell’oro), sc. 100 di m.ta Gli ultimi due erano artigiani nella lavorazione
dell’oro per creare fili da tessitura.La lista prosegue con:Agnolo Alessandro e compagni linaiuoli, sc. 100 di
m.taBartolomeo da Filichaia e compagni, setaiuoli, sc. 100
di m.taSeguono altri sei mercanti di sete….Saldo del Cegia, vaiaio (pellicciaio) sc. 25;maestro Berto Cino, pianellaioFrancesco Gaburri e compagni, rigattiere, 220 sc.Nel Rinascimento il mercato di seconda mano (Francesco Gaburri) nel settore
dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi era molto fiorente e non era
considerato disonorevole perché un capo o abito poteva acquistare valore in
base al prestigio della sua provenienza.Isabella riceveva dal padre una rendita personale e mensile che era spesso esaurita prima della
scadenza. Era sempre molto eccitata dalla notizia che il padre stesse per anticiparle ben 4000
scudi e confidava al marito PaoloMi pago li debiti et poi starò come una regina.Malgrado la certezza che il padre l’avrebbe sempre
aiutata intervenendo in suo soccorso, Isabella non rimaneva indifferente quando
temeva che le sue finanze sfuggissero al controlloViene costà M. Gian Battista Capponi con i libri così
da esaminarli personalmente.La casa va in ruina grandissimascriveva a Paolo nel luglio del 1566.Non risulta invece che l’Orsini abbia mai consultato
un libro contabile per tentare una stima del suo dissesto finanziario perché
era più propenso a valutare quale somma di denaro la moglie Isabella potesse
prestargli. Quando la moglie gli comunicò che era in arrivo la somma di 4000
scudi da parte di suo padre, Paolo gli
chieseSe fosse possibile averne 500.Isabella si vide quindi costretta a rivedere i suoi
atteggiamentiSono promessi a mercanti tutti eccetto trecento scudifu la sua pronta e sincera risposta.Per avere delle somme di denaro, Paolo impegnava i
suoi oggetti. Si rivolgeva ad usurai come
Daniello Barocco “hebreo”, dal quale ottenne 116 scudi per tre
candelieri d’argento o Gian Battista Cossetti dal quale ebbe 215 scudi per una
serie di piatti e fiaschette in argento.Impegnava anche tessuti, alcuni arazzi in seta da cui
ricevette 82 scudi.Finirono al Monte di Pietà vari oggetti tra cui un
tappeto orientale; una tazza decorata e uno scaldaletto in argento.Impegnare gli oggetti era una necessità molto
frequente nella nobiltà ma in genere era
preferibile che le transazioni si svolgessero lontano dalle città d’origine o
di residenza in modo da evitare il disonore.A diciannove
anni, Isabella aveva condotto trattative a Venezia per impegnare alcuni suoi
oggetti mentre Paolo preferiva contrattare a Firenze invece che a Roma, dove
risiedeva.Isabella si rivolgeva spesso al Monte di Pietà di
Firenze perché l’istituzione era diventata di dominio de’ Medici e gestita da
funzionari del duca.
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
La principessa offriva in garanzia gioielli per somme
che arrivavano a 2000 scudi, ma essendo il monte gestito dai Medici poteva riaverli
indietro più rapidamente.Il padre Cosimo I, da buon affarista, aveva saputo
sfruttare il banco dei pegni per proteggere i poveri dagli “ebrei” a beneficio
della propria famiglia, offrendo prestiti a interessi contenuti come riportò la
stessa Isabella:S.E. Ill.ma si
piacerà promettere et pagare irrevocabilmente allaMag. Uffizia li
proveditore et ministri del Monte di Pietà di Firenze12 mila ducati di moneta e quei più che monteranno le
interessi delli detti12000 in 3 anni a ragione di cinque per cento per
l’anno dello assegnamentodatoli il Sig. Dica nostroE’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
Il Sig. Paulo Jordan me ha ditto che S.E. gli presta
100mila scudiper pagare li suoi debiti, dandoli però diritti delle sue entratedi restituirli in 5 annicomunicò Ridolfo Conegrano ad Alfonso d’Este nel
febbraio del 1563.L’Orsini aveva esagerato dato che si trattava di un
prestito di 30mila scudi e Cosimo I si
assicurò in pegno ben di più delle rendite delle proprietà.Un anno dopo ricomprò due feudi degli Orsini, Isola e
Baccano, dai Cavalcanti, mercanti fiorentini a cui l’Orsini aveva venduto i
feudi per pagare i debiti. Le terre
furono in seguito trasformate giuridicamente in donazione irreversibile a
favore di Isabella garantendole una rendita dalla precaria fonte maritale.Anche questi 30.000 scudi non furono sufficienti perché tre anni dopo Paolo dichiarò di dover vendere delle fattorie.Il 17 gennaio 1566 il cardinale Antonio Michele
Ghislieri fu eletto papa prendendo il nome di Pio V.Per Paolo Orsini s’apriva la nomina di governatore
generale della Chiesa cattolica.Alla notizia Isabella scriveva al marito felice per la carica assunta e aggiungeva:…Dio faccia che si perserveri perché voglia bene alla
moglie etche non desideri le donne d’altri che qui consiste
ogni cose per pe,et essendo la più felice donna al mondo perché
(osserverè) queste due cose.Ma lassiamo le burle ancora che a me non sono burle.Io ho grandissimo contento delle favori di N.S. (Pio
V) Paolo nella lettera aveva comunicato la sua nomina a
governatore della chiesa ed esponeva un problema che si presentava difficile da
risolvere .Sarebbe stato opportuno che Isabella andasse “a stare
meco (a Roma)Paolo aveva infatti bisogno del decoro che gli
conferiva una moglie presente, come comunicò a Cosimo IScrissi (a V.E.) il desiderio haver di far venir mia
moglie a Roma,hora di nuovo supplico V. Ecc. a degnarsi a farmi tale
favore acciò piùche possi servir N.S. (Pio V il quale ogni giorno mi
fa1000 favori et perciò desidero continuare tal servizio
che credo siSia il consenso di V. Ecc.tia” La situazione precipitò. Isabella non aveva alcuna
intenzione di andare a Roma e lo stesso Paolo si giocò l’incarico tanto ambito
ancora prima di entrare in servizio.Il motivo della perdita della possibile nomina a Governatore
della Chiesa cattolica ?L’Orsini, da sempre, era stato attratto da tutto ciò
che era lusso, fasto, lo dimostrano i debiti sempre ingenti, e aveva mostrato
le insegne di governatore ancora prima della sua nomina. Lo stendardo adorno
delle chiavi di San Pietro, simbolo del papa, al cospetto dell’ambasciatore
francese ancora prima che Pio V avesse dato l’annuncio ufficiale della sua
nomina.Una grave infrazione di protocollo che sconcertò il
Vaticano e lo stesso Pio V rimase incredulo nel percepire l’incapacità
dell’Orsini di mantenere una condotta adeguata.Il papa fu costretto a ritirare la nomina…C’è da dire che analoghe irregolarità in passato erano state ignorate
senza gravi conseguenze. È probabile che Cosimo I abbia esercita una certa
influenza sul papa per revocare la sua nomina. A questo punto non era più
necessario il trasferimento a Roma di Isabella. Trasferimento che difficilmente
si sarebbe realizzato anche nel caso della nomina dell’Orsini a Governatore.Lo stesso Cosimo I era indispettito dal fatto che
l’Orsini abbia cercato di fare colpo proprio sull’ambasciatore francese. Il granduca
spesso si lasciava andare a gesti amichevoli nei confronti della Francia
e a volte creava delle discordie tra i Valois egli Asburgo. Il suo obiettivo era quello di non farsi
considerare una facile pedina dell’imperatore Asburgico sullo scacchiere
europeo. Cosimo I aveva invece tracciato per l’Orsini la strada politica di
fedeltà per l’impero. Una strada non
accettata dall’Orsini che non sopportava le imposizioni del suocero e alla base
c’era anche un fatto culturale perché gli Orsini erano sempre stati sostenitori
della Francia.Francia che sperava di riportare l’Orsini dalla
propria parte con approcci piuttosto lusinghieri.Per Franceso II di Valois, il duca di Bracciano
portava con sé la lealtà di altri membri del suo vasto casato, tutti potenziali
soldati. Erano in corso le guerre di religione che causarono continui scontri
tra la corona e gli ugonotti per non parlare delle crescenti ostilità con gli
Asburgo ed era quindi importante aggiudicarsi gli uomini della famiglia Orsini.Paolo era entusiasta della prospettiva di prendere le
armi a favore della Francia ma nello stesso tempo era scontento per l’assenza
di lucrosi incarichi operativi da parte della Spagna. Una Spagna
comprensibilmente riluttante a concederli incarichi o posizioni che
richiedevano grandi abilità d’amministrazione e strategie. Era opinione diffusa
la sua incapacità di dirigere con una buona amministrazione i propri vasti
feudi.Scrisse quindi ad Isabella dicendogli di aver perduto
l’incarico di governatore generale a causa delle calunnie dell’ambasciatore
spagnolo e che si era messo a disposizione della Spagna solo in virtù dellaDependenza e parentato che io ho con il Duca mio signore.Accennò anche alla grande soddisfazione di aver
ricevuto a Roma l’ambasciatore francese che era disposto a formulargli una
proposta concreta.Isabella era anche una grande diplomatica dotata di
una grande intuizione della realtà. Il padre la voleva sempre al suo fianco
anche nelle vicende politiche e gli comunicò
quello che stava accadendo. Insieme decisero che il marito ribelle doveva
essere trattato con una certa diplomazia, poiché il suo orgoglio era stato già
duramente colpito dalla revoca dell’incarico pontificio. Cosimo decise di non
intervenire e fu Isabella a dare una risposta al marito e nello stesso tono che
il padre usava nei confronti dei sudditi rivoltosi:
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Monte di Pietà
della Città di Firenze (Fam. Dé Medici) 29/02/1645 – Pergamena
Palazzo dei Capitani
di Parte Guelfa
poi diventato
Monte di Pietà
E’ anche vero che ricorreva ai prestiti su pegno solo
in caso di strema necessità mentre Paolo era invece solito vendere lotti di
terreno delle sue proprietà per soddisfare le richieste dei suoi creditori. Una
condotta da parte dell’Orsini che metteva Cosimo I a disagio.Cosimo I de’ Medici aveva favorito il matrimonio della
figlia Isabella con l’Orsini per proteggere i confini meridionali del suo
Granducato ma se il patrimonio del genero finiva in mano d’altri, il matrimonio
stesso diventava inutile.Per cui ancora un volta il de’ Medici decise di
concedere un prestito all’Orsini costituito da una forte soma di denaro prelevato
da una parte dell’eredità della moglie Eleonora di Toledo.
A me pare cosa meglio strana che voi vogliate lassar il
certoper l’incerto et vogliate mostrar al mondo d’aver il
cervello vollubilecome parrebbe se tal cosa facessi… ma voglio far conto
chel’ambasciatore (francese) venga con questa
commessione, chenon lo credo, perché se così fusse il re vi avrebbe
scritto unalettera et non mandatovelo a dir a boccha
semplicemente,ma come ho detto, voglio presupporre che l’abbia
l’imbasciatore talcommissione, vi prego a pigliar esemplo dagli altri
che hannoservito Francia, che mai hanno avuto cosa di quelle
che sono statepromosse loro, et so che per condurvi a tal cosa, viprometteranno mari et monti, et al osservarlo non sarà
nulla.Voi potere star con il Re Filippo senza obbligo
nissumoet volete suggettarvi a uno che ha più bisogno di voi;il Re Filippo in tempo de pace vi dà di più che a nessunaltro cavaliere italiano et credo se vorrete attender,
chevi darà anchora…. Fate carezze a ognuno et fate
differentiada quelli che vi sono amici a quelli che vi sono finti Isabella, riconoscendo in cuor suo di aver usato
parole forti, mitigò il suo pensiero e concluse che, in fin dei conti, erano
decisioni che solo il marito poteva prendereSe voi sarete franzese et io franzese et se voi
imperial,et io imperial, et di questo statene sicuro… ma essendo
voipiù savio de me lasserò fare a voiUn Isabella nella veste di moglie remissiva anche
sembra solo retorica. L’Orsini capì la lettera… i de’ Medici volevano che
rimanesse fedele alla Spagna.Isabella aveva avuto l’incarico di “manipolare” Paolo
o comunque di riportarlo nella giusta ”via”.Il rapporto coniugale s’era arricchito di gravi
tensioni. In Paolo un solo pensiero: “la moglie apparteneva al padre e non a
lui”.La pretesa che lo seguisse a Roma non era affetto
coniugale ma solo una dimostrazione di affermazione del proprio onore, orgoglio
e virilità.Isabella raramente seguì il marito a Roma e una sua
permanenza nel castello di Bracciano (degli Orsini) fu definito “terribile dicembre”. Altri avvenimenti o comportamenti sarebbero alla base
di una possibile crisi del rapporto coniugale.La visita del Cardinale Farnese a Firenze..Il cardinale Farnese è arrivato qui… Dio faccia….
satisfar allogia inpalazzo del principe e di Francesco.. et mio fratello
non lo lassa maiIl cardinale Farnese era cugino di Paolo e suo nemico personale….Nelle lettere tra Isabella e Paolo spesso si riscontra
un fraseggio da coppia innamorata mentre il conflitto traspare da altri
particolari.Isabella dimostrava un evidente disinteresse per il
nome degli Orsini perché si firmava “Isabella Medici Orsini” e raramente aggiungeva il
termine “duchessa di Bracciano”. Tutti la chiamavano semplicemente “Signora Isabella”.La sua immagine pubblica, l’influenza che esercitava e
la posizione che ricopriva, dipendevano esclusivamente dal fatto che era una
Medici per nascita.Quando parlava del “duca
mio signore” si riferiva sempre al
padre. L’unico motivo d’orgoglio per Paolo era il legame con
un nobile casato quale i Medici.Eppure nel passato il casato Orsini aveva esercitato
un certo fascino sui de’ Medici.Un Clarice Orsini si posò con una trisavola di
Isabella senza ricevere alcuna dote. Allora I Medici erano dei mercanti.A Paolo va il merito di aver istituito l’archivio di
famiglia Medici e adesso per cercare di riportare “lustro” al suo casato,
commissionò allo storico veneziano Francesco Sansovino “L’historia di casa
Orsina”.
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
L’autore fu
compensato con la rendita dell’affitto di un macello e della relativa bottega
di macellaio a Cerveteri, nei territori degli Orsini.Nel libro pubblicato nel 1565, l’autore evidenziò le antichi
origini della famiglia Orsini. Lodò le coraggiose gesta dei guerrieri Orsini e
concluse con un panegirico del
committente. L’autore aveva a disposizione poco materiale, perché le imprese
militari degne di nota del duca Orsini erano piuttosto scarse, e quindi lodò la
”bella, grande e ben formata statura, e il volto
come si vede, fra il piacevole e il grave, e l’aspetto benigno e dimostrativo
delle doti eccellenti del suo cuor generoso”.Cosimo I ed Isabella restarono forse sorpresi leggendo
le motivazioni addottate per la scelta di Paolo come genero del duca Medici:Ma questo sia il colmo di tutte le lodi, che gli
possono dare,che havendosi guadagnato tre supremi titoli
d’eccellenza, cioè dibell’animo, di saldo giudizio, e di invitto valore…..il signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze, stimato
per consensocomune di tutti i popoli, il più prudente e il più
fortunato Principe,che habbia hoggi il mondo, conoscendo con esquisito
giuditiol’occulte virtù di questo Signore…. se lo fece genero,
dandoli laSignora Isabella per moglie, donna di bontà, di
cortesia, e di valoreIncomparabile, e non punto dissimile al suo eccellente consorte. Un libro pieno di falsità, sul motivo per cui l’Orsini
s’imparentò con i Medici, che aveva lo scopo di fare colpo su Isabella.
L’obiettivo non fu raggiunto e causò, all’indomani della pubblicazione del
libro, un forte diverbio tra i coniugi.Durante il litigio Paolo disse ad Isabella:Infine io sono da più di Vostra Eccellenzaalludendo all’origine antichissima della propria
baronale casata.Isabella rispose subito al maritoI Medici per grandezza, magnificenza e senno sono i
primi principi d’Italia,dopo sua Santità, e voi infine non siete un feudatario
di Santa Chiesa”.Paolo non reagì verbalmente alla forte provocazione di
Isabella che alludeva alla maniera con cui aveva acquisito il suo ducato e
rispose con uno schiaffo che colpì la donna.
Nel processo di Camilla La Magra. la prostituta rilevò che l’Orsini
l’aveva presa a spintoni. Non era quindi la prima volta che il duca alzava le
mani ad una donna. Isabella
s’allontanò dal marito a causa anche della violenza subita. Nel febbraio del
1565 scrisse da Pisa, dove si era ritirata, al marito Paolo che si trovava a
FirenzeSono stata per fine adesso a rispondervi perché ero et
con ragionenella medesima opinione de prima cioè di dire tutte le
ingiurie davoi ricevute al duca mio signor… ma…. mi sono adesso
risolutaper meglio nostro a non ne parlar con persona di
questa cosa poiché…è di tanto pergiuditio. Ma acciò che voi tanto
maggiormenteconosciate lo error vostro ch’è grandissimo…. esser
miomarito…. comporta
l’onor mia et vostro, io sono contentaal perdonarvi et se non fatevi intender che con voipiglierò qualche rimedio”Isabella non specificò le ingiurie di Paolo ma
probabilmente erano sia verbali che fisiche. Un gesto violento contro la sua
persona era un’offesa gravissima e nessuno poteva prendere a schiaffi una
principessa Medici. Eppure dimostrò un grande amore perché volle tenere in sé
quella violenza subita e non riportarla in una lettera che poteva essere letta
dai suoi familiari o da estranei.Isabella non poteva rispondere al marito con la stessa moneta, non era nel suo carattere. La principessa nutriva un grande interesse per i quartieri posti sull’altra sponda dell’Arno
dove aveva deciso di stabilirsi. C’era Villa Baroncelli e voleva acquisirla
ma la richiesta richiedeva l’appoggio
del fratello Francesco che era rientrato dalla Spagna nell’autunno del 1563.
Era stato per tanto tempo in Spagna e la sua personalità non aveva avuto
giovamento dal soggiorno all’estero.
Francesco I che sotto la guida del padre Cosimo I fu avviato al governo degli stati. Nel gennaio del
1565 Isabella avanzò al padre una speciale richiesta che fu girata al fratello FrancescoPerché io ho da molti anni desiderato una villa
appresso Fiorenza conquesta occasione ho voluto suplichar V. Ecc. che toccandoli in la sua parteBaroncelli, me ne voglia fare gratia, et oltre alla
comodità che sentirò dellavilla riceverò ancora per singularissimo favore il
presente che verrà dalleMani di V. Ecc.La Villa Baroncelli, nota anche come Poggio Imperiale,
è situata sul Colle di Arcetri nei pressi di Porta Romana ed era circondata da
un terreno confinante con Palazzo Pitti.
Villa Baroncelli
Nel XV secolo il mercante Jacopo Baroncelli l’aveva
costruita dandole un’architettura
semplice a pianta rettangolare con una
sequenza di stanze che furono concepite attorno ad una corte. Nel 1487 la
famiglia finì in bancarotta e fu costretta a vendere la proprietà ad un
creditore, Agnolo Pandolfini. Il Pandolfini la vendette nel 1548 al banchiere
Pietro Salviati che investì una somma notevole ristrutturandola e soprattutto
arricchendola di splendidi e pregiati arredi. Tra i più noti
si ricorda una grande tavola di Andrea del Sarto, attivo a Firenze nel 1529,
raffigurante “L’Assunzione della Vergine”. Un immagine di grande bellezza per i
toni delicatissimi e lo sfumato leonardesco, caratterizzato da pennellature
evanescenti, privi di contorni precisi. Diventò la pala d’altare della cappella
adiacente alla vila ed oggi conservata
nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Villa Baroncelli
Assunzione della Vergine
(Artista: Andrea d’Angolo di Francesco Luca
Derto: Andrea del Sarto.
(Rep. di Firenze, 16 luglio 1486 – Rep. Di Firenze, 29 settembre 1530
Dato che suo padre era un sarto diventò noto come “del Sarto” cioè
“figlio del Sarto”.
Pittura: olio su tavola – Datazione: 1522/1523
Misure: (239 x 209) cm
Collocazione: Palazzo Pitti – Firenze
Ingresso Cappella – Villa Baroncelli
Firenze – Poggio Imperiale – Educandato (1823)
Un secolo e mezzo dedicato alla formazione delle Donne d’Europa
Alla morte del banchiere Salviati, Cosimo I confiscò
la villa, con tutto ciò che conteneva, e
tutte le sue proprietà sfruttando una legge che lo stesso Granduca aveva promulgato che gli permetteva di confiscare i
beni ai ribelli.
Pietro Salviati era in apparenza un suddito fedele, ma
il figlio Alessandro, avuto dal matrimonio con Cassandra Salviati (?), era un
convinto ribelle antimediceo. L’Alessandro nel 1554 si era unito alle truppe di
Pietro Strozzi a Siena per combattere contro i fiorentini. Dopo la sconfitta fu
catturato e Cosimo I, che era un Salviati per parte di madre (era figlio di Giovanni
de’ Medici, detto delle Bande Nere, e di Maria Salviati), gli concesse la
possibilità di pentirsi. Alessandro Salviati rifiutò e Cosimo I lo fece
giustiziare nel 1555. Cosimo I dovette attendere dieci anni ed alla morte di
Pietro Salviati si vendicò sul resto della famiglia confiscandogli tutte le
proprietà da cui ebbe un grandissimo profitto.
Giovanni de Medici (delle Bande Nere) e Maria Salviati,
genitori di Cosimo I
Artista: Giovanni Battista Naldini
(Firenze, 3 maggio 1535; Firenze, 18 febbraio 1591)
Dipinto: olio su tavola – Datazione: 1585
Misure (140 x 115) cm
Collocazione: Galleria degli Uffizi – Firenze
Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, e nonna di Isabella
(Arista: Jacopo Carucci, conosciuto
come
Jacopo da Pontormo o semplicemente Pontormo
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1543/1545 circa
Misure (87 x 71) cm
Collocazione: Uffizi – Firenze
Di Maria Salviati esistono due dipinti, entrambi del Pantormo.
Uno è quello posto nella galleria degli Uffizi di Firenze dove la donna è
ritratta in tarda età e l’altro si trova nel Museo di Baltimora.
In quest’ultimo la donna è raffigurata accanto ad un bambino/a.
Alcuni critici affermano che il bambino fosse Cosimo I de’ Medici nato dal
matrimonio con Giovanni delle Bande Nere e unico figlio. Altri invece
sostengono che fosse una bambina ed esattamente Giulia de’ Medici, figlia
naturale del Duca Alessandro de’ Medici (a cui successe Cosimo I) e nata nel 1535.
In entrambi i dipinti Maria Salviati fu raffigurata con un abito nero vedovile,
dato
che suo marito era morto per la gangrena di ferite riportate in battaglia.
Maria Salviati ritratta con ka nipote Bianca
(Artista: Pontormo, vedi sopra
Dipinto: Olio su tavola – Datazione: 1539 circa
Misure: (8,8 x 7,13) cm
Collezione: Museo d’arte Walters – Baltimora (USA)
Acquisizione del dipinto ?
………
Cosimo I aveva assegnato al figlio Francesco I alcuni
compiti tra cui quello di distribuire le terre che erano state espropriate alla
famiglia Salviati per ricavare un beneficio non solo economico ma anche
politico. Villa Baroncelli era la proprietà più prestigiosa dei
Salviati e come Palazzo Pitti dei Medici era circondata da vasti terreni. Un
vero paradiso posto ad appena un chilometro dal centro di Firenze. Anche l’arredamento, altrettanto prestigioso,
e il quadro di Andrea del Sarto, finirono ai Medici.Erano in molti ad ambire alla villa e naturalmente
Isabella aveva la forte intenzione di non lasciarsela sfuggire.Francesco I era però con altre intenzioni….. il
rapporto tra Isabella e il fratello Francesco non era molto buono.
Probabilmente nel fratello c’erano delle invidie legate al bellissimo rapporto
che la sorella aveva con il padre Cosimo I. Francesco, dopo la richiesta di Isabella di avere la
disponibilità di Villa Baroncelli, le scrisse:al desiderio di V.S. Ill.ma circa della villa di
Baroncelli non posso iocorrispondere, perché non sendo liquidato le cose
attinenti a quellaconfiscatione, non m’è lecito il deliberarne, né ella
deve dubitare inogni caso che le manchino ville, potendo usare le
nostre come proprie sueUna risposta da alto funzionario del demanio che
lascia intravedere una mancanza d’affetto da parte di Francesco verso la
sorella che viene tratta con un certo distacco.Per Isabella c’era una sola possibilità ed era quella
di rivolgersi al padre.Cosimo I aveva incaricato Francesco I della confisca
del patrimonio dei Salviati ma era anche
vero che l’ultima parola spettava sempre al padre Cosimo I a cui i desideri
della figlia erano prioritari rispetto all’autorità conferita al figlio.Diede quindi ordine al figlio Francesco di cedere la
villa ad Isabella.Per Francesco fu uno smacco terribile. la sua ira non
aveva confini…… sua sorella l’aveva spuntata ed ora possedeva qualcosa che lui
non aveva e cioè una villa, che potremo definire reale, che non avrebbe voluto
dividere con nessuno.La villa Baroncelli di Poggio Imperiale diventò quindi
la Villa di Isabella che lei chiamava ….la mia villa
… scrivendo al marito.Subito lasciò libero sfogo ai suoi sentimenti con interventi nella proprietà. Fece adornare
le pareti con centinaia di “palle” medicee in modo da identificare facilmente
la villa con il nobile nome della sua famiglia.
Poggio Imperiale (Villa Baroncelli) in una veduta del
1700
Poi altri interventi che furono descritti da un
contemporaneo
Quando fu benignamente donata la villa di Baroncelli
alla suaCasa di Serenissimi Gran Duchi, non erano né il Palazzo né lavilla di quella bellezza, grandezza e magnificenza che
sonohoggi, perché il palazzo fu abbelito e accresciuto
dalla Sig. Isabella, come
ancora si vede delli invenzioni del suo nome inpiù parti…. Ancora fatta di piante e stanze e mura dei
i Giardini etla villa ancora abbelita et migliorata con fontane, in
giardiniin commodità alle case dei lavoranti, di frantoio de
olio….tutti questi sono migliorate di decine di migliaia di
scudi.
Sui terreni coltivati, al di là dei giardini, c’era
una vigna, alberi da frutto, ulivi ed una voliera. Isabella acquisì anche delle
proprietà vicine, come le terre che appartenevano al pittore di corte Santi di
Tito.
Grazie a questi acquisti, potè costruire una strada
alternativa che permetteva di raggiungere Firenze passando dietro la chiesa di
San Felice e garantendo, in questo modo, un accesso più facile alla proprietà.
Trasformò i giardini in un mondo fantastico popolato
di divinità. Tra le sculture che impreziosivano il giardino c’era una statua di
marmo di Dovizia, dea dell’abbondanza e simbolo molto caro alla città di
Firenze, e grandi teste e vasche di marmo. Fece giungere da Roma due lastre di
granito, in realtà un lungo pezzo di marmo di provenienza sepolcrale
appartenente ad un antico sarcofago romano, e una testa di donna anch’essa
molto antica.
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della
famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi
maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura
del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere
d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici
e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile
per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Isabella commissionò al de Rossi un’altra statua per
il suo giardino: “una Venere in marmo maggior del vero”, anch’essa nuda
e con lo sguardo rivolto verso il basso diretto all’Adone morente.
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Isabella di Cosimo
de' Medici a 16 anni
Alessandro
Allori (1535-1607)-
(Firenze,
31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura:
Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure
(88 x 71) cm – Collezione: Privata - InghilterraL’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Dallo scultore Vincenzo de’ Rossi, al servizio della famiglia, Isabella acquistò due sculture di gran pregio. Due grandi nudi maschili dai quali si nota l’indipendenza della padrona di casa alla cultura del tempo. Le donne della nobiltà non commissionavano sculture e le opere d’arte che acquistavano erano sempre legate a motivi religiosi o naturalistici e mai erotici.
In qualunque altro contesto sarebbe stato impossibile per una donna ordinare delle opere così erotiche come quelle del de’ Rossi.
Si trattava di un “Bacco con Satiro”, oggi
conservata nel Giardino di Boboli, che
dà un’idea dell’aria magica che si respirava nel giardinoBacco presenta un grappolo d’uva intrecciato nei
riccioli dei capelli. È in piedi con le possenti gambe saldamente ancorate al
piedistallo e con torso muscoloso lievemente avvitato. Il suo sguardo è
proiettato in avanti come a guardare lontano. Un piccolo satiro si trova, quasi
nascosto, tra le sue gambe. In origine questa statua era posizionata sul colle
dove sorge la Villa. Bacco, allegoricamente, doveva guardare le vaste terre che
si estendevano ai suoi pedi. Isabella volle creare, con la sua grande sensibilità,
un legame tra l’ambiente circostanze e la scultura di pietra grigia riuscendo a
dare a Bacco e al piccolo satiro, la sensazione di essere davanti a delle
creature viventi.
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
La seconda scultura acquistata dal de Rossi fu un “Adone
morente”.“Il dio giace prono, lo splendido viso torturato dal
dolore, mentre il cinghiale, inviato dall’adirata Diana per ucciderlo, dopo averlo
ferito a morte, giace ai suoi piedi”.Perché Isabella scelse questo soggetto ?Probabilmente per dimostrare la sua erudizione dato
che nell’antichità molte fanciulle erano dedite al culto di Adone.Forse la motivazione va ricercata nelle vicende familiari
della giovane donna.Il fratello Giovanni, a cui era particolarmente
affezionata, fu in modo prematuro
strappato alla vita da un destino crudele.“Isabella poteva identificarsi con Venere, amante di
Aidone, e fare propria la disperazione della dea. Una disperazione descritta da
Ovidio nelle metamorfosi, che Isabella conosceva dato che aveva un’ottima
formazione classica.E come dall’alto intravide il corpo che in fin di vita
si torceva nel suostesso sangue, si precipitò giù, strappandosi veste e
capelli, percotendosi il pettocon le mani, come non le era costume.Lamentandosi poi col fato disse“No, non potrà la tua legge disporre d’ogni cosa.Imperituro rimarrà il ricordo, Adone, del mio lutto”
Una statua che fu prima attribuita,
per la sua bellezza, a Michelangelo
Ercole che sorregge il Mondo
Opera di Vincenzo de Rossi e posta all’ingresso della villa
La statua di Adone ricordava quindi ad Isabella la
triste fine del fratello Giovanni. I due
amavano soggiornare insieme nelle varie residenze di campagna e avevano forse
progettato in futuro di condividere una proprietà.
L’avrebbero abbellita con gli oggetti antiche che
entrambi, allora adolescenti, avevano cominciato a collezionare con grande
passione.
Nella villa
Isabella creò il proprio mondo autonomo, a sua immagine, e adorava il clima
mite che l’ambiente le offriva “il luogo più fresco nell’estate”.
Era giovane, appena ventenne, bella e senza figli,
circostanze che avrebbero gettato ogni altra donna del rinascimento nella vergogna
e nella disperazione.
Alessandro Allori (1535-1607)-
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Pittura: Olio su pannello ?:– Datazione: 1560
Misure (88 x 71) cm – Collezione: Privata - Inghilterra
L’assenza
di figli per lei non era un problema ma un modo di consolidare la libertà che
il padre le aveva concesso.Pur
avendo un ruolo importante nelle azioni politiche del padre, godeva della sua
libertà e dei suoi divertimenti che erano una parte importante del suo vivereCerchiamo
spassi o facciamo l’arte di Michelacciocioè
l’arte dell’ozio.È
anche vero che non era indolente dato che le sue richieste erano sempre
esaudite.Vezzeggiata
dal padre ? No… perché furono l’indole e l’intelligenza di
Isabella a conquistare l’ammirazione del padre Cosimo I e questo sin da bambina
favorendo in questo modo il soddisfacimento, l’esaudimento di ogni sua richiesta.La
principessa usò la sua villa per la creazione di una nuova fase di vita.Le
sue qualità legate: al potere politico che le era riconosciuto in città e non
solo; alla sua influenza e all’intelligenza; all’amore per il sapere , la
cultura e la vita sociale; raggiunsero alti livelli d’espressione. Una vita che se da un lato dava grandi
soddisfazioni, dall’altro aveva anche qualche rischio.
Villa Baromcelli
Isabella
non cercava mai di associare la sua immagine a manifestazioni di carattere
artistico religioso dato che i suoi interessi erano profani.Aveva
una grande interesse per la musica che le permetteva di esibire ruoli diversi
come autrice, esecutrice, ecc.La
musica era intesa sia come intrattenimento sia anche come accompagnamento ad
altre forme artistiche.“Isabella e i suoi contemporanei sapevano cogliere nella musica
tutta una serie di sfumature, messaggi verbali o musicali che sono difficili da
codificare.Numerose allusioni di carattere sessuale, versi in
apparenza casti ma in realtà colmi di erotismo che trasformavano l’ascolto
in un’ esperienza di seduzione.Nel mondo di Isabella, la musica di qualità non era di facile
accesso e questo benchè a Firenze fossero molto attivi i “cantambanchi” agli
angoli delle strade.Ascoltare delle voci insegnate al canto ed accompagnate da
strumenti musicali raffinati come quelli in possesso di Isabella era un esperienza diversa.Era un privilegio ascoltare “belle musiche” a casa di Isabella,
in un ambiente che, con la sua architettura e arredamento, donava alle canzoni
un’area sublime”.
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Villa Baromcelli
Isabella
cercava i migliori musicisti e nel seguito romano del marito Paolo Giordano
c’era un cantante napoletano che era richiesto spesso da lei a cortemi
farà favore grandissimo mandarmi il Napolicello che cantaperché
ci manca una parte. La
sua passione per la musica la portò a
commissionare un quadro all’Allori intorno al 1565 dal titolo “Isabella con
musica”.
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
È
raffigurata in una posa simile a quella che la ritrae all’età di sedici anni e
con abiti quasi simili.Appare
ora più magra, con lo stesso sorriso e con l’espressione del volto da persona
più matura.Un
Isabella molto cambiata rispetto a quando aveva sedici anniNon
sono più una putta (bambina) et… quello non conoscho nella etàadesso
lo conosceròcon
una mano stringe ancora la catena che lega lo zibellino, un talismano di
fertilità e con l’altra regge la pagina di uno spartito.Era
una musicista oltre che poetessa. Una breve composizione è riuscita a sopravvivere al tempo
inesorabile che tende a cancellare tutto…Lieta
vivo et contentaDapoi
che ‘l mio bel soleMi
mostra chiari raggi come suole,Ma
così mi tormentaS’io
lo veggio sparirePiù
tosto vorrei sempre morire La
presenza dello spartito nella mano di Isabella è davvero singolare e fa
riflettere.Le
nobildonne generalmente venivano ritratte con un cagnolino, con un bambino o
con un classico libro di preghiere.La
cortigiana invece era spesso raffigurata con uno strumento musicale o spartito
che alludevano ai molteplici talenti nell’arte della seduzione. Isabella non si
preoccupava di questo aspetto e riusciva quindi ad esaltare non solo la sua
posizione sociale ma anche il suo amore verso la musica importante elemento di
stimolo nella sua vita.Nel
suo salotto una musica madrigale (testo poetico e musica, con almeno tre
diverse voci) rivolta al romanticismo ed
anche alla sensualità.Una
“bella musica” come la definì Ridolfo Conegrano, abituale frequentatore della
villa Baroncelli.L’influenza
di Isabella nel campo della musica fu notevole tanto da varcare i confini di
Firenze.Maddalena
Casulana,
la prima compositrice e cantante donna,
cercò e ottenne la sua protezione, …………………
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Maddalena Casulana
(1544 – 1590)? Fu una compositrice, liutista e
cantante italiana.
è considerata la prima donna compositrice
ad
aver pubblicato
nella storia della musica occidentale. Non si sa dove nacque perché alcuni
storici la citano come originaria di Casole d’Elsa (Siena) altri
nata a Vicenza.
Il suo primo
lavoro è datato 1566, quattro madrigali in una collezione “Il Desiderio”
Morir
non può il mio cuore
Morir
non può il mio cuore:
ucciderlo vorrei, poi che vi piace.
Ma trar non si può fuore
del petto vostr’ove gran tempo giace.
Et uccidendol’io,
come desio,
so che morreste voi,
morend’anch’io.
Questo madrigale
vuole mostrare al mondo l’errore vanitoso degli
uomini, i quali
credono di essere i soli a possedere doti intellettuali
e ritengono
impossibile che ne siano dotate anche le donne
Due anni dopo
pubblicò a Venezia il suo primo vero libro di madrigali
per quartetto
di voci, “Il primo libro di
madrigali”, che fu la prima
composizione
musicale pubblicata da una donna. In quello stesso anno
Orlando di Lasso
condusse un’opera della Casulana alla corte di
Alberto V di
Baviera a Monaco, ma quella composizione non è stata trovata.
Nel 1579, 1583 e
1586 pubblicò, sempre a Venezia, altri libri
di raccolte di
madrigali
In
alcune delle sue opere Maddalena scrisse di quanto fosse difficile
essere
una donna compositrice ai suoi tempi.
Concerto delle Donne
http://concerto-delle-donne.nl/maddalena-casulana-oeuvre/
https://www.youtube.com/watch?v=iDAnLolekKI&feature=emb_logo
……………………
Maddalena
Casulana cantava da mezzosoprano accompagnandosi con il liuto. La sua vita da
musicista itinerante dovette affascinare Isabella.La
musicista, allora ventottenne, dedicò ad Isabella il primo libro di madrigali,
scritto per quattro voci, e dato alle stampe con una bellissima motivazione:Conosco
veramente Illustrissima et Eccellentissima Signora, che queste mieprimitie,
per la debolezza loro, non possono partorir quell’effeto,ch’io
vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testimonioall’Eccellentia
Vostra delle divotion mia, di mostrar anche al mondo(per
quanto mi fosse concesso in questa profession della Musica)il
vano error de gl’huomini, che de gli alti doni dell’intelletto tantosi
credono patroni, che par loro, ch’alle Donne non possonomedesimamente
esser communi. Ma con tutto ciò non ho volutomancar
di mandarle in luce, sperando che dal chiaro nome diVostra
Eccellentia (a cui riverentemente le dedico) tanto di lumedebbano
conseguire, che da quello possa accendersi qualchealtro
più elevato ingegno.Maddalena
riconosceva che lei ed Isabella erano un’anomalia in quanto donne, compositrici
ed esperte in una materia dominata da artisti e mecenati di sesso maschile. I
madrigali raccolti nel libro hanno per protagonista Isabella, in un modo sia velato che scoperto, ed erano
eseguiti durante le riunioni, incontri e spettacoli nella sua villa. La
prima canzone del libro, che inaugurava una serata musicale nella villa
Baroncelli,era
una “laude” dedicata ad Isabella, in cui si esaltano le sue doti.Il
titolo… “ Tant’alto s’erge”.. quattro voci intonavano:Tant’alto
s’erge la tua chiara luceDonna,
ch’agli occhi nostriun
nuovo sol ti mostri,e
così vaga splendi,ch’a
sublime tue lodi ogn’alma accendi;ond’il
gran nome d’Isabell’adornol’aria
percuote alterament’intorno. La
canzoni che seguirono invitano l’ascoltatore in un mondo di passioni ardenti,
amori imperituri e dolorosi, caratterizzati da complicati intrecci di
relazione. In un’altra canzone le voci dichiaravano:Morir
non può il mio cuore,ucciderlo
vorrei,voi
che vi piace;ma
trar non si può fuore dal petto vostr’ove gran tempo giace……………….Sculpio
ne l’alm’Amore l’immagin vostr’econ
sì ardente face l’abbrugia ognor, che more………………..C’è
da dire che l’erotismo legato alla musica era per certi versi lontano dalla
corte di Isabella a differenza di città come Ferrara e Mantova.È
difficile pensare ad una donna nel rinascimento capace di organizzare
spettacoli, come nel caso di Isabella, che sapeva mettere in scena ed
interpretate dei brani in modo da inviare messaggi e formulare delle
dichiarazioni sulla sua vita.Diede
incarico ad un poeta di corte, Giovan Battista Strozzi, di scrivere alcuni
versi per una serie di madrigali sul tema della lontananza e di renderli noti
con la dicitura che erano stati scritti “ad
istantzia della Signora Isabella de’ Medici sendo il Signor Paolo suo consorte
a Roma e lei a Firenze”.Con
toni simili alla canzone che compose lei stessa, i versi pregavano gli astriStelle,
o felici, che ‘l mio ardente solesempre
veder potete……….
rivolgetele belle
orme al bell’Arnoch’io
non pianga ad ogn’ora, e pianga indarnola
dipartenza, che mi duol sì fortech’io
non temo di morte.Isabella
in queste canzoni assumeva il ruolo della moglie malinconica che soffriva per
l’assenza del marito. Una donna che stoicamente sopportava la separazione
forzata.Il
pubblico era convocato per tenere compagnia alla donna e svolgeva un ruolo nel
teatro creato dalla padrona di casa. Infatti i messaggi della canzone non
restavano chiusi nei grandi saloni della villa ad un stretto auditorio ma
venivano pubblicati e fatti circolare di corte in corte valicando i confini di
Firenze. La
presenza del marito nella “mia villa” di Isabella era saltuaria e
spesso rivestiva anche il ruolo di
padrone di casa.L’8
settembre 1564La
sera S. Paulo e Donna Isabella li fecero
banchetto con una mezzadozzina
di gentildonne et si fece musica et si ballain
onore dell’ambasciatore spagnolo.L’evento
aveva un suo risvolto politico: garantire uno scambio tra Paolo Orsini e
l’ambasciatore affinchè lo stesso Paolo restasse fedele alla Spagna e
l’ambasciatore, a sua volta, gli rendesse rendite e onori.Isabella
durante l’assenza del marito aveva sempre degli ospiti
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse
al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una
serata per sole donne. Questi
incontri, banchetti, serate di musica e
danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che
Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando
che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del
giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato
in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il
rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la
signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini,
che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che
erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei
come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma
chi erano questi demoni? Cortigiani
al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi
adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti
suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle”
di Celio Malespini.
È
un opera simile al “Decamerone” in una versione cinquecentesca con una raccolta
di novelle che avevano come tema corteggiamenti, scherzi, equivoci, avvenimenti
che erano legate ad episodi realmente accaduti a Firenze. Avvenimenti a cui
l’autore, di origine veronese, aveva assistito o sentito parlare.
Un
particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a
Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto
importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni
teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti
soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle
novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi
anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un
altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una
presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva
un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio
di continue burle.
Ridolfo
a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo
in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove
quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il
tempo allegramente”.
Con
la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno
il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno
era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate
della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni
aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’
Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
Fausto Sozzini o
Socini/Socino
(Siena, 5 dicembre
1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e
riformatore religioso
Il
Sozzini faceva parte del gruppo culturale di Girolamo Bargagli, autore del
manuale di giochi dedicato ad Isabella. Era nipote di Lelio Sozzini che aveva
una ricca corrispondenza con Giovanni Calvino ed altri eretici del Nord.Il
segretario di Isabella, che condivideva le idee dello zio Calvino, cercò di
fondare una setta antitrinitaria i cui
membri successivamente presero il nome di
“sociniani”.Rifiutavano
l’esistenza della Trinità e della verginità di Maria e consideravano San
Giuseppe il padre naturale di Gesù.Fausto
Sozzini, nei suoi compiti di segretario, era obbligato al disbrigo delle
numerose pratiche per conto di Isabella e del marito Paolo. Un
impegno difficile che richiedeva molto tempo e che lo distraeva dai suoi
impegni teologici.Proprio
in questo periodo pubblicò il suo primo manoscritto “De sacrae scripturae
autoritate” che esaltava il primato della religione cristiana sulle altre
religioni e l’importanza di accompagnare questa supremazia con prove storiche.I
contenuti di questo manoscritto entrarono a fare parte del circolo culturale di
Isabella. Se il fratello Giovanni, destinato a diventare papa, fosse stato
vivo, certamente la sorella sarebbe
stata più attenta nella scelta di un segretario cercando di non legare il suo
nome ad un personaggio con conclamate simpatie eretiche.
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La
principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le
donne della nobiltà andavano a cavallo e
a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel
galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno
profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime
provocando delle gravi patologie. Nell’estate
del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di
Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
Il
Belmonte consigliava alla lettrice di essere tollerante con quelle che erano le
“debolezze” del marito e, soprattutto, di restare casta e virtuosa.Isabella
ricordava nelle sue continue lettere al marito, di essere a conoscenza delle sue
relazioni extraconiugali invitandolo a porre un definitivo freno alla sua
condotta libertina.In
un’altra lettera dichiarava, in modo romantico, che l’avrebbe seguito fino in
India ma subito dopo colpiva con forzaVorrei
mi facessi gratia farmi far un vostro ritratto in uno anello,lo
stesso che quello voi dato di quella dama che lo desidero infinitamenteLa
dama a cui allude Isabella non fu identificata ma era certamente una delle
tante donne con cui Paolo s’intratteneva in rapporti ambigui. Potevano essere
delle cortigiane ma anche la “bellissima e
garbatissima senese” a favore della quale Paolo aveva implorato
presso Francesco i (fratello di Isabella !!!!) una deroga alle leggi suntuarie
affinchè potesse indossare abiti e gioielli che erano riservati solo alle donne
di maggiore rango.Paolo,
malgrado le sue infedeltà, sapeva benissimo che Isabella le sarebbe rimasta
sempre fedele ma, nel dubbio, erano in gioco non solo l’onore ma anche il
patrimonio del sig. Orsini.Isabella
viveva a Firenze da sola e il padre le dava un’ampia libertà.. i dubbi
sorgevano spontanei nella mente dell’Orsini perché non poteva controllare la
moralità della moglie e per questo motivo desiderava il suo trasferimento a
Roma.Isabella
desiderava ardentemente l’affetto, avrebbe potuto cercarlo e trovarlo altrove,
ma rimase fedele al suo ruolo di moglie, anche se sola e trascurata, come
risalta nelle sue espressioni letterarie e musicali e dalle lettere inviate al
maritoVostra
moglie, chi dorma sola nel suo lettoOppureTornerò
in villa (Baroncelli) alla mia vita solita solitudineerano
frasi con cui chiudeva le sue numerose lettere.La
dichiarazione più stravagante fu quella riportata in una lettera del 29 marzo
1566Io
sono solissima et molto scontenta et non mi sentotroppo bene et stamattina mi trovo a letto col mio
solitodolor
di testa ma credo nasca della grandissima solitudine etafflitione
in che hora mi trovo e troverò per molti mesi….Io
prego avermi per scusa se non vi scrivo più lungo perché ildolor
del capo non mi lassa Isabella
reagiva prontamente a qualsiasi insinuazione di Paolo sulla sua condotta. Nel
giugno del 1566 il marito l’aveva accusata di
“far musiche con il sig. Mario”.La
donna rispose subito con una lunga lettera in cui abilmente sviava la terribile
insinuazione e ricordava al marito che sapeva della sua condotta immorale
malgrado i suoi falliti tentativi di nascondere ogni cosaIo
non sono tanto bestia ch’udendo i fatti io non credo vi possete immaginarche
io mancho credere alle parole… vi pare
avere una moglie di cosìpoco
valore, come sono io…… anche se mio padre vi ha tenutoin
conto di figliuolo Un
commento per ricordare al marito che era, da sempre, in dipendenza economica del
suocero.In
un'altra lettera rispose alla accuse di Paolo
con un grande ironiaSto a Baroncelli perché posso meglio passar qua
le miemiserie
e non in Fiorenzo et volessi dio che le musiche che dite che focon
il Sig. Mario fusssino spesse che mi potessi levar laimmaginatione…
del pochi amor che mi portate,perché
né musica né altra cosa nissuna mi può levare quelloche
mi mostrano li fattiC’erano
diversi uomini di nome Mario che frequentavano la corte di Isabella ed uno era
il cugino del marito.Uno
era Mario Sforza di Santa Fiora a cui fu assegnato un incarico militare che era
ambito dallo stesso Paolo Orsini.Un
altro era un lontano cugino dell’Orsini, Mario Orsini del ramo di Monterotondo.Mario
orsini si guadagnava da vivere con le attività militari e per questo era
entrato al seguito di Paolo Orsini e anche alla corte di Cosimo I de’ Medici.Era
un uomo che si trovava a suo agio nella villa di Isabella intrattenendosi in
canti, musica o giochi.Era
lui il famoso sig. “Mario” verso il quale la principessa nutriva un sentimento
particolare ?Nel
lontano dicembre del 1562 Mario si trovava a Pisa per portare le sue
condoglianze a Cosimo I per la morte della moglie Eleonora di Toledo e dei
figli. Il suo fine era entrare a far parte del nuovo ordine militare fondato
dal duca: i cavalieri di Santo Stefano.Un
investitura che richiedeva denaro e Mario sperava di averlo dal fratello
maggiore, Troilo.Fu
Troilo la vera ragione per cui Isabella
potè schermirsi in modo convincente delle accuse che Paolo le aveva rivolto,
perché non era con Mario che, intorno al 1565, Isabella “faceva musiche”
bensì con suo fratello Troilo.Troilo
Orsini giunse a Firenze al seguito di Paolo Giordano
I Orsini ( un antico cugino) insieme ad
altri familiari e furono alloggiati, a vario titolo, nel Palazzo Antinori adiacente
a Palazzo Vecchio dove alloggiava lo stesso Paolo con la moglie Isabella de’
Medici. La sua venuta a Firenze fu dopo il 1558 anno del matrimonio tra Paolo
ed Isabella.Troilo
Orsini era figlio di Paolo Emilio Orsini,
Consignore dei Vicariati di Monterotondo e d’Imperia, e di Imperia Orsini, dei
Signori di Foglia. Dal matrimonio nacquero: Troilo, Cecilia, Paolo Emilio II.Secondo
le testimonianze storiche la famiglia Orsini risalirebbe al 333 d.C. con un
capostipite di nome Orsicino, generale dell’imperatore Costante rimosso dalla sua carica per una calunnia ed esiliato
a Roma. A Roma diede origine alla casata degli Orsini che già nel 589 era
celebre per le sue ricchezze e per i numerosi feudi in suo possesso. Famiglia
Orsini che era anche chiamata con l’appellativo “de filis Ursis”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Io
mi trovo a Firenze con molte belle donne a desinar meco
scrisse al marito nel maggio del 1566, tacendogli capire che aveva organizzato una serata per sole donne. Questi incontri, banchetti, serate di musica e danzanti, avevano alla base una mancanza di rispetto della quiete pubblica che Isabella e il suo seguito non rispettavano. Il sorriso sorge spontaneo nello scrivere pensando che negli anni sessanta del Cinquecento molti fiorentini erano “privati del giusto riposo notturno”.
Era in detto tempo moltiplicato in Firenze gran numero di cocchi, di maniera che tal volta era tanto il rumore che pareva rovinasse tutto Firenze; e massime la notte; che c’era la signora Isabella, figliuola del duca e moglie del signor Giovan Paolo Orsini, che spesso in sulle due ore in là, usciva di palazzo con i suoi cocchi, che erano quattro, sonando, urlando, fischiando, che parevano tanti demoni, lei come giovane, non considerando più altro, davano scandalo”. Ma chi erano questi demoni? Cortigiani al seguito di ambasciatori, giovani nobili fiorentini, cavalieri e paggi adolescenti che vivevano a casa di Isabella. Molti suoi amici e conoscenti, come lei stessa, figuravano tra i protagonisti delle “Duecento novelle” di Celio Malespini.
Un particolare dell’opera è che fu pubblicata quanto l’autore si trasferì a Venezia nel 1609 e si sentì al sicuro da eventuali rappresaglie. Un aspetto importante è che molti di queste novelle furono la base di molte espressioni teatrali inglesi. Un pubblico inglese che amava gli scandali avvenuti soprattutto presso le odiate corti papali.
Dalle novelle s’apprendono particolari su Elicona Tedaldi “un gentluomo amato molto, e favorito da Donna Isabella… dilettandosi anch’egli di cantare allo improvviso”.
Un altro personaggio delle novelle era il ferrarese Ridolfo Conegrano che era una presenza fissa a corte di Isabella.
Aveva un ruolo particolare con il suo repertorio di canzoni sguaiate ed era anche bersaglio di continue burle.
Ridolfo a Firenze frequentava assiduamente il palazzo di Isabella ed era l’unico luogo in cui si sentiva a suo agio tanto che disse al Duca di Ferrara: “Donna Isabella ha un suo loco fuori che va a Roma, dove quella signora li fece tante carezze con musicha e ballo tanto che passa… il tempo allegramente”.
Con la scomparsa del fratello Giovanni, avvenuta alcuni anni prima, morì a Livorno il 20 novembre del 1562 (a causa della tubercolosi e della malaria), nessuno era in grado di arginare, mettere freno, ad alcune espressioni spericolate della giovane sorella. Nel 1562 Giovanni aveva 17/19 anni mentre Isabella aveva compiuto i vent’anni.
Giovanni de’
Medici
(Firenze, 29
settembre 1543; Livorno, 20 novembre 1562)
Figlio
secondogenito di Eleonora di Toledo e di Cosimo I de’ Medici, fu
nominato cardinale
da papa Pio IV nel concistoro del 31 gennaio
1560.
Alla nomina aveva
diciassette anni e venne subito nominato amministratore
della arcidiocesi
di Pisa. Fino alla nomina a cardinale del fratello
Fernando I de’
Medici, era il porporato italiano più giovane.
Nel 1857, durante
la prima ricognizione delle salme de’ Medici, venne scritta
Una dettagliata
relazione. La sua salma:
“i
resti della toga cardinalizia consunti per la parte anteriore, ma rimasti
giacevano
in una cassa scoperchiata erano quello…”
(Artista: Lomi
Baccio
(?, 1550 – Pisa,
1595)
Olio su tela –
Misure ?
Collocazione: Pisa
Giovanni era stato
raffigurato più volte dal Bronzino. Questi ritratti
servirono da
modelli per la creazione della figura da parte del Lomi.
Giovanni presenta
la medesima impostazione, il medesimo sguardo e increspatura delle
labbra, nonchè la
medesima ricaduta ondulata delle ciocche dei capelli sulla fonte.
Di rilievo è il
particolare della resa materica della mantellina
cardinalizia, nel
profilo del colletto e nelle maniche della camicia
finemente
impunturate.
Da non confondere
con un altro Giovanni de’ Medici figlio
naturale di Cosimo
I de’ Medici e di Eleonora degli Albizzi,
nato a Firenze il
13 maggio 1567
Giovanni de’ Medici (figlio naturale di Cosimo I)
Isabella
aveva come segretario il senese Fausto Sozzini che aveva una sua formazione
culturale in teologia e legge.
(Siena, 5 dicembre 1539; Luslawice, 3 marzo 1604)
Teologo e riformatore religioso
I giochi erano
molto presenti nelle corti italiane, era un modo per
trascorrere in
modo piacevole i pomeriggi e le serate. Giochi a carte,
di memoria e di
cultura generale. Il primo testo di giochi apparso in Italia
fu quello di
Innocenzo Ringhieri, del 1551, dedicato a Caterina de’ Medici.
Il titolo era “Cento
giochi liberali et d’ingegno” ed era
un libro per sole
Signore. Tuttavia
dame e cavalieri giovano spesso in squadre contrapposte e le
Migliori giocatrici
si lamentano quando gli avversari maschi le lasciavano vincere,
togliendo alle
partite il piacere della competizione,
Nel 1662 Girolamo
Bargagli di Siena, scrisse un nuovo testo sui giochi dal titolo
“Il Dialogo de’
giuochi che nelle vegghie sanesi si usano da fare” e fu dedicato ad
Era un vero e
proprio catalogo di giochi dal carattere molto diverso da quelli
descritti dal
Ringhieri. Riuscì a censire ben centotrenta giochi che coinvolgevano
i partecipanti di
entrambi i sessi. Erano adatti a tutte le feste e pensati per un
numero elevato di
giocatori. Il Bargagli aveva l’obiettivo di stimolare l’interazione
piuttosto che
eleggere un vincitore.
.......”giuoco
del parlare all’orecchio, quando un giovane dice ad una donna in segreto
un
motto, e ella senza dir parola fa qualche atto... e si comanda ad un’altro
ch’indovini”..
il
“giuoco del a.b.c. quando si fa pigliare a tutti una lettera, e poi si fa dire
un vero, che
cominci
per quella” ....” quello della musica
del Diavolo, ogn’uno facendo un
verso
d’un animale”.
La maggior parte
dei giochi avevano lo scopo d’incoraggiare uno scambio
malizioso tra
uomini e donne.
Alcuni avevano
risvolti culturali o letterari.
Il
“giuoco del ritratto della vera bellezza” e il “giuoco della pittura” richiedeva che
morali delle dame
presenti, con un linguaggio che doveva imitare Petrarca o Ariosto.
Altri giochi
avevano lo scopo di rilevare segreti del passato dei giocatori, come il
“giuoco
delle disgratie in amore, dove ciascuno narra una disgrazia occorsali amando, e
il
giudice discerne se quella veramente fosse disgratia, o pur colpa e difetto
suo”.
C’erano anche dei
giochi riservati alle ore più tarde della notte, quando i freni
inibitori si erano
praticamente allentati. È facile pensare all’elite fiorentina intenta
al “giuoco delli schiavi” e al “giuoco delle serve e
de’servidori” in cui si fingeva che
uomini e donne
venissero comprati e venduti per essere messi al servizio di coloro
che li avevano
bramati. C’era il “giuoco dello spedale de’
passi, dove si finge che tutti
commodamente
sieno ricevuti”; un altro era quello del “maestro di scola” dove i
C’erano persino
giochi che sembravano blasfemi considerando quanto fosse
presente la Chiesa
nella società del tempo, in cui i giocatori fingevano di
essere monache e
frati e minavano delle cerimonie religiose.
Le serate a casa
di Isabella non erano delle feste organizzate da una
“matrona”. Un aspetto delle sue feste molto gradito
all’amico Conegrano
Erano i
“tentamenti dolcissimi”, quasi tutti gli intrattenimenti suscitavano
il brivido del
contatto tra i sessi, in gran parte di natura fisica. Sguardi e
sorrisi venivano
scambiati durante gli spettacoli teatrale, dopodichè gli ospiti
sceglievano un
compagno per le danze; reggere insieme la pagina di uno
spartito per
cantare offriva l’occasione di sfiorarsi
con le mani. Uomini e
donne sceglievano
la persona dell’altro sesso che trovavano più attraente
come compagno nei
giochi proposti. Isabella aveva in queste feste un ruolo
di regista ? Amava
godersi lo spettacolo dei suoi ospiti impegnati nei
giochi
mantenendosi in solitudine, in trepidante attesa del marito per
“pascersi dei suoi
raggi” come amava ripetere nelle sue canzoni ?
Questo forse non lo sapremo mai.
La principessa diventò spericolata anche sotto l’aspetto del suo profilo fisico. Le donne della nobiltà andavano a cavallo e a caccia ma il costume imponeva che fossero attente al loro corpo per procreare dei figli. Molte di loro nel galoppo sarebbero state attente nel saltare con il cavallo un fosso più o meno profondo. Una caduta avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime provocando delle gravi patologie. Nell’estate del 1563 durante una delle tante battute di caccia, nei pressi della Certosa di Firenze, subì un grave incidente.
Certosa di Firenze
Il
medico di corte, Andrea Pasquali,, data la gravità dell’incidente, inviò subito una lettera al padre Cosimo I de’
Medici
La
Signora Donna Isabella nostra, a hore XII circa cascò dalla schinea agiù
per una grotta d’altezza di cinque in sei braccia et ha percosso ilcapo
in la parte summa dove è gran contusione, imperò
non profondapiù presto per la superfice…..il petto va bene, le braccia e
la gambe tutte;imperò si duole assai, maxime nel muoversi.E per più securtà si è cavato oncie sei di sangue dalla parteopposita per fare diversione, oltre all’evacuazione.Si darà da mangiare una papa e dell’acqua e si
lascerà riposare.
Secondo un altro racconto “la
chinea della Signora Isabella andò pian piano in un fosso alto circa 20
braccia”. (Circa 37 metri).
È probabile che il dottore Pasquali abbia parlato a Cosimo I
di un fossato meno profondo per non allammarlo.
Un dato è comunque inequivocabile: nessuno era in grado di
fermare la grande vivacità di Isabella.
Il vuoto affettivo
causato dalla morte del caro fratello Giovanni fu forse in parte colmato
dalle persone che frequentavano la corte della principessa durante il giorno.
Ma nella vita della giovane donna c’era una mancanza
d’intimità e cioè la vicinanza di un coetaneo con cui dialogare e soprattutto
con una sensibilità simile a quella posseduta dal fratello Giovanni.
Con nessuno degli altri fratelli, Isabella si sentiva a suo
agio.
Con Francesco I c’era uno scarso affetto legato forse anche
al carattere del principe troppo misantropo, severo e distaccato mentre con gli
altri fratelli, Ferdinando e Pietro, c’era alla base una certa differenza
d’età. Avevano sette e dodici anni in meno rispetto a lei che aveva superato i
vent’anni e quindi non potevano essere
suoi confidenti.
È necessare fare attenzione a non cadere nell’errore di
considerare il legame tra Giovanni ed Isabella come “particolare”. Era un
legame di natura non fisica e la concezione di quell’antico rapporto, basato
sul dialogo e sulla comprensione, era sufficiente a mantenerla vicina al marito
Paolo Giordano Orsini. Nella sua vita
non ci sarebbe stato posto per nessun altro, da quanto si evince dalle sue
lettere, e questo malgrado le stravaganze del suo vivere.
In quel periodo il marito Paolo, con l’avanzare dell’età
diventava sempre meno attraente.
Raramente si formulvano dei commenti sull’aspetto fisico di
un uomo se non perché rivestiva quale ruolo sociale o politico molto
importante.
Paolo Giordano si faceva notare per la sua fisicità che ogni “giorno
diventata sempre più ingombrante”.
Paolo
Giordano I Orsini
(Autore:
Ottavio Maria Leoni
Roma,
1578; Roma, 1630
Dipinto:
Olio su tela ; Misure (63,4 x 50,4) cm
L’ambasciatore
veneziano a Roma lo definì “ di estrema
grandezza” pur specificando
cautamente, una precisazione necessaria per non cadere in pericolose critiche, “ma con tutto questo assai forte e gagliardo”.
Probabilmente
Isabella era intristita da diverse
problematiche legate al suo matrimonio: la continua lontananza del marito; l’obesità del marito e, soprattutto, il
tormento di un possibile tradimento e quindi infedeltà da parte dello stesso
marito.
Malgrado
fosse innamorata aveva dei forti dubbi sulla fedeltà del marito dato che
l’adulterio maschile era una normalità nella società rinascimentale. Un
problema molto grave tanto che era presente nella letteratura un manuale di
condotta scritto da Pietro Belmonte e dal titolo “Institutione
della sposa”.
La
suddivisione del Casato degli Orsini nei vari rami avrebbe avuto origine
in Matteo Rosso Orsini, detto il Grande
(1180; 12 ottobre 1246), figlio di Giovanni (Giangaetano) Orsini e di Stefania
Rubea (De Rossi).
Era
signore di decine e decine di Terre, nel 1234 fu podestà di Viterbo e nominato
senatore di Roma da Papa Gregorio IX nel 1241. Lo vediamo impegnato contro
l’imperatore Federico II di Svevia che era giunto a Grottaferrata per
impadronirsi di Roma. Nel 1246 fece testamento lasciando agli eredi il suo
immenso patrimonio e vestì l’abito di terziario francescano.
Si
sposò tre volte e da questi matrimoni nacque la complicata suddivisione del
casato degli Orsini:
-
Primo
Matrimonio con Perna Gaetani da cui nove figli/e:
Mabilia che sposò Angelo Brancaleoni;
Giacomo, religioso;
Ruggero;
Giordano, cardinale;
Andreola;
Mariola;
Gentile, capostipite degli Orsini di
Nola;
Giovannello
-
Dal
secondo matrimonio con Giovanna Dell’Aquila, ebbe tre figli/e:
Matteo,
detto di “Monte”, uomo d’armi;
Napoleone, capostipite degli Orsini di
Bracciano e Gravina.
-
Dall’ultimo
matrimonio con Gemma di Oddone di
Monticelli non nacquero figli/e.
Monterotondo
(Roma) – Palazzo Orsini
A
Rinaldo Orsini toccò quindi la signoria di Monterotondo. Una linea importante i
cui esponenti presero parte attivamente nelle lotte nella Roma medievale. Nel
1370la figlia di un discendente Giacomo, Clarice
sposò Lorenzo il Magnifico, Signore di
Firenze, il terzo della dinastia de’ Medici. Sul finire del XVI secolo la
dinastia decadde.Molti
suoi esponenti furono coinvolti in tristi vicende e persero i feudi per
confische o furono assassinati. Enrico e Francesco, gli ultimi esponenti della
linea, vendettero Monterotondo alla famiglia Barberini nel 1641.Troilo
viveva quindi a Firenze a spese del cugino Paolo, cercando di entrare nella
famiglia de’ Medici per rendersi disponibile ad eventuali incarichi da parte di
Cosimo I.Era
quindi al servizio di Paolo ricevendo degli ordini come…” Perché V.S. conosca più chiaramente ch’io, sono
desideroso che si spedisca il negotio del Pignatello (uno dei tanti
feudi di Paolo Orsini), et che quanto prima se ne
venchi, mando a posta Maestro mario Bartucci acciò che se ne dia fine ad ogni
cosa, et perché da lui V.S. intenderà pienamente in ciò il desiderio mio”.I
parenti di Troilo, che erano rimasti a Monterotondo, s’aspettavano dallo stesso
Troilo dei precisi rendiconti sull’attività di Paolo Orsini che era il “capo”
del nobile casato. Un vero e proprio controllo sull’Orsini dato
che le sue azioni avrebbero coinvolto potenzialmente tutti gli esponenti del
casato comprese quindi anche i rami collaterali.Alla
fine del 1563 lo zio Giacomo riferiva al nipote Troilo la sua
soddisfazione nel sapere cheLe
cose dell’Ill,mo Sig. Paolo Giordano (Orsini)
siano così beneincaminate….
Desiderando io infinitamente vedere la S.E. fuora deltravaglio
che…. devono apportare tanti debiti….. perché tutti honoreet
gloria di S.E. ancora alli suoi parenti, servitori et amicifarne
partecipare….. sarà sufficiente…. farli havere figliuolo”.Qualunque
azione negativa subita o intrapresa da Paolo Orsini avrebbe coinvolto tutto il casato.Tutti
gli Orsini, sia quelli di Monterotondo che quelli di Bracciano ( a cui
apparteneva il marito di Isabella de’ Medici), avevano dei gravissimi problemi
economici.Era
naturale per gli Orsini attendere con ansia la nascita di un erede da parte di
Paolo Orsini per consolidare ulteriormente il legame con la potente famiglia
de’ Medici.L’estate
successiva lo stesso zio Giordano
scriveva nuovamente a Troilo con una certa preoccupazionePrego
V.S. darmi avviso certo della gravidanza della S.Ra Donna Isabella,et
di quanto tempo et esendo certa, come desidero, ricordar qualchevolta
con buona occasione all’Ill.mo Paulo Giordano, che li piacciafarla
governo di sorte, che non le succeda come l’altra volta”.Il
significato di questa lettera è chiaro. Era infatti opinione diffusa che il
comportamento stravagante di Isabella con i suoi continui divertimenti e le
ripetute e pericolose battute di caccia a cavallo, avevano provocato in passato
degli aborti spontanei. Nella
famiglia Orsini era opinione diffusa e chiara che il marito Paolo Orsini non
avesse alcuna autorità sulla moglie.Su
questa presunta gravidanza dell’estate 1564 anche Ridolfo Conegrano in una lettera
al Duca di Ferrara Alfonso II d’Este scrivevaSi
tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida ancora… lei dica non esservero
e non voglia confessareIl
comportamento di Isabella era completamente differente da quello delle altre
nobildonne che sarebbero state fin troppo ansiose di rendere nota la loro
fertilità.Troilo
era autorizzato a nutrire un certo interesse verso Donna Isabella in quanto
moglie del cugino che era un importante veicolo per le fortune del casato.Poteva
cantare, ballare con lei ma sempre rispettando le regole… una principessa
“intoccabile” e di “proprietà” dell’ Orsini a cui era vietato accostarsi….Isabella
con il suo carattere si riteneva libera e Troilo era un uomo ambizioso ed
esponente di un casato in bancarotta. Lo
stesso Troilo fece un attento studio sulla sua situazione a corte e capì che
per avere un certo peso nella corte medicea non servivano i favori di Paolo
Orsini ma bensì la simpatia di Isabella.Era
animato da un grande desiderio d’affermazione, che sfiorava la disperazione, e
non aveva una grande simpatia per il cugino Paolo.Il
suo interesse per Isabella fu evidente nei mesi successivi alla morte di
Giovanni de’ Medici, fratello della donna. Il Troilo si trovava lontano da
Firenze e ricevette da un amico una lettera con una minuziosa narrazione dell’incidente della
caduta da cavallo di Isabella. “L’Amico”
conosceva benissimo l’interesse del Troilo verso la principessa a tal punto da
volerlo informare dell’accaduto.Nella
sua visione della realtà, Isabella era
solo un mezzo per il raggiungimento di una posizione sociale più elevata ?La
donna era una “stella” della corte
medicea con la sua intelligenza, vivacità e fascino, e quindi oggetto di
desiderio.I
sentimenti di Isabella verso Troilo ? I riferimenti non sono molto chiari in merito.Troilo
era un giovane bello ed affascinante, avevano pochi anni di differenza, e al
contrario di Paolo Giordano Orsini aveva impugnato le armi e compiuto delle
imprese coraggiose. Nella
visione di Isabella il giovane assomigliava al famoso nonno Giovanni delle
Bande Nere, un personaggio che sembrava
uscito da un racconto dell’Ariosto e che animava la sua immaginazione
rievocando un antico romanticismo.È
vero era cugino del marito, un aspetto che rendeva molto pericoloso la nascita
di un amore, ma nello stesso tempo più eccitante.C’era
una realtà che sembrava favorire la nascita di questo amore: la sua solitudine
causata dalle lunghe e ripetute assenze del marito, la libertà di cui godeva,
le relazioni extraconiugali del marito che sembrava aver perduto ogni dialogo
con lei malgrado la presenza di fredde lettere.Triolo
la poteva raggiungere facilmente a Palazzo de’ Medici oppure a Villa Baroncelli
dove era sempre sola.Fra
Isabella e Troilo si accese una segreta
relazione tra il 1564 o il 1566.La
donna aveva numerosi contatti e nelle sue serate cantava con paggi, ambasciatori
e cavalieri ma nessuno era in gradi di offrirle quello che cercava ..un
contatto a livello profondo e personale.Troilo
non fu probabilmente solo un amante perché riuscì a rivestire quel ruolo di dialogo che la
donna aveva con il fratello Giovanni.Il
padre Cosimo I avrebbe potuto censurare il comportamento della figlia ma non
intervenne e sembra quasi che abbia acconsentito la nascita di questo legame
perché si rese conto che il matrimonio non l’appagava e Troilo giunse proprio
nel momento in cui la donna aveva il bisogno di colmare un profondo vuoto
sentimentale. la
loro relazione era certamente nota a molta gente ma la regola vietava di
parlarne e tanto meno di farvi cenno per iscritto. Celio
(Orazio) Malespini (Malespina) , nato nel 1532 e di cui s’ignora il luogo di
nascita (forse Verona), fu autore delle “Duecento Novelle” e una delle novelle
riguardava il rapporto tra Troilo ed Isabella. Naturalmente non poteva farne i
nomi e dipinse i protagonisti come complici di un misfatto invece che di una
relazione amorosa.Nella
novella Isabella era adirata perché Ridolfo Conegrano, l’ambasciatore ferrarese
che considerava suo devoto spasimante e che fingeva di ricambiare, s’era
innamorato di una giovane che era amata da Troilo.Isabella
e Troilo studiano un intrigo per punire Conegrano.Fanno
in modo che l’ambasciatore inviti la giovane a cena nella propria casa.“Trà
tanto, Donna Isabella vestitati da huomo, accompagnata dall’Ursino (Orsini), e
duo altri gentilhuomini suoi confidati, conducendo una schiava, che era venuta
da Livorno, brutta, e sozza, come un mostro, ma però assai giovane, quale non
intendeva nulla il nostro idioma (lingua)”, raggiunse la casa
dell’ambasciatore.Qui
i complici avvicinano un mozzo di stalla, gli fanno giurare di tenere la bocca
chiusa e gli chiedono a che punto della cena si trovasse il padrone di casa e
la sua ospite.“Quasi
alla fine” risponde il famiglio.Isabella
quindi indaga la possibilità di andare “senza essere veduti da alcuno, nella
camera là dove egli dorme” e il mozzo mostra la strada. Portano allora la
schiava nella stanza da letto e la depositano “ignuda come nacque” nel letto
dell’ambasciatore; trovandolo “morbido, e delicato... essendo... assai stanza,
subito s’addormentò”.Nel
frattempo, durante la cena, la giovane si congeda e invita Conegrano a
raggiungerla dopo poco nella stanza da letto di lui; invece di recarvisi però,
raggiunge Troilo e Isabella nella stalla. Conegrano sale quindi nella sua
stanza dove entra senza accendere le torce, intravede una figura sdraiata nel
letto e l’avvicina con l’intenzione di appagare il suo desiderio. A quel punto
la schiava si mette a urlare nella sua lingua: “Io non voglio, io non voglio,
cane, o Dio agiutami !”; Conegrano salta fuori dal letto, chiama qualcuno che porti
la luce, e rimane inorridito davanti al “sozzo, e contrafatto ceffo della
brutta schiava, che credendosi ch’ella fusse la bella giovane, l’haveva baciate
cotante volte così avidamente le labbia”.Troilo
ed Isabella si precipitano allora al piano superiore dove Isabella rimprovera
Conegrano sperando che abbia imparato la lezione per l’incostanza dimostratale:“Io mi sono voluta vendicare, nel modo ch’io ho potuto,
disturbandovi i vostri difetti, e piaceri: meritando voi però magior castigo;
poiché non rispettate punto le donne altrui”.Conegrano,
ascoltando impietrito, ammette la sua vergogna: Troilo propone che la schiava
possa trascorrere il resto della notte nel letto accogliente con la promessa
che i servitori di Conegrano “non la
trattino così male, come hanno fatto poco innanzi”.Conegrano
accetta, accompagna gli ospiti alla porta e “il povero schermito Ambasciatore,
se n’andò a dormire in un altro letto, credendo che il suo fusse tutto pieno di
pidocchi”.
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Nella
novella la relazione tra Isabella e Troilo è platonica ma è con Troilo che la principessa gira per
Firenze travestita da uomo come facevano le cortigiane veneziane quando
volevano uscire per strada.Per
un lettore del XVI secolo, questo particolare della storia, la principessa che
si traveste da uomo, sarebbe scandaloso tanto quanto le imprese sessuali al
centro del racconto.Forse
Isabella non dichiarò mai apertamente il suo amore per Troilo ma rese noto il
suo amore con altri mezzi come la poesia e la musica.Esistono
una serie di lettere tra Isabella e Troilo dalle quali traspare una profonda
malinconia che ritroviamo anche nelle poesie e nelle canzoni eseguite nella
villa Baroncelli. Nelle lettere d’Isabella
i sentimenti sono espressi in maniera simile a quelli dichiarati per il
marito. Le
lettere inviate al marito venivano lette da tutti mentre quelle per Troilo
erano tenute nel massimo segreto e che per questo motivo assumono un
significato molto profondo perché coinvolgono due persone che non possono esprimere apertamente i loro sentimenti e non possono
stare insieme ogni volta che lo desiderano.Una
situazione che probabilmente non dispiaceva alla donna che era affascinata dall’immagine dell’eroina
evocata nelle sue canzoni d’amore ed infatti scrivevaIo
ho ricevuto una lettera di V.S. a me di grandissimo contento,et
più me saria stato la presenza di quella, da me tanto desideratapiù
che la propria vita.V.s.
mi fa torto a dubitare che la lassi, che mai da me si darà occasionedi
perdermi tanto bene e un Signore da me tanto desideratoet a
chi sono schiava et hubrigata in eterno,et a
chi se degnato per sua benignità farmi degna dell’amor suo.V.S.
stia assicurata che a me non pare esser niente e smarita e persa,e
ogni ora mi par mille, et se non fossi la grande speranza che hodi
rivederla, a quest’ora saria finita. Et
confidomi nella grandecortesia
sua, col supricharla che il ritorno sia più
presto cheElla
può, se quella punto ha cara la vita mia….Sono
numerosi i riferimenti sulle lettere inviate da Troilo ad Isabella ma una sola
s’è salvata dalla distruzione del tempo. Troilo
omette il nome della destinataria ma mette il proprio nome nel firmarla.La
lettera rispondeva ad una missiva inviata da Isabella nella quale rimproverava
Troilo di aver parlato troppo liberamente della loro relazione.Un
problema che viene affrontato anche in una delle sette lettere che furono
attribuite ad Isabella e nella quale mette in guardia Troilo nei suoi rapporti
con Francesco SpinaGuardi
lei non so che homo sia da tener le segreteChi
era Francesco Spina ?Era
il tesoriere del fratello Francesco I ed Isabella aveva dei validi motivi per
desiderare che il Troilo si tenesse lontano da luiNell’unica
lettera non perduta di Troilo, l’uomo risponde anche ad un sospetto avanzato da
Isabella che la lettera, ricevuta in precedenza, non fosse scritta
personalmente da lui perché dimostrava una competenza troppo raffinata della
lingua toscana.L’uomo
era nato a Roma e la sua lingua era diversa da quella di Isabella che conosceva
benissimo il toscano.Il
Troilo risposeA
scusarmi e a dolermi, se bene sarebbe più a proposito il parlare con voia
bocca che scrivere, imperò io vi ho voluto scrivere questa per più unacertezza
della mia servitù, la quale non credevo che Voi stimassi si leggierach’io
dovessi comunicare con nessuno quello che passa tra Voi e me,avendo
a cuore l’onor vostro quanto la vita propria.Quanto
poi io non abbia né composta né scritta l’altra mialettera,
non so farne d’altro in certificazione
d’essa, che mandarvi lapresente,
assicurandovi che la mia ignorantia è aiutata tanto da l’amore,che
mi farebbe fare altro che mettere insieme cinquanta parolefiorentine,
sì che, padrona mia cara, abbiatemi per vostro fedelissimoservitore,
se bene mi ha generato in me un poco di sospetto dinon
essere da voi amatoMalgrado
le attenzioni, i due innamorati sapevano benissimo che la loro relazione non
era un segreto.Un
rappresentate dei Medici, Ciro Alidosi, scrivendo dall’Emilia Romagna, domandò
al segretario di corte Antonio Serguidi di consegnare alcune lettere a Troilo e
Isabella, dando per scontato che i due si trovassero insieme.Lo
stesso Troilo riceveva continue suppliche da parte di amici, familiari e
conoscenti per un suo intervento presso Isabella per avere dei favori.In
merito c’è una lettera avanzata nell’agosto del 1654 da parte del nobile Sforza
Aragona di AppianoIll.mo
Cugino e Sig.mio osservandissimo. Io invio alla Signoria V.Ill.mauna
lettera della Signora mia consorte che va alla Signora dogna Isabella cheè in
risposta a una sua per causa che S. Ecc.Ill.ma si degna di fare tener dimano
a battesimo ad una bambina che in questa notte in quattro hore e mezzomia
Signora consorte per Dio grazia partorì, et è bona sanità dell’uno etl’altra.
Però V.S.Ill.ma sarà contenta del buon recapito et procurarne risposta.Troilo
aveva altri parenti che gravitavano nella corte medicea ma la richiesta dello
Sforza Aragona dimostrerebbe come fosse a conoscenza del rapporto preferenziale
che il cugino aveva con la principessa. In ogni caso la principessa, a quanto
sembra, battezzò la bambina.Questa
forte influenza che il Troilo aveva sulla donna, finì con il valicare i confini
del vasto ducato.Nel
maggio del 1564 l’uomo ricevette una lettera da un certo Lepido Massarini che
gli ricordava di essere stato al suo servizio come soldato in Francia.Il
signor Lepido era stato imprigionato in un carcere di Siena con una pena di
“più anni” per aver eseguito un crimine, non specificato, che aveva causato “gravissimi
danni ai figli e moglie”.Il
prigioniero chiedeva a Troilo di “fare una parola a S. Paolo Giordano mio signore e
mandare quella sua indirizzato all Ill.mo Sig. Principe, nel quale domanda la
liberatione”.Non
si sa se Paolo Giordano Orsini sia intervenuto
perché il Lepido, due anni dopo, era ancora in prigione. Nell’aprile
del 1566 il detenuto fece un altro tentativo riscrivendo al TroiloIll.mo
mio Signore, con ogni debita reverentia humilmente le fo intendereche
essendo hormai stato mesi 37 in Siena carcerato da necessità costretto,son
stato costretto mandar a codesta felicissima Corte la mia moglie, acciòche
ella, con favore e potentissimo braccio di V.S. Ill.ma negotii,se
possibil sarà, la mia liberatione…… Il desiderio mio sarebbe,siccome
molto meglio da mia moglie piacendole però potrà sapere,che
V.S.Ill.ma presentasse mia moglie avanti la Ill,ma etEccell.ma
Signora Donna Isabella la quale per sua natural bontàet a
sua istanza facesse sì che si presentasse il memoriale che mia mogliele
daria, all’Ill.mo et Ecc.mo Signor Principe suo fratello, ottenendoV.S.Ill.ma
per grazia specialissima dalla sopraddetta Eccll.maSignora
che, presentando detto memoriale al Signor Principe,mi
mandasse in grazia.Una
lettera gravissima perché dimostrava un aspetto che per i due innamorati era
pericoloso.Il
Lepido, pur essendo in prigione, aveva scoperto di avere più possibilità
d’ottenimento della grazia chiedendo aiuto a Troilo nell’intercedere presso
Isabella piuttosto che rivolgersi al marito di lei. Qualcuno gli aveva
consigliato di mettere la moglie sotto la protezione di Troilo per fare un
passo importante verso la donna.Un
povero carcerato , anonimo, sconosciuto, era riuscito a sapere quindi, nella
prigione di Siena, della forte relazione esistente tra i due innamorati.Una
relazione che era ormai nota a tutti e
che andava avanti probabilmente dal 1564
e al momento della lettera di Lepido eravamo nell’aprile del 1566,
………………….
11.
Giovanna D’Austria sposa Francesco I de’ Medici
Il
18 dicembre 1565 Francesco I de’ Medici, fratello d’Isabella, sposò Giovanna
d’Austria ( d’Asburgo) e la città di Firenze era a festa.
Giovanna
fece il suo ingresso trionfale da Porta al Prato.
Intorno le strade sono arricchite da archi di
trionfo, statue, fontane.La
cerimonia nuziale nella Basilica di Santa Maria Novella.
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Per
l’occasione del matrimonio vennero realizzati
bellissimi edifici con l’intervento di artisti come il Vasari, il
Borghini, il Caccini, ecc:-
Il
Corridoio Vasariano (realizzato da Giorgio Vasari, architetto, pittore e storico
dell’arte – Arezzo, 30 luglio 1511; Firenze, 27 giugno 1574); un percorso
sopraelevato che collega Palazzo Vecchio, residenza del Governo, a Palazzo
Pitti, residenza del Granduca;
Giorgio Vasari
-
Il
mercato delle carni, posto sul Ponte Vecchio, venne spostato nell’attuale
Piazza della Repubblica. Uno spostamento reso necessario a causa dei cattivi
odori e dello spettacolo indecoroso. Al posto del mercato sorsero le botteghe di orafi e di gioiellieri.
-
Il
cortile di Palazzo Vecchio venne decorato con stucchi e pitture (affreschi del
Michelozzo) che riproducevano alcuni centri dell’impero austriaco (Vienna,
Insbruck, Praga, Costanza), in onore della sposa. Un’iscrizione in latino,
posta sulla parete orientale, dava il benvenuto alla principessa:
Caesaris invicti
augusti pulcherrima proles”
Giostre,
tornei, mascherate coinvolgeranno la città
per molti giorni.Feste
fiorentine che furono coordinate dal monaco benedettino Vincenzo Borghini,
priore dell’Istituto degli Innocenti e luogotenente di Cosimo I de’ Medici
nell’Accademia del Disegno. A
corte ci saranno degli spettacoli con scenografie del famoso Bernardo
Buontalenti. Venne messa in scena la commedia “La Cofanaria” di
Francesco D’Ambra al cui centro c’erano di intermezzi che narravano la storia
di Amore e Psiche.
“La Cofanaria”, in
versi sdruccioli, scritta nel 1550 – 1555-
la giovane Laura,
creduta vedova di Claudio Fidamanti e figlia del vecchio Ilario.
Ippolito, che ama
invece Marietta, cerca di evitare il matrimonio.
Alla fine si
scopre che Claudio non era morto e quindi Laura non è vedova e
Marieta risulta
essere figlia dello stesso Ilario.
(A seconda del tipo
di parola che termina il verso si parla di verso tronco, piano o sdrucciolo.
una parola piana
(accento sulla penultima sillaba) e sdrucciolo se termina con una
parola sdrucciola
(accento sulla terz’ultima sillaba).
Francesco d’Ambra
(Firenze, 29 luglio 1499 – Roma, 1558), commediografo
Giovanna d’Austria
(Alessandro Allori
– 1535/1607
Datazione del
dipinto: 1570
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Francesco I de’
Medici
Artista: Allori ?
Collocazione:
Uffizi - Firenze
Con
il matrimonio stava per iniziare per Giovanna d’Austria una nuova vita ?La
risposta è negativa perché la sua vita coniugale sarà costellata da umiliazioni
e continue soprusi psichici che finiranno con minare il suo fragile stato di
salute già precario per le numerose patologie.Giovanna
d’Asburgo, nota come Giovanna d’Austria, (Johanna von Habsburg
o Johanna von Österreich), era nata a Praga il 24 gennaio 1547. Per
nascita era Arciduchessa d’Austria perchè figlia (ultima di 15 figli) di
Ferdinando I d’Asburgo (fratello di Carlo V), imperatore del Sacro Romano
Impero, e di Anna Jagellone, figlia del re d’Ungheria e Boemia Ladislao II.Per
motivi dinastici fu forse messa in disparte ma non per questo non ebbe
pretendenti malgrado le cronache parlino di una ragazza non molto bella.Una
ragazza sfortunata, privata dall’affetto dei suoi genitori e in preda a gravi
problemi fisici.“Curva in avanti, per via d’una deformazione della colonna
vertebrale; bassa; il viso appuntito, lungo; gli occhi sporgenti, no…. La
pulzella non è bella ma porta come dote
un pesantissimo titolo nobiliare”.“La povera donna aveva una colonna vertebrale orribile. Una
cifosi (gobba) e una lordosi (tratto lombare molto marcato) eccessive, tanto da
avere il bacino quasi orizzontale. Per
rimettere insieme le vertebre della povera donna dovettero sicuramente usare la
plastilina quando normalmente una colonna vertebrale si riesce alla meglio a
rimetterla insieme senza bisogno di fissanti. Immagino il dolore giornaliero… e
soprattutto nel partorire!!!!” (Prof.ssa Donatella Lippi, Storia della
Medicina)I de’ Medici avevano una grande ambizione di
scalata sociale e il matrimonio con una
principessa asburgica poteva rappresentare un successo fondamentale nell’ascesa
della casata. Già
nell’ottobre del 1563 Cosimo I chiese ufficialmente la mano di Giovanna ma le
trattative si prolungarono fino al 1565 a causa della morte dell’imperatore
Ferdinando d’Asburgo (25 luglio 1564) e dell’intervento del Duca di Ferrara
Alfonso II d’Este che mirava, anche lui, alla mano della sedicenne ragazza.
Nacque addirittura una questione diplomatica in merito alla precedenza della
richiesta di matrimonio tra i Medici e gli Este.All’inizio
del 1565 le trattative furono concluse e nel mese d’ottobre Francesco I, che
era stato già elevato al rango di
principe, si recò ad Innsbruck per conoscere la sposa, dopo aver avuto
l’assenso del re Filippo II di Spagna.Nell’occasione
lo stesso Francesco I de’ Medici portò a Giovanna e al fratello l’imperatore
Massimiliano II, dei ricchi doni per rafforzare il prestigio internazionale dei
Medici.Francesco
I, aveva ragione la sorella Isabella de’ Medici, nel descriverlo non era per
niente sincero dato che il cuore era da tempo impegnato con l’intrigante ed
avvenente Bianca Cappello. Era solo un
matrimonio dettato da regole politiche. I due promessi sposi si recarono poi a
Firenze per strade diverse.
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel
dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna
d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Francesco I de’
Medici
Artista: Sofonisba
Anguissola
(Sophonisba
Angussola / Sophopnisba Anguisciola
(Cremona, 1532
circa – Palermo, 16 novembre 1625)
Misure (85,4 x
146) cm – Collezione Privata
Nel dipinto che ritrae il matrimonio di Francesco I con la regina Giovanna d’Austria, Isabella de’ Medici appare alla spalle della sposa.
Si nota Isabella
de Medici alle spalle della sposa
(Artista: Jacopo
Ligozzi
Verona, 1547;
Firenze, marzo 1627
Fu definito
“pittore universalissimo” per i suoi molteplici temi
Isabella
accompagnò Giovanna d’Austria, anche due giorni dopo le nozze, in carrozza al
Duomo per una solenne messa cantata.
Dopo
le nozze ci furono i festeggiamenti che durarono ben due mesi. Festeggiamenti
animati con “assurde” cacce di animali selvatici, per l’occasione furono
importati orsi ed altri animali esotici. Le celebrazioni ebbero il loro culmine
nel carnevale che fu particolarmente sfarzoso.
Il
marito di Isabella de’ Medici, Paolo Giordano non poteva mancare in
quell’occasione e approntò degli addobbi straordinari pensati per primeggiare
sugli artisti che si erano adoperati per abbellire le strade.
Commissionò
al pittore fiorentino Santi di Tuto,
allora giovane ed emergente, una serie
di decorazioni provvisorie da disporre in Piazza San Lorenzo.
Vasari
citò l’artista affermando come “ con molto ed incredibile fatica… dipinse di chiaroscuro, in più pezzi di tele
grandissimi istorie de atti di più uomini illustri di casa Orsini”.
Fu
eretto un grandissimo palcoscenico in
legno in piazza San Lorenzo per uno spettacolo in cui furono protagonisti lo
stesso Paolo Giordano Orsini e il cognato Francesco I de’ Medici. Tra gli spettatori Cosimo I de’ Medici con la
fianco la figlia Isabella, vestita con un bel abito di seta bianca.
Ridolfo
Conegrano, che aveva assistito allo spettacolo, riferì alla corte di Ferrara
che
Si
fece il torneo del Sig. Paolo e riuscì benissimo.Il
principe su una stella che viene sul nel cielo et in huomo sopra, et si fermònel
mezzo del teatro et subito si sentì una musica de Quattro fanciullich’era
sul lato di una banda del teatro…. Poi finite…… con moltorumopre
et fuochi et usca il Sig. Paolo et Pirro Malvezzi vestiti d’armebianche
gravate et di tella d’aregento et seta biancha et havevano conloro
due paggini vestiti delle medesime telleta et sei tamburi,sei
trombetti et due angeli, girati il campo si fermarono da uno capodel
teatro, poi compare la nave degli Argonauti con cinque cavalieri.A
questi spettacoli seguirono delle giostre a cui presero parte Francesco I,
Paolo Orsini ed altri nobili e “poi si fece una
collatione sontuosissima et al fine tre dame et tre cavaglieri armati tutti di
biancho su bellissimi cavalli fecero la battaglia balletto. Fu cose
meravigliose da vedere”.
Le
esibizioni di cavalli danzanti era uno spettacolo fisso nei grandi
intrattenimenti delle corti europee.
Naturalmente
molti si domandarono il costo di un simile e grandioso evento soprattutto alla
luce della grave situazione finanziaria dell’Orsini.
Molti
commentatori registrarono delle cifre di spesa accompagnate da un certo stupore
e il Conegrano fu abbastanza preciso nella sua dichiarazione
La
spesa è stata di 15 mila scudi ma al mio giudizio è 7 o 8, perchéin
vero la maggior spesa era nel teatroUna
volta conclusi i festeggiamenti Giovanna d’Asburgo si dovette adattare ad uno
stile diverso da quello in cui era abituata anche se intrisa da profonde
delusioni dovute alla mancanza d’affetto da parte dei genitori.
Aveva
portato con sé delle dame di compagnia
che a Firenze erano chiamate le “tedesche” e con cui conversava naturalmente nella sua
lingua madre.
Nonostante
il conforto delle sue dame di compagnia doveva integrarsi nella nuova famiglia.
Un obiettivo non facile da raggiungere per diversi motivi.
Il
suocero Cosimo I era sempre benevolo con
le donne e a maggior ragione con la
nuora, a differenza di Francesco I alla cui base c’era scarso interesse per la
moglie dato che il suo cuore da sempre era rivolto alla famosa Maria Cappello.
Per
Francesco I il matrimonio, a prescindere dalle sue importanti motivazioni
politiche, era basato solo sulla nascita di potenziali eredi. Una grave
mancanza di rispetto nei confronti della donna
sul quale era un opinione diffusa che per “per
la sua statura molto piccola e magra… vi è opinione che per questo rispetto non
sia atta a generare”.
Eppure malgrado queste forti differenziali
caratteriali, Isabella trattò sempre con affetto la cognata, dandole quell’amore, quella comprensione e il
dialogo che le mancavano da parte del marito
Nel caldo maggio del 1566, Isabella
si era ritirata a Villa Baroncelli e scrisse:
Mi
trovo di nova oggi a Fiorenza a visitar la principessa et desinatoin
palazzo et sono stata lì tutto il giorno della notte.
A
Giovanna piaceva molto la frutta e ogni volta che Isabella si recava lontano da
Firenze, gli faceva recapitare delle ceste di deliziosi frutti che prelevava
nei numerosi giardini di famiglia…”non ho
manchato far subito al mio arrivo diligentia di frutta et quelle poche si sono
trovate se li mandano”, le scrisse in una lettera da Pisa nel maggio
del 1568.
Giovanna Garzoni
(Ascoli Piceno,
1600; Roma 10/15 febbraio 1670)
Pittrice e
miniaturista
Nell’
ottobre del 1568, Isabella si trovava a Poggio
a Caiano..
Andando per questi giardini ho trovato queste poche
frutteche
con questa mia le invio, quella accetti
con il bono animoIsabella
si rivolgeva a lei, che era sei anni più
giovane, con atteggiamenti sempre gentili e rispettosi. Diceva sempre di averle
voluto scrivere per
Ricordarmi
a nostra altezza per quella affetionatissima servache
li sono et sarò sempre mentre viva.Teneva
sempre ben presente l’etichetta e il protocollo che erano molto sacri presso la
corte asburgica.
Giovanna,
che era sempre sola e isolata dal marito, come molte moglie straniere dopo il
matrimonio, non sempre erano trattate con garbo dai parenti acquisiti e quindi
apprezzava molto i gesti della cognata.
La stessa Isabella fu felice quando uno
dei suoi servitori, Luigi Bonsi, fu accettato dallaPrencipessa….
Nella sua comitiva per mio amore che…. la servirò di coreLo
stesso Bonzi diventò informatore di
Isabella su quanto accadeva a Palazzo Vecchio e l’aggiornava su eventuali
dicerie che la riguardavano e che
circolavano tra quelle pareti..
Inoltre
fu probabilmente grazie a Giovanna,
incoraggiata da Isabella, che il suo amore Troilo Orsini ricevette un incarico
particolarmente importante ed ambito da tanti.
Nel
1567 si recò in Germania con il prestigioso compito di rappresentare i
Medici alle nozze del cugino di Giovanna, il duca di Baviera (Alberto V sposava
Anna d’Austria), che l’aveva a sua volta scortata a Firenze appena un anno
prima.
Era
questo il genere di incarico che Troilo desiderava perché gli offriva la
possibilità di ricevere doni, stringere rapporti e coltivare la propria
immagine in un largo scenario europeo.
Isabella
aveva cercato più volte di realizzare i desideri del compagno quando si presentavano le occasioni
opportune.
Nel
gennaio del 1567 Troilo raggiunse Mantova, in qualità di rappresentate
della duchessa Isabella, per portare una missiva indirizzata alla duchessa
Eleonora d’Austria moglie del duca di Mantova Guglielmo Gonzaga..
Gl’ho
commesso et venga a basarli la mano in mio nome et così diquella,
come della singolari osservanza mia verso lei.Supllico che li presti intera evidenzaIl
nuovo incarico in Germania era molto prestigioso e ci vollero numerosi
stratagemmi, da parte di Isabella, per
far si che la scelta del rappresentante cadesse proprio su Troilo.
L’uomo
non aveva infatti una formazione diplomatica e non era nemmeno fiorentino.
Sicuramente
non fu scelto da Federico I ma piuttosto da Giovanna dietro le insistenze e le
indicazioni di Isabella.
I rapporti tra Federico I e la moglie Giovanna
non erano dei migliori dato che veniva anche esclusa dalle questioni politiche.
La donna aveva però la sua voce nelle questioni che riguardavano la sua terra d‘origine
e probabilmente, sfruttando questa prerogativa, aveva scelto proprio Troilo.
Comiso
I probabilmente sorrise sulla scelta di Troilo e capì che c’era l’influenza nell’incarico
sia della nuora che della figlia assecondando la decisione.
Francesco
I invece fu molto irritato dalla scelta
e fece redigere dal segretario di corte, Bartolomeo Concino, una lunga lista di
istruzioni su come comportarsi ad ogni passo del viaggio, rivolgendosi a Troilo
con il “tu” come a ribadire la propria posizione di superiorità su un suddito
che non gli era molto simpatico.
La
questione secondo il segretario Concino era la precedenza…”Avvèrtiti soprattutto che se fusse personaggio per il
Duca di Ferrara, non gli cediati in modo altro né pubblico o privato….. per non
pregiudicare al possesso che habbiamo della precedenza”.
In
tutte le corti, sia della penisola che d’Europa, c’erano dei rappresentanti
fiorentini e ferraresi che litigavano
per ottenere la precedenza nelle processioni, negli incontri con i capi di
Stato, oppure a tavola.
Troilo
svolse in modo brillante il suo prestigioso incarico di rappresentante alle
nozze tedesche del cugino di Giovanna d’Asburgo, tanto che due anni dopo gli fu
affidato un incarico politicamente più delicato.
Nell’aprile
del 1568, fu inviato alla corte di re Carlo IX di Francia con il preciso
incarico di “congratularsi con la Sua
Cristianissima Maestà per la vittoria contro il principe di Condè”.
In realtà il motivo del suo viaggio in
Francia era quello di congratularsi con Carlo IX e la madre Caterina de’ Medici
per la sconfitta inflitta agli ugonotti a Jamac, nell’ambito delle guerre di
religione tra la corona e i protestanti rivoltosi. Tra le lettere affidate a
Troilo, una era di Cosimo I nella quale il duca non si limitava alle semplici
congratulazioni ma s’impegnava ad offrire un aiuto militare alla Francia
Invieremo
un contingente di 2000 fanti della nostra milizia e100
cavalieri…. così da spargere il nostro sangue, poiché v’è bisogno disopprimere
ed estinguere quei ribelli sedizioni e nemiciSicuramente Cosimo I, nell’interesse dei Medici e nel suo
ruolo di sovrano, capì che era opportuno mostrare in questa guerra un sostegno
alla corona francese.
Qualche
mese dopo gli ugonotti subirono un’altra forte sconfitta a Montcontour e Troilo
fu nuovamente inviato a Parigi con il compito di portare non solo le
congratulazioni per la nuova vittoria ma anche le felicitazioni per le recenti
nozze di Carlo IX.
Il
re francese sposò Elisabetta, figlia
dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Asburgo e infanta di Spagna,
nipote di Giovanna d’Asburgo. (Massimiliano II era fratello di Giovanna
d’Asburgo).
Giovanna
d’Asburgo richiese personalmente a Cosimo I, da parte della nipote, di inviare
il suo medico Filippo Cauriano per assisterla alla corte francese.
Fu
in questa missione a essere immortalata in un dipinto che fu simbolo degli
antichi rapporti tra la Francia e il Casato dei Medici.
(dipinto di
Anastasio (Anastagio) Fontebuoni
(Firenze, 1571;
Firenze, 1626)
(Misure (188 x
233) cm
Nel quadro
Caterina de’ Medici e Carlo X, il ragazzo con il bastone
(Molti
indossano abiti blu e oro, perché questi
erano i colori araldici
francesi
all’epoca. Anche Troilo, nella sua funzione di ambasciatore,
è vestito con
armature e colori francesi.
Triolo
s’inchina a Caterina de Medici, ancora sovrana di fatto, e le porge le
congratulazioni per le nozze. Il
cavaliere era molto amato dalla corte francese e in particolare da Caterina e
dal suo figlio prediletto Enrico, tanto che a volte i soggiorni oltralpe si
prolungavano più del previsto.Isabella
era infelice nel separarsi dall’amante in queste missioni diplomatiche ma alla fine capiva che era una necessità. In
fin dei conti Troilo stava diventando un
personaggio importante nelle corti europee, più di suo marito, e il merito era soprattutto suo. Dal
1564 Isabella aveva quindi una relazione clandestina con Troilo e tutti a corte
ne erano a conoscenza. Malgrado questa situazione scabrosa, che avrebbe primo o poi causato un intervento di Paolo
Orsini e non si sa in che misura, la donna continuava la sua normale vita di
corte con una posizione di rilievo nella scena politica del padre.Ridolfo
Conegrano, cavaliere ed ambasciatore del duca di Ferrara Alfonso II d’Este a
Pisa, riportò l’accoglienza ricevuta dall’arciduca Carlo Francesco II
d’Austria, fratello di Giovanna.Un
ricco cerimoniale perché l’Arciduca fu accolto da Francesco I, da alcuni nobili
a cavallo e da contingenti militari. Tutti schierati alla Porta Prato di
Firenze per poi proseguire per Palazzo Vecchio…..Stava
S. A. (Comiso I) aspettandolo. In una camera a terrobe con laSig.
Donna Isabella e cinquanta gentildonne delle prime dellacittà,
vestite tutte di drappi d’oro di seta e ricami di gioie.S.A.
vestita d’una sottana che il fondo era il velluto nero, tuttoricamato d’oro e argento.Sig.
onna Isabella vestita tutta di bianco et oro drappo con ricamie
gioie infinite e perle bellissime al collo, tanti riccamente vestitae
con tanta garbura che non si potea descriver più La
famiglia de’ Medici nei suoi ricevimenti a Corte dava l’impressione di essere
una famiglia unita anche per motivazioni politiche.In
realtà ognuno procedeva nel suo cammino di vita in maniera indipendente e solo
il rapporto tra Isabella e il padre era un’eccezione perché tra i due c’era un
grande dialogo.Cosimo
I de’ Medici aveva perso la moglie Eleonora di Toledo il 17 dicembre 1562 e da
allora non si era risposto.Le
cronache citarono Cosimo I come un donnaiolo e certamente avrà
avuto le sue fughe amorose.
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo
I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso
con una delle tante cortigiane, Eleonora
degli Albizzi. Siamo
nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato
nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa
24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò
il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Un
commentatore dell’epoca riferì che Eleonora degli Albizzi era allora ancora
vergine e il duca la portò nelle sue stanze all’insaputa del padre di lei.
Eleonora
era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie
patrizie entrambe di Firenze.Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
12.
Eleonora degli Albizzi e Cosimo I
Cosimo I nel 1565, tre anni dopo la morte della moglie, ebbe un forte legame amoroso con una delle tante cortigiane, Eleonora degli Albizzi. Siamo nel 1565, Eleonora essendo nata nel 1543 aveva 22 anni mentre Cosimo I, nato nel 1519, aveva 46 anni. Tra i due circa 24 anni di differenza….. mentre scrivo mi sfugge un sorriso… forse un giorno svelerò il motivo dato che mi resta poco tempo da vivere....
Eleonora era figlia di Luigi degli Albizi ( Albizzi) e di Mannina Soderini, due famiglie patrizie entrambe di Firenze.
Famiglia Albizzi
originaria della Germania
e giunti in Toscana
verso la fine del XII secolo
Firenze – Palazzo
degli Albizzi
(Borgo degli
Albizi, 12)
Il
padre Luigi, alle prese con una grave crisi finanziaria, diede subito il suo
parere favorevole alla relazione che in città “non era un segreto per
nessuno”.Eleonora,
giovane e bella ragazza, si sentì molto lusingata dall’attenzioni del
prestigioso signore di Firenze e certamente provò l’ebrezza del potere, subendo
il ricco fascino della corte medicea e rimase abbagliata dall’eleganza e dalla
raffinatezza di quel mondo inaccessibile visto anche le precarie condizioni
economiche del padre. Un padre coscienzioso avrebbe dovuto cercare
di ostacolare quella relazione ma probabilmente subentrò nell’uomo la visione
di un regalo “del cielo” per i suoi problemi finanziari che avrebbero potuto
essere risolti con il nascere di questa assurda parentela.Alla
base della relazione c’era anche un elemento importate legato alla vedovanza di
Cosimo I e nulla quindi poteva ostacolare un possibile matrimonio con la
ragazza.Incominciarono
a vivere insieme e ben presto la ragazza rimase incinta e nel 1566 nacque una
bambina. Isabella come Francesco non era entusiasta del matrimonio del padre tuttavia, come madre di una bambina appena
nata, la madre meritava qualche riguardo.Eleonora dopo poco tempo s’ammalò ed Isabella andò a
trovarla insieme al padre e al medico di corte.Raccontò a Francesco, che si trovava a Poggio CaianoArrivai qui a ore ventidua e trovai Donna Leonora che
non stava troppobene, con febre e pondi (perdite)…La putta stava benissimoLa salute della bambina stava a cuore ad Isabella.
Nella lettera aggiunse in un post scrictumHora che siano a hore 12 a me pare che stia assai male
contutto ciò poppa bene Eleonora si riprese ma la bambina morì poco dopo e il
suo nome non è noto.Il
duca era profondamente innamorato? Probabilmente vide nella ragazza il
rifiorire di una seconda giovinezza favorita anche da un amore profondo.
Infatti la nascita della bambina fece nascere nel duca un entusiasmo ancora
maggiore tanto da meditare di rendere ufficiale la loro relazione, che non era
un segreto per nessuno, e di sposarla.Dopo
la morte prematura della bambina il duca colmò di attenzioni e delicatezze la
sua giovane amante, un amore profondo, organizzando per lei delle feste e anche
delle battute di caccia per distrarla e cercare di farle tornare la serenità.Andò
oltre perchè gli garantì un vitalizio perpetuo di 1000 scudi per porla al
sicuro da eventuali difficoltà,La
corte medicea, il figlio Francesco I, Ferdinando (cardinale) .. Isabella accettarono questa relazione del padre ?Il
figlio Francesco I, il futuro granduca, non accettò questa relazione e
soprattutto l’idea di un possibile matrimonio tra i due e Guglielmo Enrico Saltini nel suo testo “Tragedie
Medicee Domestiche 1557 – 1587” scrisse che il figlioApertamente
fece al duca rimprovero di queste sue debolezze”
Il
duca scoprì che la sua relazione non era più “segreta”, difficile pensare il
contrario vista l’importanza del personaggio.
Accusò Sforza Almeni, il suo fidato servitore, di aver rilevato le sue
confidenze e dopo un forte confronto lo pugnalò al cuore in Palazzo Vecchio. Il
duca aveva perso letteralmente la testa vivendo il suo amore per Eleonora.Dopo la nascita della bambina, il cronista Agostino
Lapini riferì..” A’ di 22 maggio 1566, in
mercoledì, fu morto Sforzo perugino, che era il primo cameriere che avessi il
duca Cosimo de’ Medici, et il più favorito, che fu la vigilia dell’Ascensione,
dicesssi che l’ammazzò il suo patrone, per aver scoperto un non so che segreti
di grand’importanza” Lo Sforza in realtà aveva informato Franceso I dei
progetti nuziali del padre. Una rivelazione sicuramente legata al tentativo di
guadagnarsi la fiducia del figlio del duca pensando al momento che sarebbe
succeduto al padre. Cosimo I intuì la fonte della rivelazione e il camerlengo,
venendo a conoscenza delle ire del duca, pregò lo stesso Francesco ed Isabella
di intervenire in suo favore. Nessuno dei due si sentì in dovere d’intervenire
per difenderlo. Lo Sforza cercò di
calmare il suo padrone con la dolcezza, ma il duca sguainò la spada e gridando “Traditore,,,
Traditore” lo colpì al cuore.Cosimo addirittura disse di essersi dispiaciuto per
aver concesso allo Sforza “l’onore eccessivo di essere ucciso di propria
mano”.
Firenze – Palazzo
Sforza Almeni
Posto tra Via de’
Servi e Via del Castellaccio
Lo stemma dei
Medici di Toledo posto all’angolo del Palazzo Sforza Almeni
(Cosimo I de’
Medici ed Eleonora di Toledo)
È u palazzo
cinquecentesco forse progettato da Bartolomeo Ammannati per
Piero d’Antonio
Taddei ed eretto in un’area confinante con il tiratotio
dell’Aquila. Fu
confiscato da Cosimo I alla famiglia Taddei per la sua
opposizione al
regime mediceo. Fu quindi donato dal duca al suo coppiere Sforza Almeni che
intervenne sulla struttura arricchendola di decorazioni pittoriche su
tutto il prospetto
principale. La decorazione fu realizzata da Cristoforo Gherardi con
l’importante
collaborazione di Giorgio Vasari in base ad un progetto e a dei disegni
che furono forniti
dalla stesso Vasari nel 1555 circa.
Il Vasari preoccupato
della possibile perdita dell’opera “per essere all’aria
“conteneva tutta
la vita dell’uomo dalla nascita per infino alla morte”.
Giovanni Cinelli
Cavoli (?) nel XVII secolo annotò, visitando il palazzo che le
pittura era in
cattivo stato “ "ma questa da un certo punto in qua ha ricevuto
grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi
ricordo averla meno di 30 anni sono diligentemente osservata per esservi le
sette arti liberali dipinte"…. “ nel cortile vi cono L’ORDINE E L’INGANNO statue bellissimi i capelli
Scultura che oggi
si trova nella sala di Michelangelo al Museo del Bargello.
Una meravigliosa opera in marmo dello scultore
manierista Vincenzo Danti.
Fu realizzata nel
1561 proprio per Sforza Almeni, camerlengo di Cosimo I de’ Medici.
Non si sa il motivo
per cui l’Almeni abbia commissionato questo tema per la
scultura, forse
per un episodio della sua vita. Non si hanno neppure rifermenti che permettano
di comprendere
come le due figure rappresentino “L’Onore e l’Inganno”. Il riferimento
è legato alle notizie
che il Vasari ci fornisce nel suo testo “Vite”.
Infatti il critico
letterario Ferdinando Ranalli, nel suo commento alle note del Vasari
in merito alla
scultura, riferì nell’Ottocento che “ "per sapere che quelle due figure
sono l'Onore e l'Inganno è proprio necessario che alcun ce lo dica".
la Vittoria, nel
Palazzo Vecchio di Firenze.
La figura
vincente, l’Onore, schiaccia l’Inganno con un ginocchio sottomettendolo
in segno di
vittoria, così come accadeva nella scultura michelangiolesca, la cui posa è
ripresa da Vincenzo Danti che però stempera notevolmente la vigoria di
Michelangelo trasformandola in una più elegante "tortuosità"
manierista, con il corpo dell'Onore nettamente incurvato e dalle membra più
slanciate.
All’interno in una
sala una volta affrescata forse dal Vasari
“Sala delle
Allegorie”
Lo
Sforza Almeni era stato al servizio del duca per ben ventiquattr’anni.Nel
1567 Eleonora diede alla luce un bambino che fu battezzato con il nome di
Giovanni. La nascita del nascituro mise in agitazione la corte medicea perché si delineavano dei potenziali pericoli
nell’assetto ereditario. Infatti Cosimo I legittimò il bambino legalizzando la
sua nascita… ancora una volta riuscì ad imporre la sua volontà.Il
comportamento del duca nei confronti della sua amata cominciò a declinare
probabilmente alla base c’erano forse le continue diatribe familiare sulla
relazione. La
nascita del bambino, a cui non mancava l’affetto paterno, non servì a consolidare ulteriormente
l’unione di coppia perché l’interesse di Cosimo I per la donna cominciò a
diminuire. La causa di questo grave mutamento sentimentale fu forse anche legato
all’intervento di un personaggio decisamente importante nella scena politica
del tempo: papa Pio V.Il
papa dichiarò di continuo le sue rimostranze contro questo legame che definiva “irregolare”
aggiungendo la minaccia di non dare seguito alla tanto agognata nomina a
Granduca tanto desiderata dallo stesso
Cosimo I.Le
nozze con Eleonora degli Albizzi svanirono e lo stesso Cosimo, senza perdere
tempo, s’infatuò di una nuova giovane donna, Camilla Martelli.La
separazione da Eleonora fu sancita con un contratto matrimoniale che garantiva a Cosimo I la
massima libertà e la donna fu costretta a sposare un nobile fiorentino, Carlo
Piantacichi. La
storia è veramente intricata perché il Piantacichi era stato condannato a morte per un
omicidio. Si riuscì con l’inganno a fare
cadere le accuse sul Piantacichi e in
cambio fu costretto ad accettare le nozze con Eleonora ricevendo anche una dote
di 10.000 scudi.Cosimo
I donò “ come risarcimento alla sua ex amante” una cintura di rubini e perle
con al centro uno zaffiro bianco.Dal
matrimonio nacquero tre figli ma per Eleonora la vita riservò ancora dei forti
dolori.Nel
1578 il marito Carlo l’accusò di adulterio e la costrinse a rinchiudersi nel
monastero di Fuligno a Firenze. (
E’ l’ex convento di Sant’Onofrio detto anche delle monache di Foligno. Era chiamato
di “Fuligno” perché apparteneva alle
monache francescane provenienti dall’Umbria che l’occuparono a partire dal
1419 mentre in precedenza aveva accolto
le suore agostiniane. Nel convento il prezioso dipinto dell’Ultima Cena di
Pietro Perugino (Città della Pieve, 1446 – Fontignano, 1523)
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nel
convento la donna subì molte prepotenze ed ingiustizie.Nel
1616 Francesco Renzi, agente di Don Giovanni de’ Medici (figlio di Elenora e
Cosimo I) a Firenze, scrisse più volte al suo padrone lamentandosi del
comportamento di Carlo Piantacichi e del figlio Bartolomeo…“huomo oggi ozioso et in parte bisognioso ma non di
pensiero”si presentò al convento obbligando la
madre a pagare i suoi debiti.Nella lettera il Renzi riportò il triste commento
della donna ormai abbandonata“non vol più sapere de fatti sua che quel poco che ha
stare in questo mondo ci vuol vivere quieta”
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Ultima Cena di
Pietro Perugino
Nei confronti della famiglia Piantacichi furono
intraprese delle azioni per il recupero della dote.
Fu il figlio Giovanni de’ Medici ad aiutarla e
sostenerla, denunciando anche i soprusi di cui era vittima.
In una lettera scritta a Maria Cristina di Lorena de’
Medici, sempre nel 1616, Don Giovanni scrisse
“Mia
madre […] è ridotta in età quasi decrepita a esser molestata et maltrattata da
chi ella ha procurato levar del fango. […] Saprà adunque V. A. S. che
Bartolommeo Panciatichi, non huomo ma peggio che animale senza ragione,
pretende da essa signora mille impertinenze, et dopo haverla infinite volte
ingannata, con inganni vergognosissimi per ogni vilissimo plebeo aggiratore, la
vuole hora, con donazioni surretizie, molestare, perchè ella non possi far…
del suo quel che gli piace”.
Negli
anni la situazione non migliorò e il 19 ottobre 1620 il Renzi scrisse
nuovamente a Don Giovanni de’ Medici ipotizzando che la madre fosse stata avvelenata
“Harivò
poi il medicho di S. S. Ill.ma [Eleonora degli Albizzi] m.re Benedetto
Mattonari, il quale la visitò et gli trovò una gran febbre con un polso
alterato assai et domandò quello che gli era venuto; trovò che laveva vomitato
et presa la febbre con il freddo. Io dubitai di veleno perchè uno male così
alli in proviso mi parve cosa grande”.Riuscì a sopravvivere al presunto avvelenamento perché
Eleonora morì , nonostante i dolori provati di continuo, a Firenze il 19 marzo
1634… aveva 91 anni… nel monastero visse 56 anni…..
Il figlio di Eleonora degli Albizzi e di Cosimo I de’
Medici prese, come abbiamo visto, il nome di Giovanni in memoria di un figlio del duca che portava
lo stesso nome a cui Isabella era molto affezionata. La donna per lasciare sempre vivo il ricordo
del fratello nella sua unicità, lo chiamava Nanni. Il ragazzo rimase nella
famiglia de’ Medici e intraprese la via
diplomatica.
Giovanni de’
Medici
Giovanni
de’ Medici (figlio illegittimo)
Artista:
Bronzino v.s.
Datazione:
1551 circa
Pittura:
olio su tavola – Misure ?
Collocazione:
Museo d’Arte di Toledo
Giovanni de’
Medici
(Artista: Bronzino
v.s.
Datazione:
1550/1551
Giovanni
de’ Medici (figlio naturale di Cosimo i)
Artista:
Giorgio Vasari
Datazione:
1573-75
Collocazione:
Staatliche Museen, Gemaldegalerie - Berlino
.........
13. Le Gravidanze di Giovanna d’Austria
Altre nascite
si verificarono a distanza di poco tempo nella casa de’ Medici.Giovanna d’Asburgo moglie di
Francesco I, smentendo coloro che la definivano “troppo esile per procreare”, nel settembre del
1566 annunciò una gravidanza di tre mesi. Isabella sfruttò la notizia a suo
vantaggio scrivendo al marito Paolo Giordano, che desiderava il suo trasferimento
a Roma, di dover restare a Firenze per il parto della cognata che sarebbe
avvenuto alla fine di marzo.Ma nel febbraio del 1567 Giovanna mise al mondo una
bambina a cui fu dato il nome di Eleonora.Giovanna ebbe altre due figlie femmine negli anni
successivi ma entrambe vissero solo qualche mese. La figlia maggiore non stava bene e la madre era molto
preoccupata.Nel settembre del 1570 si trovava a Siena assieme al
marito mentre la piccola Eleonora, di tre anni, era rimasta a Firenze con le
balie.La bambina prese la varicella e volle che fosse un
parente a lei vicino a curarla.Disse al suoceroIo ne scrivo un motto ancora alla S. ra Donna
Isabella, acciò si contentidi ricerverla in casa suaIsabella assicurò la cognata di essere “pazza di allegrezza”
alla prospettiva di prendersi cura della nipotina.Isabella scrisse al fratello Francesco per informarlo
sulle cattive condizioni della figlia ricevendo una laconica risposta che
dimostrava la sua mancanza d’educazione:el male che V.E. mi scrive esser venuta alla mia
puttina, me è di queldispiacer che la su può imaginare. Ma poi che non è di
rimedio a quelloche ordine S. Divina M.tà, bisogna che noi ci
conformiano con voler suo Francesco era molto adirato con Giovanna…… perché non
gli aveva dato alla luce un figlio maschio…Lo stesso Francesco non nutriva grandi sentimenti nei
confronti delle figlie ma Giovanna aveva provato con ben tre gravidanze a darle
un figlio maschio.In merito ad Isabella
nel frattempo nessuna gravidanza e la mancanza di prole dal matrimonio
con l’Orsini era un mistero.La donna aveva avuto
degli aborti spontanei nel 1561 e nel 1562, ma da allora nessun nuovo
segno di gravidanza.Nel 1564 Ridolfo Conegrano riferìSi tien certo che la S.ra Donna Isabella sia gravida
ancora lei dice non esser veromi disse che non sapeva se fusse et se non fussein realtà Isabella non voleva restare incinta in un
periodo in cui l’Orsini era a Roma e Troilo a Firenze.C’erano delle cattive dicerie sul conto che
circolavano in città e che potevano destare qualche preoccupazione…Ella hebbe senza il marito die figliole femmine, le
quali furono mandateallo spedale degli Innocenti. Erano
delle dicerie dato che probabilmente
alla base della mancata gravidanza di Isabella c’erano dei problemi
fisici ai quali bisogna aggiungere l’intesa vita notturna e le continue
cavalcate.Se
avesse voluto di proposito evitare una gravidanza avrebbe potuto adoperare quei
numerosi contraccettivi a cui faceva riferimento un testo scritto dal senese
Pietro Mattioli e che era stato pubblicato a Firenze nel 1547.Il
Mattioli sosteneva che l’erba ruta “fa ella anchora orinare… e caccia il
vento.. e spegne le fiamme di Venere.la radice e’l seme di Lbistico (Ligustico)
sono di quelle cose, che scaldano, di
modo che provocano i mestrui. L’elaterio provoca .. i mestrui… ammazza
il fanciullo nel ventre della madre”.Secondo
il Mattioli un medico di sua conoscenza si era arricchito vendendolo. Tra le
altre erbe figurava il puleggio che
“provoca bevuto i mestrui, il parto e le secondine”.
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia
(Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Pietro Andrea
Mattioli
(Siena, 12 marzo
1501; Trento, 1578)
Umanista, medico e
botanico
(Arista;
Alessandro Bonvicino/Buonvicino
Detto il Moretto o
Moretto di Brescia
1498 circa – 22
dicembre 1554
Pittura: olio su
tela – Datazione; 1553
Misure (84 x 75)
cm
Collocazione:
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso – Genova
Commentarii in libros sex Pedacii
Dioscoridis Anazarbei, de medica materia.
Venice: Vincenzo Valgrisi, 1554.
Nel
1588 papa Sisto V emise una bolla che decretava “le pene più severe per
coloro che procuravano veleni per sopprimere e distruggere il feto concepito…
che con veleni, pozioni e malefici inducono nelle donne la sterilità…. E la
stessa pena dev’essere inflitta a coloro che offrono pozioni e veleni di
sterilità alle donne e producono impedimenti al concepimento del feto e si
sforzano per compiere tali atti o in alcun modo li consigliano, e per le donne
stesse che volontariamente assumono tali pozioni”.L’emanazione
della bolla metteva in evidenza come le donne erano numerose nel ricorrere a
questi contracettivi.Erbe
dal potere contraccettivo che erano disponibili nelle botteghe degli speziali
d’allora e Isabella era un ottima
cliente.
Affresco di una farmacia (Magister Collinus, secc. XV-XVI), Castello di Issogne, Val d’Aosta
Uno
dei conti pagati dal padre Cosimo I per
la figlia Isabella ammontava a ben 200 scudi che erano destinati a “Stefano Rosselli e compagni speziali”.
I
suoi acquisti potevano anche comprendere però delle “pozioni” d’altro genere.
Quando
Paolo Giordano Orsini ed Isabella erano fidanzati, l’uomo esortò la fidanzata a
non seguire l’esempio della sorella Felice che …”non sa fare se non figlie
femmine”.
Erano
passati ben 10 anni dal loro matrimonio e cominciò ad essere ansioso per la
mancanza di un erede.
Nell’agosto
del 1569 si trovava in Toscana, presso l’abitazione di Passignano, vicino a
Firenze, dove si fermava per le battute di caccia.
Passignano sul
Lago Trasimeno
Scrisse
alla moglie invitandola a raggiungerlo anche per metterla incinta…. impresa
difficile visto le numerose assenze.Isabella
rispose al marito dopo… tre giorni..Aveva
letto la sua lettera e gli chieseLo
prego a scrivermi più chiaro accio che le posso fare tutto quelloche
potrò et saprò come servire.Noi
siamo a Cerreto et ci staremmo tre o quattro giorni secondo che diceil
duca mio signore, il quale sta bene et vi si raccomanda. Io sto bene dellamia
denti ma male del animo perché sto senza la mia dognina la qualeadoro
(forse
la sedicenne Leonora). Si fanno assai belle cacce
di starneet
lepri et il resto del tempo si gioca a picchetto (gioco a carte) Cerreto
Guidi era una delle mete preferite da Cosimo I che si vantava come “ le caccia di Cerreto le quali so, veramente
così belle et dilettevoli che più non si può desiderare dove et con l’uccello
et con li cani s’è amazzate tante starne, lepre, caprij et rufolatti (piccolo
cinghiale) che ciascheduna sera si tornava a casa
carichi di preda. So che quando ella… verrà da queste bande passerà il tempo
forse più allegramente che in quella Campagne di Roma perché qua si gode in un
tempo con la vista il salvatico et il domestico”.
Cerreto GuidiIsabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Isabella
era molto furba e finse di non capire quello che le chiedeva il marito…Cerreto
Guidi non era molto distante da dove si trovava l’Orsini e la principessa non
ebbe la minima intenzione di raggiungerlo e nemmeno lo invitò ad unirsi alle
loro battute di caccia. Voleva evitare
in ogni caso una gravidanza ma d’altra parte adoperava un contraccettivo
naturale molto efficace e migliore di quello venduto dagli speziali….. la
lontananza.Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Isabella
de’ Medici
Artista:
Scuola di Alessandro Allori (1535-1607)
Datazione:
1570-74
Collocazione:
Carnegie Museum of Art - Pittsburg
14.
Camilla Martelli
Camilla Martelli
Artista:
Alessandro Allori
Datazione: 1570
Collocazione:
Uffizi, Firenze
Il garofano rosso
sul corpetto, simbolo del matrimonio
Subito
dopo la burrascosa separazione dalla compagna Eleonora degli Albizzi, Cosimo I
de’ Medici s’innamorò di Camilla Martelli. Era nata a Firenze il 17 ottobre 1547 e figlia
di Antonio di Domenico e della sua seconda moglie Fiammetta di Niccolò
Soderini.Anche
lei, come Eleonora degli Albizzi, era molto più giovane di Cosimo I con una
differenza di 26 anni.Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Il
padre era definito un povero o
miserabile da molti biografi della donna anche se il realtà aveva ereditato nel
1559, dal fratello maggiore Girolamo, vari ed estesi feudi nel territorio
pisano.Camilla
studiò presso il monastero agostiniano di Santa Monica.Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un
matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto
del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come
appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior
parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Vurginia Martelli (?) (figlia di Camilla Martelli e di Cosimo I de' Medici)
(Artista:
Alessandro Allori
Firenze,
31 maggio 1535; Firenze, 22 settembre 1607
Collocazione:
Museo d’Arte di Saint Louis (USA)
Cornice
a “cassetta” profilo trabeazione toscana fine XV – inizi XVI secolo;
con
arabeschi dorati in fregio, pacco dorato e dipinto di nero.
(La cornice a
“cassetta” è costituita da un telaio rettangolare piano, ai bordi del quale,
sia all’interno che all’esterno, vengono applicate delle modanature. La
modanatura interna, detta alla battuta, sopravanza leggermente il telaio per
trattenere il dipinto, quella esterna, detta al profilo, ha soltanto una
funzione decorativa e di chiusura; la parte di telaio rimasta libera prende il
nome di fascia. Le modanature al profilo e alla battuta possono prevalere l’una
sull’altra, così da costituire due tipi caratteristici: cornice alta al profilo
e cornice alta alla battuta).
Pittura: Olio su
pannello – Datazione: 1570 circa
Misure (27 x 23)
cm
Lascito al Museo
di Saint Louis di Mary Plant Faus
Il quadro ha una
sua storia di vita ricchissima ed affasciante così come
la nobildonna che
rappresenta.
Il quadro aveva un
suo titolo “Ritratto di Dama”. Un dipinto risalente al 1570 circa che
esprime la ricca espressione del manierismo
fiorentino. Il Museo di Saint Louis
ricevette il
quadro come lascito di Mary Plant Faust nel 1966. Gli operatori del Museo si dedicarono
al dipinto con
restauri accompagnati da ricerche ed anche da indagini tecniche.
Attività che
furono svolte nel 2012 da Claire Winfield, conservatrice di pittura e da
Winfield e Judith
Mann che erano curatori dell’arte europea fino al 1800.
Durante gli
interventi di restauro il dipinto rilevò delle sorprese sia sull’artista che
sulla
stessa opera. Il
quadro presentava dei danni causati dall’umidità che aveva creato
delle creste
verticali. La “pennellata” del dipinto e i suoi colori vibranti erano stati
rovinati
(“oscurati”) da una vecchia vernice sintetica che era diventata nel tempo
grigia
ed opaca. La
vernice fu rimossa e emersero nel dipinto nuovi dettagli.
Diverse aree,
soggette a modica dell’artista, diventarono visibili. Con l’uso della
riflettografia a
infrarossi furono rilevate delle modifiche. La mano destra della Dama
fu ridisegnata e
spostata… perché questo spostamento ?
Per aggiungere un
ricco e grosso ciondolo sulla collana.
Il restauro rilevò
un’altra scoperta. La Dama o modella, fu
identificata come Camilla
Martelli de’
Medici, prima amante e poi moglie di
Cosimo I de’ Medici.
Camilla godette di
uno stile di vita molto sfarzoso almeno fino alla morte del marito.
Fu descritta come
vanitosa, superficiale e spesso adornata con molti gioielli.
Il prezioso
ciondolo quadrato che fu aggiunto nel dipinto nacque dal desiderio dell’Allori
di ritrarre il suo
soggetto non solo nei lineamenti e nel lussuoso abbigliamento ma anche
nel voler
immortalare l’attenzione della donna ai beni terreni.
C’è da dire che il
quadro in origine fu attribuito ad un altro pittore. Agnolo
Bronzino, anche
lui manierista, e quasi contemporaneo dell’Allori (tra i due
pittori circa
trent’anni di differenza dato che il Bronzino era nato a Monticelli di
Firenze nel
1503. Fu ricercata la storia sulla
proprietà del quadro e fu trovata anche una
fotografia del ritratto, scoperta da Mann, che
presentava un’annotazione nella
quale si
attribuiva l’opera ad Alessandro Allori.
(Secondo il mio
modesto parere si dovrebbe trattate della figlia di Camilla, Virginia)
La Provenienza del
quadro
- 1855
Comte James Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855), Paris, France
1865/03/27
In the sale of “Galerie Pourtalès: Tableaux Anciens et Modernes,” Paris, France
Sedelmeyer Gallery, Paris, France
By 1898 -
Rodolphe Kann, Paris, France
By 1905 - 1926/05/18
Wildenstein & Company, Paris, France; New York, NY, USA
1926/05/18 - 1996
Leicester Busch Faust (1897-1979) and Audrey Faust Wallace (1902-1991); St.
Louis, MO, by regalo; Mary Plant Faust (1900-1996), St. Louis, MO, by eredità
1997 -
Saint Louis Art Museum, donazione of Mary Plant Faust
………………………
La
famiglia di Camilla Martelli non godeva di una posizione elevata e
questo malgrado la loro appartenenza a una ricca e potente casata
aristocratica.
Chiesa di Santa
Monica
La chiesa
apparteneva al monastero delle Agostiniane di Santa Monica,
dette dal popolo
di “Santa Monaca”, provenienti da Castiglione Fiorentino e che
si erano dovute
rifugiare a Firenze durante la guerra tra le milizie fiorentine nel XV secolo.
Il monastero fu
donato da Ubertino de’ Bardi nel 1442 perché attribuì alle preghiere della
Superiora (Suor Jacopa
dei Gamberini) la grazia di aver avuto figli della propria moglie.
Il de’ Bardi
acquistò il terreno, “l’Albergaccio”, vicino via dei Serradi, e vi fece
costruire il
monastero che fu dedicato a Santa Monica, madre di Sant’Agostino.
Nel 1447 fu iniziata
la costruzione della chiesa, sotto il patrocinio della famiglia
Capponi, il cui
stemma è sulla facciata con portale proprio de Quattrocento.
Nel XVI secolo
l’edificio fu rimaneggiato con il rifacimento dell’altare, sovrastato
dal quadro della
Deposizione di Giovanni Maria Butteri del 1583, e del coro.
Il piano rialzato con le grate dalle
quali le monache di clausura seguivano la messa
Nella Basilica di
Santi Spirito, di Firenze, nella cappella Bini,
è presente un
quadro che raffigura Santa Monica seduta su un trono e
circondata da
monache del suo ordine e da due novizie.
La scena
ha alcuni schemi
stilistici tratti da Piero del Pollaiolo come il trono che
ricorda quelli
delle Virtù per il Tribunale della Mercanzia.
Nella parte
inferiore del quadro sono raffigurate le seguenti scene:
Matrimonio di
Santa Monica; Santa Monica che prega per
la conversione del
Figlio
(Sant’Agostino); Partenza di Agostino per Roma; Santa Monica
parlando con il
figlio a Ostia, ha la visione del Redentore; Funerali di Santa Monica.
(Artista;
Francesco Botticini
(Firenze, 1446 –
Firenze, 1487 –
Datazione del
dipinto: 1471 circa
Studiò
nel convento di santa Monca per un certo periodo anche se le sue lettere
scritte nel tempo, autografe nella firma, dimostrarono una scarsa capacità
nello scrivere.All’et
di vent’anni circa diventò l’amante di Cosimo I de’ Medici.Come
si conobbero ?La
risposta è legata allo strano gioco del
destino. Fu la precedente amante e compagna, anche se per breve tempo, di
Cosimo I, Eleonora degli Albizzi a presentargliela.Eleonora
era cugina, da parte di madre, di Camilla Martelli. L’Albizzi,
che aveva dato a Cosimo I un figlio chiamato Giovanni, fu costretta a sposare
Bartolomeo Panciatichi nel settembre del 1567.
L’allontanamento della donna fu di poco posteriore all’inizio del nuovo
e forte legame con Camilla da cui nacque, il 28 maggio 1568, una figlia che fu
chiamata Virginia.Quando
si conobbero Cosimo I aveva circa quarant’otto anni (Camilla era ventiduenne), era
vedovo da cinque anni e si era ritirato
volontariamente dal governo, lasciando gli affari di stato al figlio Francesco
I (il primo maggio 1564) riservandosi il titolo ducale.I
genitori di Camilla furono contenti sulla nascita di questa relazione, infatti
Cosimo I affermòDatami con
buona gratia del padre et madrementre
decisamente scontenti furono invece i figli del duca.In
una lettera dello stesso Cosimo I al figlio Francesco apparve chiaro il
disappunto del genitore"Sono un privato e ho preso in moglie una gentildonna
fiorentina, e di buona famiglia", Il
disappunto dei figli aumentò quando nacque Virginia che fu allontanata dalla corte e mandata in
casa di Antonio Ramirez de Montalvo, primo cameriere del duca, che la fece
passare per sua nipote.Cosimo I malgrado si fosse ritirato a vita privata
aveva sempre una forte ambizione politica e dinastica e, proprio in quel
periodo, stava trattando con il papa Pio V per ottenere il titolo di Granduca
della Toscana. (Argomento che è trattato nelle pagine successive).Nei colloqui confidenziali che precedettero
l’incoronazione, il pontefice chiese in modo chiaro al duca d’interrompere il concubinato,
ovvero la relazione con Camilla, ma la risposta fu negativa. C’è da dire che un
figlio del duca, Ferdinando, era cardinale a Roma.L’unica via da percorrere per non perdere la nomina di
Granduca era quella di regolarizzare la relazione con un legittimo matrimonio.
Nulla impediva il negozio giuridico perché Camilla era nubile e lo stesso duca
era vedovo.Tornato a Firenze il 29 marzo 1570, fu celebrato il
matrimonio in forma strettamente privata. Erano presenti i genitori di Camilla
e il confessore di Cosimo I che officiò la cerimonia.I figli del duca non erano presenti ?A quanto sembra la risposta dovrebbe essere negativa.
Fa stupore l’assenza di Isabella che in ogni caso era sempre vicina al padre a
cui era legata da un profondo affetto.
Virginia de’ Medici
(Artista: Bottega di Alessandro Allori
Pittura: Olio su tavola – Datazione: XVI secolo
Misure (66,5 x 51,5) cm
Collocazione ?
Virginia de’ medici
Artista: Anonimo
Datazione: 1583
Collocazione: Sconosciuta
Virginia de’ Medici
Artista: Lavinia Fontana (?)
Datazione: 1586
Collocazione: Uffizi, Firenze
Come per sua madre Camilla Martelli, il simbolo di un matrimonio, il garofano rosso, è stato messo nella parte superiore del corpetto del suo vestito. Sullo sfondo a destra vediamo Palazzo Pitti, come appariva negli anni '80 del Cinquecento e in cui Virginia trascorse la maggior parte dei suoi anni come Principessa Medici
Le nozze di Cammilla e Comiso
Affresco nella Casa Museo Martelli
Via Ferdinando
Zannetti, 8 - Firenze
Il matrimonio
fu morganatico cioè aveva effetti solo religiosi. La moglie veniva
esclusa dallo status del marito, dai titoli e dalle prerogative della sovranità.La notizia del matrimonio provocò nei figli una grande agitazione.Particolarmente adirato fu il figlio Francesco. Il
padre gli aveva inviato una lettera nella quale dichiarava di sposare Camilla
per scrupolo di coscienza e che il matrimonio non avrebbe colpito i diritti
patrimoniali dei figli e dei nipoti. Francesco I, almeno come riportarono le cronache, fu
preso tanto conquistato dallo sconforto che si dimenticò di avvertire i
fratelli.Questo accidente mia ha travagliato di maniera che mi sonodimenticato di me stesso.una frase contenuta nella lettera che inviò al
fratello cardinale Ferdinando che lo rimproverava di aver appreso la notizia
dal papa e non dalla sua famiglia.Anche gli altri figli di Cosimo I, Isabella e
Pietro, criticarono il comportamento del
padre e lo attribuirono ad indebolimento senile, opinione che sarebbe stata
condivisa dai cortigiani.Dopo le nozze la moglie trascorse la sua vita lontano
da Palazzo Pitti che era la residenza ufficiale della famiglia granducale.Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Firenze – Villa di Castello
Nel periodo invernale la coppia trascorreva lunghi
soggiorni a Pisa dove il clima era più mite.La loro vita era molto semplice dato che il Granduca
aveva ridotto il personale di servizio. La moglie cominciò a concedere ai suoi parenti numerosi
favori e onori.Il padre fu creato cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
con dispensa delle “provanze” di nobiltà; il cugino Domenico Martelli chiese di
essere nominato cameriere di don Pietro de’ Medici, figlio di Cosimo I, ma non
riuscì ad ottenere l’incarico.Ottenne invece la dote per la sorella maggiore Maria,
vedova di Gaspare Ghinucci, che si risposò con Baldassare Suarez.Cosimo I
concesse alla moglie una rendita personale con la quale comprò nel dicembre 1571 la
villa “Le Brache”, nel Comune di Sesto Fiorentino, non lontana da Villa Castello. La proprietà
venne ampliata negli anni successivi con l’acquisti di terre limitrofe.
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Firenze – Palazzo Pitti – Cappella
Firenze – Palazzo Pitti
Villa – Le Brache
Nella loggia degli affreschi tardogotici con storie degli
Argonauti (Giasone lotta con un drago)
Ricevette dal marito vari preziosi doni in gioielli e
ornamenti ed anche un mulino nel territorio di Grosseto.La figlia della coppia Virginia, in seguito al
matrimonio fu legittimata, e visse con i genitori.Appena due anni dopo il matrimonio, la salute di
Comiso I cominciò ad avere dei problemi mentre Camilla cominciò ad avvertire
degli strani momenti d’insofferenza verso il marito e i suoi disturbi. Questo stato di
nervosismo determinò dei forti mutamenti sul suo comportamento. Cominciò ad avere una passione sfrenata sia verso i
gioielli che per agli abiti costosi ed elaborati a tal punto che i cognati
l’incominciarono a vedere con sospetto e sempre con una maggiore avversione.Francesco I temendo che la donna stesse approfittando
della senescenza del marito per farsi attribuire sempre più dotazioni e regali,
fece redigere alla fine di febbraio del 1574 una protesta.Protesta che fu rogata dal notaio Francesco
Giordani in cui si affermava cheEventuali provvedimenti del padre in favore di Camilla
Martelli odella figlia Virginia, non sarebbero stati da lui
ratificati.La stesso Francesco I fece spiare Camilla dal proprio
segretario Antonio Serguidi che fu inviato a Pisa per informarlo sullo stato di
salute del padre.
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Foto del 1973
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo Le lettere di Serguidi erano piene di osservazioni
malevoli e di critiche per Camilla nei confronti della quale l’ostilità del
segretario era incrementata anche dal
contrasto sull’assegnazione di un beneficio ecclesiastico. C’era anche un
atteggiamento arrogante che la stessa donna, ritenendosi in modo ingenuo al
riparo da ogni pericolo, teneva verso i segretari e gli stessi familiari.Nel gennaio del 1753 Cosimo I fu colpito da un grave
attacco apoplettico che lo paralizzò parzialmente e gli fece perdere la capacità di parlare e
sentire.Fu portato a Firenze, Palazzo Pitti, dove accudito
dalla moglie, trascorse in precarie condizioni gli ultimi mesi della sua vita.Il Granduca morì
il 21 aprile 1574 e la sua morte determinò nella moglie un repentino
mutamento della sua condizione sociale.La
vedova aveva solo ventinove anni e tutti i lasciti e benefici del marito vennero
impugnati da Francesco I perché temeva che la donna si risposasse.Poche ore dopo la morte di Cosimo I, il granduca
Francesco I ordinò che la Martelli, con le dame al seguito e le donne di
servizio, in totale 14 persone, fossero condotte alla volta del Monastero
Benedettino delle Murate.In questo monastero veniva osservata una stretta
clausura a cui le nuove ospiti erano obbligate a conformarsi.
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Palazzo Medici – Pisa
Facciata del
palazzo dove sono visibili le strutture portanti medievali
Pisa – Palazzo Medici, a sinistra, e la chiesa e convento di S. Matteo
Visti dal lungarno Mediceo
Firenze – Monastero delle Murate
Dalla seconda metà del Quattrocento a per tutto il
Cinquecento, il monastero
ospitò le figlie delle più importanti famiglie nobiliari
dell’epoca (Sforza,
Gonzaga, Este, Piccolomini, Orsini, Farnese, Da Montefeltro…)
diventando
anche un importante crocevia culturale. Nel 1478 ospitò
Caterina Sforza,
la madre di Giovanni de’ Medici delle Bande Nere (padre di
Cosimo I), che
vi morì e fu sepolta nella chiesa. Un’altra ospite importante fu
Caterina de’ Medici all’età d’otto anni. Era parente di papa
Clemente VII
(cugino del nonno di Caterina) e la bambina si trovò in
pericolo durante la
ribellione dei fiorentini contro il governo del cardinale
Passerini che era
stato imposto dal papa. La ribellione culminò con l’assedio
di Firenze.
La bambina venne accolta e amorevolmente protetta dalle suore
dal 1527 al 1539,
quando per volere della Signoria, fu costretta a trasferirsi
e tenuta in ostaggio
nel convento di Santa Lucia.
Il papa ricompensò con generosità le
suore del convento Le Murate e la stessa Caterina de’ Medici
(successivamente
regina consorte del re di Francia Enrico II) rimase molto
legata
al convento. Infatti con atto solenne del 14 giugno 1584
regalò alle suore
una fattoria in Valdelsa che fu detta di “Santa Maria di
Lancialberti”.
Nel convento entrarono le figlie naturali di don Pietro de’
Medici, figlio di Cosimo I
e di Eleonora di Toledo, nate in Spagna.Caterina de’ Medici
Sala
delle Colonne
Nel
1557 una forte alluvione provocò una vittima tra le suore. Crollò il muro
dell’orto,
la chiesa fu distrutta furono perdute
preziose suppellettili sacre,
quadri
e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio
da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul
muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi
miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Caterina de’ Medici
Sala delle Colonne
dell’orto, la chiesa fu distrutta furono perdute preziose suppellettili sacre,
quadri e libri. Un busto raffigurante “Maria Col Bambino”, scolpito da
Desiderio da Settignano, fu salvato miracolosamente e collocato esternamente
sul muro di recinzione sotto un tabernacolo. In seguito gli furono attribuiti
“strepitosi miracoli che favorirono abbondanti elemosine” e consentirono la
Madonna
Col Bambino
Artista:
Desiderio da Settignano
Desiderio
di Bartolomeo di Francesco, detto Ferro
Settignano,
1430 circa – Firenze, 16 gennaio 1464
Datazione:
1453 circa
Collocazione:
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
La
vita nel monastero era difficile ed insopportabile per la Martelli. Attraverso
il padre cercò di ottenere dal granduca una destinazione meno punitiva.
Francesco I fu irremovibile ma fu successivamente informato dal fatto che le suore desideravano che la forzata convivenza con la donna avesse
termine.Con
rammarico ordinò quindi il trasferimento della Martelli.Il
10 agosto 1574 fu trasferita, con le
donne del seguito, nel monastero di “Santa Monaca” dove aveva studiato
nell’infanzia.La
vita in questo secondo convento era improntata a regole meno rigide: pur
permanendo il divieto di uscire senza licenza speciale del granduca, le monache
le permettevano di ricevere visite con una certa frequenza. Incontrò
più volte l’inviato del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, Ercole Contile,
quando si preparava il matrimonio tra la figlia Virginia e il figlio naturale
del duca, Cesare d’Este. Ma l’inattività, la solitudine e le costrizioni che
anche la nuova sistemazione le imponevano finirono con colpire la sua salute.
Nonostante ciò il rigore non si allentò e la Martelli poté lasciare per breve
tempo il monastero solo nel febbraio 1586, in occasione del matrimonio di
Virginia e per speciale intercessione di Bianca Cappello, seconda moglie di
Francesco I. Quest’ultimo, alcuni giorni prima, aveva preteso dalla Martelli la
rinuncia a favore della figlia della villa Le Brache, che aveva acquistato in
proprio, e inoltre di tutto quel che le era stato donato da Cosimo.A
maggio del 1586 Francesco I scrisse a Francesco Guerini: “R. nostro carissimo, Il Cardinale de’ Medici ottenne
da Papa Gregorio senza alcuna mia partecipazione, che la signora Camilla Martelli
moglie già del Gran Duca buona memoria potessi introdurre nel monasterio di
santa Monaca, dove ella si trova, certa quantità di donne vedove maritate et
fanciulle, con facultà di uscirne et rientrarvi a ogni sua posta, et con tante
altre larghezze, di stanze, et altre comodità, che di monasterio ben stretto,
e venerando, si è ridotto con questo concorso di donne, et con questi abusi, a
uno scandolo pubblico della città. Onde noi che conosciamo in quanto pericolo
stia non solo quella signora che pur fu moglie di nostro padre, ma anco molte
fanciulle che ella tiene in sua compagnia, per evitare maggiori scandali ci
siamo risoluti di supplicare Sua Santità a farci gratia non solo di revocare,
et annullare tutte le gratie et brevi concessi da papa Gregorio alla signora
Camilla, et ad altre donne et huomini, fuor dell’ordine della clausura, ma
ancora a ordinare al cardinale di Fiorenza, che se bene questo monasterio è
sotto la custodia de frati di S. Spirito, lo visiti lui stesso, et ponga
remedio a tutti quelli abusi et inconvenienti, che giudicherà necessarij
secondo la sua conscientia, et honore di quel monasterio, dicendo a Sua
Santità che ci moviamo a domandarle questa gratia et per il zelo dell’honor di
Dio, et conservatione di questo venerando luogo, ma anco per quel che con
questa larghezza, potessi toccare lo scandolo della buona memoria di nostro
padre”. Tornata
in monastero mostrò di sopportare peggio di prima la reclusione ed ebbe sempre
più frequenti disturbi psichici, tanto che nell’aprile 1587 fu chiesta al papa
l’autorizzazione a farla esorcizzare come indemoniata, e nel gennaio 1588
un’ebrea fu accusata di averle fatto fatture e malie. Finché visse Francesco I,
tuttavia, le porte del monastero rimasero chiuse per lei. Le cose cambiarono in
meglio quando, nell’ottobre 1587, successe a Francesco il fratello Ferdinando
de’ Medici, già cardinale, che si era sempre mostrato nei confronti della
Martelli meno intransigente del fratello e, in una sua visita nel gennaio 1588,
aveva constatato che si trovava «in mal termine di sanità». Le mise
pertanto a disposizione la villa medicea di Lappeggi, sulle colline meridionali
di Firenze, nella quale la Martelli rimase circa un anno, fino ai primi mesi
del 1589. In
questo luogo si tratteneva all’aria aperta, faceva passeggiate e riceveva le
visite dei parenti e degli amici, cosa che migliorò notevolmente il suo stato
fisico e mentale. Il granduca spinse la sua disponibilità fino al punto di
invitarla a esprimere quali fossero i suoi bisogni, invito al quale la donna
rispose chiedendo un’udienza privata (lettera del 31 genn. 1589 in Arch. di
Stato di Firenze, Mediceo del principato, 5926, c. 220).
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
La Peggio di
Giusto Utens
Sembra
che la Martelli volesse confidare al granduca il desiderio di risposarsi ma
egli, intuite le sue intenzioni, le negò il colloquio per questo e le ordinò di
far ritorno al più presto nel monastero di S. Monica.L’ultima
uscita della donna dal suo reclusorio avvenne in occasione delle nozze di
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena, celebrate a Firenze il 25
maggio 1589, quando fu invitata per alcuni giorni a palazzo Pitti. Sembra che
le venissero usate molte cortesie, ma alla fine dei festeggiamenti dovette
tornare in monastero. Cadde nuovamente preda dei disturbi nervosi e della
depressione, che in breve la condussero a morte.La
Martelli morì a Firenze il 30 maggio 1590 accudita solamente dalla cure delle
sorelle del convento e fu sepolta, in forma privata, nella Basilica di in
S. Lorenzo. Dieci mesi più tardi morì anche il padre.“Nei matrimonj di questo genere le donne se non sono maltrattate
dal marito lo sono poi da’ suoi parenti”.
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Camilla Martelli
La donna è ripresa
seduta, riccamente abbigliata in seta e velluto bianco
dorato secondo la
moda del tempo. Porta una collana di perle a due giri e
orecchini a
goccia, sempre di perle, In grembo tiene un cagnolino.
Camilla
Martelli con il figlio Fagoro
(il
bambino morì in tenera età)
Artista:
Alessandro Allori
(Firenze, 31 maggio 1535 – Firenze, 22 settembre 1607)
Collocazione: Dallasi Museum of Art,
The karl and Esther Hoblitzelle Collection
Medaglia
di Camilla Martelli
(Artista: Pastorino de' Pastorini , Pastorino da Siena,
Pittore,
scultore
Castelnuovo
Berardenga, 1508 circa – Firenze 1592
Datazione
della medaglia: 1684 (?)
CASA MARTELLI E I SUOI
SEGRETI
La nobile famiglia Martelli era giunta a Firenze dalla
Val di Sieve per dimorare in via degli Spadai, vicino al Duomo. Imparentati con gli Albizzi, si schierarono
con Cosimo I de’ Medici. Un’alleanza che sarà la loro fortuna economica.Vivendo a contatto con la corte medicea finirono con
il condividerne anche le dinamiche culturali.Il famoso scultore Donatello, il cui vero nome era
Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386; Firenze, 13 dicembre 1466), fu
immortalato nei soffitti del palazzo mentre lavorava in bottega per il
capostipite Roberto. Sue opere furono anche il famoso stemma Martelli, il
sarcofago della famiglia che si trova nella Basilica di San Lorenzo e il
famosissimo “David” che era destinato a dare lustro al nobile casato dei
Martelli.David che finì a Washington….Nel Cinquecento, come abbiamo visto, Camilla Martelli
sposò, con nozze morganatiche, il
Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici ma è il Seicento l’anno d’oro della
famiglia con una prospera attività legata
ai commerci, alle attività bancarie e finanziarie di vario tipo.Con il matrimonio dei cugini Marco, figlio di
Francesco Martelli e Maddalena Nicolini) e Maria Martelli (figlia di Baccio Martelli Mearguerite
Villeneuve dei baroni di Tornet ?) si riunirono tre gruppi di edifici che
costituirono un unico e grande Palazzo. Un edificio di ben cinquemila metri
quadri posto nell’importante via del Popolo di San Lorenzo.Nel
corso degli anni l’edificio fu più volte restaurato e i saloni abbelliti con
pregati mobili e tappezzerie e da ricche collezioni artistiche.Un
importante punto d’incontro culturale
con la presenza anche d’antiquari e commercianti. Passarono i Romanoff, i
Demidoff. Numerose opere d’arte giunsero nel palazzo in eredità, come i paesaggi del ‘700 romano
acquistati dall’abate Domenico Martelli,
o in pagamento di debiti (famoso il caso del Marchese del Carpio che
andò in rovina a causa dei numerosi debiti di gioco). Purtroppo
con l’unità d’Italia la fortuna dei Martelli si sgretolò anche a causa delle
nuove tasse sulle proprietà fondiarie.La
famiglia non potè continuare a prestare denaro e le opere d’arte del palazzo
cominciarono ad essere messe in vendita.Fu
così che il famoso “David” di Donatello giunse a
Washington, alla National Gallery insieme al San Giovanni di Rossellino, mentre
un famoso Cingoli apparve alla National Gallery di Londra e un Velasquez non si
sa dove sia.
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
San Giovanni
Battista da giovane
(Arista: Antonio
Rossellino
pseudonimo di
Antonio Gamberelli, detto il
“Rossellino”
per il colore dei
suoi capelli
(Settignano, 1427
– Firenze, 1479
Davide di
Donatello
National Gallery
of Art, Washington
Molte
opere furono cedute ma, per fortuna, altre si salvarono grazie all’impegno di
alcuni esponenti della famiglia.Nel
1986 il ramo principale della casata s’estinse e donna Francesca Martelli
lasciò il palazzo in eredità alla Curia Fiorentina.Un
lascito legato ad un preciso vincolo…. “la quadreria del palazzo aperta al pubblico almeno una
volta alla settimana…”.Fu
una custodia mal risposta… è strano ma mi sembra di rivedere un comportamento
legato ad una nobile Fondazione…… dove un amministratore un certo Antonello
detto “il pelato”… aveva ben poco rispetto di strutture che risalivano al 1500…Comunque
il palazzo venne abbandonato e per ben dieci anni non fu oggetto di visite
anche perché era sempre “chiuso”…. Chiuso in apparenza… dato che era aperto per
altre mani… non certamente corrette e rispettose dell’ambiente, dato che sparirono arredi, vasellame, stampe
e medaglie…
Ancora
una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare
una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era
posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto
rispetto per la cultura…..
Improvvisamente
un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta
di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera
che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Ancora una volta mi ritorna in mente quando questo fantomatico Antonello fece bruciare una bellissima poltrona che era appartenuta ad un marchese e sulla quale era posto un bollino di catalogazione della Soprintendenza………
Quanto rispetto per la cultura…..
Improvvisamente un colpo di scena…. Un quadro della quadreria del Palazzo Martelli, “Veduta di Venezia” di Van Lint, apparve sul mercato antiquario di Sotheby,s……opera che fu identificata e recuperata..
Scattò
quindi immediato, sia per l’edificio storico che per l’antica quadreria, il
vincolo d’insieme…. Ma il danno era ormai fatto…I
trafugamenti furono sospesi…… il
patrimonio culturale fu salvato.. il patrimonio doveva appartenere a tutta la
città.La
situazione ci complicò perché la questione fu chiusa solo nel 1998 e collegata
ad un curioso giro che fu definito “nodo Bardini”.Una
situazione che potremmo definire tipicamente italiana…..Stefano
Bardini (Pieve Santo Stefano, 13 maggio
1836 – Firenze, 12 settembre 1922) era un famoso collezionista d’arte con una
fama a livello mondiale.Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Il
Bardini decise di creare nel suo palazzo, alla fine dell’ottocento, alcune sale
per esporre innumerevoli opere d’arte.
Opere esposte per invogliare gli acquirenti, i collezionisti
all’acquisto.Per
creare un ambiente adatto allo scopo, fece dipingere le pareti di un blu molto
profondo che fu chiamato “blu personale”
per diventare “blu Bardini”.
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Targa che ricorda la visita di Gregorio X
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Perché
usò questo particolare colore sulle pareti ?Usò
il blu cobalto per fare risaltare le sue opere. Aveva una clientela molto
elevata dal punto di vista sociale, non solo italiana ma anche mondiale, e
s’era ispirato ai colori dei sontuoso palazzi di Pietroburgo e agli
aristocratici russi che vivevano a Firenze, Pisa, Roma.Aveva
preso a testimonianza il magnifico palazzo blu che si trova sul lungarno di
Pisa e che nel 1783 aveva ospitato il Collegio Imperiale Greco Russo.
Pisa – Collegio
Imperiale
C’è
da dire che il colore del Bardini fu usato anche da Nelie Jacquemart, anche lui
collezionista d’arte e cliente del Bardini, per il prestigioso museo parigino
che ospita le sculture rinascimentali italiane.Firenze,
allora capitale, era una città animata da un grande fermento culturale e sede
di uno dei più importanti mercati d’arte anche per la presenza di una vasta
nobiltà proveniente da ogni parte d’Italia.Le
trattative del Bardini riguardavano le opere di artisti importanti come il
Tiziano, Botticelli, Paolo Uccello. I suoi clienti erano, tra gli altri, il
Louvre, l’Hermitage i cui direttori si fermavano nel palazzo per ammirare le opere d’arte esposte.A
lui si rivolgevano gli storici Berenson ed Home per avere notizie e i clienti
collezionisti, per gli acquisti, come Acton, Vanderbilt, Rothschild.Ogni
richiesta avanzata da un cliente poteva
essere esaudita e così per statue, arazzi, dipinti, mobili, tessuti anche rinascimentali.Un
mercato che era favorito da diversi fattori come il decadimento
dell’aristocrazia che vendeva le proprietà per avere liquidità, degli ordini religiosi
che disperdevano le grandissime ricchezze accumulate in tanti secoli ed anche
il terribile vizio del gioco checolpiva
i grandi patrimoni degli aristocratici che finivano con il mettere in gioco
anche i titoli nobiliari.Alla
morte di Stefano Bardini l’immenso patrimonio costituito da ville, palazzi e
opere d’arte di inestimabile valore, furono lasciate al Comune di Firenze…. Un
lascito legato come segno di gratitudine
alla bellissima città rinascimentale che “tanto gli aveva dato come uomo”.Con
l’avvento del fascismo il Comune si comportò come un vero “collezionista
d’arte” nei confronti dell’immenso e prestigioso patrimonio che aveva ricevuto
in dono. Chiunque volesse abbellire gli uffici del potere, cominciò a
saccheggiare, a trafugare a piacimento le stanze dove erano custoditi i tesori
artistici.Il
figlio Ugo, una persona molto sensibile anche se le cronache lo descrissero
come introverso, rimase tanto ferito dai continui trafugamenti delle opere che
compilò un testamento. Morì nel 1965, senza eredi, e nel suo testamento molto vendicativo
affermava che “ha richiesto 30 anni per permettere allo stato italiano di
risolverlo”.
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Firenze – Piazza
dei Mozzi- sullo sfondo il Palazzo dei Mozzi.
A sinistra Palazzo
Bardini del XIII – XIV secolo
Una sala del Museo
di Palazzo Bardini
Museo Bardini –
Sala del Crocifisso
Pisa – Collegio
Imperiale
Che
significa ?
Ugo
Bardini nominava erede lo Stato
Svizzero, in seconda il Vaticano e solo come terzo erede lo stato italiano e
precisamente il Ministero della Pubblica Istruzione con
l’obbligo,
in caso di accettazione, di destinare l’intera somma ricavata
dalla
vendita di tutti i beni, alla compravendita mondiale di una o
due
opere d’arte di eccezionale importanza anteriori al 1600, da destinare
successivamente ai musei della città di Firenze.
Ma come poteva essere
venduta una intera eredità che comprendeva infiniti pezzi di inestimabile
valore? Come potevano essere venduti palazzi ed edifici storici e monumenti
italiani? La ” beffa” pensata da Ugo Bardini forse era proprio quella,
aspettarsi che lo stato italiano applicasse la legge di tutela e vincolasse
l’eredità per non disperdere il patrimonio.
La
strade che si presentano erano due:
-
Lasciare
l’eredità inutilizzata e quindi esposta al degrado;
-
Eseguire
le volontà testamentarie ed acquisire le opere richieste, valutate in circa 35 miliardi di lire, e solo dopo
quest’operazione il patrimonio sarebbe diventato di proprietà dello stato.
Nel
1975 il giovane Antonio Paolucci catalogò l’eredità Bardini. Un giovane che
amava la sua città e come studioso di storia dell’arte desiderava impedire la perdita di quel ricco patrimonio
culturale.
Nel 1995, grazie al
governo tecnico di Lamberto Dini, al ruolo di ministro di Paolucci, l’appoggio
di Valdo Spini, Sandra Bonsanti e Giovanni Berlinguer, e dall’allora Presidente
della Commissione Cultura alla Camera, Vittorio Sgarbi, si ottenne il miracolo,
con il decreto numero 120 del 6 marzo 1996, furono stanziati i soldi per
acquisire le opere e districare l’eredità Bardini.
Antonio Paolucci, ministro dei beni
culturali istituì una commissione composta da Cristina Acidini ( soprintendente
beni artistici e storici Firenze), Evelina Borea ( ufficio centrale beni
culturali ministero), Marco Chiarini ( direttore galleria Palatina Firenze),
per individuare le opere da comprare sul mercato internazionale. Il tempo a
disposizione non era molto, il governo Dini era un governo tecnico e come tale,
temporaneo, bisognava portare a termine l’intricata situazione per il bene di
tutti.
Cercare di acquistare opere per 35
miliardi di lire fece sicuramente rumore in tutto il mondo. Collezionisti
internazionali si mossero sia in occidente che in oriente, proposte arrivarono
da antiquari, da galleristi, da privati e mercanti pubblici. La cifra destinata all’acquisto era di
notevole entità , ma nonostante ciò trovare opere del prezzo di 15/16 miliardi
l’una non era cosa semplice.
Altro nodo e altro
paradosso, fu lo stemma di Donatello, facente parte della collezione Martelli
che era purtroppo giunto legato con una eredità all’arcivescovado che comprendeva
anche il palazzo Martelli.
Il Ministero, in
rispetto delle volontà testamentarie di Ugo Bardini che, come detto imponeva
l’acquisto di una o più opere d’arte, comprò lo stemma eseguito da Donatello
per 17 miliardi di lire da una Curia che in cambio cedette anche il Palazzo
Martelli e tutto il suo contenuto artistico.
Nel 1998 i funzionari
statali entrarono a Palazzo Martelli.
Al loro arrivo non
trovarono nulla,, gli armadi vuoti, nessuna porcellana, molti quadri erano
a terra ed altri spariti assieme a
numerose stampe e ceramiche
La casa diventò come si
può ammirare oggi.
Nel palazzo furono
eseguiti dei lavori con il ripristino originario dei pavimenti, delle pareti e
delle volte. Furono anche collocate delle lampade ottocentesche.
Smontando un
controsoffitto affiorò un dipinto “Amore
tra fedeltà e temperanza” che era stato coperto per lo scandalo delle false
nozze fra il nobile Marco Martelli, erede della casata a metà dell’ 800, e la
bella Teresa Ristori, che fu disconosciuta dopo sette anni di matrimonio e tre
figli.
Il prezioso stemma di Donatello si trova al Museo
Bargello mentre fra i salotti e quadreria si trovano i pannelli nuziali del
Beccafumi, le tele di Luca Giordano, la “Congiura di Catilina” di Salvator
Rosa, l’”Adorazione del Bambin Gesù” di Piero di Cosimo, ..ecc.Nella casa si trova un passaggio nascosto, una piccola
stradina tra le case per arrivare alla cappella di famiglia senza essere visti.
Un percorso che collega Casa Martelli
alla Basilica di San Lorenzo e che è stato aperto al pubblico.Fu forse usato anche da Michelangelo per sfuggire alla
“prigionia” della Sacrestia Nuova per sfuggire all’ira dei Medici.
Sala
da bagno
Il
cortile
Il salone gialloUna
porta del Settecento
La chiave con il segreto del suo funzionamentoMatrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15.
La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
Sua
S.tà del Papa (Sisto V) spontaneamente fuor d’ogni mio pensiero non chè
richiesta,
m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate
preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa
il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli
quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non
ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da
sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio
filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella
ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Sala
da bagno
Il
cortile
Una
porta del Settecento
Matrimonio
tra Camilla e Cosimo I
Roberto
Martelli e Donatello
…………………………..
15. La Nomina di Cosimo I de’ Medici a Granduca
Nell’ottobre
del 1569 Cosimo I de’ Medici scrisse alcune lettere ai duchi di Mantova,
Ferrara e Urbino per comunicare la stessa notizia. Lettere scritte tutte con lo
stesso tono e nelle quali informava “i suoi pari che in realtà non erano più
tali”….
richiesta, m’ha decorato di titolo di Gran Duca di Toscana con le più
onorate preeminentie et dignità, ch’io stesso non havrei saputo domandare.
Sa il mondo ch’io sono stato alieno da ogni ambitione d’honori ma il
recusargli quando vengono largito… sarebbe un mostrarsene indegno.
Non ho desiderato questo splendore se bene l’ho io accettissimo…
da sì santo pontefice…. non ho altro interesse che d’amore et
d’obsequio filiale. Lo so che l’Ecc. V. ne havrà piacer per sapere
chella ch’io l’amo sinceramente
Roma - Dicembre
1569 - Nomina di Cosimo I de’ Medici a
Granduca
Una
lettera chiaramente non sincera… Cosimo I aveva fatto di tutto per cercare di
ottenere il titolo granducale che gli avrebbe permesso di avere una posizione
di prestigio.Alcuni
storici ipotizzarono come il titolo granducale fu favorito dalla consegna, a
tradimento, dell’eretico Pietro Carnesecchi che si era rifugiato a Firenze
confidando nella protezione di Cosimo I.
Lo stesso Cosimo avrebbe messo la
sua flotta al servizio della Lega Santa che si stava formando per contrastare
l’avanzata ottomana in Oriente.
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
Cosimo I de’
Medici con la corona granducale
(Artista: Lodovico
Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San
Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore,
architetto e scultore
Pittura: Olio su
tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione:
Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
I tre importanti
simboli del potere di Cosimo I de’ Medici
sono stati
fiorentino Paolo
Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze
del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
Affresco le
“Storie di Furio Camillo”
(Artista:
Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati”
o Francesco Salviati
Firenze, 1510 –
Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale
all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545,
ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di
Domenico Romano.
Raffigura le
storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli
invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco
presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte
di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla
sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del
potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona
Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Fecero
quindi il loro ingresso formale a Roma e raggiunsero, con il loro seguito, il
Vaticano.Cosimo
I ed Isabella incontrarono il papa Pio V nel salone delle Udienze, la Sala
Regia, e solo allora gli emissari asburgici capirono il vero
motivo della venuta a Roma del duca.
Vaticano – La Sala
Regia
Papa Pio V
Il
papa invitò Cosimo I a sedersi, un privilegio che era riservato a chi doveva
essere incoronato.Nella
sala l’atmosfera si fece piuttosto tesa perché gli ambasciatori asburgici si
ritirarono in segno di protesta perché ritenevano quel gesto un insulto al re e
all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Isabella,
essendo una donna, non potè partecipare all’evento.Dopo
qualche giorno la de’ Medici si recò a fare visita al papaAccompagnata
da molte gentildonne andò a baciar li piedi al
Papa
dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Anche
Eleonora di Toledo, madre d’Isabella, aveva fatto visita al papa nel corso
dell’ultima sua venuta a Roma nel 1559
circa, come rappresentante femminile del casato de’ Medici.Una
settimana dopo, il 4 marzo, Comiso I venne incoronato nella Cappella Sistina.
Vaticano – Cappella SistinaL’Incoronazione
di Cosimo I de’ Medici
Opera
del Bronzino ed è conservato
All’
Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Pietro Carnesecchi
Firenze, 24
dicembre 1508; Roma, 1 ottobre 1567
Umanista e
politico
Artista: Domenico
di Bartolomeo Ubaldini
detto Domenico
Puligo
(Firenze,
primavera 1492; Firenze, settembre 1527)
Il
duca aveva sempre cercato di ricevere un titolo che lo togliesse dalla
condizione di feudatario dell’imperatore e che gli desse una maggiore
indipendenza politica. Non trovando alcun appoggio da parte imperiale si rivolse quindi al
papato. Con il papa precedente, Paolo IV, aveva già tentato di ottenere il
titolo di re o di granduca ma senza riuscirci.
Dopo molti favori e maneggi più o meno legittimi, fu proprio papa Pio V
ad emanare la bolla che conferiva a Cosimo I de’ Medici il trattamento di “Altezza
Serenissima” e il titolo di Granduca (Un titolo che nella gerarchia nobiliare ha un posto
intermedio tra quello di duca e di
Principe)Il
13 dicembre1569 Cosimo I ricevette la notifica ufficiale del titolo di Granduca
dal papa nell’ambito di una solenne cerimonia.Il
Ridolfo Conegrano inviò una relazione al duca di Ferrara che fu conquistato da
una grande rabbia pensando che Cosimo I,
un commerciante attivista ed erede di un ramo cadetto della famiglia, potesse a
buon diritto vantare una superiorità di rangoStamano
S. Duca havito da S.S.tà il titolo di Ser,mo Gran Duca di Toscano,
il
Sig. Principe andò a Pitti con tutta la corte, si fece portar il duca in
seggiola
accompagnato
ditto Sig. Principe a piedi con ambasciatori a Palazzo nel
salotto
grande dove sta sotto baldachino.
S.
S.tà le mandava Sig. Michele suo nipote d’annonciar il privilegio di
Gran
Duca con molte parole amorevole in lauda di S. Altezza.
Il
Conegrano concluse la lettera descrivendo la parte che preferiva perché legata
ai relativi festeggiamentiSta
sera si fa uno festino in palazzo dove sono alcune gentildonne.
Verso
la fine di gennaio 1570, Cosimo I
annunciò a corte l’intenzione di recarsi a Roma per ringraziare papa Pio
V della bolla.In
realtà il suo proposito era quello di ricevere direttamente l’incoronazione
formale dal papa e questo provocò le ire sia della Spagna che degli stessi
austriaci.La
corona granducale era pronta per essere inviata a Firenze. Vi avevano lavorato
per alcuni mesi degli orafi fiorentini che l’adornarono con il giglio, simbolo
di FirenzeSi
disse che valeva duecentomila scudi, per esservi dentro 75 pietre preziose,
di
più sorte, tutte grosse e belle…. e di poi, di sopra, una grillanda
di
bellissime e grossissime perle.
La
corona di granduca di Toscana era diversa da quella principesca e da quella
ducale. Era caratterizzata da un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini e
perle dal quale partivano delle punte triangolari d’oro verso l’alto.Era
priva del berretto di velluto interno ed aveva la particolarità di avere al
centro, nella parte anteriore, un grosso giglio bottonato.(Il
termine è utilizzato in araldica per indicare il giglio sbocciato, fiore
dell’iris simile al lilium. Ha la caratteristica di essere disegnato da cinque
petali superiori (tre principali e due stami più sottili e bocciolati, e dalle
ramificazioni inferiori, tutte disposti in modo simmetrico).
Firenze - Piazzale Michelangelo - Giardino dell’Iris
(Artista: Lodovico Cardi, detto il Cigoli
Cigoli di San Miniato, 21 settembre 1559; Roma, 15 giugno 1613;
pittore, architetto e scultore
Pittura: Olio su tela: Datazione: XVI secolo
Collocazione: Palazzo Medici Riccardi – Firenze
………………..
fiorentino Paolo Penko e dovrebbero essere visibili nella
Sala delle Udienze del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze.
Firenze – Sala
delle Udienze – Palazzo Vecchio
(Artista: Francesco de’ Rossi, detto “Il Salviati” o Francesco Salviati
Firenze, 1510 – Roma, 11 novembre 1563
L’affresco risale all’epoca di Cosimo I de’ Medici e venne realizzato tra il
1543 e il 1545, ispirandosi alla scuola del Raffaello e avvalendosi della
collaborazione di Domenico Romano.
Raffigura le storie del generale romano Furio Camillo che, di ritorno dall’esilio,
liberò Roma dagli invasori Galli Boi nel 390 a.C.
L’affresco presenta un allusione allegorica legata alla ripresa della città di
Firenze da parte di Cosimo I dopo la morte violenta del suo predecessore
Alessandro e alla sconfitta e cacciata dei rivoltosi.
I tre simboli del potere di Cosimo I de’ Medici erano:
la Corona Granducale, Il Collare del Toson d’oro e lo Scettro.
Collare del Toson
d’Oro
Il
3 febbraio Cosimo I partì per Roma
lasciando a Firenze Francesco I, per fare le sue veci, e il figlio minore
Pietro. Isabella accompagnò il padre per condividere con lui il grande piacere
dell’incoronazione.
Dopo
numerose tappe in alcune città toscane, giunsero a Roma il 16 febbraio entrando
da Porta del Popolo.
Roma – Porta del
Popolo
Incisione di
Giuseppe Vasi da Corleone
Secondo
la consuetudine , i dignitari in vista soggiornarono a Villa Giulia che era
estata edificata da papa Giulio e nel quale aveva lavorato anche Giorgio
Vasari, arista al servizio di Cosimo I.
Villa Giulia in un
affresco del XVI secolo
Vaticano – La Sala
Regia
Papa dove fu ricevuta di sommo benevolenza e cortesia
Vaticano – Cappella Sistina
Opera del Bronzino ed è conservato
All’ Art Gallery New South Wales di Sydney in Australia
Opera di un
pittore fiorentino del XVI secolo
(Olio su tela –
Misure: (123 x 165) cm
Tra i personaggi
che assistono alla cerimonia si riconosce il nano di corte, il nano Morgante,
che fu immortalato del Bronzino. Il pittore anonimo
seguì l’iconografia della pittura murale di Jacopo Liguzzi nel Salone del
Cinquecento in Palazzo Vecchio e della stampa di Giovanni Stradano che fu
eseguita nel 1582 e pubblicata nel 1583.
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Incoronazione di
Cosimo I de’ Medici
(Artista: Jan Van
de Straet – detto: Giovanni Stradano o Stradanus
Bruges, 1523 –
Firenze, novembre 1605
Pittore fiammingo
attivo a Firenze
Cosimo
I indossava un abito di broccato “riccio sopra
riccio” e una “toga di velluto rosso chermisi, con le maniche a campana
foderate di ermellini, e di sopra a detta vesta una pelle di detti ermellini
per insino a mezze spalle”.
Era accompagnato dal genero Paolo Orsini, che
reggeva lo scettro, e da Marcantonio Colonna, cognato dell’Orsini e come lui
importante rappresentante della nobiltà romana, che portava la corona.
Cosimo
aveva in mano qualcosa e quando s’avvicinò all’altare, dove il papa in piedi lo
attendeva, gli porse l’oggetto in dono:
Altare della
Cappella Sistina
Un
bellissimo calice d’oro finissimo di libre X il manco,
lavorato
benissimo, con tre bellissime figure, cioè Fede. Speranza
e
Carità, tutte d’oro…. quale fe’ Benvenuto Cellini.
Presso
l’altare Pio V istruì Cosimo I aRicevere
la corona… sapendo che siete chiamato ad essere Difensore
della
Fede… obbligato a proteggere vedove e orfani e chiunque sia in
difficoltà,
e che possiate essere sollecito servo e insigne
governante
agli occhi di Dio.
Aveva
raggiunto il suo scopo….. diventare Granduca di Toscana.Isabella
e Cosimo I lasciarono quindi Roma e intrapresero un viaggio, per la verità con
molta calma, per rientrare a Firenze. Giovanna,
la moglie di Francesco, gli andò incontro a circa metà della strada come riferì
il Conegrano il 22 marzoS.A.
è a San Casciano con la S.ra principessa e la S.ra Isabella,
la
quale è venuta da Roma con S.A-“
Il
duca d’Este Alfonso II chiese al
Conegrano se Isabella si fermò a Roma lasciando partire il padre.Infatti molti si aspettavano che l’Orsini supplicasse
il suocero di fare restare la figlia come era successo a Bracciano nell’ultimo viaggio ornai distante nel tempo.La
verità fu che Isabella non solo non si fermò a Roma ma nemmeno soggiornò in
casa del marito Orsini. Un
cronista infatti dichiarò come IsabellaAndò
ad alloggiare nella casa del Cardinale (Ferdinando) suo fratello
nel
Palazzo Firenze a Campo Marzio.
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo
Firenze – Sala del Primaticcio
oppure
fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle
Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase
di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Nel
1571 ci si stava preparando per una missione contro gli ottomani e fu deciso di
affidare a Paolo Orsini un imbarcazione
dove si sarebbero imbarcarti i numerosi esperti militari del suo casato.
Nella lista dei militi mancava qualcuno. Alla fine del giugno del 1571 Troilo
da Firenze scrisse a Paolo Orsini…” Da le acchuse del S. Honore Savello
potrà V.E. vedere l’impedimento mio in poterla servire in questo viaggio
dell’armata. So che tutto quello che li potessi dir di più mi potrebbe
superfluo.
Il
Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi
“impedimenti” nel partecipare alla
missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte
francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il
cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva
intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il
Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le
flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto
di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si
presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La
battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7
ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane
che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La
metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero
Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di
savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La
battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate
da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià
che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
Fortezza di NavarrinoL’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17.
Francesco I de’ Medici e Giovanna
d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca
Cappello era nata a Venezia nel 1548,
figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.
Venezia – Ponte
“ca’ Cappello”
È uno degli
edifici più belli del rinascimento veneziano.
La sua facciata è
contraddistinta da ben 37 aperture. Si sviluppa sua
quattro piani. Il
piano terra presenta solo un esafora centrale e due coppie
di monofore, una
per lato. Sempre al piano terra si aprono due portali ad
acqua. La faciata
è movimentata sia da disegni marmorei che dalla presenza di
numerosi
balconcini che presentano un differente aggetto.
Il palazzo risale all’inizio del XVI secolo e fu
commissionato dalla famiglia Trevisan
all’architetto (ammiraglio e magistrato)
Bartolomeo Bon (Venezia ? – Venezia, dicembre 1509), seguace di Mauro Codussi
anche lui famoso architetto.
Successivamente il palazzo pervenne alla famiglia Cappello e
nel 1577 Bianca
Cappello ne era la
proprietaria per poi donarlo al fratello Vittore nel 1578.
Bianca
era “una tipica bellezza veneziana, con una folta capigliatura tizianesca,
sfumata dal rosso al biondo, ben riprodotta nel suo ritratto. Con la carnagione
candida e un seno florido, era l’incarnazione di una Venere o una Flora”La
sua famiglia aveva accolto addirittura Cosimo de’ Medici da bambino quando la madre lo inviò a
Venezia per proteggerlo dalle truppe imperiali, dopo la morte del padre
(Giovanni de’ Medici “Delle Bande Nere”), alla fine del 1526 (Cosimo I aveva
allora sette anni)
Cosimo I de’
Medici all’età di 19 anni
Artista: Jacopo Carucci,
conosciuto come
(Pontorme, 24 maggio 1494 – Firenze, 1 gennaio 1557)
Pittura: tempera su tavola – Datazione: 1538 circa
Misure: (100,90 x
77) cm
Collocazione: ?
Ma
non era stato il legame con i Medici a portare Bianca a Firenze. Il suo arrivo
a Firenze fu legato ad uno scaldalo che
colpì la nobiltà veneziana.All’età
di dieci anni Bianca perse la madre ed il padre, impegnato nell’attività
politica veneziana, si risposò con la nobildonna Lucrezia Grimani. La
nobildonna era figlia del Doge Antonio Grimani e sorella del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani.Le
cronache citarono un rapporto non proprio felice con la matrigna e la giovane
passava il suo tempo chiusa in casa guardando la città e il canale, dalla
finestra.Di
fronte al palazzo di Bianca c’era il
Palazzo Camin – Tamossi dove i proprietari, i Tamossi, esercitavano la
professione di banchieri.Nel
palazzo c’era una filiale del banco Salviati, famosi banchieri fiorentini.Dalle
finestre del suo palazzo vedeva benissimo alcune finestre degli uffici del
banco come narrò Bartolomeo (il padre di Bianca) «...alquanto
discosta dalla mia, dove habito al Ponte Storto, ma che facilmente però si può
veder per retta linea per via del canal.»Vedeva
spesso un giovane affacciato da quelle finestre e finì con l’innamorarsi.
Le finestre del
banco Salviati viste da palazzo Cappello.
Forse fu la
finestra sopra il portico quella in cui Bianca Cappello
vedeva il giovane
di cui s’innamorò.
Il
giovane era Pietro Bonaventuri, un funzionario che lavorava nel banco e fece
credere alla ragazza di essere un esponente della nobile e ricca famiglia
Salviati.Accecata
dall’amore la giovane Bianca, allora quindicenne, credette al giovane.Era
figlio di Zenobio Bonaventuri, un fiorentino che lavorava anche lui alle dipendenze
della famiglia Salviati. La ragazza non seppe leggere negli occhi del fidanzato, gli affidò
i gioielli della sua dote, e decisero nella notte tra il 28 ed il 28 novembre
1563 di fuggire abbandonando la sua casa paterna.La fuga della ragazza
provocò molto clamore a Venezia a causa del rango sociale della famiglia dato
che il padre, dopo essere stato membro della “Quarantia e Uditore Vecchio”
, era stato nominato “Provveditore sopra i Dazi”.
La fuga di Bianca
CappelloL’ambiente è
veneziano e Bianca appoggia le mani sullaspalla di Pietro
Bonaventuri. È malinconica e volge lo sguardoverso la sua casa
che non rivedrà più. In secondo piano si notanoi due barcaioli
che sono pronti ad imbarcare i due giovani.(Artista: Andrea
Appiani, il Giovane(Milano, 1817;
Milano, 18 dicembre 1865Datazione: prima
del 1865Collocazione:
Musei Civili di Arte e storia – Brescia)
Gli
Avogadori del Gran Consiglio di Venezia emanarono un bando capitale contro
Pietro Bonaventuri ed i suoi complici con una taglia sopra la loro testa per
chi avesse consegnato alla giustizia, vivo o morto, il seduttore.
Il
padre di Bianca aggiunse alla taglia dei soldi e alcuni cronisti riportarono
anche la notizia di come la banca Salviati fu bandita. Ma su questa fonte non
ci sono delle conferme.
Lo
stesso padre di Bianca si rivolse con
gli ambasciatori a Cosimo I de’ Medici,
la
coppia era nel frattempo giunta a Firenze, per ottenere la restituzione della
figlia e la relativa condanna di Pietro. I due giovani furono convocati da Cosimo I che
non prese alcun provvedimento.
Probabilmente
la coppia fece una buona impressione al duca e restò stupito dalla forte
determinazione con cui Bianca seppe difendersi.
A Firenze i due giovani si sposarono ed andarono ad abitare in un palazzo in
piazza San Marco ( al n. 21). Bianca scoprì che l’uomo sposato
l’aveva ingannata perché non aveva alcun rapporto familiare con i
Salviati e si dimostrò un donnaiolo.
Una vita piena di stenti e quindi
ben lontana dalla vita brillante a cui la giovane aspirava e che il marito
Pietro non era in grado di assicurarle. Nel 1564 nacque una bambina a cui
diedero il nome della nonna materna, Pellegrina (nel 1576 sposerà il conte
Ulisse Manzoli Bentivoglio).
La vita di
Bianca stava per cambiare perché diventò
l’amante di Francesco I de’ Medici.
Quando si
conobbero Francesco I e Bianca ?
Non si hanno
riferimenti in merito.
Secondo
alcuni storici i due si conobbero quando Cosimo I de’ Medici li convocò a corte
in seguito alla denunzia nei confronti di Pietro Bonaventura da parte del padre
della ragazza.
Esistono
altre versioni colorite. Celio Malespini, nelle sue “Duecento Novelle” dove
appare il racconto di Isabella, Troilo e la schiava intrufolata nel letto di
Ridolfo Conegrano, pare avesse non poche informazioni riguardanti Bianca. Narra
infatti che costei aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesco
chinandosi sul balcone della casetta del Bonaventura, in cui viveva come una
prigioniera.
Francesco
passava sotto casa sua per recarsi nel laboratorio del casino adiacente alla
chiesa di San Marco, dove svolgeva i suoi esperimenti alchemici e produceva
porcellane e veleni.
Successivamente
il principe fece in modo che Bianca fosse invitata a casa di alcuni vicini
fedeli ai Medici, la famiglia spagnola dei Mondragone, per dichiararle il suo
amore e corteggiarla in modo che “
Roma – Palazzo Firenze
Roma – Palazzo Firenze – Sala del Primaticcio
oppure fu ospite in una villa, sempre di proprietà del fratello cardinale, sul colle Pincio nota come Villa Medici. Una villa da poco acquistata e che era in fase di ampliamento e che sarebbe diventa la residenza principale del cardinale.
Roma – Villa
Medici
Un
membro della corte scrisse a Firenze riferendo che Isabellaè
stata già tre giorni con qualche fastidio et dolore de’ reni, non senza
speranza
di gravidanza
16.
La Spedizione in Oriente
Il Troilo era ritornato da poco da una missione in Francia e i suoi “impedimenti” nel partecipare alla missione in Oriente erano legati alla lealtà che doveva mostrare alla corte francese che non aderivano alla lega antiottomana.
Il cavaliere godeva di un ottima stima presso la corte francese e non aveva intenzione di perderla.
Paolo Orsini partì per l’Oriente mentre il Troilo rimase a Firenze con Isabella.
Le flotte di Spagna, Venezia e Stato Pontificio si riunirono in Sicilia nel porto di Messina l’ultima settimana d’agosto del 1571 e don Giovanni d’Asburgo si presentò con ben 21.000 soldati al seguito.
La battagli di Lepanto, detta anche delle Echinadi o Curzolari, avvenne il 7 ottobre 1571, nel Golfo di Corinto tra le flotte musulmane e quelle cristiane che erano federate sotto le insegne pontefice della Lega Santa.
La metà delle galee erano della Repubblica di Venezia e l’altra metà dalle galee dell’Impero Spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di Lucca, del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova.
La battaglia si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate guidate da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Muezzinzade Alì Pascià che morì nello scontro.
La Battaglia di
Lepanto
Persone
Rappresentate: Vergine Maria; Marco Evangelista;
Santa Giustina di
Padova; San Pietro; San Rocco
Artista: Paolo Caliari,
detto il Veronese
(Verina, 1528 –
Venezia, 19 aprile 1588
Datazione: 1571 –
Pittura: Olio su tela
Misure (169 x 137)
cm
Collocazione:
Galleria dell’Accademia – Venezia
Paolo
Orsini scrisse al Cosimo I..”Io sto bene, se non che ho una frizata di poca importanza, et mi pregio
che come suo servitore ho solo sodisfatto a me.. perché ho combattuto con Portù
bascià”.Era
una replica all’ iniziale riluttanza di Cosimo I di assegnare a Paolo Orsini
una posizione di comando nella spedizione... e per il duca di Bracciano quella
mancanza di fiducia era ancora una ferita aperta.Il
successo riportato a Lepanto garantì all’Orsini incarichi di maggior rilievo
nelle campagne della lega Santa che si svolsero nell’anno successivo. Filippo
lo nominò generale della fanteria italiana al servizio degli spagnoli per la
riconquista della fortezza di Navarino, nel Peloponneso, che era stata
conquistata dai turchi ai veneziani nel 1499.
L’offensiva
fu sferrata nel 1572, ad un anno esatto dalla battaglia di Lepanto, una scelta non casuale. Paolo, che aveva voce
in capitolo le processo decisionale, rilevò la sua opinione sui tempi e le
modalità dell’attacco. Fu un offensiva
che venne definita “maldestra” e fu quindi oggetto di critiche. Aveva
trattenuto le navi, si lamentarono i veneziani, dimostrandosi non troppo sicuro
e troppo cauto. Per altri l’Orsini diventò oggetto di schermo in quanto
incapace di governare la sua nave “a causa della eccessiva pinguedine”
(robustezza, grasso).Navarino
fu l’ultimo atto della sua carriera militare. Ricevette una lettera dalla
Spagna in cui si diceva che “è amato e gradito dal re ma... non li pare
motivo questo del present’anno di incomodar un par di Vostra Eccellenza”.Oltre
agli errori commessi da Paolo Orsini nella battaglia di Navarino, ci furono
anche quelli commessi dalla Lega che non seppe trovare una linea comune nella
strategia militare.Isabella
aveva giudicato l’impresa come una “gita” e non sbagliò nelle sue previsioni .
17. Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Asburgo .....Bianca Cappello
Nel
maggio 1572
il Conegrano scrisse al duca d’Este per riferire l’ennesimo scandalo legato
alle stravaganze di casa de’ Medici
Qui è
ritornato il Sig. Mario Sforza il quale si partì di qua a dì passati et si
disse
per esser il S. principe sdegnato et parimente con la sua consorte
(Giovanna
d’Asburgo) perché lei havea detto a S.A. la principessa (Isabella)
che
Non si
perché S.E. non lo vedde volentieri”.
Bianca Cappello
Bianca Cappello era nata a Venezia nel 1548, figlia di Pellegrina Morosini e del nobile veneziano Bartolomeo Cappello.
Bianca Cappello
Artista:
Alessandro Allori
Galleria degli
Uffizi - Firenze
Bianca Cappello
(?)
(Arista:
Alessandro Allori
Firenze, 31 maggio
1535; Firenze, 22 settembre 1607
Pittura: olio su
rame – Datazione: 1570/1590
Misure (37 x 27)
cm – Collocazione: Uffizi - Firenze
La dama ritratta è
sicuramente Bianca Cappello che fu dipinta, dallo stesso
Allori, in un
affresco che si trova esposto nella Tribuna
degli Uffizi.
Su retro si trova
la raffigurazione di una scena allegoria:
il sogno della
vita umana o allegoria della vita umana
Bianca
Cappello viveva a Venezia nel palazzo che oggi è denominato “Trevisan
Cappello”.
Posto nel sito
sestiere di Castello, affacciato suo Rio di Palazzo di fronte
a palazzo
Patriarcale, poco distante dalla Riva degli Schiavoni e da
Piazza San Marco,
al palazzo s’accede superando il Ponte “ca’
Cappello”, privato.