VIAGGIO LUNGO LE STRAGI DI STATO - LA LOTTA CONTADINA IN SICILIA - PRIMA PARTE
E la lotta
contadina in Sicilia ?
La Sicilia fu una delle prime regioni che sviluppò, subito dopo la fine
della guerra, un movimento di lotta contadino. Sin dal 1944 i contadini
siciliani si ribellarono per la mancata applicazione dei Decreti Gullo che
deliberavano la concessione delle terre incolte e malcoltivate ai contadini, la
modifica dei contratti agrari, le procedure per lo scioglimento degli usi
civici e la quotizzazione dei demani. Tutti decreti che erano sempre stati
boicottati, con cavalli giuridici o con veri atti fi forza, dai grandi
latifondisti cioè dai grandi feudatari del passato. In realtà i movimenti
operai e contadini in Sicilia risalgono al 1891 con i Fasci Siciliani
dei lavoratori.
 |
| (Fascio Dei Lavoratori – Campobello) |
Un movimento d’spirazione libertaria, democratica e socialista, che si sviluppò in Sicilia dal 1891 al 1894, e fondato il primo maggio 1891 a Catania da Giuseppe De Felice Giuffrida. Un movimento di proletariato costituito da braccianti, minatori ed operai. Fu represso con un duro ed inspiegabile intervento militare ad opera del governo Crispi. Azione che fu avvallata dal re Umberto I.
(Giuseppe
De Felice Giuffrida - fondatore dei Fasci))
Il
movimento chiedeva fondamentalmente delle riforme, soprattutto in campo
fiscale, ed una più avanzata normativa nell'ambito agrario che permettesse una
revisione dei patti agrari (abolizione delle gabelle e la
redistribuzione delle terre).
I partecipanti al movimento
chiedevano anche il diritto di voto. Fin dal 1861, con
la nascita dello Stato unitario esso era concesso solo all’1,9% della
popolazione, su 22 milioni di italiani potevano esercitare tale diritto meno di
400 mila persone, quelle cioè che avevano un certo reddito e un titolo di
studio.
(Fascio Dei
Lavoratori – Castelvetrano)
Una grande partecipazione al movimento
si ebbe anche fra le minoranze presenti nell'isola, in particolar modo quella
albanese, in cui un folto gruppo di donne albanesi fu particolarmente agguerrito e fiducioso di un
possibile cambiamento (sugli albanesi della Sicilia gravava maggiormente la
situazione socio-economica dell'epoca).
(Piana degli Albanesi – Palermo)
Il 20 gennaio 1893, a Caltavuturo (PA), cinquecento contadini di ritorno dall'occupazione simbolica
di alcune terre del demanio, usurpate dai borghesi (tra cui il segretario comunale), si fermarono davanti al Comune per chiedere un incontro
con il sindaco.
I manifestanti si stavano allontanando quando
si trovarono di fronte le forze dell’ordine schierate con le baionette in
canna. Cominciarono a sparare senza preavviso. Sembra che a dare inizio alla
sparatoria fu una guardia municipale. Ci furono 13 morti e molti feriti. I
morti furono lasciati sulla strada fino a notte, in pasto ai cani, e non fu
permesso soccorrere i feriti.
«In un
primo tempo», scrisse don Giuseppe Guarnieri, «la popolazione,
nell'udire gli spari, pensò trattarsi di mortaretti fatti scoppiare in onore di
San Sebastiano, ma ben presto fu chiara la tragica realtà di una inumana ed
inutile strage che poteva e doveva essere evitata».
A Caltavuturo non si era ancora formato un Fascio e la manifestazione era
stata organizzata da una Società operaia. La strage destò una grande emozione a
livello nazionale. Qualche giorno dopo il deputato Colajanni presentò
un’interpellanza al ministro dell’Interno, il famigerato Francesco Crispi,
siciliano di Ribera. Denunciò le
condizioni di vita dei contadini siciliani e le violenze e gli abusi dei
proprietari e in una riunione presso il Fascio di Palermo parlò della miseria
dei lavoratori e dello spreco di denaro pubblico, citando il caso del Teatro
Massimo in costruzione, e invitò gli operai a unirsi ai contadini.
 |
| Il Castello Saraceno |
(Foto dal Castello Saraceno)
Il Fascio di Palermo lanciò una sottoscrizione e si svolsero manifestazioni di solidarietà. Il 23 aprile la somma raccolta fu consegnata ai familiari delle vittime di Caltavuturo e i dirigenti dei Fasci Bosco, Verro e Barbato vi tennero un comizio, più volte interrotto dal delegato di PS, che denunciò i manifestanti che lo avevano accolto al grido: “Viva il socialismo”, “Viva la rivoluzione”.
Ci fu un’inchiesta sull’eccidio. Fu sciolta l’amministrazione comunale, venne accertato che il segretario e altri impiegati municipali coltivavano abusivamente le terre demaniali, ma il segretario comunale successivamente fu reintegrato nell’incarico. Alcuni anni dopo le terre venero lottizzate e distribuite ai contadini.
A seguito di tale massacro furono organizzate numerose manifestazioni di solidarietà sia da parte dei Fasci, che sul piano nazionale,( i fasci cominciarono a diffondersi nel resto d’Italia) ed aumentò l'esasperazione dello scontro sociale.
Il governo inviò l’esercito, con l’ordine
di sparare sulla folla. Fu un
susseguirsi di massacri: in breve tempo, dalla fine del 1893 ai primi giorni
del 1894, ci furono 92 morti tra i popolani e
un solo soldato. Sommando i 16 morti precedenti, quelli della strage di
Caltavuturo e i caduti in altre circostanze, ci furono, dal gennaio 1893 al
gennaio 1894, 108 morti. I massacri più sanguinosi a Giardinello (10 dicembre,
11 morti), a Lercara (25 dicembre, Natale, 7 morti), a Pietraperzia (primo
gennaio, 8 morti), a Gibellina (2 gennaio, 20 morti), a Marineo (3 gennaio, 18
morti), a Santa Caterina Villarmosa (5 gennaio, 13 morti). A volte si sparò
senza i regolari squilli di tromba e a sparare, prima o assieme ai soldati,
furono i campieri dei mafiosi.
Giardinello
(Palermo)
10
Dicembre 1893
Il
Fascio dei Lavoratori fu fondato a Giardinello poche settimane prima del massacro. Una prima manifestazione
di malcontento si ebbe il 3 dicembre. Ancora una volta erano le donne a
protestare non solo per l’abolizione
delle tasse sui prodotti alimentari ma anche per lo scioglimento delle guardie
campestre locali (mafiosi al servizi dei proprietari terrieri) e per
l’istituzione di una lavanderia pubblica essenziale per i bisogni della
popolazione. Il 10 dicembre i manifestanti si radunarono nella piazza subito
dopo la messa (è domenica). Il piccolo centro allora faceva circa 814 abitanti.
All’uscita della chiesa iniziò una prima protesta… si levarono alte le grida: “Abbasso
le tasse e il Municipio”, “Abbasso Guardie campestri e Birri”. La
situazione precipitò perché i manifestanti raggiunsero la casa del sindaco,
posta vicino al municipio, e chiesero una risposta dal primo cittadino. Il
sindaco non rispose e questo creò una forte agitazione tra la folla. La moglie
del sindaco s’affaccio dalla finestra di casa e versò sulla folla un secchio
d’acqua. Un gesto accompagnato da forti insulti. I dimostranti riuscirono ad
entrare nel Municipio saccheggiandolo e incendiando mobili ed archivi. Alcune
donne presero due ritratti del re e la bandiera nazionale e il portarono in
piazza gridando: Viva la Casa Savoia”,
“Viva il Re”, “Viva la Regoina”. I pochi Carabinieri presenti a Giardinello
furono costretti a chiamare rinforzi da Montelepre. La situazione sembrava più
calma, la gente aveva sfogato la sua rabbia ma dalla casa del sindaco venne
sparati dei colpi d’arma da fuoco sulla folla….
Furono uccise dieci persone… la folla inferocita uccise il segretario
comunale e la moglie.
(La Tomba del
Gigante)
LERCARA FRIDDI
25 Dicembre 1893 … Natale
Il giorno precedente un gran numero di donne
avevano guidato un azione di protesta contro le tasse. Poi la situazione
degnerò con l’assalto dei circoli dei nobili. Lercara era un paese di
agricoltori e minatori… gente che viveva in condizioni di miseria e che subiva lo sfruttamento anche dei
minori … i famosi “carusi” che lavoravano nelle miniere di zolfo.
I
manifestanti assaltarono anche i casotti
daziari, detti anche “caselli”,
devastandoli e bruciandoli. La forza pubblica non riuscì a contenere l’azione
di protesta della gente disperata.
Il giorno
successivo…. è Natale verso le 16 le donne, ancora una volta importanti
protagoniste del movimento di protesta, con gli uomini e i bambini si riunirono
in piazza… avevano un obiettivo: assaltare il municipio. Avevano in mano degli
stracci che svoltolavano come se fossero delle bandiere e gridavano: “Giù le tasse… Abbasso il Sindaco”.. Si
percepiva nelle loro grida una senso di stanchezza… di rabbia… non tolleravano più la sfruttamento e la
fame.
Dai
balconi dei palazzi nobiliari si gridava…”Morte
agli istigatori… morte ai sovversivi”…era la voce dei nobili, dei latifondisti..
dei proprietari delle ricche miniere..
Il
vice prefetto ed il Procuratore di Palermo si recarono subito a Lercara per
cercare di calmare la folla. Il vice
prefetto, dal balcone del munipio promise l’abolizione di alcune tasse ma il
lancio di sassi da parte dei manifestanti, lo costrinse a ritirarsi.. Con il
pubblico ministero e il magistrato esaminatore fu costretto a fuggire scendendo
da una finestra sul retro. Nel frattempo arrivarono da Palermo i rinforzi
militari.. dai balconi i nobili invitavano le forze dell’ordine ad agire…
I
due schieramenti si trovarono l’uno di fronte all’altro… i militari invitarono
a folla a disperdersi… attimi di silenzio…. Poi improvvisamente i manifestanti
affrontarono le truppe governative con sassi e bastoni…..i militari spararono
nel momento in cui i dimostranti stavano per riuscire a sfondare la barriera
militare… sul selciato morti e feriti… si parlò di sette morti ma in realtà
furono undici.. Nella piazza un’atmosfera di cinica e turpe istigazione al massacro.
“Non si
sarebbe mai saputo chi avesse sparato per primo […] non è affatto da escludere
che a sparare per primo fosse stato qualche campiere, qualche mammasantissima,
appostato dietro l’angolo di qualche casa e incaricato di provocare la strage
da una delle fazioni che si contendevano il potere in paese. Le carte tacciono
in proposito”. (Mario Siragusa, Stragi e stragismo nell’età dei Fasci
siciliani. In “La Sicilia delle stragi”. a cura di Giuseppe Carlo Marino.
Newton Compton Editori Roma.2007. pag. 119)(Prof. Elio Camilleri – Autore di
saggi sulla mafia).
(Lercara Friddi – Chiesa Madre )
(Lercara Friddi – Uomini in Miniera)
In questo contesto, il
presidente del consiglio, il siciliano Crispi, adottò la linea dura con un intervento militare
comprendente esecuzioni sommarie e arresti di massa.
La situazione in Sicilia era grave. La lunga catena di
eccidi evidenziavano uno stato di emergenza.. un malessere economico e sociale
che opprimeva l’isola. È necessario essere obiettivi e riconoscere come Crispi,
prima di ricorrere alla forza, si era insediato come capo di governo il 15
dicembre 1893, tentò una via pacifica per cercare di tamponare il disordine
sociale nell’isola. Il 25 dicembre inviò ai Prefetti dell’isola una circolare
per fare abolire o ridurre le tasse comunali da parte dei Sindaci.
La circolare telegrafica riportava: “ Il movimento dei contadini contro i Municipi rivela i vizi delle
amministrazioni comunali. La ripartizione delle tasse locali spesso non è stata
fatta con equità e prudenza, e in molti luoghi quelli cosiddetti galantuomini
hanno fatto pesare sui lavoratori il pagamento delle imposte. È tempo ormai di
correggere questi errori, e sarebbe questo il vero mezzo per impedire giorni
luttuosi e di portare la pacificazione negli animi di coloro che vivono della
loro opera manuale. Comunichi immediatamente questi miei consigli ai sindaci
della provincia e provveda affinchè siano esauditi i voleri del governo”.
Oltre a Lercara Friddi lo stesso giorno di Natale la
popolazione di Valguarnera (Enna9 si ribellò per le tasse comunali. Furono
incendiati degli edifici pubblici e privati. Trenta persone furono arrestate.
La drammaticità degli eventi portò il governo Crispi a proclamare il 3 gennaio lo stato d’assedio, lo
scioglimento dei Fasci e l’arresti dei dirigenti. Uno stato d’assedio che
cesserà il 18 agosto 1894. Il generale Roberto Morra di Lavriano venne nominato
commissario straordinario per la Sicilia.
Il decreto, come detto, del 3
gennaio 1894, all’articolo 2 affermava: “Il
Tenente Generale Roberto Morra di Lavriano e della Montà Comandante il XII
Corpo d’armata è nominato nostro Commissario Straordinario con pieni poteri.
Tutte le autorità civili e militari sono poste sotto la immediata di Lui
dipendenza. Dal 3 gennaio 1894 il regio Commissario Straordinario assumerà i
pieni poteri su tutta la Sicilia e tutte la autorità civili e militari daranno
esecuzione al decreto”.
Con lo stato d’assedio, la
svolta autoritaria del governo Crispi era compiuta. I Fasci dei Lavoratori
erano fuori legge e il movimento, in quel momento, era in piena crescita, Lo stesso 3 gennaio a
Palermo si riunì il comitato centrale dei Fasci. Si denunciavano le repressioni
brutali e si avanzavano alcune richieste al governo, tra cui l’abolizione del
dazio sulle farine, un’inchiesta sulle amministrazioni locali, la
legalizzazione dei patti agrari e delle deliberazioni del congresso di Grotte,
la costituzione di collettività agricole e industriali, il salario minimo. Ma
ormai la situazione era precipitata e i dirigenti arrestati saranno giudicati
da tribunali di guerra. I vescovi siciliani inveirono contro gli “istigatori
malvagi” e le “ree dottrine”, condannando socialisti e massoni. Anche il
vescovo di Caltanissetta, che prima aveva mostrato di comprendere le “ragioni
del malcontento”. Si unì al coro. Il
cardinale di Palermo, Celesia, condannò i “mestatori anarchici e socialisti”.
4 Gennaio 1894
Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta)
Il 20 novembre 1893 200 soci del fascio dei Lavoratori
si recarono alle ore 14 alla periferia del contro per accogliere l’arrivo del
presidente del movimento Lo Vetere. Il corteo era preceduto dalla bandiera
tricolore nazionale, dalla fanfara e da tutti i presidenti delle varie sezioni
della stessa associazione che indossavano fasce rosse.
Il comandante dei carabinieri della compagnia
territoriale di Caltanisetta, Pellegrini, informò il Prefetto che nel rispetto
dell’ordine, i dimostranti “no arrivando
Lo Vetere, hanno percorso la via maestra, sciogliendosi alle ore 15”.
il 10 dicembre del 1893, Pellegrini informò il
Prefetto che alle ore 11,50 “persone del
Fascio dei Lavoratori, indossando bracciali rossi con musica e bandiera, si
sono recati fuori dall’abitato per attendere l’arrivo del presidente Filippo Lo
Vetere proveniente da Palermo, al suo arrivo verrà ricevuto al grido di “Evviva
il Fascio” e il corteo si scioglierà alle ore 13,45”.
Il Prefetto, con lettera del 12 dicembre, chiederà al
comandante dei carabinieri se “i
promotori del corteo del 10 dicembre sono stati denunziati all’autorità
giudiziaria per l’inosservanza dell’art. 7 della Legge sulla P.S”.
La risposta, con lettera del 14 dicembre, sarà: “ i promotori della passeggiata eseguita dal
Fascio dei Lavoratori di Santa Caterina non avendo ottemperato all’art 7 della
Legge sulla P.S., son stati denunziati con processo verbale all’Autorità
Giudiziaria”.
Il 4 gennaio ignorando il decreto del governo Crispi
sullo stato d’assedio della Sicilia, il fascio di Santa Caterina organizzò una
manifestazione di protesta contro l’amministrazione comunale. Si chiedeva la
riduzione delle imposte comunali molto pesanti.
Gli aderenti al fascio sfilarono per le vie del paese.
Una manifestazione quella del 4 e del 5 che è particolare nel suo evolversi
perché il movimento era giovane (si era costituito da appena quattro mesi per
merito di Filippo Lo Vetere). Un movimento che aveva valide direttive dato che
il Lo Vetere (presidente), il vicepresidente e il segretario erano spesso
assenti.
Nei primi giorni del 1894 venne affisso in paese un
manifesto con cui il sindaco prometteva di “sacrificare
anche gli stipendi di tuti gli impiegati al fine di accontentare la popolazione
sulla riduzione delle imposte”.
Il 4 gennaio il consiglio comunale si riunì d’urgenza,
si temevano disordini, e deliberò la diminuzione del “focatico e delle tasse sul bestiame”. Il provvedimento con fu
accolto in modo positivo dalla popolazione tanto che nella stessa giornata ci
fu una manifestazione di protesta.
Il “Giornale di Sicilia” del 5 gennaio riportò gli avvenimento del
giorno precedente: “Le trombe del Fascio
suonavano di continuo, aspettando la riunione dei soci. Nel pomeriggio
un’immensa popolazione percorse le vie del paese con la bandiera e le trombe
alla testa gridando “ Viva il Re ! Abbasso le tasse ! Viva l’unione! Celestino
Giuseppe, vice presidente del Fascio, arringò i dimostranti e li esortò alla
calma e al rispetto; li pregò a non lasciarsi vincere dagli esempi dolorosi
degli altri paesi e a non sentire i fomentatori, che per mire di passioni o
d’interessi consigliano la peggio. Il popolo si sciolse persuaso, ma non
convinto”.
A guidare la manifestazione del 4 gennaio erano tre
componenti del Consiglio direttivo: Manzone, Bruno, Nicosia e La Placa che era
un socio del Fascio.
La manifestazione si sciolse senza incidenti e in
serata arrivarono 15 militari all’ordine del tenente Colleoni. Il tenente venne
a conoscenza del nome degli organizzatori e che per il giorno successivo era
prevista una manifestazione più partecipata.
Il 5 gennaio alle ore 12 la popolazione si riunì in
Piazza Garibaldi. I manifestanti avevano
la bandiera, ritratti del re e della regina e un Crocifisso. Iniziarono a
protestare gridando: “Viva il Re! Viva la
Regina! Viva il Crocifisso! Abbasso le tasse!”.
Prima della manifestazione il tenente invitò il
vicepresidente Celestino e il cassiere del Fascio, Bruno, a sciogliere la
protesta. Risposero che “essendo dimissionari, non avevano nessun
potere all’interno del Fascio”.
La manifestazione si snodava per le vie del centro e
il tenente Colleoni con 12 militari si schierò in Piazza Garibaldi.
Appena la folla giunse in piazza il tenente cercò di
sciogliere la manifestazione invitando la folla a cessare nella protesta.
Alcuni manifestanti accolsero l’invito e rientrarono nelle proprie case mentre
circa 2.000 persone, tra cui molte donne e uomini, continuarono nella protesta.
Verso le tredici i militari invitarono i manifestanti
a sciogliere l’adunata ma senza successo. Fu ordinato il primo squillo di
tromba e dopo venti minuti il secondo e poi ancora il terzo ed ultimo squillo.
I dimostranti non si arresero e si
raggrupparono ancora più numerosi sotto la bandiera restando immobili.. senza
reagire.
L’atmosfera stava diventando sempre più testa… il
maestro elementare Michele Capra, rendendosi conto del grave pericolo, si
affacciò dal balco della propria casa situata proprio in Piazza Garibaldi. Dal
balcone cercò di esortare, con grande animo e con parole quasi supplichevoli, “di sciogliere l’adunata e di rimettersi
agli ordini delle autorità”.
Il tenente Colleoni cercò ancora una volta di
convincere la folla a finire nella protesta e pronta fu la risposta di Filippo
Manzone al militare: “fate ritirare la
truppa, con le buone la folla si disperderà”.
L’ufficiale s’era ormai convinto che i manifestanti
prima o poi avrebbero aggredito e nonostante gli inviti del maestro Capra, fu
ordinato il fuoco. Un fuoco che provocherà dieci morti e venti feriti tra
uomini, donne, anziani e bambini.
Scene tremende… da fare rabbrividire.. nella Piazza
grida strazianti, dolorose imprecazioni, panico e fuga dei dimostranti… alla
fine sul selciato riempito di morti,
alcuni agonizzanti.. e la piazza vuota con alcuni soldati e i militari tra cui
tre feriti non gravi.
Il plotone rientrò in caserma .. la popolazione è
disperata.. si recuperano i morti.. i feriti verranno portati nelle loro
abitazioni.. quattro dopo una lenta e penosa agonia moriranno nei giorni 9, 21
gennaio e 10 febbraio 1894. Nel telegramma firmato Ardizzone si legge: “Ecco come andarono i fatti a S. Caterina…Le
donne incitanti come energumeni uomini furono causa principale dei dolori
fatti”. (Archivio Centrale dello Stato di Roma).
Le vttime:
Orazio Terravechia di 10 anni;
Rosa Ippolito di 10 anni;
Mariano La Placa di 17 anni;
Salvatore Frumentino di 24 anni;
Calogero Stella di 28 anni;
Tommaso Amico di 38 anni;
Giuseppe Buonasera di 43 anni;
Marco Rizza di 48 anni;
Calogero Buonasera di 58 anni;
Calogero Lazzara di 68 anni.
A questoi dieci martiri si aggiunsero:
Maria Grazia La Placa di 20 anni;
Vittoria Falzone di 29 anni;
Antonia Casurci di 50 anni;;
Calogero La Placa di 50 anni;
Tra i militari restarono feriti il soldato Leonardo Peccile
e i Carabinieri Calvioli e Mastrodomenico.
Il 10 gennaio “Il Siciliano” organo del Comitato
centrale dei Fasci dei Lavoratori, subito sequestrato dal Morra, riportò gli
attimi strazianti di quella strage che furono descritti da Benedetto Salemi nella
visita al cimitero di Santa Caterina. Vide le vittime..”Si va al Cimiero per una via che sale leggermente ad un colle, nel
piccolo campo dei morti, a sinistra, stavano schierate le casse che serrano i
poveri uccisi. Ce n’era una, grande: una vecchia barella tinta di grigio con
due larghe fasce di nero che s’incrociavano. Il custode, levata una grossa
pietra da su il coperchio, lo sollevò. Nella vecchia barella avevano messo due
cadaveri: uno su l’altro: uno con la faccia sotto i piedi dell’altro ! Sopra,
stava un ragazzo: era morto dopo una lunga agonia e aveva gli occhi a pena
socchiusi, e sul viso profilato ancora un’espressione di angoscia. L’altro era
un uomo, con un po’ di barba sotto il mento. Aveva i grandi occhi neri
sbarrati: era morto nel vigor della vita, fulminato, e quegli occhi vitrei che
dal corpo supino guardavano il cielo, pareva invocassero, ancora morti, il
Cielo: pareva che quello sguardo, con una serenità lunga di eroe, dicesse:”O
Signore, Signore ! Vedete…”
“Dopo altre casse.. fatte di tavole bianche, ce n’era una piccola, foderata
di roba celeste; povera roba ma
immacolata, lo volli vedere l’innocente piccola vittima che forse non aveva
nemmeno gridato! E pregai il custode di schiodare la cassa. La bambina era
grande per i suoi nove anni. giaceva, con la testina un po’ volta da un lato e
le braccia distese lungo i fianchi. Non aveva ancora la rigidità della morte e
la sua faccia era rossa, e sulla bocca, coperta di bava, colava dal naso una
schiuma sanguigna che gorgogliava ancora, a intervalli che pareva avessero la
regolarità del respiro”.
“Ma, è viva ! esclamai”.
“Il custode sorrise.. e rispose “Viva ?” e richiuse il coperchio”
“Oh era morta davvero, povera bambina ricciuta ! Era morta davvero, misera
madre derelitta, ora ! povera madre straziata che nella disperazione della sua
pena ebbe pure la forza di rivestire il cadavere della sua creatura; di
chiudere gli occhi alla sua bimba morta; di foderare di roba celeste la cassa
nella quale dovevano chiudere per sempre, la figlia sua uccisa; nella quale
dovevano portarle via, per sempre, la figlia sua perduta !”
Sei anni dopo Pirandello, nel suo romanzo “I Vecchi e
i Giovani” pubblicherà quella visita al cimitero di Santa Caterina pubblicata
dal Sallemi.
Santa Caterina nei giorni seguenti all’ecidio sembra
spopolata, frastornata e chiusa nel proprio dolore. Molti si saranno chiesti “com’è successo”. Una risposta che ha soluzioni sociali e
politiche, azioni repressive a volte disumane,, come quelle del 5 gennaio… che
possono dare spiegazioni al tragico evento.
Il 17 gennaio alle ore 15 si presentò la polizia nel
comune per una perquisizione nella sede del Fascio e per il suo scioglimento,
in base al decreto prefettizio del 15 gennaio. Il locale, ubicato al piano
terra in fondo a Via Garibaldi, probabilmente al numero civico 20 cioè nello
stabile che all’epoca era abitato dai D’Anca.
I funzionari di PS:
-Luigi De Sarro, delegato provinciale di PS:
Diomede Saveri, maggiore del Reggimento Fanteria;
Nostre Giovanni, comandante della locale stazione dei
Carabineri.
Con l’assistenza del quarantenne D’Anca Giuseppe,
detentore della chiave dell’associazione, i militari eseguirono una
perquisizione del locale e successivamente al formale scioglimento del Fascio.
Sul Fascio avevano riposto tante attese i cittadini di
Santa Caterina per ottenere miglioramenti economici e per superare quello
stato di perenne miseria e sfruttamento
sul lavoro.
Per i luttuosi avvenimenti ci furono molti arrestai e
denunzie con l’accusa di “incitamento
alla guerra civile, resistenza e violenza alla forza pubblica”.
Il Tribunale di guerra di Caltanissetta istituirà a
marzo il processo per i denunziati.
Nel frattempo le indagini si erano concluse e il 21
febbraio 1984 il Tribunale di Caltanissetta rinvierà a giudizio, proprio di
fronte al Tribunale di Guerra, ventotto manifestanti della rivolta.
A carico di Filippo Lo Vetere, presidente
dell’associazione e residente a Palermo, l’autorità giudiziaria spicherà un
mandato di cattura per aver promosso, con la sua propaganda e “quale mandatario di Giuseppe De felice
Giuffrida” , Capo del Fascio di Catania, la sommossa del 5 gennaio.
Riuscì a sfuggire alla polizia e si rifugiò a Lugano
in Svizzera. Rientrerà in Italia quando sarà prosciolto da tribunale militare
presieduto dal colonnello Vincenzo Orsini. Il processo si chiuderà il 5 marzo
1894 con la condanna di 23 imputati e l’assoluzione di cinque.
Il generale Morra di Lavriano, al comando di un esercito di circa 60.000
uomini si renderà artefice di brutali
azioni su donne, bambini, sulle masse disagiate. Effettuerà arresti in massa ed
avrà il coraggio di organizzare una manifestazione in cui premiò i soldati che
avevano sparato sui manifestanti….. si recò anche al palazzo arcivescovile per ringraziare il
vescovo Celesia..
I tribunali di guerra erano palesemente illegittimi, poiché lo Statuto
albertino, la costituzione dell’epoca, prescriveva che non si poteva derogare
all’organizzazione giudiziaria ordinaria se non con una legge. Invece i
tribunali vennero istituiti dal generale Morra di Lavriano in base a un decreto
regio, mentre occorreva un voto del parlamento.
(L’ufficio del Generale Morra a Palermo)
Nei vari processi che si susseguirono nei primi mesi del 1894 (il 7 marzo
cominciò il processo di Trapani per il massacro di Giardinello, il 10 marzo per
i fatti di Lercara, il 26 marzo per i fatti di Marineo, il 7 aprile il processo
di Palermo a undici dirigenti) gli imputati furono accusati di cospirazione
contro i poteri dello Stato, di eccitamento alla guerra civile, alla
devastazione, strage e saccheggi.
L’accusa che nei Fasci ci fossero pregiudicati e delinquenti venne ribadita nel processo di Palermo dall’avvocato fiscale. Un’ accusa che gli imputati respinsero definendola “ridicola”. De Felice prese per buone le cifre che vennero fornite e fece il rapporto con il numero dei soci dei Fasci secondo le fonti ufficiali. Facendo la proporzione tra il numero dei deplorati (indagati) della Camera dei deputati e il numero dei parlamentari, ricavò che tra i lavoratori la moralità era quindici volte maggiore che tra i deputati. Commenta Colajanni:
L’accusa che nei Fasci ci fossero pregiudicati e delinquenti venne ribadita nel processo di Palermo dall’avvocato fiscale. Un’ accusa che gli imputati respinsero definendola “ridicola”. De Felice prese per buone le cifre che vennero fornite e fece il rapporto con il numero dei soci dei Fasci secondo le fonti ufficiali. Facendo la proporzione tra il numero dei deplorati (indagati) della Camera dei deputati e il numero dei parlamentari, ricavò che tra i lavoratori la moralità era quindici volte maggiore che tra i deputati. Commenta Colajanni:
“E il confronto sarebbe
riuscito più concludente in favore dei Fasci se posto tra questi e i
commendatori e i cavalieri del regno d’Italia; con questa differenza che i
delinquenti operai per piccoli reati vanno in galera, i commendatori
delinquenti vanno fino in Senato”.
Il delegato di PS di Piana dei Greci definì i dirigenti dei Fasci dei sobillatori.
Un difensore gli chiese da cosa lo arguiva e il delegato rispose che su ordine
di Barbato i soci dei Fasci si erano fatti crescere i baffi (allora li
portavano solo i nobili e i borghesi).
Intervenne Barbato che sintetizzò la sua attività:
Intervenne Barbato che sintetizzò la sua attività:
“Non predicavo amore, ma non
predicavo odio. Educavo. Persuadevo dolcemente i lavoratori morenti di fame che
la colpa non è di alcuno, è del sistema […]. Certo, la nostra propaganda è
energica, fa rialzare la testa. I contadini si lasciano crescere i baffi, dice
il delegato. È vero. Essi hanno acquistato la coscienza di essere uomini. Non
domandano più l’elemosina. Chieggono ciò che è diritto. La menzogna è svanita,
è svanita la loro viltà: con la nostra propaganda si innalzano. Non si
appostano più per uccidere il padrone a tradimento: lo guardano negli occhi e
domandano colla forza del diritto. E scioperano”.
Non è il lavoro di routine di un sindacalista o di un capopartito, è la
missione di un apostolo. E nei processi la personalità dei dirigenti dei Fasci
si rivela per intera, suscitando l’ammirazione anche dei militari che li giudicano.
I capi dei Fasci sono accusati di complotto contro lo Stato, al soldo di nazioni straniere. Le “prove” che vengono portate sono ridicole, come il cosiddetto “trattato di Bisacquino”. I dirigenti dei Fasci nell’ottobre del 1893, in quel comune in provincia di Girgenti, avrebbero sottoscritto un trattato con la Francia e la Russia per dividere la Sicilia dall’Italia. Il delegato di Bisacquino nel processo sostenne che aveva “la certezza metafisica” dell’esistenza del trattato, evidentemente inesistente. Nel febbraio-marzo sempre del 1894, nel corso di un dibattito parlamentare sui Fasci, Crispi, per sostenere la tesi del complotto, citò un manifesto in cui i soci dei Fasci, “figli del Vespro”, venivano esortati alla rivolta. Il deputato socialista Prampolini chiese. “È firmato?”. Crispi risponde “È firmatissimo”. Non c’era nessuna firma e il proclama era stato scritto da un vice cancelliere di pretura di Petralia Soprana e inviato al marito di una donna, di cui era innamorato, per metterlo nei guai. Questa sarebbe stata la prova provata del complotto internazionale.
I difensori degli imputati non potevano essere degli avvocati, erano ufficiali dell’esercito. Ma essi ben presto si accorgono di non aver a che fare con delinquenti e De Felice alla fine del processo di Palermo li ringraziò a nome di tutti gli imputati:
I capi dei Fasci sono accusati di complotto contro lo Stato, al soldo di nazioni straniere. Le “prove” che vengono portate sono ridicole, come il cosiddetto “trattato di Bisacquino”. I dirigenti dei Fasci nell’ottobre del 1893, in quel comune in provincia di Girgenti, avrebbero sottoscritto un trattato con la Francia e la Russia per dividere la Sicilia dall’Italia. Il delegato di Bisacquino nel processo sostenne che aveva “la certezza metafisica” dell’esistenza del trattato, evidentemente inesistente. Nel febbraio-marzo sempre del 1894, nel corso di un dibattito parlamentare sui Fasci, Crispi, per sostenere la tesi del complotto, citò un manifesto in cui i soci dei Fasci, “figli del Vespro”, venivano esortati alla rivolta. Il deputato socialista Prampolini chiese. “È firmato?”. Crispi risponde “È firmatissimo”. Non c’era nessuna firma e il proclama era stato scritto da un vice cancelliere di pretura di Petralia Soprana e inviato al marito di una donna, di cui era innamorato, per metterlo nei guai. Questa sarebbe stata la prova provata del complotto internazionale.
I difensori degli imputati non potevano essere degli avvocati, erano ufficiali dell’esercito. Ma essi ben presto si accorgono di non aver a che fare con delinquenti e De Felice alla fine del processo di Palermo li ringraziò a nome di tutti gli imputati:
“Essi che accettarono titubanti le
nostre difese perché ci credettero per un momento colpevoli, li avete sentiti,
hanno col maggiore entusiasmo sostenuta la nostra difesa perché ci sanno innocenti.
Essi dubitarono della nostra fede, noi non dubitammo mai della loro lealtà,
vennero sconosciuti al carcere, uscirono fratelli nostri”.
Le condanne, sia nel processo di Palermo che negli altri processi furono
pesantissime: De Felice fu condannato a 18 anni di carcere, Verro a 16, e nel
processo per i fatti di Lercara aveva riportato un’altra condanna a 16 anni,
Bosco e Barbato a 12, Montalto a 10, gli altri a pene minori.
Non ci furono solo i tribunali militari, anche la magistratura ordinaria fece la sua parte e furono arrestate e inviate a domicilio coatto 1.962 persone.
La solidarietà nei confronti dei condannati fu forte e concreta: alle elezioni politiche del 1895 De Felice fu eletto deputato (elezione annullata e ripetuta per due volte) a Catania e a Roma, Barbato a Milano e a Cesena, Bosco a Palermo. I socialisti in Sicilia triplicarono i voti. E il nuovo presidente del Consiglio, il palermitano Antonio Di Rudinì, concesse l’amnistia (14 marzo 1896), a condizione che non ricostruissero il movimento.
Negli anni successivi ci fu un grande flusso migratorio: in poco più di un decennio lasciarono la Sicilia circa 560.000 persone e le partenze continuarono fino a toccare il milione su una popolazione di circa 3 milioni e mezzo.
Le lotte contadine riprenderanno negli anni precedenti e successivi alla prima guerra mondiale e nel secondo dopoguerra. Dai Fasci siciliani alle lotte degli anni ’40 e ’50 del ‘900 esse costituiscono il più grande movimento di massa impegnato in una lotta di liberazione dalla mafia e dai suoi complici che continua fino ai nostri giorni.
Non ci furono solo i tribunali militari, anche la magistratura ordinaria fece la sua parte e furono arrestate e inviate a domicilio coatto 1.962 persone.
La solidarietà nei confronti dei condannati fu forte e concreta: alle elezioni politiche del 1895 De Felice fu eletto deputato (elezione annullata e ripetuta per due volte) a Catania e a Roma, Barbato a Milano e a Cesena, Bosco a Palermo. I socialisti in Sicilia triplicarono i voti. E il nuovo presidente del Consiglio, il palermitano Antonio Di Rudinì, concesse l’amnistia (14 marzo 1896), a condizione che non ricostruissero il movimento.
Negli anni successivi ci fu un grande flusso migratorio: in poco più di un decennio lasciarono la Sicilia circa 560.000 persone e le partenze continuarono fino a toccare il milione su una popolazione di circa 3 milioni e mezzo.
Le lotte contadine riprenderanno negli anni precedenti e successivi alla prima guerra mondiale e nel secondo dopoguerra. Dai Fasci siciliani alle lotte degli anni ’40 e ’50 del ‘900 esse costituiscono il più grande movimento di massa impegnato in una lotta di liberazione dalla mafia e dai suoi complici che continua fino ai nostri giorni.
L'on. de Felice fu difeso in
sede giudiziaria dall'avvocato siciliano G.B. Impallomeni.
(Il
Processo a Giuffrida De Felice)
(Francesco
Crispi…..di Ribera… un assassino
Il
ministro dalle false prove…. Dello Scandalo della Banca Romana e ..delle due
mogli…)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo la seconda guerra mondiale in Sicilia erano ancora presenti
nel territorio dei grandi latifondi legati alle nobile famiglie aristocratiche.
Feudi che risalivano ad antiche concessioni regie normanne, aragonesi, sveve.
Il movimento contadino acquistò vigore quando fu emesso il decreto Gullo n. 279
del 19 ottobre 1944 che, come abbiamo più volte visto, concedeva i terreni mal
coltivati ai contadini. Ma i proprietari terrieri della Regione non erano
certamente decisi a perdere un potere economico e soprattutto sociale. Fu per
questo che nel 1948 si formarono in Sicilia dei centri di assistenza legale per
i contadini. Infatti i proprietari per non perdere i propri vasti latifondi
ricorsero a vie legali contro i contadini che rivendicavano i propri diritti legate
alle concessioni. I terreni incolti dovevano essere assegnati ai contadini
richiedenti che si dovevano costituire in cooperative o in altri enti.
Solo in questo modo potevano avere la concessione “di terreni di proprietà privati o di enti pubblici che
risultino coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro
qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali
dell’azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale
(art, 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n.279 (in Gazzetta ufficiale, serie speciale 4 novembre 1944
n.77).
Sorse il Comitato di Solidarietà Democratica che riunì vari
avvocati per assistere e difendere legalmente i lavoratori per le lotte
sindacali e i contadini per l’ottenimento dei terreni incolti in base alla
Riforma Agraria.
Il
Comitato provinciale di Palermo fu il primo in Sicilia e dopo la formazione
degli altri comitati nelle varie città siciliane, nel 1951 divenne regionale
con funzione di coordinamento.
Ma
la Sicilia contava già le sue vittime in questa dura e difficile lotta
contadina.. Vittime dei carabinieri, della polizia…e della mafia, che difendeva
gli interessi dei latifondisti.
28 Maggio 1944 – Licata (Ag)
Polizia e carabinieri spararono sulla folla che protestava
per la riammissione all’ufficio di collocamento di un dirigente fascista… 3
morti, 18 feriti e 120 dimostranti arrestati.
19 Ottobre 1944: Palermo
In
quella tragica mattina i palermitani erano scesi in piazza per reclamare il
lavoro, il cibo e la ricostruzione dei palazzi colpiti e sventrati dalla
guerra. Una dimostrazione di piazza che si ripeteva da diverso tempo. Una folla
eterogenea costituita da gente umile, donne e bambini e da esponenti e
militanti dei vari partiti. Tutti avevano un obbiettivo comune: chiedere il
pane.... il lavoro.
Una
triste immagine della città colpita dalla guerra e dal difficile inverno del
1943. Un inverno difficile che i palermitani e i siciliani riuscirono a
superare grazie agli aiuti alimentari anglo-americani. Ma nel febbraio del 1944
avvenne qualcosa di grave.
L’amministrazione civile dell’isola passò dal governo d’occupazione
alleato al governo italiano… la situazione precipitò….
Francesco
Musotto era stato nominato da Badoglio prefetto nell’aprile dell’44. Un uomo
dalle idee separatiste e che godeva della fiducia degli alleati, dei partiti
politici e del movimento separatista (tranne alcuni esponenti mafiosi delle
Madonie).
Musotto
tenne a cuore la situazione sociale della propria città. Con la sua nomina a
prefetto, riapparvero nei negozi palermitani dei beni di prima necessità. E’
vero beni che prima erano introvabili ma
il mercato nero ancora dominava il mercato con prezzi decisamente alti..
I
provvedimenti riguardanti gli aumenti degli assegni familiari, dei salari e
degli stipendi erano solo dei provvedimenti “di facciata” perché malgrado le
disposizioni ben pochi datori di lavoro accettarono queste direttive salariali.
Nel
maggio del ‘44 il Consiglio dei Ministri approvò le norme per l’attuazione del
programma, in base alla legge Gullo, dei cosiddetti “granai del popolo “. In
questi granai municipali doveva
confluire il grano prodotto nell’annata. Gli esperti alleati avevano
calcolato che, tenuto conto dello stato delle culture e del mancato uso di
fertilizzanti e le condizioni meteo, la produzione agraria dell’annata avrebbe
coperto solo il 65% dell’intero fabbisogno delle zone occupate. Era quindi
necessario attuare quelle misure che avevano come obiettivo di favorire “l’ammasso da parte dei produttori mentre per
la parte rimanente avrebbero provveduto gli alleati”.
Per
le nove province fu stabilito il conferimento di una quota complessiva minima
di 3.100.000 quintali per potere assicurare la distribuzione giornaliera di 200
gr di pane e di 100 gr di pasta ai cittadini. Cittadini che dovevano essere
muniti di una tessera annonaria (con esclusione dei produttori, coltivatori
diretti, ecc.)
((Tessera
Annonaria)
Era necessario il conferimento all’ammasso di almeno i
2/3 della produzione.
Malgrado i calcoli.. gli inviti.. si delineò il fallimento dei “granai del
popolo”. Infatti il 5 settembre in tutta la Sicilia a fronte dei famosi
3.1000.000 quintali ne erano stati conferiti solo 1.012.000 quintali cioè
appena il 32,6% della quota minima di conferimento.
Al grave problema alimentare si aggiungeva quello
gravissimo dell’ordine pubblico che in
Sicilia aveva aspetti preoccupanti. Nell’estate 1944 l’inflazione aveva
raggiunto livelli drammatici. Il costo
della vita presentava indici sconvolgenti e questo all’indomani della
liberazione di Roma, della successiva nomina del principe Umberto II a
luogotenente del regno e delle dimissioni di Badoglio (giugno 1944).
Gli uomini del CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) si
battevano per sostituire nelle cariche coloro che erano stati nominati
dall’AMGOT. Il CLN di Palermo aspirava all’assunzione del potere politico su
tutta la Sicilia, ma veniva avversato dai CLN di Catania e degli altri capoluoghi
isolani.
I contrasti politici finirono con il coinvolgere anche
Musotto che fu accusato ingiustamente di incapacità e di nutrire sentimenti
separatisti.
Il Consiglio dei ministri italiano approvò a maggioranza la nomina di Salvatore Aldisio ad Alto
commissario della Sicilia. La sua nomina
fu una ferma presa di posizione del Governo e del CLN romano contro il
pericoloso movimento eversivo dell’indipendentismo siciliano. Aldisio non
deluse le aspettative di chi lo elesse: « cominciò
ad allontanare dalle cariche i separatisti o coloro che erano sospettati di
esserlo » , ad iniziare dal sindaco palermitano Lucio Tasca. Ad agosto,
anche il Partito Comunista iniziò una
seria opera di organizzazione in tutta la Sicilia nell’intento principale di contrastare il
separatismo, nonostante vi fu, nell’allora recente passato, una certa simpatia
reciproca tra Andrea Finocchiaro Aprile e Palmiro Togliatti, capo del PCI, il
quale affermò, durante una seduta del Consiglio dei ministri, che « la propaganda separatista aveva successo
perché si collegava “a tradizioni storiche di lotta per la libertà del popolo
siciliano [...] tutt’altro che sparite e tutt’altro che da disprezzare”, e
sfruttava il vastissimo elenco dei torti che veramente sono stati fatti in
Sicilia nel sistema dello Stato italiano” ».
(L’Alto
Commissario per la Sicilia – Aldisio)
La
fame… il carovita, il mercato nero continuarono a sconvolgere la vita sociale.
Giuliano era già presente nella scena sociale dell’isola e il separatismo
trovava sempre più una facile diffusione
tra gli isolani conquistati dall’idea di
una Sicilia tradita dal governo. Gli stenti creavano continui cortei davanti ai
palazzi municipali e governativi così come quella fatidica mattina del 19
ottobre. Quel giorno era stato
proclamato uno sciopero da parte dei dipendenti comunali per chiedere “l’estensione anche a loro degli aumenti
economici che il governo centrale aveva riconosciuto agli impiegati statali”.
Il commissario prefettizio barone Merlo aveva respinto
tali richieste, adducendo “ motivi di
bilancio che non consentivano nuovi aggravi finanziari all’amministrazione
comunale », con la conseguenza della messa in atto di uno sciopero che
doveva aver luogo il 18 del mese, poi rientrato per le sommarie promesse
riguardo a un’indennità di carovita, e ripreso proprio il giorno successivo, il
19 ottobre, in cui avvenne l’eccidio.
Piazza Pretoria
Il
corteo partì da Piazza Pretoria per portarsi davanti a Palazzo Comitini allora
sede della Prefettura (oggi del Provincia).
Palazzo Comitini
I
manifestanti chiedevano che una delegazione di dipendenti comunali fosse
ricevuta dal Prefetto Paolo D’Antoni e dall’Alto Commissario per la Sicilia
Salvatore Aldisio, già ministro dell’Interno. Gli scioperanti chiedevano con
ripetuti slogans” pane e pasta per
tutti”. La folla era ammassata
davanti al palazzo presidiato da una trentina di carabinieri e agenti di
Pubblica Sicurezza. La tensione era alta tanto che furono chiuse le finestre e
il portone d’ingresso del palazzo fu sbarrato. Più volte i dimostranti chiesero
un incontro con il prefetto e l’Alto Commissario. Ma a risposta fu incredibile…”entrambi erano assenti”….
(Il Prefetto Paolo
D’Antoni e Mons. Mingo Corrado, Vescovo di Trapani)
Alcuni
facinorosi cominciarono a battere con pietre e legni le saracinesche dei
negozi, che erano chiusi, provocando un gran frastuono. Gli scioperanti
chiesero ancora una volta di essere ricevuti anche dal viceprefetto Giuseppe
Pampillonia. Era presente.. così come probabilmente i due “assenti”, ma il
viceprefetto prese una grave decisione che sarà tragica per il susseguirsi
degli eventi. Invece di accettare di parlare con una delegazione di
dimostranti, telefonò al comando militare della Sicilia per chiedere un forte
contingente di soldati. Il generale era
quel “famoso” Giuseppe Castellano che firmò l’armistizio a Cassibile…. Il
famoso armistizio passato alla storia come “l’armistizio della vergogna”.
Il Generale
Italiano (in abito scuro) della
“sofferta firma” della “resa” italiana “senza condizioni”
Poi addolcita con
il termine “Armistizio”
Cassibile (Sr) – 3
settembre 1943
LA
FIRMA:
Per
il Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo italiano f.to Giuseppe
Castellano, Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo Italiano
Per Dwight Eisenhower, generale dell’Esercito degli U.S.A., Comandante in Capo delle Forze Alleate, f.to Walter B. Smith, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Capo di Stato Maggiore.
Per Dwight Eisenhower, generale dell’Esercito degli U.S.A., Comandante in Capo delle Forze Alleate, f.to Walter B. Smith, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Capo di Stato Maggiore.
Presenti:
On. Harold Macmillan, Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze alleate
Robert Murphy, rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti
Royer Dick, Commodoro della Reale Marina britannica, Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo
Lowell W. Rooks, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Sottocapo di Stato Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale delle Forze alleate
Franco Montanari, interprete ufficiale italiano
Brigadiere Kenneth Strong, Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il Quartier Generale delle Forze alleate.)
On. Harold Macmillan, Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze alleate
Robert Murphy, rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti
Royer Dick, Commodoro della Reale Marina britannica, Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo
Lowell W. Rooks, Magg. Gen. dell’Esercito degli U.S.A. Sottocapo di Stato Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale delle Forze alleate
Franco Montanari, interprete ufficiale italiano
Brigadiere Kenneth Strong, Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il Quartier Generale delle Forze alleate.)
La
richiesta del viceprefetto fu accolta dai vertici militari che in realtà erano
stati allertati già dalla prima mattinata. Dalla caserma “Ciro Scianna”, di
Corso Calatafimi, i soldati , circa 60, del 139° fanteria (quasi tutti di origine sarda)
vennero fatti confluire su due camion in Via Maqueda.
Caserma “Ciro
Scianna”
Via Maqueda –
“Quattro Canti”
Erano
comandati dal giovanissimo sottotenente Calogero Lo Sardo… quant’è strana la
vita… il giovane era nato a …. Canicattì. A ciascun soldato fu consegnato
un fucile modello “91”. Trentacinque
soldati ebbero in dotazione due caricatori e gli altri ventuno un solo
caricatore e due bombe a mano del tipo “Brera”.
Nei pressi dei “Quattro Canti” il convoglio militare fu preso a
bersaglio con lanci di pietre e qualche latta.
Nessuna arma era in mano alla folla… i militari giunti sul posto
ricevettero l’ordine di caricare i fucili e di sparare sulla folla.
Le
testimonianze “parlarono di un automezzo
carico di soldati che s’inoltrava in mezzo alla folla. Sull’automezzo volarono
sassi e alcune latte lanciate dai dimostranti.. si udì un esplosione vicino al
camion.. forse un soldato aveva perso la testa
e lanciò una prima bomba…” un aspetto che la commissione non riuscì
mai a chiarire.
.
Il
plotone di fanteria del 139° Regimento della Divisione Sabauda sparò sulla
folla... ci fu una strage... “La Strage del Pane” con 23 morti e 153 feriti.
Le
vittime:
Grifati
Salvatore di 9 Anni;
Damiani
Michele di 12 ¨¨:
Ferrante
Giuseppe ¨12 ¨;
Balistrieri
Giuseppe di 16 anni;
Cordone
Domenico di 16 anni;
Di
Gregorio Andrea ¨16 ¨;
Oliveri
Andrea ¨ 16 ¨;
La
Spia Gioacchino ¨17 “;
Lo
Verde Rosario ¨17 “;
Orlando
Salvarore “ 17 “ :
Galata'
Vincenzo di 19 “;
Midolo
Erasmo “ 19 “;
Lanzarone
Eugenio di 20 “;
Giannotta
Francesco “ 22 “;
Maligno
Giuseppe “ 22 “;
Puccio
Vincenzo “ 22
“;
Volpes
Aldio “ 23 ¨;
Gandolfo
Carmelo “ 25 ¨;
D'Atria
Natale “ 28 “;
Corsaro
Rosario “ 30 “;
Pecoraro
Anna “ 37 ¨:
Cacciatore
Vincenzo “ 38 “:
Parrinello
Cristina “ 61 “;
Venturelli
Giacomo “ 70 ¨¨,
Il generale
Giuseppe Castellano (l'8 settembre 1943 aveva firmato l'armistizio di
Cassibile) comandava il 139° Reggimento Fanteria della Divisione Sicurezza Interna “Reggio”
(ex Divisione Fanteria “Sabauda”). I militari spararono alla folla proprio
davanti al Palazzo Comitini allora sede della Prefettura oggi della Provincia.
Il numero
delle vittime e dei feriti poteva essere superiore considerando il numero di
colpi che i soldati avevano a disposizione per sparare: 91 caricatori da 6
colpi comportano la disponibilità di ben 546 colpi….
(Palermo – Vicolo sant’Orsola)
Nessuno dei
militari dotati di due caricatori ebbe il tempo materiale di usarli perché la
folla, dopo i primi spari e le esplosione, si disperse nelle stradine
circostanti. Si calcola che furono sparati almeno 300 colpi…..sul selciato
rimasero i mori ed i feriti e le autorità, subito dopo il massacro, si
affrettarono con l’uso di idranti a cancellare le macchie di sangue sulla
strada.
Una famosa
circolare di quegli anni consentiva ai militari di sparare ad altezza d'uomo in
presenza di adunate sediziose.
La Circolare
Roatta del 26 luglio 1943, fatta propria dal generale Taddeo Orlando (il 31
agosto 1944) e diramata ai comandi
militari obbligava “le truppe ad agire contro il popolo senza
esitazione...... e di reprimere con le armi qualunque perturbamento dell'ordine
pubblico....senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe
nemiche”.
Il
generale Castellano ed il governo dell'epoca sposarono la versione ufficiale
secondo la quale i militari della 139° fanteria furono aggrediti dai
“separatisti” e nessuno avrebbe dato l'ordine di sparare”.
Dopo
50 anni la verità venne alla luce del sole e la versione ufficiale fu smentita.
Nel
1995 il sardo, Giovanni Pala, allora appartenente al reggimento coinvolto nella
strage, affidò al giornale ¨L'Unita´” una clamorosa confessione: “ In Via
Maqueda non era in corso nessun assalto. Eppure quando la nostra colonna
raggiunse alle spalle la folla, il tenente Lo Sardo diede l'ordine di scendere
dai mezzi e di caricare i fucili. Tutto accadde in pochi istanti. I soldati che
erano in testa al convoglio cominciarono a sparare ad altezza d'uomo e a
scagliare bombe a mano Breda. Una scena bestiale. La gente scappava da tutte le
parti lasciando sulla strada morti e feriti””. (La rivelazione fu fatta al giornalista dell'Unita´, Giorgio Frasca
Polara (Ünità deL 19 dicembre 1995).
Il
sottotenente Lo Sardo rispose sicuramente a un ben preciso comando… forse
premeditato… voluto da chi ?
Ci
furono responsabilità politiche ?
Le
forze alleate erano al corrente di ciò che stava per succedere ?
La
Circolare Roatta affermava: “« ...poco
sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. Perciò ogni
movimento deve essere inesorabilmente stroncato in origine... muovendo contro
gruppi di individui che perturbino ordine o non si attengano prescrizioni
autorità militare, si proceda in formazione di combattimento e si faccia fuoco
a distanza, anche con mortai e artiglieria senza preavviso di sorta, come se si
procedesse contro truppe nemiche. »
In base a questa “criminale” circolare nei cinque giorni
successivi al 25 luglio 1943, ci furono degli scontri con 93 morti, 536 feriti
e e 2276 arresti.
Il 26 luglio 1943, dopo la festa popolare per la caduta del
regime fascista, ad eliminare ogni dubbio sulla continuità della violenza ci
pensò il “nuovo capo di Stato Maggiore, nominato da Badoglio… proprio il
generale Mario Roatta. Non perse tempo il “grande generale” e subito emanò la
circolare che ordinava a tutti i presidi di reprimere nella maniera più decisa,
anche sparando, ogni manifestazione corteo o comizio o assembramento che “turbi
l’ordine pubblico”.
La circolare era del 26 luglio ’43 e il 31 agosto del’ 44 fu
ribadita, confermata con un provvedimento del generale Taddeo Orlando, ministro
per la guerra del governo di concentrazione nazionale allora in carica e
presieduto da Bonomi.
Generale
Roatta
(Taddeo
Orlando)
(Taddeo
Orlando, Emilio Grazioli e Mario Robotti –
Durante
un corteo a Lubiana)
Ma le soprese non finiscono…..Una circolare simile, sia nella
forma che nella sostanza, venne emessa sette anni dopo …. Come ? In Pieno
regime repubblicano .. ovvero
…”antifascista”. E’ la circolare n. 400 dell’1 giugno 1950… una circolare
sconosciuta che porta il nome del Ministro della Difesa……?????? Uno dei
tanti….. il Suo nome ? Randolfo Pacciardi che la emanò.
Pacciardi, di idee repubbblicane, fu nel dopoguerra,
segretario del PRI, nell’ottobre del’ 48 affermò: “al momento opportuno
occorrerà arrestare 300 comunisti e socialisti per neutralizzare la sinistra”.
 |
| Randolfo Pacciardi ad un congresso a Molfetta |
(Il 23 Agosto 1974 la magistratura di Torino scoprì il
complotto facente capo a Edgardo Sogno , Randolfo Pacciardi ed altri fra
cui Junio Valerio Borghese. Il golpe era
previsto per ferragosto e aveva come obiettivo di forzare l'intervento dei
militari a favore di una repubblica presidenziale).
Nel giugno del 1950 la famosa circolare citata.” ... in ogni caso il fuoco non va mai
impiegato a scopo intimidatorio. Il fuoco sarà diretto contro gli elementi più
facinorosi e contro coloro che commettono gravi violenze o incitano a queste
contro le forze dell'ordine...".
Le Reazioni
L’Anto Commissario per la Sicilia, Aldisio, accusò “ i manifestanti di aver assalito dei camion
carichi di farina che attraversavano la città” (un aspetto che nessuna
fonte riportò…)
Il CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) di Palermo accusò
“i separatisti e gli ex fascisti” e chiedevano “l’accelerazione dei processi di epurazione”.
I repubblicani accusavano i monarchici mentre l’Avanti
chiedeva di “colpire i separatisti… che
armavano la mano dei sicari per provocare repressioni sanguinose”.
LA STAMPA
Subito dopo la
strage la stampa riportò diverse
dinamiche dei fatti… è anche vero che fu applicata una spietata censura… una
versione riportava: “la forza pubblica, dopo essere riuscita a
sciogliere pacificatamente un primo assembramento di dimostranti…. era
costretta a mobilitare un automezzo carico di quaranta soldati appartenenti
alla divisione Sabauda, per prevenire eventuali intemperanze di una colonna che
si ricostituiva e si ingrossava di elementi estranei provenienti dai bassi
strati della popolazione. Quando poi dalla folla venne lanciata una bomba a
mano, che ferì nove soldati, i superstiti risposero facendo uso dei moschetti e
delle bombe a mano di cui erano armati”.
La versione riportata da altri quotidiani…” « [di] soldati
[che] avrebbero fatto uso delle armi senza nessun preavviso, e per di più senza
essere stati fatti oggetto del lancio della bomba. I nove soldati sarebbero
stati feriti da una delle bombe a mano lanciate dal bordo dello stesso
autocarro, la quale essendo caduta a breve distanza dal camion, e precisamente
sul lato sinistro, ne avrebbe determinato il danneggiamento “.
La stampa non fu obiettiva e non poteva
esserlo… si fece cadere la colpa dell’eccidio sul MIS (Movimento
Indipendentista Siciiano) di Finocchiaro Aprile . “ Aldisio accusava i separatisti di preparare un “colpo
di mano” contro le autorità dello Stato. Aveva dato ordine di perquisire la
sede palermitana del MIS, dove – com’era del tutto prevedibile e naturale –
furono rinvenuti dei “documenti antistatali” (cioè di propaganda
indipendentistica) ai quali fu attribuita grande importanza. Otto individui che
si trovavano nei locali furono fermati. Fu contestualmente disposta, a tempo
indeterminato, “la chiusura della sede dei separatisti” ».
La
conseguenziale risposta di Finocchiaro Aprile fu determinata a voler sfruttare
le opportunità propagandistiche offertegli dalla stessa ambiguità dei fatti
riguardanti la strage: « la
responsabilità [di essa], una delle più terribili e infami che siano mai
avvenute, grava tutta sul governo italiano, il quale impiegò truppe note per la
loro dedizione alla monarchia sabauda, che non riscuote più la fiducia del
popolo, e per il loro odio contro noi siciliani, manifestato in più occasioni.
L’intervento di queste truppe quando la dimostrazione era al suo termine e
l’uso dei mezzi bellici più micidiali contro una folla inerme sono rilevatori
di un sistema che le leggi più elementari della civiltà non possono non
condannare ».
Il
giornale “La Voce Socialista” accusò “i
lavoratori in sciopero che gridavano e occupavano le strade…” accusandoli
di “incoscienza e mancata
organizzazione”.
Il 20 ottobre sulla stampa apparve un comunicato del
governo sul massacro avvenuto a Palermo il giorno precedente: "In occasione di una dimostrazione diretta ad
ottenere miglioramenti di carattere economico, compiuta ieri a Palermo da
impiegati delle banche e dell’esattoria, gruppi estranei, sobillati da elementi
non ancora chiaramente individuati, prendevano l’iniziativa per inscenare una
manifestazioni sediziosa. Davanti alla sede dell’Alto Commissariato venivano
esplosi colpi d’arma da fuoco contro reparti dell’Esercito, che erano così
costretti a reagire. Si deplorano 16 morti e 104 feriti. L’ordine pubblico è
stato ristabilito. Il Comitato provinciale di liberazione nazionale si è subito
riunito ed ha dichiarato di mettersi a disposizione dell’Autorità governativa
locale per la ricerca dei responsabili della manifestazione sediziosa".
In
Sicilia fu autorizzata la pubblicazione, sul “Giornale di Sicilia” del 20 ottobre
1944, di un manifesto che era firmato dal “Partito d’Azione”, dal PCI, dalla
DC, dal Partito della Democrazia del lavoro
e del Partito Socialista. Il manifesto sottolineava la gravità dei fatti
ed affermava: “ come vogliamo che nelle
masse si accresca la coscienza di popolo civile così esigiamo che la vita dei
cittadini sia a tutti sacra”… che dichiarazione patetica…..!!!!!!!!!
La
reazione del Governo ? Il Governo Bonomi
II fu il 62° governo del regno d’Italia ( dal 12-18 giugno 1944 al 12 dicembre
1944).
Un
governo d’Unità Nazionale… con
-
Democrazia
Cristiana (DC)
-
Partito
Comunista Italiano (PCI)
-
Partito
Socialista di Unità Proletaria (PSIUP; già PSI);
-
Partito
Liberale Italiano (PLI)
-
Partito
Democratico del Lavoro (PDL)
-
Partito
d’Azione (PdA)
I
membri:
-
Presidente
del Consiglio dei Ministri: Ivanoe Bonomi (PDL)
-
Sottosegretari
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a)
Sergio
Fenoaltea (PdA)
b)
Giuseppe
Spataro (DC) con delega per la “Stampa e Informazione”;
-
Ministri
Senza Portafoglio:
a)
Alberto
Cianca (PdA);
b)
Alcide
De Gasperi (DC);
c)
Bartolomeo
Meuccio Ruini (PDL);
d)
Giuseppe
Saragat (PSIUP);
e)
Carlo
Sforza (Indipendente);
f)
Palmiro
Togliatti (PCI);
g)
Benedetto
Croce (PLI) fino al 27 luglio 1944;
h)
Nicolò
Carandini (PLI) dal 27 luglio al 12 dicembre 1944
Ministeri:
-
Aeronautica:
Piero Piacentini (Militare) – Carlo Scialoja (PDL) , sottosegretario;
-
Affari
Esteri: Ivanoe Bonomi (PDL) ad iterim dal 20 luglio 1944;
Giovanni Visconti Venosta
(Tecnico)
Renato Morelli (PLI) con
delega per gli “Italiani all’estero”;
-
Africa
Italiana: Ivanoe Bonomi (PDL) ad iterim;
-
Agricoltura
e Foreste: Fausto Gullo (PCI) – Gino Bergami (Tecico), sottosegretario;
-
Comunicazioni:
Francesco Cerabona (PDL) – Angelo Raffaele Jervolino (DC)
sottosegretario con delega
per le Ferrovie – Mario Fano (Tecnico) con
delega per le “Poste
e telegrafi”.
-
Finanze
: Stefano Siglienti (PdA) – Antonio Pesenti (PCI), sottosegretario;
-
Grazia
e Giustizia : Umberto Tupini (DC) – Carlo Bassano (PDL), sottosegretario;
-
Guerra
: Alessandro Casati (PLI) – Mario Palermo (PCI) , sottosegretario; Giovanni
Battista
Oxilia (militare) dal 3 giugno
1944;
-
Industria,
Commercio e Lavoro: Giovanni Gronchi (DC)
- Giudo Molinelli (PCI),
sottosegretario con delega per
“l’Industria e Commercio;
Mariano Costa (PSIUP),
sottosegretario con delega per il “Lavoro”;
-
Interno
: Ivanoe Bonomi (PDL) ; Emilio Canevari (PSIUP), sottosegretario ;
-
Lavori
Pubblici: Pietro Mancini (PSIUP) – Giuseppe Bruno (PdA), sottosegretario;
-
Marina;
Raffaele De Courten (militare) - Antonio
Ramirez (PdA), sottosegretario; Angelo
Corsi (PSIUP) con delega per la
“Marina Mercantile”;
-
Pubblica
Istruzione : Guido De Ruggiero (PdA),
Bernardo Mattarella (DC), sottosegretario;
-
Tesoro:
Marcello Soleri (PLI) ; Antonio Manes (PDL), sottosegretario;
(Il Governo Bonomi
in una riunione del dicembre 1944)
L’indomani
della strage (20 ottobre) si riunì a Roma il Consiglio dei Ministri sotto la
presidenza dell’on. Ivanoe Bonomi. Alla riunione era presente anche l’Alto
Commissario per la Sicilia… il democristiano Salvatore Aldisio.
Proprio
ad Aldisio venne affidato l’incarico di “istruire
un’ampia indagine tendente ad accertare le cause” del…..”tragico incidente”.
Venne
incaricato di condurre una rigorosa indagine l’Ispettore Generale di PS
(Pubblica Sicurezza) Michele Iantaffi (già questore nell’Isola).
(Nel
settembre del’ 44 il governo Bonomi chiese proprio a Iantaffi di esprimere un
giudizio sulla futura gestione della pubblica sicurezza nell’Isola. Iantaffi
sostenne che “la Direzione Generale non
poteva essere mantenuta in vita non soltanto perché ricordava troppo da vicino
le esperienze di periodo fascista, ma anche perché con il suo carattere di
eccezionalità avrebbe potuto determinare dei contrasti con gli organismi
ordinari”. A prevalere fu la posizione alleata, che aveva ancora funzioni
di controllo, secondo la quale era necessario un organismo superiore di
coordinamento della P.S. Fu così che la Direzione Generale venne trasformata in
Ispettorato di PS per i servizi interprovinciali in dipendenza dell’Alto
Commissario per la Sicilia).
L’Ispettore
Iantaffi fu affiancato nell’indagine dai rappresentanti dei partiti politici e
da alcuni esponenti del CNL (Comitato Nazionale Liberazione)
I
rappresentanti dei partiti politici erano:
-
Dott
Pasquale Cortese (DC);
-
Prof.
Giuseppe Drago (PSI);
-
Prof.
Giuseppe Montalbano (PCI);
-
Il
generale dei regi Carabinieri comandante di Brigata , Amedeo Branca.
Ben
presto in seno alla commissione sorsero dei forti dissidi. I politici
sostenevano l’esistenza di parecchie irregolarità amministrative penali (
l’imprudente distribuzione della bombe ai soldati) e di carattere doloso (l’uso
illegittimo delle armi da fuoco). Iantaffi rimase da solo nella commissione
perché prima i rappresentanti del CNL e poi quelli dei partiti politici
uscirono dalla commissione.
Il
4 novembre 1944 il dott. Iantaffi fece pervenire la sua relazione sul massacro
di Palermo, un fascicolo di appena 14 pagine (sic), ai seguenti funzionari:
-
Al
procuratore militare presso il Tribunale di Guerra di Palermo;
-
Al
Ministro dell’Interno (Ivanoe Bonomi);
-
All’Alto
Commissario per la Sicilia (Aldisio);
-
Al
comandante del Corpo d’Armata di Palermo;
-
Al
Prefetto di Palermo D’Antoni.
Il
funzionario nella sua “scolastica “relazione sottovalutò fatti e circostanze
importanti e probabilmente fece sparire fotografie e dichiarazioni..
lettere che evidenziavano il
comportamento anomalo delle forze militari. La sua relazione escludeva ogni
responsabilità politica e militare….(non poteva essere altrimenti……).
Accettò
la tesi del generale Castellano: “ la
provocazione da parte della folla”.
Naturalmente
la relazione non venne sottoscritta dai rappresentanti del CNL e dei partiti
politici.
Il
20 febbraio 1947 iniziò il processo sull’eccidio… una grande celerità a poco
più di due anni dai fatti. Il dibattimento presso il Tribunale militare di
Taranto. Una sede scelta per legittima suspicione dato che si temevano nella
città siciliana degli scontri.
Il
collegio giudicante era composto dal:
-
Contrammiraglio
Leonardo Elena come presidente;
-
Dal
maggiore dell’esercito Rolando Tafuri;
-
Dal
capitano di vascello Sergio de Judicibus;
-
Dai
tenenti colonnelli Giuseppe Santelli e Roberto De Cesare
Imputati…
ventuno militari…. Apriva la lista Calogero Lo Sardo (Canicattì 1 gennaio 1917,
che all’epoca comandava il drappello di soldati. Era sottotenente in
servizio al 139° reggimento di fanteria. Era difeso dall’avv.
Parlavecchio del foro di Palermo. Gli imputati, tutti liberi, dovevano
rispondere del “reato di delitto di strage”.
Il
PM, colonnello Paolo D’Ambrosio nella sua requisitoria affermò che non si
doveva parlare di “delitto di strage” ma
di “eccesso colposo nell’uso legittimo
delle armi”. Concluse la sua arringa chiedendo la condanna a dieci anni di
reclusione per gli imputati. La difesa degli imputati chiese una sentenza di
assoluzione ovvero una sentenza di “pacificazione
sociale”.
Ad
appena due giorni dall’inizio del processo, cioè il 22 febbraio ci fu la
sentenza dopo circa tre ore di consiglio. La sentenza ? .. Una farsa come riportano nel loro racconto
Salvo e Giuseppe Musumeci..
Innanzitutto
vennero esclusi dall’elenco delle vittime , i 26 caduti, Carmelo Natale di 35
anni e Carlo Conti di 34.. perché ? Non vi erano prove sufficienti per
“accertare che erano realmente deceduti a causa della sparatoria di via
Maqueda”.. Fu confermato il numero dei 158 feriti e si confermò che tra le
vittime c’erano due donne… Anna Pecoraro e Cristina Parrinello. Le due donne
lavoravano in una stireria situata proprio di fronte al Palazzo della
Prefettura… i soldati lanciarono una bomba all’interno del negozio…….
Per
gli imputati il verdetto definitivo: “ è
riconosciuto l’eccesso colposo per legittima difesa.. escludendo però,
l’aggravamento delle previsione dell’evento”.
Con questo clamoroso capovolgimento del capo d’accusa, la Corte
dichiarò: “ di non doversi procedere a carico di tutti gli imputati… per essere
tutti i delitti estinti da amnistia” !!!!!!!!
In conclusione nessun colpevole.. era riconosciuta la tesi secondo la quale i
militari si difesero dall’attacco dei manifestanti che usarono le bombe a mamo
e non bastoni… pietre o randelli…
Ma
il fatto più singolare di tutto l’iter processuale fu che un processo
giudiziario così importante non avrebbe avuto mai un giudizio d’appello contro
la sentenza.
Due
giorni dopo la sentenza il PM D’Ambrosio, il 22 febbraio, propose un ricorso
d’appello contro la sentenza. Ma lo stesso PM il 31 maggio 1947, in modo
inspiegabile ma non troppo, dichiarò di rinunciare all’impugnazione che lui
stesso aveva annunciato. Né la Procura Generale si adoperò perché non aveva
nulla in contrario. Perché il Pm ritirò il ricorso in appello ? E’ facile
intuire la risposta….
A
causa della rinuncia di appello da parte del PM, il tribunale nello stesso
giorno (ovvero il 31)…. che grande celerità…emanò un’ordinanza che era firmata dal:
-
capitano
di vascello, De Judicibus, presidente;
-
colonnello
dell’esercito Paolo Impiccichè, giudice relatore;
-
tenente
colonnello dell’aereonautica Rodolfo De Giorgi, giudice;
-
capitano
di fregata Luciano Marra, giudice;
-
maggiore
dell’aereonautica Felice Bastianelli, giudice.
L’Ordinanza:
“che
dichiarava inammissibile il ricorso per annullamento proposto dal PM” ed
ordinava “ l’esecuzione immediata della sentenza impugnata”…. Amen
Dal
4 giugno 1947, data in cui la sentenza passò in giudicato, sul massacro il
silenzio più assoluto. Come abbiamo visto solo nel 1995 un soldato che faceva
parte dei soldati mandati in Via Maqueda, Giovanni Pala rilevò la vera dinamica
degli avvenimenti.
Ma
il processo… il vero processo ha avuto inizio con la recente apertura degli
archivi dell’OSS (Office of Strategie Service) negli Usa, del Vaticano e
dell’ex PCI. Sono venuti alla luce documenti inediti che fanno piena luce sui
tragici fatti di quel giorno.
Documenti
…tanti…..
In
un rapporto segreto della spia Vincent Scamporrino, datato 10 agosto 1944, sono
riportate, tra virgolette, alcune dichiarazioni del capomafia don Calogero
Vizzini: “… gli abitanti di
Caltanissetta, Agrigento e Catania sono ostili alla Divisione Sabauda. È noto
infatti che quest’ultima ha ricevuto ordini segreti (di natura politica) per il
mantenimento dell’ordine pubblico nella eventualità di una rivolta popolare. Si
ripeteranno così i Vespri Siciliani. Il popolo è stanco di subire i barbari
metodi della polizia”.
In
un altro rapporto segreto trasmesso dal console generale americano a Palermo,
Alfred T. Nester, datato 27 settembre 1944 e trasmesso al segretario di Stato
Usa, si legge: “ l’OSS compie un
eccellente monitoraggio della Sicilia… in questo teatro la politica è in
subbuglio soprattutto per colpa del movimento separatista e del partito
Comunista. Sono in molti a prevedere l’esplosione di gravi disordini”.
Una
previsione veritiera quella del Nester, che era presente ai fatti del 19
ottobre, e in una relazione al
Segretario di Stato Usa riferì: “ero
personalmente presente per la durata di tutto l’episodio… Il governo si sforza
di fare ricadere la responsabilità di questi disordini sui separatisti. Questa
versione potrà trovare qualche credito, ma in tutta franchezza io non credo che
siano stati i separatisti ad organizzare gli scioperi o i disordini culminati
nella sparatoria”.
Vincenzo
Purpura, leader del Partito d’Azione in Sicilia e testimone oculare riferì su
un documento desecretato datato 13 novembre 1994 e conservato negli Archivi
Nazionali Nara di College Park nel Maryland,..”i primi a sparare sono stati senza dubbio alcuno i soldati, che hanno
poi lanciato alcune bombe a mano…”
Il
prof. Giuseppe Montalbano, leader del PCI in Sicilia, in una lettera
classificata segreta e conservata all’Archivio Centrale dello Stato (busta 1,
fasc. Ovra) del 21 ottobre 1944 e inviata al ministro Palmiro Togliatti
dichiarava: “la responsabilità
dell’eccidio ricade esclusivamente sui soldati e gli ufficiali della Divisione
Sabauda, che hanno lanciato le bombe e sparato con fucili mitragliatori, senza
alcuna provocazione. La popolazione si sente abbandonata dalle autorità e
perché i separatisti continuano a soffiare sul fuoco…. Una tendenza estremista,
filo separatista, che vi è anche alla direzione della Camera del Lavoro”.
Togliatti
non rispose a questo messaggio ed è veramente strano. Sul massacro di via
Maqueda lo stesso Togliatti non disse nulla…. Strani misteri della politica.
Ci
sono delle lettere del periodo in esame che furono censurate….
La
Sig.ra Teresa Morvillo scriveva a Franca Morello in una lettera datata 21
ottobre 1944:
“….. noi dalle
finestre dell’ufficio abbiamo assistito ad una fase di esso… se tu avessi visto
! La maggior parte era costituita di bambini dai 10 ai 12 anni ! C’erano
giovanotti imberbi, qualcuno più grande…. Gridando si sono messi a fare un gran
baccano dovunque, insomma sciopero. Ma nessun bastone o arma era nelle loro
mani… il gruppo più grosso si trovava a reclamare pane e pasta dinnanzi il
Palazzo della Prefettura, nient’altro che questo faceva. Quando meno se
l’aspettava ha visto arrivare un camion con un gruppo di badogliani,
sardignoli, i quali, non si sa perchè, appena giunti in mezzo ai dimostranti
hanno buttato le bombe a mano e sparato con i fucili mitragliatori. Hanno fatto
circa 200 tra morti e feriti, la maggior parte bambini, giovanottini e, come
sempre, altre vittime innocenti che non prendevano parte alla dimostrazione ma
o guardavano o si trovavano lì vicino !!! Ciò ha prodotto la generale indignazione
e l’indomani mattina sono apparsi manifestini con scrittovi che “la
cittadinanza era a lutto per le vittime del piombo sabaudo”.
I
documenti su riportati smentiscono la tesi dell’aggressione da parte dei
dimostranti.
Nell’atrio
di Palazzo Comitini, oggi sede della Provincia, nel 1994 fu messa una lapide a
ricordo della strage. Sono riportati i nomi delle vittime…. Ancora oggi Palermo
e tutta la Sicilia aspettano un segno di resipiscenza da parte dello stato……..
ma è inutile attendere…….
Per
i politici che non sanno cosa significhi “resipiscenza” mi affido al Dizionario
Treccani e copio la definizione: “Il
rinsavire e il ravvedersi, riconoscendo l’errore in cui si è caduti, tornando
al retto operare”.
Concludo
il racconto sulla “Strage del Pane” . una strage di stato, come tante altre,
non ricordate dai libri di storia… con una poesia di Maria Agrippina Amantia
del 19 ottobre 1944…
“Chi parla è un ipotetico Peppino, un soldato
che dovette sparare, insieme ai suoi compagni, sulla folla affamata, composta
principalmente da donne e bambini, nella rivolta del pane del 19 ottobre 1944 a
Palermo in via Maqueda.
Peppino, ebbe l’ordine di sparare ad altezza d’uomo! Quindi, per uccidere
Peppino, ebbe l’ordine di sparare ad altezza d’uomo! Quindi, per uccidere
Se non avesse
obbedito, sarebbe passato per la corte marziale. Dunque, lui dice: «Meglio
sarebbe stato che mia madre mi avesse abortito! Non avrebbe avuto un figlio
assassino». Perché lui, obbedendo all’ordine di sparare su gente inerme, la cui
unica colpa era quella di chiedere pane, questo si sente: un assassino.
Ho voluto dirvi
come questa poesia è venuta alla luce. Peppino, ha chiesto perdono. Riposa in
pace”
“ Comu l’agneddi
n’uccenti
cascava nterra la genti,
u sangu s’ammiscava ntra iddu
ca facia ribrezzu…”
cascava nterra la genti,
u sangu s’ammiscava ntra iddu
ca facia ribrezzu…”
(“La Gente cadeva a
terra ferita e uccisa come degli agnelli.
Il loro sangue
diventava tutt’uno e faceva orrore “..)
MORTI PPI NENTI 19
ottobri 1944
Palermu,
mentri ch’era surdatu.
mentri ch’era surdatu.
N’semula e me
cumpagni,
appumu l’ordini di sparari ncapu
a ddi disgraziati,
ca pi sciupirari s’avianu riunutu.
appumu l’ordini di sparari ncapu
a ddi disgraziati,
ca pi sciupirari s’avianu riunutu.
A jiddi, i nostri
cumannanti,
avissumu duvutu sparari!
si omini avissimu statu!
ma nuddu si ribillò, di li surdati,
si nun l’ascutaumu
a corti marziali ni mannaunu.
avissumu duvutu sparari!
si omini avissimu statu!
ma nuddu si ribillò, di li surdati,
si nun l’ascutaumu
a corti marziali ni mannaunu.
Ma comu mi pozzu
scurdari,
di fimmini, ddi picciriddi,
ca currievunu mpazzuti
ca vulevunu sulu essiri sfamati?
di fimmini, ddi picciriddi,
ca currievunu mpazzuti
ca vulevunu sulu essiri sfamati?
Co stomucu vacanti,
nturciuniatu,
ca s’avissuru mangiatu
puri li petri s’avissuru pututu!
ca s’avissuru mangiatu
puri li petri s’avissuru pututu!
tradituri!
ni ficiru fari na carnificina!
sparari artizza d’omu!
fu l’ordini scilliratu,
niuru, niuru, comu lu piccatu.
ni ficiru fari na carnificina!
sparari artizza d’omu!
fu l’ordini scilliratu,
niuru, niuru, comu lu piccatu.
Comu l’agneddi
n’uccenti
cascava nterra la genti,
u sangu s’ammiscava ntra iddu
ca facia ribrezzu,
ma tu, sparautu, lu stissu!
comu s’erutu nvasatu e pazzu.
cascava nterra la genti,
u sangu s’ammiscava ntra iddu
ca facia ribrezzu,
ma tu, sparautu, lu stissu!
comu s’erutu nvasatu e pazzu.
Megghiu avissi statu!
ca me matri m’avissi aburtutu!
ca n’un figghiu assassinu,
nun l’avissi avutu!
ca me matri m’avissi aburtutu!
ca n’un figghiu assassinu,
nun l’avissi avutu!
Ottobre
1944 : Licata (Agrigento)
Nel
corso di una manifestazione di contadini, i carabinieri aprono il fuoco
uccidendone due, ferendone 19 e provvedendo a denunciarne altri 80.
14 – 15 Dicembre 1944 : Catania
A Catania, una folla tumultuante manifesta contro il richiamo alle armi
devastando il Municipio, la sede del Banco di Sicilia dove sono ubicati gli
uffici dell’esattoria comunale. Il corteo giunse dinanzi alla sede del
Distretto militare, dal cui interno i militari esplosero colpi di arma da fuoco
che uccisero il giovane Antonio Spampinato. Furono tratti in arresto 53 manifestanti, fra i quali
gli studenti separatisti Egidio Di Mauro, Salvatore Padova da Ispica, Giuseppe
La Spina. Fra coloro che risultarono denunciati
a piede libero c’erano Concetto Gallo, i fratelli Gullotta, Michele Guzzardi,
Giuseppe Galli, Isidoro Avola, Guglielmo Paternò Castello.
(Catania – Distretto Militare)













































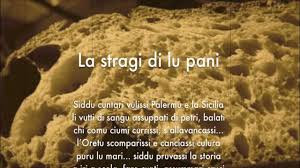




Commenti
Posta un commento