I CASTELLI DI MAZZARINO - PERLA DEL BAROCCO SICILIANO
 |
Mazzarino – Provincia di
Caltanissetta
Dal sito: http://archivio.blogsicilia.it/tagli-alle-province-da-lunedi-chiusi-alcuni-uffici-a-mazzarino/
|
Il
centro di Mazzarino, posto nel lembo interno e collinare della provincia
Nissena, tra Caltanissetta e Gela, offre scenari grandiosi…” laddove in primavera i profumi dei fiori e degli ortaggi che maturano
al sole riempiono di profumi l’aria; laddove in estate il grano si mostra con
le sue splendide spighe dorate e in autunno gli uliveti innalzano le loro cime
argentee e i vigneti si susseguono l’uno dopo l’altro”.
È
considerato la perla del barocco siciliano per la bellezza delle sue chiese e
del suo centro storico.
Le
recensioni dei turisti su Mazzarino sono lusinghiere e dimostrano la sua
importante vocazione turistica per i suoi molteplici aspetti culturali:
“Un paesino di
contadini ma con dei gioielli architettonici degni di una grande città d'arte.
Mazzarino presenta
un'arte divina con le sue opere architettoniche. È una cittadella con le sue
tradizioni, sia politiche sia religiose che si distinguono tra di loro. A tutti
voi turisti, vi invito a visitare Mazzarino. Li troverete tutti i tempi lontani, che oggi non ci sono più”.
“Ridente paese nel centro della Sicilia, su una verde
vallata di mandorleti ed oliveti, ricco di pregiate facciate architettoniche, di
antichi dipinti e artistici manufatti lignei dentro le chiese. Tutela le
antiche tradizioni locali, l'enogastronomia e la pasticceria. Buona ospitalità
e prossimo ad altri centri artistici ed archeologici.
Da non perdere altare ligneo dei Cappuccini , le facciate
architettoniche e il Castello di Mazzarino”.
Mazzarino
proprio per i suoi aspetti archeologici, storici, architettonici, religiosi,
naturalistici è stata proposta a far parte dell’Unesco con il riconoscimento
del “Comune di Mazzarino come Città D’Arte, ai sensi dell’art. 13co.V della
L.R. n.28/)) ed è stato incluso tra i Comuni ad economia prevalentemente
turistica.
 |
Chiesa Madre
| Dal sito : http://www.dvd-game-new-releases.info/skin/mazzarino-s.akp |
IL
CASTELLO VECCHIO DI MAZZARINO
http://www.comune.mazzarino.cl.it/Comune/kalos/castello.htm
Nella
tradizione locale è comunemente detto “Castelvecchio” o anche “U Cannuni” in
riferimento all’unica torre cilindrica (sud-ovest)
superstite che somiglia ad un gigantesco cannone.
Incerta
è la data della sua nascita.
Il
castello fu in tempi antichissimi una fortezza e diversamente dall’altro
castello di Grassuliato, fu abitato ed usato in epoche diverse, sempre subendo
delle trasformazioni.
In
epoca bizantina ed araba, quando il florido villaggio sorgeva al “Piano”, una
contrada sita circa 2 km in linea d’aria più a valle dell’odierna Mazzarino,
doveva esserci un castello. Una solida struttura, costruita probabilmente su un
preesistente fortilizio romano, a presidio della Valle del Braemi e del
Diseuri.
In
epoca normanna, quando era ancora vitale il vicino Castello del
Grassuliato, e quando la popolazione dal
“Piano” si trasferì nel luogo dove oggi sorge Mazzarino, il Castello Vecchio entrò
a fare parte di una serie di fortificazioni che nella zona comprendeva oltre al
Castello di Grassuliato anche i Castelli di Butera, Aidone ed altri luoghi
forti.
È
certo che la fortezza fu ricostruita dopo la dominazione musulmana e normanna,
dalla famiglia Branciforte nel XIV secolo. È proprio del 1325 un privilegio di
Federico d’Aragona in cui figura il nome del castello come proprietà e
residenza dei Branciforte.
(Branciforte o Branciforti, nobile
famiglia siciliana, che una leggenda fa discendere da Obizzo, un cavaliere che
militò sotto Carlo Magno.
Obizzo, leggendario capostipite della famiglia Branciforte,
era un cavaliere di grande valore nell’armata di Carlo Magno. Nella battaglia contro i Longobardi Obizzo si
trovò a difendere da solo le insegne del
Re e la bandiera “orofiamma” contro tre nemici. Rimase con le mani mozzate ma
continuò con ardore a tenere alata l’insegna reale. Da quel momento Ovizzo
prese l’appellativo o cognome di
Branciforte. Diventò Alfiere generale dell’esercito del Re e ottenne
come premio la città di Piacenza infatti il Mugnos lo cita “che indi fu ricambiata in terre, castelli ed altro nel piacentino”.Il
primo Branciforte ad insediarsi in Sicilia fu Guglielmo sotto l’imperatore
Federico II di Svevia. In realtà la famiglia Branciforte era già presente in
Sicilia perché alcuni anni prima Aloisia Branciforte aveva sposato nel
1275 Orlando I Grifeo Maniace, che era V
Barone di Partanna e stratigoto di Messina. Guglielmo Branciforte morì a
Catania nel 1347 lasciando i feudi di Piacenza ai fratelli Bosso e Gaspare
mentre le numerose terre in Sicilia andarono ai nipoti Raffaello e Ottaviano
che erano figli di un terzo fratello Stefano. Stefano Branciforte era
incaricato in Sicilia di riscuotere i dazi e controllare il traffico delle
merci nel porto di Licata e maestro razionale del regno.
(foto dal sito : https://it.wikipedia.org/wiki/File:Branciforte_Stemma.jpg)
 |
http://www.mazzarino.it/public/mazzarino/fotoantiche/?page=8
|
Una
struttura in piena efficienza agli inizi del XV quando i Branciforte erano già
diventati Conti di Grassuliato e di Mazzarino.
Il
castello diventò la residenza dei Signori e un’altra ricostruzione o
ristrutturazione, la subì nel XVI secolo in seguito ai danneggiamenti subiti
alla metà dello stesso secolo. Fu poi abbandonato prima del XVII secolo quando
i Branciforte costruirono in paese il loro magnifico palazzo. Palazzo che trovò
la sua nascita nell’epoca in cui Mazzarino si era ormai sviluppato tanto da
diventare un grosso centro famoso anche per le sue attività culturali.
 |
Mazzarino – Palazzo Branciforte
https://www.lasiciliainrete.it/monumenti/listing/palazzo-branciforti-mazzarino
|
Il
Castello fu abbandonato e in parte smantellato da chi vi asportò materiale da
costruzione e poi nel 1693 subì dei danni a causa del terremoto del 1693.
http://win.lafrecciaverde.it/n127/mazzarino/art.html
In
origine il castello era costituito da quattro torri cilindriche angolari che
erano collegate da cortine murarie merlate all’interno delle quali si
sviluppano gli ambienti abitativi e di servizio oltre ai vari cortili interni.
 |
|
|
Le
torri occidentali dovevano avere una dimensione maggiore rispetto a quelle
orientali ed erano costituite da ben tre livelli collegati da scale in pietra
che erano ricavate all’interno delle stesse torri. L’ingresso era costituita da
un apertura a sesto acuto sita tra le due torri occidentali della quale restano
poche tracce visibili.
Le
pareti nord e sud presentano delle aperture che sono tipologicamente diverse. Questo
dimostra come il castello nel corso del tempo sia stato oggetto di varie fasi
di ristrutturazione come è rilevabile anche dalla lettura della merlatura
inglobata a quota del calpestio del terzo livello della parete nord. I resti di
un grande camino sono visibili sulla parte rivolta a nord.
Il castello è stato oggetto di interventi di
restauro conservativo per la salvaguardia delle imponenti strutture superstiti.
Lo scavo che è stato effettuato all’interno dell’area delimitata dalle
strutture murarie perimetrali, ha permesso la ricostruzione planimetrica di
alcuni ambienti e l’importante individuazione di alcune cisterne ben interrate per la raccolta di aridi e
liquidi.
Cronologia
Storica
1143 - un Manfredi (Aleramico) di Policastro è ricordato come primo signore di Mazzarino (notizia assai dubbia) - Amico 1855-56, II, p. 70.
1288
- Vitale di Villanova riceve da re Giacomo il feudo di Mazzarino tolto a
Giovanni di Mazzarino, figlio di Manfredi signore di Mongialino (Comune di
Mineo – Catania) accusato di tradimento - ibidem.
 |
Un Tramonto dal Castello di
Mongialino
https://www.flickr.com/photos/limas1973/6881227566/
|
 |
| Aggiungi didascalia |
 |
Castello di Mongialino
https://www.enricocartia.it/castello_di_mongialino-w5321 |
 |
Re Giacomo II Perez di Aragona
(1267 – 1327)
Dal 1285 al 1296 re di Sicilia
come Giacomo I
Ritratto nel Monastero di Santa
Maria di Poblet, 1400
|
1292
- in un privilegio di Federico III del 1325, viene citata la vendita del feudo
di Mazzarino “cum castro” effettuata nel 1292 in favore di Raffaele
Branciforti (un ‘altra fonte cita l’acquizione del feudo in seguito ad un
contratto di matrimonio)- Di Giorgio Ingala 1996, p. 93.
Da
questo atto d’acquisto si può dedurre che il castello con la città erano in
quel tempo esistenti. Il castello era naturalmente adibito a residenza dei Signori
e Conti oltre ad avere una sua posizione strategica importante per il controllo
del territorio. Fino all’abolizione della feudalità, nell’anno 1812, il feudo
resterà sotto la dinastia dei Branciforte.
1325
- in seguito alla morte di Calcerando di Villanova, Stefano Branciforte
acquistò metà della signoria di Mazzarino che lascerà in eredità al figlio
Raffaello/Raffaele.
Questi essendo già in possesso della restante parte dello 'stato' (complesso feudale) acquisita con il matrimonio con Graziana di Villanova, figlia ed erede di Calcerando, diventò unico signore di Mazzarino.
Questi essendo già in possesso della restante parte dello 'stato' (complesso feudale) acquisita con il matrimonio con Graziana di Villanova, figlia ed erede di Calcerando, diventò unico signore di Mazzarino.
Giovanni,
figlio di Raffaele, cavaliere sotto Federico il Semplice, “ridusse alla regia ubbidienza” la città di Piazza Armerina, allora
detta “Piazza”. Per questa impresa ricevette dal sovrano non solo città ma
anche il titolo di Barone.
Dall’aragonese
Re Martino I ricevette anche la fortezza ed il feudo di Grassuliato oltre ai
feudi di Condrò e Gatto.
Nel XVII secolo Nicolò
Placido Branciforte, principe di Leonforte, ebbe un’unica figlia ed erede,
Stefania che sposò Giuseppe Lanza e Branciforte, principe della Trabia. Tutti i
beni dei Branciforte si trasferirono alla famiglia Lanza.
1676 - alla morte di Giuseppe Branciforte, gli successe il nipote Carlo Maria Carafa che stabilì la sua residenza a Mazzarino contribuendo alla creazione dei principali edifici di culto e residenziali dell'epoca. Il castello venne probabilmente abbandonato.
1676 - alla morte di Giuseppe Branciforte, gli successe il nipote Carlo Maria Carafa che stabilì la sua residenza a Mazzarino contribuendo alla creazione dei principali edifici di culto e residenziali dell'epoca. Il castello venne probabilmente abbandonato.
Con
un decreto del 18 maggio 1790, il Principe di Butera e Conte di Mazzarino,
Salvatore Branciforte, nominò un certo Don Pietro Accardi che malgrado “sia in età minorile”, diventò “castellano di codesto Castello di
Mazzarino, che trovasi vacante”.
IL
CASTELLO VECCHIO NEL CINEMA
Nel
castello si svolsero alcune scene del film la “Piovra 10” se non ricordo male
girato nel 2001. Un assalto con elicotteri della polizia e con due fuoristrada
per un inseguimento sullo sterrato. Un inseguimento che fu realizzato con dei
poliziotti appartenenti al decimo reparto mobile della Questura di Catania e
dal reparto di volo di Reggio Calabria. La storia del film, scritta da Mimmo
Rafele, Pier Giuseppe Murgia e Sergio Silva e diretta da Luigi Perelli,
racconta una Sicilia che reagisce prendendo atto della coscienza antimafia e
aiutando le istituzioni. Una storia che presenta spunti sentimentali e che
presenta dialoghi veramente intensi che fanno riflettere. Indimenticabile il
discorso magistrale alla “nuova mafia” del boss mafioso “Tano Cariddi”
interpretato con bravura dall’attore Remo Girone.
Vicino
al castello è stato ricavato un piccolo teatro in cui si eseguono durante il
periodo estivo delle rappresentazioni teatrali.
Proprietà attuale: pubblica (Comune).
Proprietà attuale: pubblica (Comune).
http://www.mazzarino.it/mazzarino/cartella/fotoantiche.asp
Mazzarino – Via degli Orti – 1940
Mappa del Catasto Borbonico –
Comune di Mazzarino
Mappa Catasto Borbonico – Centro
Cittadino di Mazzarino
Da Mazzarino al Castello di Grassuliato
IL CASTELLO DI GRASSULIATO
Il Castello di Grassuliato
La foto dal sito: https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-grassuliato?ldc
Il
Castello di “ Grassuliato, Garsiliato o Saliato”, nel Comune di Mazzarino, si trova
nell’ex feudo “Salamone”.
Posto
sulla sommità di un’emergenza rocciosa, a 418 m s.l.m., permette una visione
piuttosto ampia del territorio circonstante (sulla sottostante vallata del
fiume Gela). È accessibile da un fronte attraverso un ripido sentiero d’accesso
facilmente percorribile. È inserito in un’area dal grande valore archeologico
che, a quanto mi risulta, non è stata ancora del tutto indagata.
La
particolare morfologia del luogo ha favorito la costruzione del castello, le
cui fabbriche si distribuiscono sulla collina gessosa seguendone i livelli. Una
fortezza legata alla presenza di un villaggio, Casale “ Gelasium”, che sorgeva
nella vallata circostante e che perse progressivamente la sua importanza
strategica con la costruzione e il relativo sviluppo dell’abitato di Mazzarino.
STORIA
Il termine “Grassuliato” nel “Vocabolario Siciliano,
Etimologico Italiano e Latino, dell’Abate Michele Pasqualino da Palermo”
(Palermo, Reale Stamperia MDCCLXXXVI(1786), significa “rocca”.
Le
fonti sono rare e molti storici indicano il castello come caposaldo militare in
epoca normanna quando entrò a fare parte di un sistema di fortificazione
piuttosto ampio. Probabilmente il sito
doveva essere fortificato in epoca bizantina e araba e andando ancora più
indietro nel tempo anche in epoca romana. I ruderi sono la chiara testimonianza della
presenza di nuclei abitativi nella zona
discendenti dalla vicina e gloriosa città greco-sicula di “Mactorium” che fu scoperta da Paolo Orsi sul
Monte Bubbonia. Un castello che per la sua particolare posizione altimetrica
era in grado di resistere agli assalti nemici. Proprio per scongiurare i
tragici assalti nemici e per propiziare il favore degli dei, il castello
costruito dai romani fu denominato “Grassuliato”. Un nome che derivava dai 24
“Salii” (Saliati) sacerdoti di Marte.
Sacerdoti
di Marte che custodivano 12 scudi e lance sacre al dio della guerra e che
portavano in giro per i nuclei abitativi durante il mese di marzo. Una
processione accompagnata da inni sacri e da balli propiziatori. Lance che erano
presenti nell’antico simbolo che gli stessi romani concedettero alla cittadina
di “Macarina”.
Secondo
le ricerche del prof. Giuseppe Ferreri, riportate nel libro “ Il Mistero di
Mazzarino” il castello del Grassuliato è collegato alla presenza dell’antica
città romana di Macarina che fu fatta erigere dalle autorità romana in una zona
situata fra le importanti “mansiones” di Colloniana e di Philosophiana.
La
“mansio” (“mansiones” è il termine plurale) erano delle stazioni di posta lungo
le strade romane. Erano gestite dal governo centrale e messe a disposizione di
dignitari, ufficiali o di chi viaggiava per ragioni di stato. L’identificazione
degli ospiti era legata a documenti simili a passaporti. L’etimologia del
termine proviene dal latino “mansus”, (“manere”) con il significato di
“fermarsi, rimanere”.
(Le “Mansiones”
lungo la Catania –Agrigento. Itinerarium Antonini
La foto è tratta
dal sito: http://www.alqamah.it/2015/10/31/la-favola-delle-regie-trazzere-di-sicilia-capitolo-primo-parte-vii-la-viabilita-interna-della-sicilia-romana-la-catina-agrigento-e-la-halesia-enna-phintia-i/
(Insediamenti e
Mansiones
Opera della
dott.ssa Rosa Casano del Puglia)
(il
comune viaggiatore aveva a disposizione le “cauponae” cioè delle aree di sosta
private che spesso si trovavano vicino alle “mansiones”. Avevano una
reputazione minore rispetto alle “mansiones” perché considerate spesso
equivoche e malfamate perché frequentate da malfattori e prostitute. Un aspetto
che è stato rilevato dagli archeologici
in seguito al rinvenimento di graffiti sulle rovine delle “cauponae”.
(Ostia Antica – la
Caupona di Fortunato
C’erano anche la
“Tabernae” che erano destinate ai patrizi.
Le “tabernae” ebbero una loro diffusione legata sia allo sviluppo viario
che ad una disposizione di legge secondo cui “le case vicine alla strada dovevano offrire ospitalità”.
Tabernae poste lungo gli
itinerari e che avevano la funzione di “ostello”. Naturalmente potevano essere
lussuose o presentare un livello di accoglienza decisamente scadente.
(Taberna Romana
Foto tratta dal sito: http://www.datuopinion.com/caupona
(Taberna Romana –
Menù
Infine
erano presenti le “mutatio” cioè
delle “stazioni di servizio” destinate anche agli animali ed ai “veicoli”. Si
trovavano sugli itinerari ad una distanza di circa 12 – 18 miglia tra loro ed
offrivano vari servizi. Si potevano comprare i servizi dei carrettieri, dei
maniscalchi e degli “equarii medici”
(veterinari) per la cura dei cavalli. Come riporta il sito di Wikipedia
l’imperatore Tiberio sfruttando la collocazione delle “mutatio” riuscì a coprire
in un solo giorno le 500 miglia che separavano l’Illiria da Mogontiacum dove il
fratello Druso Germanico era in agonia per una gangrena causata dai postumi di
una caduta da cavallo.
(LA Mutatio di
Fontana Fredda(Castell’Arquato
Foto tratta dal
sito: https://valdarda.wordpress.com/2013/04/09/castellarquato-erede-di-veleia-muoveva-i-suoi-primi-passi-nel-ii-secolo-d-c/
Nell’
“Itinerarium Antonini” è documentata
una strada che collegava Catania con Agrigento e univa il Mar Mediterraneo con
lo Jonio. Alcuni cittadini scampati alla distrutta “Mazaris” (Mazara?) e
“diverse decine” di romani, reduci dalla battagli di Agrigento, intorno al 265
a.C., in obbedienza al “Prescritto” ricostruirono una nuova città in un sito
posto ai piedi del Monte Gibli, in località “Piano delle Vigne” (in una zona
compresa fra l’odierna Chiesa del SS Salvatore e la chiesa della Madonna delle
Grazie). Una città che denominarono “Macarina”.
In
questa zona erano presenti delle vestigia risalenti alla presenza sicana,
fenicia e greca. La presenza di queste rovine favorì la ricostruzione
dell’abitato che forse si estese sino alla località denominata “Garciteddra”.
Un sito particolarmente ricco d’acqua per la presenza di numerose sorgenti e
per la sua natura pianeggiante adatto alla ricostruzione della nuova città.
Secondo
il prof. Ferreri i romani indicarono la città come un “Oppidum” cioè un
insediamento cittadino fortificato ma ancora non abbastanza esteso da poter
essere indicato con l’appellativo di “civitas”. Gli “oppida” erano per i romani
dei veri e propri centri amministrativi nei territori conquistati. Molti di
questi centri diventarono successivamente delle città romane. L’Oppidum” di Macarina era un importante
centro amministrativi che assicurava la gestione di un vasto territorio
caratterizzato da piccoli centri urbani e villaggi rurali.
(L’Oppidum
fortiticato di Moleta del Remei-Lugares/ Alcanar – Tarragona)
(VIII – VI secolo
a.C. e successivamente II sec. a.C.)
Foto tratta dal sito : http://agorahistoria.com/tag/oppidum/
(Baetulo,
l’iberica Baitolo, era il nome della città fondata dai Romani in prossimità del
mare intorno al 100 a.C.
Sulle sue rovine
sorse la città di Badalona. Plinio il Vecchio definì Baetulo come “oppidum civium romanorum”
Ovvero “città
fortificata di cittadini romani”. Era famosa per la produzione di vino.
Baetulo – Terme –
Mosaico dei Delfini del I sec. d.C.
Foto dal sito : https://it.wikipedia.org/wiki/Baetulo
(Uno studio
dell’Università di Barcellona e del Museo di Badalona hanno portato
all’identificazione di anfore con vino Baetulo. Anfore che si trovavano su tre
navi affondante sulle coste del Mediterraneo al tempo di Augusto (I sec. d.C.)
i contenitori di ceramica erano fabbricati nella stessa Baetulo come dimostrano
i rinvenimenti a Peixau e nella piazza Pompeu Fabra. Due navi si trovavano nel
nord della costa catalana (Palafrugel e Port de la Selva) mentre la terza a sud
della costa francese a Port Vendres. Il rinvenimento dimostra l’importanza che
Baetulo aveva nella produzione di vino che veniva esportato. Le anfore dovevano
giungere nella città romana di Narbo, l’attuale Narbonne, che era un importante
centro di commercio durante l’Impero Romano.
La foto è tratta
dal sito:
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20140206/54400897180/identifican-vino-baetulo-barcos-siglo.html
Gli
“oppida” erano costruiti su declivi pianeggianti e circondati da colline sulle
quali gli stessi rimani costruivano del castelli o torri di avvistamento.
Strutture militari che avevano come obiettivo il controllo del territorio e
offrire ai cittadini delle condizioni di sicurezza.
L’oppidum
di Macarina costruito in località “Piano-mineddi” era protetto dal castello di
Macarina ( (il Castello Vecchio di Mazzarino), dal castello di Grassuliato e
dal Castidduzzu. Strutture realizzate su delle colline che circondavano
“Piano-minnelli”.
Il
“Castidduzzu” fu individuato nella località “Ruccazzu” (Canalotto) ed è
visibile dal castello Grassuliato. Nel luogo si trovano grandi ammassi di
pietre calcaree forse provenienti da un antica costruzione fortificata che
serviva per il controllo della valle che si estende dalla Contrada “Favara”
alla “Cosa a vurpi” e che è attraversata dal torrente “Jardiniddru”, affluente
del fiume Gela.
Macarina fu quindi uno
dei più importanti insediamenti in una vasta area rurale di circa 40 km di
raggio. La sua importanza aumentò quando fu realizzata l’intensa coltivazione
granaria del “fundus”. La città diventò una delle maggiori fornitrici di grano
per Roma. Macarina e “Castrum Janni” (Enna) furono considerate le due città più
importanti della colonizzazione romana nell’interno dell’isola e per questo
oltre che ad essere dotate di strutture difensive, erano anche destinate alla
residenza dei governatori. Nelle “Verrine” di Cicerone sono presenti delle
citazioni che riguardano i suoi frequenti viaggi in Sicilia per controllare
l’operato dei consoli e dei governatori che si arricchivano alle spalle dei
contadini siciliani. Cicerone chiamò la città Macarina e i suoi abitanti
macarinesi. Una città importante per il suo vasto e fertile territorio dedito
alla coltivazione di frumento e all’allevamento dei bovini per i suoi ricchi
pascoli. La città fu dotata di templi, di edifici sacri, di strutture
pubbliche. Tra il 1952 ed il 1954, sindaco della città era il prof. Filippo
Siciliano, alcuni contadini rinvennero in località “Piano Minnedri” una grande
giara adatta per contenere derrate alimentari e cereali.
La
giara rinvenuta, di epoca romana, fu l’unico reperto oltre al vetusto castello,
che potrebbe testimoniare l’esistenza di un antico sito. Giara che fu portata
nell’atrio del Municipio e collocata in una nicchia adiacente a quella in cui
si trovava il sarcofago del Principe Branciforte.
(dal libro “I
Misteri di Mazzarino” di Giuseppe
Ferreri
Foto di Giovanni
Pappalardo)
Macarina
era una città molto popolata dai romani tanto che nel 200 a.C. le fu assegnato
il titolo di “Nobile et Vetustum Oppidum
Macarina”.
Solo
degli accurati scavi archeologici potrebbero rilevare l’esistenza di ulteriori
villaggi legati alla forte presenza romana
e risolvere tanti dubbi per l’identificazione del sito dell’antica Macarina.
(foto dal sito : www.facebook.com/GelaStories/posts/il-castello-di-garsiliato-mazzarinoi-normanni-giunti-in-sicilia-a-partire-dal-10/857876160980433/
Il
Castello “Grassuliato” fu anche indicato con il termine di “Salomone”
riprendendo il nome della contrada in cui è ubicato.
Una
denominazione probabilmente legata all’insediamento di alcune comunità agricole
e commerciali di osservanza religiosa giudaico-cristiana. Una comunità che
diede il nome anche ad altri feudi limitrofi al castello: San Nicola, Santa
Cruci, Mistrà, Manca u Spataru, Valle Mira, Val Canonicu, Floresta, Finucchiu, Sarvaria, Sufiana, Alzacuda e
Purcaria.
Il Grassuliato con il suo villaggio fu abitato per
lungo tempo perchè legato ad un esteso e ricco territorio agricolo in cui era
possibile commerciare con profitto i relativi prodotti del suolo.
Nel periodo musulmano il castello conservò la sua
importanza strategico militare.
Un caposaldo dove uomini di razza e di religione
diversa esercitarono una volontà singola e collettiva con scambi economici di
manufatti e di prodotti del suolo con i casali e le città vicine. Insomma un periodo di massima tolleranza
reciproca che determinerà un periodo di benessere sociale.
Nel centro una collettività di notabili che appoggiava
il suo “caid” fino a quando lo stesso
“caid” darà vita ad un governo personale
che lo allontanerà dal potere centrale arabo consentendo la conquista normanna.
La mancanza di un forte governo centrale musulmano permetterà ai Normanni di
conquistare la Sicilia.
Con la conquista normanna il regime militare normanno,
che rispetto a quello musulmano presentava un forte aspetto unitario,
determinerà nel casale del Grassuliato un livellamento sociale e politico agli
altri centri abitati. La forte rocca con l’istituzione della Contea Aleramica
entrerà a fare parte di un complesso difensivo che si estenderà da Falconara
sul mare, a Butera, Mazzarino, Barrafranca, Piazza, Aidone.
Il
castello di Grassuliato appare per il prima volta nei documenti del 1091. Si
tratta di un elenco di donazioni effettuate alla Chiesa di “Santa Maria della Valle di Giosafat”(1). Figura il nome di“Salomon de Garsiliat” (Salomone forse
figlio di “Guigone de Garsiliat”) e di “Enrico
de Bufera” ( capostipite degli “Aleramici), “Girondus de Mazarina” e “Girbaldus
de Comacina” (Barrafranca).
Gerusalemme – Valle di Giosafat
(dal sito : https://culturasalentina.wordpress.com/2009/08/17/l%E2%80%99antica-preghiera-delle-cento-croci)
Dal sito : https://www.cercoiltuovolto.it/video/nella-valle-di-giosafat/
Chiesa di Santa Maria
della Valle di Giosafat
La
Chiesa, posta nella Valle di Giosafat, tra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi,
conteneva la tomba della Vergine Maria ed era annessa ad un monastero. La
chiesa venne distrutta intorno al 1010 dal califfo Al-Hakim e poi venne
riedificata da Goffredo di Buglione. Sulla ricostruzione della Chiesa si ha
notizia in seguito ad una donazione effettuata nel 112 da parte di Arnolfo di
Rohes, patriarca di Gerusalemme.
La
chiesa e l’annesso convento sottostavano all’Ordine di Santa Maria di Valle
Josaphat.
Un
ordine importante e tenuto in grande considerazione da sovrani e nobili che lo
gratificarono con ricche donazioni e privilegi che furono ratificati dai vari
pontefici. Le donazioni riguardavano anche l’Italia meridionale dove i reggenti
normanni furono assidui benefattori dell’ordine. I normanni cacciati gli arabi
dal meridione d’Italia ebbero nelle loro politica la diffusione del culto
latino che passava attraverso l’istituzione di abbazie, prima benedettine, poi
cistercensi e con la conseguente e progressiva emarginazione dei centri
monastici basiliani di rito greco, di chiara influenza bizantina, e che
comunque furono al momento della conquista
aiutati nella loro ripresa religiosa e culturale.
Tomba di Maria – Valle di Giosofat
Dal sito: http://www.gliscritti.it/gallery3/index.php/album_001/Gerusalemme/tomba-maria-cioni
In
Sicilia una della più importante dipendenza della Chiesa di Santa Maria di Giosafat
era la “Gancia” di Paternò e quella di Messina. Dipendenze che furono accordate
con bolla papale del Pontefice Pasquale II emessa il 3 gennaio 1113.
La
donazione effettuata da Salomone potrebbe essere rivolta proprio alla Gangia di
Paternò che fu costruita per volere della regina Adelasia del Vasto, terza
moglie del Granconte Ruggero I d’Altavilla, nel 1092.
1308
aprile 17, Messina
Fra Guglielmo, Abate del Monastero di S. Maria di Valle di Giosafat in Gerusalemme e della Chiesa di S. Maria Maddalena di Giosafat in Messina, la quale Chiesa era situata fuori le mura di Messina nelle vicinanze di S. Croce e dei SS. Simone e Giuda, ed era una delle grangie della predetta S. Maria di Valle Giosafat in Gerusalemme, acconsente alla vendita di una casa terrana, con proaulo, sita in Messina vicino la Chiesa di S. Croce e l'Ospedale detto di Maestro Ursone, fatta da Benedetto Scalisi, materassaio, figlio di Luca, bettoliere, col consenso di costui, e la moglie Bartolomea, nella lor qualità d'enfiteuti del Monastero, a favore di Notar Giovanni Calderone, messinese. Procede la suddetta vendita pel prezzo di tarì quarantuno e grana cinquanta d'oro in pierreali d'argento sine avantagio, coll'obbligo al compratore di pagare al Monastero l'annuo perpetuo canone di tarì due e grana dodici meno un quarto d'oro.
Originale Membranaceo mm 494 x
275
Salomon
de Garsiliat, feudatario del luogo, appare in un altro documento del 1098 come
ci riferisce A. Li Gotti nel suo “Garsiliato e su altri abitati dell’interno”
ed appare come figlio di un certo “Guigone
de Garsiliat”.
Nel 1150 circa l’arabo
Idrisi cita il casale di “Gar(o gasr)
Saliatah” …”distante da Butera dodici
miglia verso levante”…”ricco di terre feraci sa seminare” e di “ ubertosi
poderi, solcati dal fiume Miele, che abbonda di produzioni del suolo”.
Il Castello di Grassuliato e Monte Formaggio
Dopo
la conquista normanna non si hanno notizie sulle reali condizioni del
castello. Il sito, sempre in epoca
normanna, appare con un importante centro lombardo della famiglia degli Alemarici (Adelasia del
Vasto moglie di Ruggero I), marchesi di Savona, che mostrerà un grande senso
cittadino nei moti rivoluzionari durante il regno normanno di Guglielmo I
(Palermo o Monreale, 1120 – Palermo, 7 maggio 1166, quarto figlio di Ruggero II
e di Elvira di Castiglia) soprannominato “Il Malo”.
Guglielmo "Il Malo"
Sotto
Guglielmo I il castello è retto da Bartolomeo di Grassuliato. Probabilmente un
lombardo che si renderà protagonista durante i moti rivoluzionari e che in
riferimento ai fatti narrati dal Falcando fu uno dei capi della sommossa.
L’origine
di questi motivi rivoluzionari fu legata al comportamento dissoluto del re.
Un
re che a Palermo era immerso nel suo magnifico palazzo circondato dai piaceri
che gli procuravano le numerose concubine cristiane e musulmane ed estraniandosi
dalle cure del regno. Dopo le domate rivolte del 1156, affidò all’ambiguo
“Grande Ammiraglio” (ministro) Maione di Bari, con la carica di ministro, il
governo del Regno.
Guglielmo
I riponeva una smisurata fiducia nei confronti del suo ministro che fu anche
nominato “amiratus amiratorum” (emiro degli emiri) e che aveva assunto un
consolidato prestigio politico superiore al suo sovrano.
La
critica storica ha avanzato tante ipotesi sul comportamento del Maione. Alcuni storici sostennero che mirasse alla
corona cerando con un opportuna politica di creare il vuoto attorno al re e
nello stesso tempo d’ingraziarsi la plebe (compito alquanto difficile visto il
suo comportamento nei confronti delle masse). Per questo motivo il ministro si
creò un fedele seguito grazie alla promozione di ammiraglio del fratello
Stefano e a quello di governatore della Puglia del cognato Simeone Siniscalco.
Altri
storici affermarono che la sua politica aveva come obbiettivo l’accumulo di
ricchezze e che con le sue azioni cercava di liberarsi di tutti coloro che
erano in grado di comunicare al re il suo comportamento dissoluto.
I
nobili non lo sopportavano per la sua origine plebea, sulla quale ci sono dei
dubbi perché il padre sembra un magistrato e un ricco commerciante d’olio, ma è
anche vero che verso la nobiltà si fece promotore di vere e proprie azioni
persecutorie.
Alcuni
avvenimenti politici dimostrarono la sua ambiguità. La pace sostenuta con il
papa Adriano IV, che nelle condizioni in cui versava lo Stato Pontificio, non
era necessaria per Guglielmo I. Si
sarebbe facilmente liberato dal nominale vassallaggio della santa Sede senza un
trattato di pace.
L’abbandono di Mhedia, in
Africa, che assediata dagli Africani non ricevette i rifornimenti né fu
soccorsa militarmente, per ordine del ministro, da una flotta siciliana al
comando del “gaito” (Kaid) Pietro, musulmano alla Corte di Palermo. Maione, che
era di Bari, si giustificò dicendo che aveva solo eseguito gli ordini del
sovrano e questo per screditare lo stesso re davanti ai suoi sudditi.
(Palermo)
Si
dice che fosse diventato l’amante della regina Margherita e che “lei teneva in casa, già pronti, il diadema
e le insegne reali” e infine che “avesse
inviata una gran somma di denaro a Papa Alessandro per dichiarare Guglielmo
incapace di regnare e affidare a lui l’investitura”.
La
storiografia ha dimenticato la sua tirannide perché numerose furono le vittime
della sua feroce persecuzione….una lunga lista che ci ha tramandatolo storico
Palmeri Niccolò (Termini Imerese, 9 agosto 1778 – Termini Imerese, 18 luglio
1837; economista, storico e politico).
(Il
Palmeri nelle sue opere storiche si basa sulle cronache latine del Regno di
Sicilia della seconda metà del XII secolo scritte da Ugo Falcando, un letterato
medievale. Un letterato vissuto tra il 1166 ed il 1190, di altissimo livello,
profondo conoscitore dei classici latini e che doveva essere vicina alla corte
normanna palermitana in cui doveva svolgere alti compiti amministrativi vista
la sua alta competenza tecnico-burocratica. La Cronaca latina del Regno di
Sicilia fu pubblicata a Parigi nel 1550 insieme ad una Epistola ad “Petrum Panormitanae thesaurarium de
calamitate Siciliae”, probabilmente dello stesso autore forse un pseudomino).
Una
lista lunghissima di persequitati:
-
Guglielmo,
Conte d’Alosa;
-
Boemondo,
Conte di Tarso;
-
Roberto
di Buovo, valoroso cavaliere e zio del Conte di Squillace;
-
“E migliaia d’altri nobili personaggi erano ad
affollare le carceri di Palermo, alcuni accecati, altri crudelmente frustati,
altri gettati in oscuri e rozzi sotterranei”.
“Né rimanevano
illese le mogli e le loro figliuole. Vedovi matrone e vergini di sangue
strappate dai loro palazzi, altre rinchiuse in carcere con i più vili
malfattori; altre per fornire zozzi piaceri al grand’ammiraglio; ed altre
ridotte ad esercitare ignobili mestieri per vivere”.
“Gli stessi
principi Tancredi e Guglielmo, figli naturali di Ruggero Duca di Puglia,
fratello primogenito del Re, erano con rigore custoditi nel Palazzo (di
Palermo)”.
Il
malcontento alla fine scoppiò tra le file della nobiltà che più di ogni altra
classe sociale era bersagliata dalla politica del ministro. La ribellione
scoppiò a Melfi per poi propagarsi a macchia d’olio in Puglia.
Castello di Melfi
La
parola d’ordine della sommossa: “Non
deporre le armi fino a quando il ministro rimarrà al potere”.
Dalla
Puglia (Otranto, Barletta, Taranto, Bari) la ribellione si propagò ad Amalfi,
Sorrento e Napoli.
La
ribellione minacciava di espandersi anche in Calabria.
Maione
cercò di spegnere la rivolta ma le città insorte si rifiutarono di ricevere le
lettere del ministro che “le invitava a
rimanere fedeli pena il castigo”.
Inviò
a Melfi addirittura il vescovo di Mazzara che giunto sul luogo per calmare gli
animi, alla fine “li rianimò”.
Maione
fu costretto a rivolgersi a Matteo Bonello, Signore di Caccamo.
Castello di Caccamo
Il
Bonello .. un giovane, bello, valoroso, magnanimo ed imparentato con la nobiltà
calabrese, stimato nell’isola e fuori.
Stemma della Famiglia Bonello
Antichissima famiglia risalente al X secolo e ricordata in un diploma
degli Imperatori
Basilio e Costantino. Diploma che è conservato nella Chiesa di S. Maria di
Nazareth. Un Bonel, oriundo della Normandia, scese in Sicilia al seguito
di Ruggero d’Altavilla che lo nominò Signore di Carini e Caccamo
Il
ministro era riuscito ad attirarlo a sé grazie al fidanzamento con la figlia e
riuscendo a “strapparlo” dalla bellissima e ricca Clemenza, Contessa di Catanzaro
di cui il Bonello era da tempo innamorato.
Matteo
Bonello fu mandato in Calabria, riunì i nobili per convincerli che “erano false tutte quelle voci
sull’Ammiraglio e che perciò dovevano restare tranquilli e fedeli”. Tra i
nobili l’ammiragglio Ruggero di Martirano, acerrimo nemico del Maione.
Nella
riunione avvenne qualcosa di strano che Maione mai avrebbe immaginato.
I
baroni calabresi riuscirono a convincere il Bonello dell’ignobile causa che
stava sostenendo. Lo convinsero della malvagità di Maione e dei tristi disegni
politici che aveva in mente e che “a lui
non conveniva sposare la figlia del
tiranno, perché sarebbe diventato suo complice, tradendo la fiducia del re e
coperto di macchie la nobiltà dei suoi natali”.
Lo
invitarono quindi a sposare la giusta causa della nobiltà ed avere la
riconoscenza di tutti gli oppressi “spegnendo”
l’ammiraglio e gli promisero “la mano
della Contessa di Catanzaro che sapevano essere lui innamorato”.
Bonello
si lasciò convincere, accettò la mano della contessa che la fanciulla, felice
perché innamorata, gli promise, e giurò di “uccidere
colui che doveva essere suo suocero”, quindi ritornò in Sicilia.
Il
Palmeri descrive i fatti seguenti: “Qui (a
Palermo), un certo Niccolò Logoteta, che
era in Calabria, avvisò il grand’ammiraglio del matrimonio tra Bonello e la
Contessa di Catanzaro, e del partito che lui aveva preso con i baroni
calabresi. Maione non voleva prestare fede a quella notizia, ma poi confermata
da latri, piuttosto scocciato si preparò a prevenire il colpo e farla pagare
cara a Bonello. Costui, intanto, reduce dalla Calabria, era giunto a Termini, e
qui lo raggiunse uno dei suoi uomini che aveva lasciato Palermo, e lo avvertì
che il grand’ammiraglio aveva promesso vendetta e stava attendendo il momento
per compierla”.
Il
Bonello scrisse al Maione una lettera molto affettuosa nella quale esprimeva
che “in
Calabria tutto era tranquillo; che i baroni erano tornati
all’obbedienza; e aggiungeva che era stato e sarebbe sempre stato in avvenire
pronto a qualunque fatica, pronto ad affrontare qualunque pericolo per lui; ma
non di averne ancora avuto quell’occasione; e che anche il suo cuore non
desiderava altro che le nozze con sua figlia; e caldamente lo pregava di non
differire oltre il matrimonio”.
Il
tono di questa lettera fece sparire i sospetti del Maione “il quale credendo di smentire tutti coloro, che lo avevano avvertito
dell’intenzione di Bonello, gongolando a tutti quella lettera mostrava”.
Il
Maione rispose con un lettera altrettanto affettuosa, cordiale, ringraziandolo
di ciò che aveva fatto in Calabria e “lo
pregava di scendere a Palermo, dove le sue nozze non sarebbero state più a
lungo rimandate”.
Bonello
non indugiò nel fare ritorno e fu “accolto
affabilmente da colui che invece, aveva giurato di sopprimere”.
Gli
avvenimenti storici come in un romanzo incominciano a diventare intricati con
un susseguirsi di azioni senza tregua….
Maione
in Sicilia si era creato un altro nemico, molto potente perché godeva della
fiducia del re, l’arcivescovo Ugo di Palermo.
Un
nemico difficile da gestire perché Maione non poteva né metterlo in cattiva luce presso Guglielmo I né rischiare
di sollevare lo sdegno degli ecclesiastici dell’isola mettendolo in prigione.
Con
grande finzione gli si era sempre dichiarato amico ma in realtà covava contro
di lui un odio irrefrenabile a tal punto che un giorno colse l’occasione “per fargli propinare un veleno”.
“ Era il 10
novembre 1160,l’arcivescovo giaceva solo, infermo, forse per il veleno già
ingerito con un primo tentativo; Maione però temendo che il suo nemico
guarisse, preparò un veleno ancora più forte e glielo portò lui stesso, nel far
della sera, facendogli credere che fosse una medicina miracolosa”.
“L’arcivescovo,
che conosceva le intenzioni di Matteo Bonello, appena il Grand’Ammiraglio fu in
casa sua, fece avvertire il giovane della presenza del ministro nel suo
palazzo; e, nella serata, Matteo Bonello radunò un buon numero di fedeli
armati, li mise in agguato sulle vie, dove Maione, rincasando, doveva passare,
e lui stesso si appostò presso la porta detta di Sant’Agata”.
“Nella casa del
prelato era, intanto, fallito il tentativo di fare bere all’arcivescovo il
veleno; l’ammalto, fiutando l’inganno, si era rifiutato, dicendo che le
medicine gli erano diventate insofferenti. Il grand’ammiraglio restò fino a
tarda sera a conversare con l’arcivescovo, poi si accomiatò ed uscì mentre, per
ordine dell’infermo, venivano sprangate, dietro il ministro, le porte del
palazzo”.
“Qualcosa doveva
però esser trapelato dell’agguato perché, quando Maione giunse sul luogo
dell’insidia, il protonotaro Matteo D’Aiello e il gran camerlengo Adenolfo,
facendosi largo tra il seguito del ministro, gli si accostarono e gli
sussurrarono all’orecchio che lì vicino stava nascosto il Bonello con un gruppo
d’armati. Ma proprio in quell’attimo sbucano dall’ombra Matteo Bonello e,
gridando che era giunto il momento di vendicare tanti innocenti, trapassò con
la spada il Maione che cadde esamine al suolo. Gli accompagnatori del ministro,
atterriti, si diedero alla fuga; il gran protonotaro, che era stato ferito, a
stento riuscì a salvarsi”.
Palermo
– Porta Sant’Agata –
Nella parte superiore della porta
era affrescata la Madonna del Carmelo ( opera non più visibile) e ai lati della
porta, nelledue lunette si trovavano due puttini non più distinguibili. Vicino
alla porta c’è la Chiesa di Sant’Agata che conserva un sasso con l’impronta di
un piede, che secondo la tradizione locale, sarebbe di Sant’Agata che qui si
sarebbe fermata.
“La Spada di Matteo Bonello”
https://antonioblunda.wordpress.com/2011/12/13/matteo-bonello-e-la-sua-spada-inchiodata-sul-portone-del-palazzo-arcivescovile-di-palermo/
Altre fonti citano che l’uccisione
di Maione, sempre il 10 novembre 1160, vigilia di San Martino, avvenne
all’imbocco della via Coperta, strada che collegava il palazzo dell’Arcivescovo
con il Palazzo Reale. Infissa sul portone dell’arcivescovado c’è l’elsa di una
spada con la quale, secondo una tradizione popolare, il Matteo Bonello uccise
il ministro Maione.
L’elsa della spada è del tipo “a
vela” ed è una caratteristica del XVI secolo quindi non riferibile ai tempi del
Bonello e di Guglielmo I.
Perché questa elsa è stata
inchiodata sul battente del portone ?
Tra le risposte degli storici c’è
la tesi secondo la quale nel periodo feudale
vigeva il privilegio e la facoltà, da parte dei baroni, di procedere
tanto in via penale che in via civile contro i loro vassalli. Una facoltà,
detta “ diritto di spada e di morte” concessa dai re a partire dal 1400. L’impero
baronale aveva come simbolo le “forche”, che s’incontravano all’ingresso delle
loro terre, per far risaltare l’autorità dei feudatari sui loro vassalli.
L’arcivescovo di Palermo possedeva, come i baroni, feudi e terre, e di
conseguenza godeva dei relativi diritti e privilegi. Nel volere manifestare il
suo potere, come monito per tutti, decise di non mettere un simbolo macabro ed
inquietante come la “forca” ma l’elsa di una spada, che nessuno successivamente,
si curò di levare forse per dimenticanza o perché fosse di continuo ammonimento
al potere politico.
Palermo – Via coperta detta oggi “Via
Matteo Bonello”
http://www.palermoviva.it/una-via-al-giorno-via-matteo-bonello/
La
notizia dell’uccisione di Maione si sparse subito per Palermo e “fu giubilo… fu insultato il cadavere del
malvagio ministro; i baroni della Puglia e della Calabria deposero le armi ma
dichiararono di riprenderle subito se si fosse osato punire il Bonello”.
(Il
suo corpo fu trascinato in modo macabro per le strade della città.. ”la gente lo colpiva con calci dopo avergli
strappato barba e capelli…”
Il
re sulle prime si mostrò sdegnato per l’accaduto per poi ravvedersi una volta
venuto a conoscenza dei misfatti del suo ministro.
Diede
la carica di ministro ad Arrigo Aristippo, arcidiacono di Catania, e concesse a
Matteo Bonello, che nel frattempo si era rifugiato nel suo Castello di Caccamo,
di tornare a Palermo.
Palermo – Palazzo Reale
L’ingresso
del Bonello a Palermo fu accompagnato da scene di giubilo e il grido “liberatore” accompagnava il suo
ingresso nel palazzo reale dove fu accolto dal re con grandi dimostrazioni di
stima. Finiti i festeggiamenti fu accompagnato a casa dai più illustri
personaggi della corte.
Maione
aveva lasciato tanti amici influenti a corte tra cui la regina Margherita,
Matteo D’Aiello ed Adenolfo che non sopportavano gli onori tributati al Bonello
ed iniziarono una vera e propria campagna verbale volta a riabilitare
l’immagine di Maione e a dipingere il Bonello come un uomo violento, incapace
di fedeltà e gratitudine, avido di gloria e di dominio, desideroso di primeggiare nella vita sociale e di mirare alla corona.
Le
insinuazioni ebbero un effetto positivo con il conseguente allontanamento del
Bonello dalla corte.
Il
Bonello convocò segretamente presso di sé, nel suo castello di Caccamo cioè in
quella che è indicata come la “Sala della Congiura” (nel marzo del 1161), i
suoi amici baroni per “provvedere alla
salvezza comune e tutti”.
Castello di Caccamo – Sala della
Congiura
Ruggero
Sclavo, figlio di Simone di Policastro fratello del Re; un certo Simone; Tancredi, nipote di Guglielmo; il Conte
Ruggero di Avellino, furono dell’avviso di deporre il sovrano e confinarlo in
una vicina isoletta e mettere sul trono il figlio del Re che “portava il nome dell’illustre avo Ruggero”.
“L’impresa non era
facile perché la custodia del palazzo era affidata a Malgerio, ufficiale prode
e fedele, e le guardie erano tante e così ben disposte che era impossibile
giungere segretamente o per forza nelle stanze del re; ma, poiché Malgerio si
assentava molte volte lasciando in sua vece il custode delle carceri, che a
quel tempo erano nel palazzo, riuscì ai congiurati di corrompere costui e farsi
promettere d’introdurli nella reggia e liberare ed armare i prigionieri per
cooperare sull’impresa. Stabilita ogni cosa, il Bonello se n’andò a Mistretta
per raccogliervi viveri ed armi nell’eventualità di una guerra e raccomandò ai
suoi compagni di non tentar nulla prima del suo ritorno”.
Il
Bonello andò a Mistretta per fortificare il suo castello nel caso di un evento
bellico. Il Bonello era infatti anche Signore di Mistretta.
Mistretta – Castello
Mistretta – Castello
http://nellaseminara.altervista.org/il-castello-di-mistretta/
“Ma questi,
essendo la congiura venuta per caso a conoscenza di un soldato imprudentemente
invitato a farvi parte, furono costretti a metterla in esecuzione durante
l’assenza di Matteo Bonello.
Il colpo fu fatto
di mattina. I prigionieri politici e i congiurati, guidati da Simone e
Tancredi, penetrarono improvvisamente nelle camere del sovrano, mentre questi
si trovava a colloquio con il grand’ammiraglio Aristippo. Guglielmo atterrito,
tentò di scappare; trattenuto e rassicurato da Riccardo di Mandra, che impedì
agli altri di toccarlo, di dichiarò pronto ad abdicare”.
“Tutto era stato
fatto senza che fuori nulla trapelasse; a render clamoroso il colpo di stato fu
la peggiore feccia di carcerati, i quali, evasi, si diedero a saccheggiare la
reggia, facendo man bassa degli ingenti tesori che vi erano e violentando le donzelle
addette al servizio della regina. Nel trambusto che ne seguì un gran numero
d’eunuchi e di Saraceni furono trucidati. Chiuso il sovrano nelle sue stanze, i
congiurati gridarono re il piccolo Ruggero primogenito di Guglielmo, poi messo
su un cavallo lo condussero per le vie della città, dicendo al popolo che lo
avrebbero incoronato al ritorno del Bonello”.
Guglielmo
I fu quindi imprigionato, nella Torre Pisana, e dichiarato decaduto mentre il
figlio Ruggero di appena 9 anni dichiarato re anche se ancora privo
dell’ufficiosità dato che si aspettava il ritorno di Matteo Bonello.
Palermo – Torre Pisana
Come
narrano le cronache furono trucidati diversi membri della corte e ci fu una
vera e propria caccia ai musulmani che erano considerati usurpatori e che
vennero massacrati a decine. I palazzi reali vennero dati alle fiamme e
saccheggiati con la conseguente distruzione di un patrimonio culturale
d’inestimabile valore. Si perse un immenso patrimonio librario tra cui
l’edizione in latino del “Kitab Rujar” ( un libro di geografia “Liber ad eorum delectationem qui terras peregrare
studeant (Il
sollazzo per chi si diletta di girare il mondo, Kitāb nuzhat al-mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq),
chiamato il libro di Ruggero(Kitāb Rujār o Kitāb Rujārī), finito verso il 1154.
Nel patrimonio artistico oltre a numerose e
pregiate porcellane andò perduto il planisfero d’argento, detto “Tabula
Rogeriana, una delle più avanzate mappe del mondo medievale e che era incisa su
una lastra d’argento, e la sfera armillare realizzate dal grande geografo arabo
Idrisi per conto di Ruggero II.
Tabula
Rogeriana
Dal sito: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/travel-atlases-maps-l17405/lot.22.html
Opere che furono fatte a pezzi e fuse. Per
dovere di cronaca il geografo Idrisi scappò dalla Sicilia dopo i fatti
sanguinosi per morire nel 1165 circa a Ceuta anche se non si è sicuri della fonte.
Furono bruciati anche gli atti conservati negli
archivi e i registri del catasto probabilmente per precisi interessi personali
di chi aveva usurpato beni immobili e fondi. Gli eunuchi che assolvevano a
corte ad importanti incarichi
amministrativi furono trucidati e la stessa fine fecero molti musulmani sparsi
nella città, che svolgevano commerci, a cui era vietato possedere armi.
Restarono in balia della plebaglia riuscendo solo in parte a salvarsi
sfruttando le viuzze assai strette dei quartieri da loro abitati. La ferocia
colpì anche il noto poeta Yahya ibn al – Tifashi.
( Gli eunuchi erano uomini privi di facoltà
virili per difetto organico o in seguito ad evirazione. Erano gli antichi
camerieri dei principi orientali e nelle corti occidentali ricoprirono
importanti incarichi amministrativi e militari. Nella Bibbia vengono ricordati
nella loro funzione di camerieri dei principi orientali anche se non è presente
alcuna citazione alla menomazione fisica).
“La popolazione al
sentire che Matteo Bonello era stato l’organizzatore della congiura, si mostrò
lieta dell’avvenimento, ma poiché, trascorsi tre giorni, lui non tornava, si
era sparsa la voce che si voleva dare lo scettro al conte Simone; a quel punto
i Palermitani cominciarono a mormorare, poi si diedero a tumultare, e infine,
prese le armi, corsero alla reggia reclamando la liberazione di Guglielmo”. (Simone sarebbe il
nome di un conte non ben identificato da non confondere con Simone, Conte di
Policastro, che era già morto nel 1156 circa).
“I congiurati
tentarono di opporsi alla folla e s’impegnarono in un violento combattimento;
ma, quando erano sul punto di essere sopraffatti, rimisero in libertà il
sovrano, facendosi prima promettere uscire liberi per lasciare Palermo”.
L’11
marzo Guglielmo I venne liberato e importante furono le mediazioni degli uomini
leali al re tra cui gli arcivescovi Romualdo di Salerno e Roberto di Messina
oltre ai vescovi Tristano di Mazara e Riccardo Palmer, designato quest’ultimo
dalla diocesi di Siracusa.
“Durante questa breve lotta trovò la morte il più
innocente di tutti, il piccolo Ruggero (di nove anni). La sua fine fu da alcuni attribuita ad una freccia, che, scagliata dal
popolo, andò a colpire il fanciullo (ad un occhio); altri affermarono che Ruggero, visto il padre in libertà, corse da
lui festosamente ma con rabbia fu respinto con un calcio mortale e spirò, poco
dopo tra le braccia della madre”.
Il
Palmeri continua nel suo racconto…”Re
Guglielmo, intanto, sopraffatto da quel grave oltraggio, cadde in tale avvilimento
d’animo che deposto il regio manto se ne stava seduto a terra, piangendo
amaramente; come prescriveva il divieto reale nessuno poteva parlargli né
avvicinarsi a lui, invece gli erano tutti intorno e lui piangendo a tutti
narrava piangendo, quell’atto miserevole che gli era capitato. Finalmente,
confortato dai vescovi, si recò nella grande sala, contigua al palazzo, e qui
convocato il popolo, si diede a ringraziarlo di ciò che aveva fatto per lui, ed
ad esortarlo a conservare sempre la stessa fedeltà. Confessava di essere stata
quella disgrazia un castigo di Dio, per la sua mala condotta, e prometteva di
ravvedersi e riscattarsi, e dichiarava di esser pronto a concedere ai sudditi
quanto da loro era stato chiesto, che andava a loro bene; diceva volere abrogare
tutte le consuetudini nel suo regno introdotte, ma faceva anche notare che così
facendo poteva essere ristretta la libertà dei cittadini, mentre in caso
contrario essere gravati di pesi straordinari; finalmente, in merito del
servizio prestato concesse al popolo di Palermo l’esenzione di tutte le gabelle
nel comprare, vendere, e liberi di portare in città ogni genere di prodotti
della terra”.
Le
improvvise liberalità del sovrano provocarono una forte reazione dai parte dei
congiurati che nel frattempo avevano ricevuto ospitalità nel castello di
Caccamo di Matteo Bonello. Il Bonello fu rimproverato dal re per aver concesso
ospitalità a tanti traditori. La risposta del Bonello fu altezzosa e in nome di
tutti rispose che “a lungo la nobiltà
aveva sopportato i soprusi del re, fra i quali il più intollerabile era
l’ostacolo opposto alle nozze delle figlie dei baroni, al cui matrimonio era
spesso negato il consenso regio; che i nobili male tolleravano le illegali
riforme recentemente introdotte e che infine reclamavano che fossero rimessi in
vigore gli antichi statuti sanciti da Roberto il Guiscardo e confermati dal
Conte Ruggero”.
Questa risposta sdegnò Guglielmo che fece
riferire “che avrebbe concesso ai nobili
quanto loro chiedevano se, essi, abbandonati i traditori, fossero venuti a lui
umili e inermi”.
I baroni rimproveravano al Bonello, per il
suo temporeggiare, il cattivo esito dell’impresa e alla fine il signore di Caccamo, radunate
le schiere, mosse contro la capitale.
“Guglielmo
si vide perduto, i soccorsi chiesti da Messina tardavano ad arrivare; le
vettovaglie raccolte rapidamente nelle campagne erano insufficienti per un
assedio; i partigiani di Maione, sgomenti, anziché preparare una difesa, si
preparavo a mettersi in salvo con le loro cose; la popolazione mostrava di
volersi schierare con i baroni che marciavano verso la città.”
Bonello spaventato dalle conseguenze
dell’impresa più che dell’impresa stessa, che si presentava facilissima, giunto
nelle vicinanze di Palermo, tornò indietro. I baroni dopo poco tempo
ritentarono l’impresa ma ormai era troppo tardi perché da ogni parte dell’isola
erano giunti soccorsi di truppe al re.
“I
nobili accettarono quindi i patti che furono loro offerti dal re per mezzo del
canonico Roberto di S. Giovanni di uscire cioè dal Regno”.
“Soltanto
tre baroni furono esclusi dal bando; il Conte di Avellino, ultimo di quel
casato, per l’età giovanile e le preghiere della nonna cugina del re; Matteo
Bonello per il grande favore che godeva presso il popolo; Riccardo di Mandra
per aver salvato la vita al re durante la rivolta e che ebbe la carica di Contestabile. Arrigo Aristippo, sospettato di complicità
con i baroni, perse il favore del re; lo riacquistò Matteo D’Aiello che,
liberato dalla prigione, riebbe la carica di protonotaro. Guglielmo giurò di
perdonare il passato di Matteo Bonello e di rimetterlo nella sua grazia ma ben
presto il signore di Caccamo dovette imparare quanto sia stolto colui che crede
al perdono di un principe contro il quale ha snudato la spada”.
Non tutti i baroni accettarono i patti di
Caccamo. Alcuni baroni capitanati da “Tancredi
e da Ruggero Sclavo, figlio di Simone (duca di Policastro), mantennero viva
l’agitazione e, fatto il centro della rivoluzione la forte Butera, Piazza
(Armerina) ed altre terre popolate da Lombardi, diedero addosso alle
popolazioni musulmane di quelle parti, fedeli al re, e spinsero le loro
incursioni fino a Siracusa e Catania”.
Ruggero Sclavo era figlio illegittimo di
Simone del Vasto (detto anche Simone di Policastro o Simone Aleramico )
(Sicilia, ante 1137 – Sicilia, 1156), Conte Di Policastro, Butera, Paternò e
Signore di Cerami. Simone era figlio di Enrico del Vasto e nipote di Adelaide
Del Vasto moglie di Ruggero I. Diventò capo degli Aleramici di Sicilia e Conte dei Lombardi in Sicilia.
Ruggero
Sclavo, Tancredi, e altri nobili tra cui anche Bartolomeo di Grassuliato si
asserragliarono nel munito castello di Butera (Il Castello di Grassuliato
rientrava nella Contea di Butera e lo stesso Ruggero Sclavo rivendicava sul
castello dei diritti feudali).
Castello di Butera
Dal sito: www.bandw.it
“Guglielmo era
deciso a domare i ribelli, radunò un poderoso esercito e prima di partire,
consigliato dagli amici di Maione di non lasciare libero a Palermo Matteo
Bonello, chiamato alla reggia, ordinò di arrestarlo e di chiuderlo in prigione.
Qui all’infelice giovane furono barbaramente cavati gli occhi e tagliati i
garretti. Uguale sorte toccò a qualche suo parente ed amico”.
“Il popolo volle vendicare
il suo eroe, uccisero il camerlengo Adenolfo e tentò pure di assalire la reggia
che però resistesse perché ben difesa. Dopo inutili tentativi nella città tornò
la calma. Guglielmo mosse contro gli insorti, assediò Butera dove si erano
ritirati (i nobili), ma la città era fortissima come luogo di difesa ed era ben
fornita di vettovaglie ed alimenti. L’assedio durò a lungo e già il sovrano,
perdendo la speranza di conquistarla aveva deciso di allontanarsi, quando
un’improvvisa discordia, sorta tra gli abitanti e la guarnigione, gli porse
l’occasione di avere per patti Butera. La città fu distrutta e smantellata,
Ruggero Sclavo e Tancredi ebbero salva la vita a condizione che partissero
subito dal Regno”.
Stessa
sorte toccò a Bartolomeo di Grassuliato, “abbandonare la Sicilia “extra regnum suum” non senza aver prima
smantellato Grassuliato il cui presidio venne preso in ostaggio dall’esercito
regio. Bartolomeo in questa fase della rivolta contro Guglielmo I fu uno dei
nobili più attivi tanto da riuscire ad attirare nella disputa anche Goffredo di
Monte Scaglioso (Matera).
La
rocca venne quindi distrutta assieme a Piazza ed altri centri vicini occupati
dai Lombardi.
Nel
1199 il Grassuliato è concesso a Bartolomeo da Amalfi
Durante
il regno di Federico II di Svevia, dopo la cacciata definitiva degli Aleramici
e dell’ultimo rampollo Ruggero Sclavo, per molti anni la fortezza era di
pertinenza del regio demanio e
amministrata dal castellano Bartolomeo di Amalfi.
Il
castello, che fu ricostruito, rimase però
demaniale per la sua particolare importanza e in un diploma del 1240 l’imperatore Federico si
lamenta con Giovanni Vulcano “provisor
castrum”, per essere stato informato da Giacomo da Lentini, che la
fortezza, della quale il Vulcano era castellano, manchi dell’indispensabile per
le persone addette alla custodia, ordinando all’uopo che “pro necessariorum defectu castrum ipsum non remaneat
immunitum"
e di “pro munitione castri nostri
Garsiliato”.
Si
suppone che in questo periodo la terra sia in possesso di Giacomo da Lentini,
altrimenti detto di San Basilio, parente con la famiglia di Giovanni Mazzarino,
signore della vicina terra omonima, e con Riccardo da Lentini "prepositus edificiorum" (preposto
alla costruzione dei casteli) dell’imperatore.
Nell’ultimo
periodo della dominazione sveva la ricostruzione di Grassulato è completa e in
un diploma del 7 febbraio 1266 si trova sotto la signoria di Pagano da
Grassuliato.
Sotto
gli Angiò la terra ritorna ancora demaniale. Infatti in un diploma del
1270 il feudo è obbligato al pagamento
delle decime che deve con Avola, Mineo e Barrafranca al vescovo di Siracusa,
indipendentemente da quelle che deve alla Reale Cappella di Palermo mentre in
documento successivo del 1274 lo stesso sovrano cataloga il castello tra le
fabbriche regie “"Castrum
Garsiliatae per castellanum unum militem et servientes quattuor".
Il casale sotto la dominazione sveva ebbe un
suo sviluppo entrando in “competizione” con le altre città demaniali di
Caltagirone, Ragusa e Butera nel tentativo di espandersi nella sottostante
pianura ai danni di Eraclia o Terranova (l’attuale Gela), assumendo l’ambito
titolo di “Comitatus Grassuliati”.
Dopo la battaglia del “Vespro” il castello con il suo esteso
casale erano di pertinenza di Ruggero Passaneto che aveva partecipato
attivamente alla rivolta contro gli Angioini nel 1282 sollevando la contea e la
terra di Mazzarino.
Le fonti storiche del Mugnos citano Ruggero Passaneto “Conte
di Grassuliato nel Ruolo Feudale di Federico d’Aragona, iniziatore di una
dinastia di valorosi, che si mostreranno degni di tutti gli avvenimenti
successivi”.
“Bernardo
Raimondo de Rebellis Conte di Grassuliato, strenuo difensore della nave regia,
nella celebre battaglia di Capo d’Orlando, de 25 giugno 1299, sta a poppa accanto
a Federico d’Aragona, , mentre Ugone degli Eimpuri trovasi
alla prua e Garzia Sancio accanto allo stendardo regio, quando a nulla vale il
valore degli eroi e di Gombaldo de Insenga, "che vago di gloria e forsaneo
di vendicare il suo nome, deturpato dal fratello traditore della Sicilia,
cacciata la gomena, che li legava alle altre navi, la nimica fila
investe", e muore arso di sangue, che perde da tutte le parti, trafitto da
mille ferite, mentre cerca un attimo di riposo poggiando la testa sullo scudo,
nè l'atto disperato dell'alfiere di Blasco d'Alagona, che nel vedere il suo
signore ammainare la bandiera regia si toglie la vita urtando la testa contro
l'albero della nave, mentre privo di sensi il giovane re viene sottratto alla
prigionia, dopo che invano ha cercato la morte gloriosa in battaglia e rabbioso
l'incontro con il fratello Giacomo”.
A Ruggero successe Riccardo ..
“Ancora negli avvenimenti del 1302, e nelle vittorie
che precedono la pace di Caltabellota, del 24 agosto dello stesso anno, si
distingue nella battaglia di Aidone Riccardo Passaneto, conte di Grassuliato,”,
il cui
figlio Ruggero…” che pur disobbedisce a
re Pietro II, negli avvenimenti del 1338, viene reintegrato nei suoi stati
dalla grazia sovrana”.
Ma fu un figlio di Riccardo, Blasco Passaneto, fedele alla corona
Aragonese a diventare il primo “Conte di Grassuliato”… “Il figlio di Riccardo, Blasco
Passaneto, nuovo conte di Grassuliato, serve fedelmente Federico IV, fratello
di Ludovico morto a 17 anni; poi quando il predominio dell'Isola viene conteso
tra la nobiltà catalana e quella latina ed il regno sembra ancora una volta
vacillare per la discesa degli Angioini di Napoli, che ancora non sanno
rassegnarsi alla perdita dell'Isola, tra i fedelissimi della corona troviamo
sempre Blasco Passaneto nei noti avvenimenti del 1374”.
Da Ruggero Passaneto il feudo passò a Raffaello Branciforti forse
in seguito ad un atto di ribellione da parte di un successore di Blasco
Passaneto.
La cronaca storica cita come primo signore di “Grassuliato e Mazzarino”
nel 1392 “Nicolo” Branciforte… Un successore dei Passaneto si ribellò a Martino
I e come conseguenza perse i feudi…” Ma col successore chiamato con nomi diversi dagli storici e che si ribella
a re Martino, inizia la rovina progressiva di Grassuliato, che viene data in
feudo, nel 1393, a Niccolò Branciforti, barone della vicina terra di Mazzarino”.
Nel 1408 è “sotto questa
famiglia rimane e la troviamo nel Ruolo di Martino..” Grassuliatum Comitatus et Castrum
apud Platiam nobilis Thomasij de Brachilis Fortibus", figlio del precedente conte Niccolò, che si era segnalato nella
ribellione di Piazza, e fratello di Federico barone di Mazzarino”.
Nel 1507 Nicolo Melchiorre Branciforti è il primo conte Di Mazzarino
e Grassuliato.
In tutti i contratti notarili della fine del XV secolo Nicolò Branciforti si firmerà sempre “"Dominus Terrarum Mazareni, Grassuliati, Auguste, etc.".
La terra del
Grassuliato è ancora abitata da qualche vassallo e in qualche contratto
notarile è citato ancora un magistrato in carica.
Giovsnni
Luca Barberi (XV secolo – XVI secolo) ( notaio e giurista autore di un’opera
che descrive i feudi popolati, terre e contee, siciliani dal feudalesimo al
Seicento) cita il Grassuliato tra i feudi disabitati e soggetta al “Mero e
Misto Impero” con Mazzarino e con i feudi di Gallitano, Gibiliusi, Alzacauda,
Sofiana, Porcaria, Bauci, Mandrablanca, Candiacagghiuni. Tutti casali abitati
in precedenza e che entrarono a fare parte della Contea di Mazarino con un
privilegio del 21 febbraio 1507 di Ferdinando il Cattolico al su citato Niccolò
Melchiorre Branciforti che era anche signore delle terre di Augusta e di
Melilli e che come abbiamo visto fu il primo conte di Mazzarino e Grassuliato.
Nel
1550 il castello era probabilmente già abbandonato dato che anche il Fazello
cita: "il piccolo centro fortificato di Grassuliato con la sua
rocca" distante diciotto miglia da Biscari - Fazello, I, p. 477.
Del
XVI secolo è lo spopolamento del feudo di Grassuliato con il trasferimento dei
vassalli nella vicina Mazzarino.
Una
leggenda narra che nel Castello di Grassuliato sia presente il fantasma di
Federico II di Svevia. Proprio in questo castello Federico II e Bianca Lancia furono
amanti. Una forte storia d’amore. Bianca Lancia aveva sedici anni quando riuscì
ad infiammare il cuore dell’uomo più
potente e freddo del Medio Evo. Era figlia di Bonifacio I d’Agliano,
conte d’Agliano, Mineo e Signore di Paterno e di una Bianca Lancia figlia a sua
volta del marchese piemontese Manfredi I Lancia.
Il Castello di Grassuliato e sulla
sinistra Monte Formaggio
STRUTTURA
ARCHITETTONICA
Dai
resti è difficile ricostruire la maestosità del castello. I resti non
costituiscono un sistema unitario e attraverso la relativa lettura dei tre
gruppi di ruderi, ancora esistenti, è possibile avere una visione frammentaria
di quello che doveva essere la fortezza.
http://www.siciliafotografica.it/homesic/index.php/reportage-mainmenu-81/nella-storia-mainmenu-86/162-lantico-grassuliato
Il Castello fu ricostruito in epoca sveva
presentando gli aspetti tipici
dell’architettura che ne contraddistingue il periodo: su scosceso monte;
solide mura, apertura a nord con arco a sesto acuto, vaste cisterne nei
sotterranei che portavano dal castello nella sottostante vallata.
Si
distinguono tre diversi gruppi di costruzione, disposti su piani diversi e
risalenti a varie età. Aspetti desumibili dalle diverse strutture dei muri e
dai diversi materiali impiegati per la costruzione.
Il
primo gruppo è costituito da due ambienti scoperti orientati sud-nord. Su una parte
si aprono tre feritoie strombate. In direzione sud-ovest, rispetto agli
ambienti precedenti, si trovano le rovine di un muro e di un ambiente quadrangolare
di metri 4 di lato, forse una torre. Tracce di un’altra torre identica si trova
sul lato opposto. Forse collegato al muro predetto si trovava un ambiente rettangolare,
piuttosto ampio. Questi resti costituiscono il terzo gruppo di rovine che sono
i più interessanti. Si tratta di un grande salone scandito da tre campate
quadrate che erano chiuse da crociere.
Sono
presenti i muri di una cappella per il culto cristiano, costruita in mattoni
pressati, costruita in mattoni pressati, ed attaccata al lato sud della
struttura muraria.
Di gran
valore architettonico è una mensola angolare sulla quale scaricavano il loro
peso le volte. I resti fuori terra visibili consentono una ricostruzione
parziale dell’impianto che secondo G. Agnello sono da attribuire ad epoca
sveva.
http://www.siciliafotografica.it/homesic/index.php/reportage-mainmenu-81/nella-storia-mainmenu-86/162-lantico-grassuliato
La
proprietà è pubblica.
(Nella
stessa contrada Salomone è visibile una struttura a pianta circolare dove
furono rinvenuti frammenti di età castelluciana, Bronzo Antico databile tra il
2200 – 1400 a.C.; frequentazione di età greca con abitato (edificio di culto e
cisterna campaniforme)
http://mazzarino.altervista.org/archivio/opuscolo/opu34.htm







































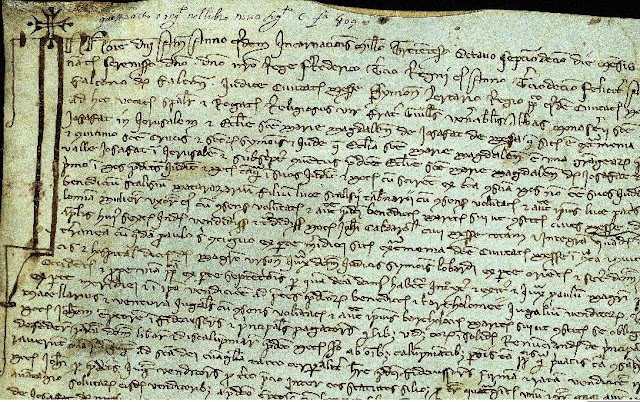

























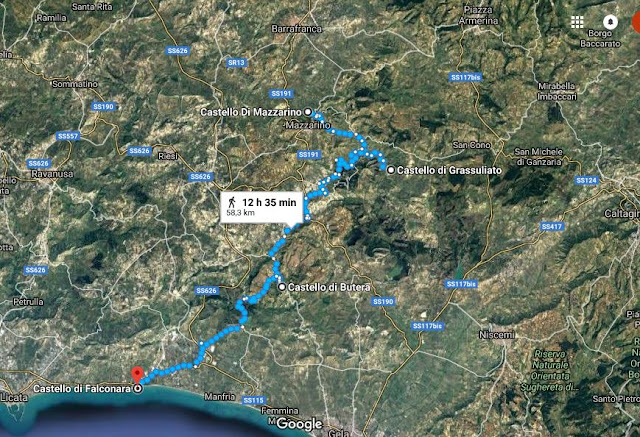



Commenti
Posta un commento