Itinerario a Tema: “Viaggio lungo gli Aeroporti Militari di Sicilia”
 |
| "Pagoda Della Pace" - Comiso (Ragusa) |
Itinerario
a Tema:
“Viaggio lungo gli
Aeroporti Militari di Sicilia” -
Da Monte Castelluccio (Ponte Olivo) a Motta Sant'Anastasia (Ct)
Indice:
-
L’aeroporto di Ponte Olivo – Lo Sbarco Alleato – La Divisione
Livorno – Il Cimitero degli Americani – Il Monumento Commemorativo alla
Divisione Livorno – Enrico Mattei, uno dei Misteri d’Italia
-
Le stragi dell’Aeroporto
di Santo Pietro – il Racconto di Giuseppe Giannola – L’aeroporto di Santo
Pietro – Il Borgo Ventimiglia
-
L’Aeroporto di Comiso –
Canicarao – La falsa Pista – Case Don Pietro – Marchese Trigona – Le spie
Inglesi nascoste nel castello – L’aeroporto dopo la Guerra – LAI – L’aeroporto
base dei Missili Cruise – L’attività pacifista di Pio La Torre – Il Movimento
Pacifista – La Verde Vigna – La Pagoda della Pace di Comiso – Morishita Gensko –
L’aeroporto oggi
-
L’Aeroporto di Gerbini - Ferrovia Catania Palermo – Eugenia Corsaro,
di 12 anni, martire della resistenza catanese, sabotò da sola la base – Le
catanesi, Martiri della Resistenza, dimenticate - Lo zuccherificio di Motta Sant’Anastasia –
Sentenza del Consiglio di Stato – Zuccherifici nel Meridione - Carburante dall’alcole in epoca fascista (la
tesi di un laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania, nel
1940) – Il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania e dell’Alto Simeto –
Geometra Sciuto Sebastiano, n. 62 dell’Albo dei Geometri di Catania
------------------------------------
L’aeroporto
di Ponte Olivo – Lo Sbarco Alleato – La Divisione Livorno – Il Cimitero degli
Americani – Il Monumento Commemorativo alla Divisione Livorno – Enrico Mattei,
uno dei Misteri d’Italia
L’Aeroporto
di “Ponte Olivo” sorgeva sull’omonima contrada lungo la strada statale SS117
bis quasi di fonte al Castelluccio di Gela.
Fu
costruito nel ventennio fascista dalla Regia Aeronautica con l’obiettivo di
essere utilizzato per i collegamenti con le colonie italiane in Africa.
L’11
settembre 1939 diventò la base operativa per il 41° Stormo Bombardamento
Terrestre con la dotazione di 18 Savoia-Marchetti S.M. 79. Il 21 ottobre 1940
il 41° Stormo fu trasferito a Bengasi in Cirenaica e nella base sembra che
fosse presente oltre agli aerei tedeschi della Lutwaffe anche il 51° Stormo
Caccia Terrestre con aerei Macchi M.C. 202.
il sito dell'aeroporto di Ponte Olivo
Macchi C202 51° Stormo - Ponte Olivo
Il 10 luglio
1943 alle ore 2,45 iniziarono gli sbarchi degli alleati a Gela. Lo sbarco
fu anticipato dal lancio di paracadutisti che fallirono la missione loro
affidata perché molti lanci sbagliarono il bersaglio e si dispersero nel
territorio. Un azione che favorì gli alleati perché le truppe italiane e
tedesche non riuscirono ad individuare gli obiettivi precisi.
Lo sbarco era costituito da una impressionante forza
navale. Dalla flotta sbarcano la colonna americana “Dime” composta dalla 1°
divisione fanteria (7 battaglioni e reparti d’appoggio) e da 2 battaglioni
Rangers.
Alle 2,55 il comandante del CDXXIX (429°) battaglione
costiero, il Maggiore Rabellino, segnalò la presenza di parecchie imbarcazioni
nemiche che muovevano in direzione di “Senia Ferrata”.
Le artigliere costiere, fino a quel momento in
silenzio perché la loro gettata era limitata, aprirono il fuoco svelando così
al nemico la loro posizione. La risposta degli Alleati fu immediata con
l’obiettivo di eliminare la batterie costiere.
Alle 3,05 vennero segnalati
i primi sbarchi a “Senia Ferrata” e alle 3,37 lo stesso Maggiore Ribellino
comunicava che “il nemico cercava di
sbarcare anche sulla destra del pontile di Gela”.
https://www.sicilianetwork.info/museo-catania-salvo-pogliese-sbarco-in-sicilia-1943-la-storia-e-ancora-tutta-da-scrivere/
La resistenza italiana a Gela, a differenza di altri
parti dell’isola, fu forte. Solo nel
battaglione costiero ci furono 197 tra morti e feriti cioè il 45% degli
effettivi.
La difesa costiera fu sopraffatta e alcuni plotoni di
rangers entrarono in città dal Belvedere. Alle ore 4,10, sbarcarono sul pontile
e forse anche da Senia Ferrata.
In città si accesero subiti degli scontri. Il primo
scontro fu con dei Carabinieri a cui diedero aiuto alcuni giovani gelesi. I
Carabinieri finirono le munizioni e furono sopraffatti dai rangers mentre i
giovani gelesi si asserragliarono sul campanile della Chiesa Madre da dove
scagliarono delle bombe a mano.
In una piccola via di Piazza Umberto il tenente Lembo,
sempre del battaglione costiero e a capo di un gruppo di soldati, cercò di
ostacolare l’avanzata dei rangers. Il nemico era troppo numeroso e i suoi
uomini alla fine caddero sotto i colpi degli alleati. Il tenete affrontò alla
fine da solo i nemici con una pistola mitragliatrice finchè non cadde ucciso.
C’erano ancora due punti che davano una forte
resistenza: dal campanile della Chiesa Madre e da Porta Marina.
Nell’antica Porta Marina il Caporale Maggiore Cesare
Pellegrini rimase da solo con la sua mitragliatrice riuscendo a fermare il
nemico sulla battigia. Una resistenza di quattro ore .. forte e tenace tanto
che il nemico fu costretto a sospendere le operazioni in quel tratto di
spiaggia. Ma il destino era già segnato.. venne circondato dai rangers e
invitato ad arrendersi fino a quando un graduato di colore riuscì ad entrare nel bunker pugnalandolo
alle spalle (il C.M Pellegrini è medaglia di bronzo al Valore Militare).
Gela – Porta Marina
Alle 6,00 le ultime sacche di resistenza erano state
eliminate e il tenente Colonello Darby, comandante dei rangers, comunicò al
Generale Patton che l’obiettivo era stato raggiunto. Gli americani d’altra
parte cominciarono a riorganizzarsi. Presidiavano la città ma nella periferia
mancavano ancora di pezzi di artiglieria e di carri che si trovavano su una
nave USA che era stata colpita dai tedeschi ed era affondata.
Fu il più grande sbarco anfibio mai tentato fino
allora. Tra Gela e Scoglitti furono impiegate 580 navi da guerra e da sbarco
oltre a 1.124 mezzi anfibi che sbarcarono le due divisioni, la 1° a Gela e la
45° a Scoglitti, per un totale di 40.000 uomini suddivisi in 27 battaglioni.
Gli stessi americani non avevano però previsto che
presto si sarebbero trovati ad affrontare i coraggiosi uomini della “Livorno”,
il famoso e dimenticato gruppo mobile “E” che si trovava a Niscemi.
Intanto la Divisione “Herman Goring” decise di
avanzare dall’area di Caltagirone e raggiunse le Case Priolo verso le 13,30. Ci
furono aspri combattimenti e alla fine furono costretti a ritirarsi.
Il III battaglione del 33° reggimento fanteria della
Divisione “Livorno”, che si trovava nei pressi della stazione di Butera,
ricevette l’ordine alle 4,07 di muovere verso Poggio Lupo. Alle 8,45 furono
raggiunti da elementi nemici e intensamente attaccati. Il Tenente Colonnello
Bruni cercò per tutta la mattinata di contrastare le due compagnie di rangers
che adoperavano tre cannoni catturati agli italiani. Dopo numerose perdite fu
costretto a ripiegare verso le 11,30 su Poggio della Femmina e su Monte del
Falcone.
Alle
05.40 il Generale Mariscalco, Comandante della XVIII
Brigata costiera, ordinava al gruppo mobile «E», dislocato a
Niscemi, di muovere su Gela, per intervenire in aiuto del
Comando del CDXXIX battaglione costiero ormai circondato.
Particolarmente
significativa fu la testimonianza di Bruno Causin, allora
Caporale artigliere della 9 batteria del 54° reggimento
artiglieria «Napoli», facente parte del gruppo mobile «E- Livorno”: «Arrivammo all’altezza
dell’aeroporto di Ponte Olivo che era giorno (provenivano da
Niscemi). Gli americani erano
già sbarcati e avevano occupato il paese. Il
Comandante della batteria era andato come al solito avanti per
vedere il posto dove schierarci coi cannoni. Aveva destinato il
punto dove andare, ma al di qua del paese di Gela,
gli americani avevano già sistemato una batteria da 105 mm.
Tornò quindi indietro, ci diede i dati di tiro mentre eravamo
ancora lungo la strada e io li segnai sul goniometro, che
essendo piccolo tenevo sempre in tasca. Come siamo andati in
posizione abbiamo sparato una salva di batteria, colpendo la batteria
americana col primo colpo. Ricordo che l’aiutante mi raccontò che
aveva visto l’inferno scatenarsi sulla batteria nemica, soldati morti, cannoni
rovesciati. Dopo continuammo a sparare per coprire l’avanzata
della Fanteria. Ma non appena intervenne la marina … mamma mia….
Ci arrivò addosso un inferno di fuoco e acciaio. I colpi ci passavano sopra, però qualcuno
arrivò anche a 40-50 metri dalla nostra posizione, ricoprendoci letteralmente
di terra, ma noi continuammo a sparare fino alle 10.30-11.00, e ricordo che il sole ci bruciava».
Ci arrivò addosso un inferno di fuoco e acciaio. I colpi ci passavano sopra, però qualcuno
arrivò anche a 40-50 metri dalla nostra posizione, ricoprendoci letteralmente
di terra, ma noi continuammo a sparare fino alle 10.30-11.00, e ricordo che il sole ci bruciava».
Alle
ore 07.30 la 155° compagnia bersaglieri prendeva contatto con il
nemico all’altezza del
passaggio a livello sulla rotabile Niscemi-Gela (SS 117), e qui venne bloccata dall’intenso fuoco dell’artiglieria navale nemica.
Contemporaneamente la 2a compagnia del CII battaglione controcarri si schierava a dare
supporto diretto alla compagnia bersaglieri, ma avanzando si ritrovò a meno di trecento metri da posizioni nemiche situate tra le abitazioni, che fino a quel momento non si erano ancora svelate.
Fu quindi fatta segno a fuoco da parte dei mortai e delle artiglierie leggere nemiche che distrussero diversi pezzi e causarono parecchie perdite, tra cui il Sottotenente Bazzoli Righini, che cadde colpito a morte mentre, incurante del violento bombardamento, continuava imperterrito le operazioni di preparazione del tiro.
Il Tenente Colonnello Conti diede allora l’ordine alla compagnia carri di attaccare, in modo
da sfondare la linea avversaria. I tre plotoni carri comandati dal Capitano Granieri attaccarono a ondate successive. Il Tenente Colonnello Darby vedendo avanzare i carri chiese l’intervento dell’artiglieria navale, ma questa non fece in tempo ad aggiustare il tiro che i carri erano già penetrati all’interno della città. Superati gli sbarramenti anticarro e penetrati per le vie di Gela, i plotoni eliminarono i centri di fuoco che si manifestavano lungo la strada, cercando di neutralizzare quelli che si erano annidati all’interno delle case.
passaggio a livello sulla rotabile Niscemi-Gela (SS 117), e qui venne bloccata dall’intenso fuoco dell’artiglieria navale nemica.
Contemporaneamente la 2a compagnia del CII battaglione controcarri si schierava a dare
supporto diretto alla compagnia bersaglieri, ma avanzando si ritrovò a meno di trecento metri da posizioni nemiche situate tra le abitazioni, che fino a quel momento non si erano ancora svelate.
Fu quindi fatta segno a fuoco da parte dei mortai e delle artiglierie leggere nemiche che distrussero diversi pezzi e causarono parecchie perdite, tra cui il Sottotenente Bazzoli Righini, che cadde colpito a morte mentre, incurante del violento bombardamento, continuava imperterrito le operazioni di preparazione del tiro.
Il Tenente Colonnello Conti diede allora l’ordine alla compagnia carri di attaccare, in modo
da sfondare la linea avversaria. I tre plotoni carri comandati dal Capitano Granieri attaccarono a ondate successive. Il Tenente Colonnello Darby vedendo avanzare i carri chiese l’intervento dell’artiglieria navale, ma questa non fece in tempo ad aggiustare il tiro che i carri erano già penetrati all’interno della città. Superati gli sbarramenti anticarro e penetrati per le vie di Gela, i plotoni eliminarono i centri di fuoco che si manifestavano lungo la strada, cercando di neutralizzare quelli che si erano annidati all’interno delle case.
Ecco
come Hugh Pond citò la scena nel suo libro: «I carri sparavano senza fermarsi, facendo roteare
le torrette e rovesciando proiettili su tutti i bersagli
possibili, con un’audacia che destò l’ammirazione persino degli
spericolati rangers».
La
battaglia durò a lungo; il nemico, nonostante avesse una superiorità
numerica in uomini e mezzi, venne a trovarsi in seria difficoltà.
Due carri penetrarono fin dentro l’abitato.
Alle 08.30 uno dei carri, quello del Tenente Navari che, incurante del fuoco di cui era fatto oggetto, riuscì a penetrare fino a piazza Umberto I, dove aveva sede il Comando americano. Le strade, prima gremite di soldati americani, si fecero deserte e il nemico credette che la presenza di quel carro annunciasse l’imminente arrivo delle forze italiane che stavano contrattaccando.
Il Tenente Colonnello Darby, Comandante dei rangers, si trovò di fronte questo carro che avanzava verso di lui sparando all’impazzata, incurante della reazione nemica. Afferrato un bazooka, gli sparò contro un razzo, ma mancò il bersaglio. Ricaricò il bazooka e questa volta colpì in pieno il carro, immobilizzandolo. Il Tenente Navari uscì dalla torretta del carro con la pistola in pugno, ma venne centrato da un colpo di fucile alla fronte (sarà ricompensato con la medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria).
L’altro carro, con a bordo il Carrista Antonio Ricci e il Sergente Cannella, avanzò all’interno del centro abitato. A un certo punto, vicino a Porta Caltagirone, visto che l’abitacolo era pieno di fumo per gli spari del cannoncino e della mitragliatrice, si fermò per orientarsi prima di procedere con la marcia. Il Sergente Cannella era sotto shock, scese allora il Carrista Ricci ma non appena saltò fuori dal carro venne ucciso dalle schegge di alcune granate lanciate contro di loro. Il Sergente Cannella ripartì rabbiosamente verso il centro cittadino, ma, superata Porta Caltagirone, investito da un diluvio di fuoco, fu costretto a ritirarsi e tornò indietro verso la piana di Gela. Poco prima di uscire dall’abitato venne centrato da un cannone anticarro.
Alle 08.30 uno dei carri, quello del Tenente Navari che, incurante del fuoco di cui era fatto oggetto, riuscì a penetrare fino a piazza Umberto I, dove aveva sede il Comando americano. Le strade, prima gremite di soldati americani, si fecero deserte e il nemico credette che la presenza di quel carro annunciasse l’imminente arrivo delle forze italiane che stavano contrattaccando.
Il Tenente Colonnello Darby, Comandante dei rangers, si trovò di fronte questo carro che avanzava verso di lui sparando all’impazzata, incurante della reazione nemica. Afferrato un bazooka, gli sparò contro un razzo, ma mancò il bersaglio. Ricaricò il bazooka e questa volta colpì in pieno il carro, immobilizzandolo. Il Tenente Navari uscì dalla torretta del carro con la pistola in pugno, ma venne centrato da un colpo di fucile alla fronte (sarà ricompensato con la medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria).
L’altro carro, con a bordo il Carrista Antonio Ricci e il Sergente Cannella, avanzò all’interno del centro abitato. A un certo punto, vicino a Porta Caltagirone, visto che l’abitacolo era pieno di fumo per gli spari del cannoncino e della mitragliatrice, si fermò per orientarsi prima di procedere con la marcia. Il Sergente Cannella era sotto shock, scese allora il Carrista Ricci ma non appena saltò fuori dal carro venne ucciso dalle schegge di alcune granate lanciate contro di loro. Il Sergente Cannella ripartì rabbiosamente verso il centro cittadino, ma, superata Porta Caltagirone, investito da un diluvio di fuoco, fu costretto a ritirarsi e tornò indietro verso la piana di Gela. Poco prima di uscire dall’abitato venne centrato da un cannone anticarro.
Commovente è la scena descritta da Augello nel suo libro:
«Le lamiere rimangono squassate, il carro fuma come una pentola a vapore.
Da quella ferraglia contorta emerge stordito, ma vivo, il Sergente Cannella. Barcolla in
mezzo alla strada, mentre qualche gelese alla finestra gli batte le mani commosso e una giovane donna esce di casa soccorrendolo, abbracciandolo. Davanti a questa scena anche i militari americani, che lo hanno colpito, dopo qualche esitazione gli vanno incontro e gli stringono la mano, prima di farlo prigioniero» .
Alle 11.00, constatata l’impossibilità materiale di mantenere le posizioni raggiunte, dopo aver subito pesanti perdite e trovandosi ancora sotto l’incessante martellamento dell’artiglieria navale (tra le 08.00 e le 12.55 le navi da guerra americane spararono 572 colpi di grosso calibro solo sul gruppo mobile), il Tenente Colonnello Conti dovette dare l’ordine di arretrare fino a Monte Castelluccio, nei pressi dell’aeroporto di Ponte Olivo sulle posizioni della difesa fissa. Il gruppo mobile «E» parteciperà comunque, come vedremo in seguito, anche alla controffensiva del giorno successivo.
https://mapcarta.com/it/17393122
- 11 LUGLIO 1943: IL
CONTRATTACCO DELL’ASSE – MONTE CASTELLUCCIO
Il Generale Guzzoni in base alle operazioni militari
del 10 luglio studiò la strategia da
adottare e giunse alla conclusione, considerando che le forze a sue
disposizione erano limitate rispetto al nemico, che era necessario attaccare le
tre teste di sbarco che erano ritenute le più pericolose ai fini della tenuta
del fronte.
La tre teste di sbarco erano: Licata, Gela e la
direttrice Augusta-Siracusa.
Si decise di sferrare l’attacco al nemico l’indomani,
11 luglio alle ore 6,00… un attacco definito “a testa bassa” in concomitanza
con un attacco aereo sempre per la stessa ora.
Quali Divisioni avrebbe partecipato alla missione ?
La Divisione “Livorno”, che avrebbe ricevuto in aiuto
i resti del gruppo mobile “E”, che gloriosamente si era comportato il giorno
precedente, e la Divisione “Hermann Goring”.
La Divisione Livorno avrebbe agito ad ovest della
strada Statale SS 117, mentre la Divisione Goring ad est. (La Strada in planimetria è segnata con
puntini rossi).
Obiettivo dell’operazione era quello di chiudere a
tenaglia, agendo su due lati, le teste di sbarco degli alleati sulle spiagge.
Le Divisioni dovevano assumere lo schieramento predisposto durante la notte in
modo che all’alba dell’11 si sarebbero trovate già in postazione.
I Comandanti delle Divisioni pianificarono nel
dettaglio lo schieramento da assumere e le logiche direttrici d’attacco.
Il Comandante della Divisione «Livorno», Generale Chirieleison, decise di assumere un dispositivo d’attacco su tre colonne:
Il Comandante della Divisione «Livorno», Generale Chirieleison, decise di assumere un dispositivo d’attacco su tre colonne:
-
la colonna di sinistra, costituita dai resti del
gruppo mobile «E», un battaglione
di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere lungo la piana di Gela, a ovest
della SS 117;
di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere lungo la piana di Gela, a ovest
della SS 117;
-
la colonna centrale, composta da due battaglioni di
fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva muovere a cavaliere della strada
Butera-Gela;
-
la colonna di destra, composta da un battaglione
di fanteria e un gruppo di artiglieria, doveva proteggere il fianco destro
della Divisione da eventuali minacce provenienti da Licata.
Anche il Generale Conrath, Comandante della
Divisione «Hermann Göring», decise di assumere un dispositivo su tre
colonne d’attacco, così suddivise:
-
la colonna di sinistra, composta dal reggimento
Panzergrenadier e dalla compagnia carri «Tigre», doveva muovere lungo la
valle del fiume Dirillo, Senia Ferrata Gela;
-
la colonna centrale, composta da un battaglione carri
e un gruppo di artiglieria, doveva muovere da Case Priolo
verso Case Spinasanta-Gela;
-
la colonna di destra, composta da
un battaglione carri ed un battaglione genio, doveva
muovere lungo la piana di Gela a est della SS 117.
AZIONE DELLA COLONNA D’ATTACCO DI SINISTRA
DELLA
DIVISIONE «LIVORNO»
DIVISIONE «LIVORNO»
La colonna d’attacco di sinistra era composta dai
resti del gruppo mobile «E», che si trovava già schierato tra il
Castelluccio e le posizioni della difesa fissa dell’aeroporto di
Ponte Olivo, da una Compagnia mortai e dal III battaglione del
34° reggimento di fanteria comandato dal Tenente Colonnello Leonardi.
La linea avanzata della testa di sbarco si snodava lungo una serie di colline distanti circa 800 metri da Monte Castelluccio, e il terreno per raggiungerle si presentava completamente scoperto e privo di appigli tattici.
Alle 05.15 arrivò l’ordine d’operazione, che descriveva l’azione delle due Divisioni; l’orario previsto per l’attacco, che doveva essere simultaneo e strettamente coordinato, era stato fissato per le 06.00, preceduto da dieci minuti di preparazione di artiglieria e da un contemporaneo attacco aereo. Però alle 05.50 il Colonnello Martini, Comandante della colonna, non era ancora arrivato sul posto, e il Maggiore Artigiani, Comandante del I gruppo del 28° reggimento artiglieria, era arrivato
a Monte Castelluccio solamente alle 05.30 e non riusciva ad avere il collegamento radio con le batterie. Il Tenente Colonnello Leonardi attese fino alle 06.30, ora in cui nove bombardieri italiani «Cant Z. 1007 bis» attaccarono la flotta americana alla fonda di fronte a Gela.
La linea avanzata della testa di sbarco si snodava lungo una serie di colline distanti circa 800 metri da Monte Castelluccio, e il terreno per raggiungerle si presentava completamente scoperto e privo di appigli tattici.
Alle 05.15 arrivò l’ordine d’operazione, che descriveva l’azione delle due Divisioni; l’orario previsto per l’attacco, che doveva essere simultaneo e strettamente coordinato, era stato fissato per le 06.00, preceduto da dieci minuti di preparazione di artiglieria e da un contemporaneo attacco aereo. Però alle 05.50 il Colonnello Martini, Comandante della colonna, non era ancora arrivato sul posto, e il Maggiore Artigiani, Comandante del I gruppo del 28° reggimento artiglieria, era arrivato
a Monte Castelluccio solamente alle 05.30 e non riusciva ad avere il collegamento radio con le batterie. Il Tenente Colonnello Leonardi attese fino alle 06.30, ora in cui nove bombardieri italiani «Cant Z. 1007 bis» attaccarono la flotta americana alla fonda di fronte a Gela.
Vedendo ciò, non avendo
collegamenti radio e temendo che un ulteriore ritardo avrebbe pregiudicato l’esito delle
contemporanee azioni delle due colonne che dovevano operare ai suoi
lati e che costituivano l’asse principale del contrattacco, prese l’iniziativa
di dare inizio all’attacco senza attendere oltre l’arrivo del
Comandante del reggimento e la preparazione dell’artiglieria,
cercando di sfruttare al meglio le armi di accompagnamento a disposizione.
I
reparti iniziarono il movimento, e subito furono investiti dal fuoco
di armi automatiche e di artiglieria campale. Nonostante tutto, la prima linea
della testa di sbarco, situata tra Poggio Frumento e Poggio Mulinazzo, fu
conquistata intorno alle 08.00.
Furono catturati circa un centinaio di prigionieri che furono avviati verso Monte Castelluccio, e da qui verso Niscemi.
Intanto il Maggiore Artigiani riuscì a mettersi in contatto col suo gruppo, che era entrato immediatamente in azione. Emblematica sulla situazione del momento e sullo stato d’animo di quanti si trovarono a combattere l’11 luglio nella piana di Gela, fu la testimonianza del Signor Cristani Raffaele, all’epoca Sottotenente del 28° reggimento di artiglieria: «Quando siamo arrivati quassù (Monte Castelluccio n.d.r.), la visione del mare gremito di navi è stata sconvolgente. Sconvolgente per la sensazione precisa di una guerra perduta che abbiamo avuto tutti. Il ricordo più ricorrente di quel giorno è la necessità, allora io giovane Ufficiale, di convincere i miei uomini, anche ultra quarantenni, a muoversi perché erano quasi paralizzati dall’impressione.
Furono catturati circa un centinaio di prigionieri che furono avviati verso Monte Castelluccio, e da qui verso Niscemi.
Intanto il Maggiore Artigiani riuscì a mettersi in contatto col suo gruppo, che era entrato immediatamente in azione. Emblematica sulla situazione del momento e sullo stato d’animo di quanti si trovarono a combattere l’11 luglio nella piana di Gela, fu la testimonianza del Signor Cristani Raffaele, all’epoca Sottotenente del 28° reggimento di artiglieria: «Quando siamo arrivati quassù (Monte Castelluccio n.d.r.), la visione del mare gremito di navi è stata sconvolgente. Sconvolgente per la sensazione precisa di una guerra perduta che abbiamo avuto tutti. Il ricordo più ricorrente di quel giorno è la necessità, allora io giovane Ufficiale, di convincere i miei uomini, anche ultra quarantenni, a muoversi perché erano quasi paralizzati dall’impressione.
Io stesso ero abbastanza
impressionato ed emozionato da tutto questo, ma dovevamo badare
a quello che stavamo facendo, quindi c’è voluto qualche
grido e anche qualche minaccia per riuscire a smuoverli, ma in pochi minuti
sono usciti da quella specie di sbigottimento e torpore che li aveva
presi».
Subito dopo aver espugnato questa prima linea nemica, la colonna iniziò l’attacco alla seconda linea, svelatasi inaspettatamente a circa 500 metri dalla prima.
Fu in questo preciso momento, erano le 08.30, che l’artiglieria navale, e più precisamente i cannoni dell’incrociatore Savannah (armato con 15 cannoni da 152 mm e otto da 127 mm), aprì il fuoco contro la colonna di sinistra della «Livorno».
Significativa è la testimonianza del Tenente Messina, effettivo al III battaglione del 34°reggimento, raccolta da John Follain nella sua opera:
«Avanzava da circa un’ora e aveva ormai attraversato metà della piana, quando udì sopra la sua testa il sibilo di un proiettile enorme, che gli scoppiò alle spalle.[…] Si rotolò al suolo nel tentativo di sfuggire alla valanga di fuoco. Sotto la violenza dei proiettili la terra intorno a lui sembrava ribollire come l’acqua in una pentola. […] Carne contro acciaio, uomini contro navi, pensò mentre il suo corpo cominciava a tremare senza controllo».
Il fuoco dell’artiglieria navale aprì larghi vuoti tra le fila del III battaglione del 34°, che per raggiungere la seconda linea nemica, sotto la tempesta di ferro e di fuoco scatenatasi, impiegò ben tre ore.
Subito dopo aver espugnato questa prima linea nemica, la colonna iniziò l’attacco alla seconda linea, svelatasi inaspettatamente a circa 500 metri dalla prima.
Fu in questo preciso momento, erano le 08.30, che l’artiglieria navale, e più precisamente i cannoni dell’incrociatore Savannah (armato con 15 cannoni da 152 mm e otto da 127 mm), aprì il fuoco contro la colonna di sinistra della «Livorno».
Significativa è la testimonianza del Tenente Messina, effettivo al III battaglione del 34°reggimento, raccolta da John Follain nella sua opera:
«Avanzava da circa un’ora e aveva ormai attraversato metà della piana, quando udì sopra la sua testa il sibilo di un proiettile enorme, che gli scoppiò alle spalle.[…] Si rotolò al suolo nel tentativo di sfuggire alla valanga di fuoco. Sotto la violenza dei proiettili la terra intorno a lui sembrava ribollire come l’acqua in una pentola. […] Carne contro acciaio, uomini contro navi, pensò mentre il suo corpo cominciava a tremare senza controllo».
Il fuoco dell’artiglieria navale aprì larghi vuoti tra le fila del III battaglione del 34°, che per raggiungere la seconda linea nemica, sotto la tempesta di ferro e di fuoco scatenatasi, impiegò ben tre ore.
Alle 11.00 circa anche la seconda linea
fu sfondata, ma i reparti erano duramente provati. A questo
punto gli americani ripiegarono dentro Gela, e il III
battaglione del 34°, appena si fu riordinato, si spinse ancora
in avanti, fino al posto di blocco di Gela, allo scopo di incalzare
l’avversario e diminuire la distanza, in modo da conquistare una buona
base di partenza per il reparto che li avrebbe dovuti
eventualmente scavalcare per proseguire l’azione in profondità e riconquistare l’abitato.
A questo punto il
Colonnello Martini, viste le precarie condizioni in cui versava
il battaglione, ordinò al Tenente Colonnello Leonardi di fermarsi e
disporsi a difesa, in modo da respingere un eventuale contrattacco
nemico, in attesa di essere scavalcati da altre unità già
richieste al Comando di Divisione.
Intanto il nemico continuava a martellare le posizioni tenute dal battaglione. Alle 13.00, si
seppe che la colonna di destra era stata distrutta da truppe corazzate provenienti da Licata, e che i tedeschi stavano ripiegando su Caltagirone; il battaglione rimaneva quindi isolato nella piana di Gela.
Alle 24.00 il Colonnello Martini impartì l’ordine di ripiegare su Monte Castelluccio col compito di costituire un caposaldo per una resistenza ad oltranza, per coprire il movimento di ripiegamento degli altri reparti della Divisione su nuove posizioni. Una compagnia fu, quindi, lasciata sul posto per coprire il ripiegamento del battaglione. Questa resistette per circa un’ora al secondo contrattacco notturno, dopodiché venne sopraffatta e solamente una parte di essa riuscì a ripiegare sul Monte Castelluccio.
Intanto il nemico continuava a martellare le posizioni tenute dal battaglione. Alle 13.00, si
seppe che la colonna di destra era stata distrutta da truppe corazzate provenienti da Licata, e che i tedeschi stavano ripiegando su Caltagirone; il battaglione rimaneva quindi isolato nella piana di Gela.
Alle 24.00 il Colonnello Martini impartì l’ordine di ripiegare su Monte Castelluccio col compito di costituire un caposaldo per una resistenza ad oltranza, per coprire il movimento di ripiegamento degli altri reparti della Divisione su nuove posizioni. Una compagnia fu, quindi, lasciata sul posto per coprire il ripiegamento del battaglione. Questa resistette per circa un’ora al secondo contrattacco notturno, dopodiché venne sopraffatta e solamente una parte di essa riuscì a ripiegare sul Monte Castelluccio.
I resti del battaglione, decimato dalle numerose
perdite tra morti e feriti, con i resti compagnia bersaglieri si
organizzarono alla meglio per la difesa sul Monte
Castelluccio.
Gli americani mandarono allora avanti una colonna
corazzata della 155a per annientare le unità italiane in ritirata. La
testimonianza dell’artigliere Causin:
«Gli americani avevano mandato avanti
sette carri armati lungo la Strada Statale 117. Io ero il quarto
pezzo e mi trovavo vicino alla strada. Il Comandante chiamò tutti
quanti i puntatori e ci disse: “Tu Causin
prendi il primo (il primo pezzo), e tu prendi l’ultimo, quell’altro lì il
penultimo e l’altro il secondo”, sicchè erano quattro quelli che noi
dovevamo colpire, però ce ne sarebbero stati altri tre che non
sarebbero stati colpiti. Lui ci disse “Quando io sparerò il
colpo di pistola in aria voi sparate”. Li fece venire avanti fino
a una distanza di 80 metri, io sul cannocchiale li vedevo come
da qui a lei, e ricordo che il primo colpo che sparai lo presi sotto, tra la
terra ed il cingolo ed il carro armato si fermò.
Poi il secondo colpo lo prese in pieno e il carro s’incendiò.
Subito sparai a un altro; alla fine solamente due riuscirono a scappare.
Ma poi dopo la marina hanno tirato tante di quelle bombe. La terra sembrava ribollire; per fortuna che avevamo una posizione meravigliosa, cioè c’era un fosso fatto dal personale del
campo di aviazione, e noi avevamo quindi come protezione una specie di argine e la bocca
da fuoco era rasente. Però una granata della marina ci prese proprio sul paraschegge, e ricordo che il cannone saltò per aria, ed io che ero seduto sul sediolino, senza neanche accorgermene mi ritrovai per terra, tutti quanti pieni di terra, e il cannone tornò giù di nuovo con un tonfo sordo, ed il Tenente gridava “Fuoco, fuoco”, e iniziammo a sparare a vista; c’erano tantissimi americani che venivano
avanti di qua e di là, erano dappertutto e quando succedeva così, come avevamo imparato durante le istruzioni si sparava un colpo qua un colpo là, in maniera da tenere il nemico sempre in allerta, che non venisse avanti, e allora si sparava un colpo più vicino, un colpo più lontano. Riuscimmo comunque a respingerli».
Alle 02.30 la colonna Leonardi dovette far fronte al terzo contrattacco nemico opponendo
un’accanita resistenza, riuscendo a resistere fino alle 7 circa ( 12 luglio), quando i pochi superstiti vennero sopraffatti e catturati.
Dopo essere stati catturati, i prigionieri vennero condotti alla volta di Gela. Per comprendere meglio le emozioni dei soldati italiani e della popolazione di Gela, è bene riportare la testimonianza del Tenente Colonnello Leonardi, dal suo «Diario di un battaglione», ripresa anche da Nunzio Vicino nel suo libro «La battaglia di Gela»: «Il piccolo drappello di prigionieri procedeva lentamente verso Gela […]. Era sfinito, lacero, insanguinato […]. Il drappello giunse a Gela […]. Ma ora vi entravamo da vinti e non da vincitori! Passammo per le vie della città. Molta gente era commossa e piangeva anche. Non pochi ci offrirono pane, acqua, sigarette, e avrebbero dato chissà cos’altro se i soldati di scorta lo avessero permesso! Un piccolo vecchietto, che si reggeva appena sul bastone, si avvicinò e ci strinse la mano. Forse aveva visto … forse sapeva! Ma gli americani lo allontanarono immediatamente. In mezzo a tanto popolo buono non mancarono però gli apatici, gli indifferenti. Non mancarono anche coloro che ci derisero e persino insultarono perché avevamo osato combattere….Pochi, ma non mancarono […]. Fieri e superbi per il dovere compiuto, alzammo la testa stanca e ci avviammo silenziosamente verso la nostra dura prigionia».
Poi il secondo colpo lo prese in pieno e il carro s’incendiò.
Subito sparai a un altro; alla fine solamente due riuscirono a scappare.
Ma poi dopo la marina hanno tirato tante di quelle bombe. La terra sembrava ribollire; per fortuna che avevamo una posizione meravigliosa, cioè c’era un fosso fatto dal personale del
campo di aviazione, e noi avevamo quindi come protezione una specie di argine e la bocca
da fuoco era rasente. Però una granata della marina ci prese proprio sul paraschegge, e ricordo che il cannone saltò per aria, ed io che ero seduto sul sediolino, senza neanche accorgermene mi ritrovai per terra, tutti quanti pieni di terra, e il cannone tornò giù di nuovo con un tonfo sordo, ed il Tenente gridava “Fuoco, fuoco”, e iniziammo a sparare a vista; c’erano tantissimi americani che venivano
avanti di qua e di là, erano dappertutto e quando succedeva così, come avevamo imparato durante le istruzioni si sparava un colpo qua un colpo là, in maniera da tenere il nemico sempre in allerta, che non venisse avanti, e allora si sparava un colpo più vicino, un colpo più lontano. Riuscimmo comunque a respingerli».
Alle 02.30 la colonna Leonardi dovette far fronte al terzo contrattacco nemico opponendo
un’accanita resistenza, riuscendo a resistere fino alle 7 circa ( 12 luglio), quando i pochi superstiti vennero sopraffatti e catturati.
Dopo essere stati catturati, i prigionieri vennero condotti alla volta di Gela. Per comprendere meglio le emozioni dei soldati italiani e della popolazione di Gela, è bene riportare la testimonianza del Tenente Colonnello Leonardi, dal suo «Diario di un battaglione», ripresa anche da Nunzio Vicino nel suo libro «La battaglia di Gela»: «Il piccolo drappello di prigionieri procedeva lentamente verso Gela […]. Era sfinito, lacero, insanguinato […]. Il drappello giunse a Gela […]. Ma ora vi entravamo da vinti e non da vincitori! Passammo per le vie della città. Molta gente era commossa e piangeva anche. Non pochi ci offrirono pane, acqua, sigarette, e avrebbero dato chissà cos’altro se i soldati di scorta lo avessero permesso! Un piccolo vecchietto, che si reggeva appena sul bastone, si avvicinò e ci strinse la mano. Forse aveva visto … forse sapeva! Ma gli americani lo allontanarono immediatamente. In mezzo a tanto popolo buono non mancarono però gli apatici, gli indifferenti. Non mancarono anche coloro che ci derisero e persino insultarono perché avevamo osato combattere….Pochi, ma non mancarono […]. Fieri e superbi per il dovere compiuto, alzammo la testa stanca e ci avviammo silenziosamente verso la nostra dura prigionia».
La zona del Castelluccio è stata per anni, e forse lo
è ancora, una pagina di storia dimenticata.. la gloriosa storia della Divisione
Motorizzata Livorno che, dopo ripetuti assalti alla Forza Alleata, rimase
circondata sui ruderi di Monte Castelluccio. Continuò a difendersi, con forza e
coraggio per circa 24 ore, fino a quando non fu sopraffatta dagli Alleati.
La Divisione
“Hermann Goring” iniziò le operazioni alle 6,00 e la colonna di
sinistra raggiunse la foce del Dirillo e successivamente “Senia Ferrata”. Un
cammino lungo la linea della ferrovia “Vittoria – Gela”. La colonna era composta dal reggimento
“Panzergrenadier” e dalla compagnia di carri “Tigre”.
Momenti
concitati che si evidenziano dal racconto del Caporale Werner Hahn, cannoniere
su un carro armato “Tigre”: «Alle 11.00
del mattino, a quasi 13 chilometri da Gela, udì il Comandante
del suo Panzer
gridare: “carro armato nemico a sinistra.[...]”. Hahn ruotò la torretta
a sinistra, più in
fretta che potè. Valutò approssimativamente in 600 metri la distanza dal carro
armato[...]. Il
proiettile colpì lo Sherman, che si incendiò. [...] Hahn fece fuoco di nuovo,
questa
volta contro uno
Sherman che si trovava a 1 500 metri. [...] Di tanto in tanto le nuvole di
fiamme e polvere provocate dall’artiglieria nemica, dai mortai e dalle armi
anticarro gli oscuravano la visuale[...]. Era uno sbarramento peggiore di
quelli che si era trovato ad affrontare in Russia. [...] Con il protrarsi della
battaglia la temperatura dentro il carro salì vertiginosamente. All’esterno
c’erano circa 35 gradi all’ombra, ma all’interno del carro Hahn valutò che
dovevano essere tra i 50° e i 60°»
La
colonna di destra partì da Ponte Olivo alle 7,45; la colonna centrale alle 8,00
e dopo aver superato la resistenza dei nemici a Case Priolo, si diresse su Case
Spinasanta per poi congiungersi con la Colonna di Destra a Piana del Signore.
Arrivarono a circa 100 m dalla spiaggia nessuna trovare una valida resistenza.
Gli
alleati non riuscirono ad impedire l’avanzata della Goring perché non avevano
disposizione mezzi a sufficienza carri armati che si trovavano sulla nave
affondata dai tedeschi. C’era una pure una difficoltà tecnica legata al fatto
che i carri armati non potevano essere trasportati sulla spiaggia dai piccoli
mezzi da sbarco e si dovevano quindi creare dei pontili galleggianti che
richiedevano tempo per la loro messa in opera.
Ancora
una volta, come era successo per la Divisione Livorno, l’incrociatore Savannah
cominciò a fare fuoco sulla colonna di destra mentre il cacciatorpediniere
Glennon apriva il fuoco sulla colonna centrale. L’avanzata della Divisione
Goering non si fermò e alle 11,00 erano alla periferia della città. Momenti di
grande tensione fra gli alleati…”la testa
di sbarco è perduta”.
In
quel momento il Comando della IV Armata intercettò un messaggio in chiaro e
attribuito al Generale Patton in cui si diceva di “sotterrare i materiali sulle spiagge e prepararsi al reimbarco”.
Gli
americani smentirono sempre questa comunicazione, non risulta tra i loro
archivi storici, e secondo gli storici l’episodio sarebbe da attribuire a
qualche ufficiale che, vista la situazione drammatica, aveva preso l’iniziativa
di trasmettere il messaggio.
Ma
improvvisamente fecero la loro comparsa gli aerei tattici americani che
attaccarono le retrovie italo-tedesche mentre una colonna corazzata con 250 paracadutisti
dell’82° Divisione, provenienti da Scoglitti, attaccarono sul fianco la colonna
di sinistra. Alle 14 le colonne di destra e centrale della Goerin erano
decimate e sotto l’incalzare dei mezzi corazzati, che gli americani erano
riusciti a far sbarcare sulla spiaggia di Gela, dovettero ripiegare. La colonna
di sinistra continuò a combattere lungo la ferrovia “Vittoria – Gela” fino alle
21,30 quando il Generale Rossi diede ordine di ripiegare.
Alla
fine della giornata questo fu il drammatico quadro finale:
Divisione
“Livorno”:
subì
ingenti perdite: tra morti, feriti, prigionieri e dispersi aveva perso 214
Ufficiali e 7.000 tra Sottufficiali e
Truppa su un totale di 11.400 uomini:
Divisione
“Harmann Goerin”
Perse
30 Ufficiali e 600 tra Sottufficiali e Truppa su un totale di 8739 uomini.
Prigionieri
Italiani
A
Gela i reperti italiani combatterono strenuamente davanti ad un nemico
decisamente meglio equipaggiato.
Molti
storici hanno definito la pagina dello sbarco degli Alleati in Sicilia come una
pagina di storia ancora tutta da scrivere e qualcuno, animato da uno spirito di
verità, si è addentrato in ricerche presso l’archivio storico militare di Roma.
Sembra che sia venuto alla luce del sole un caso di resa di un reparto italiano.
Una resa avvenuta nella prima giornata dello sbarco alleato a Gela cioè il 10
luglio 1943. Gli americani nella loro
azione di guerra avanzarono facendosi scudo dei prigionieri italiani. I militi
italiani non spararono per non colpire i compagni.
Nella
“Relazione cronologia degli avvenimenti” è riportato che: “ ore 9,20: il Col. Giuseppe Altini comunica
che la 49° btr. si è arresa perché il nemico veniva avanti facendosi coprire
dai nostri soldati presi prigionieri…”
Come
riporta il ricercatore Nuccio Mulè (in un articolo nel “Corriere di Gela, on
line” del 17 giugno 2018), si tratta di una pagina ingiallita dal tempo e
firmata dal Col. Orazio Maniscalco… una pagina che si trova in un voluminoso
fascicolo.
Nella
ricerca è venuto fuori un altro episodio avvenuto il giorno 12 luglio 1943 e
riguarda la famosa e valorosa “Divisione Livorno” che per circa 24 ore aveva
resistito, su Monte Castelluccio, agli assalti americani. Alla fine stremati e
senza munizioni, furono catturati.
Si
tratta di un racconto del Ten. Col. Ugo Leonardi che, insieme a diversi
ufficiali medici con il bracciale della Croce Rossa Internazionale, fu schiaffeggiato ed
umiliato.
C’è
poi da svelare i rapporti tra Mafia ed
Americani sia prima che dopo lo sbarco degli Alleati. Ma su questo si potrebbe
scrivere un vero e proprio trattato.
http://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/819-gela,-luglio-1943-prigionieri-italiani-usati-come-scudi-umani-dagli-american.html
Aeroporto Ponte Olivo
Accanto
all’aeroporto si trovava il cimitero di guerra di Ponte Olivo che fu costruito
nel 1943 a seguito della battaglia di Gela.
L’aeroporto in una
foto aerea
https://milocca.wordpress.com/2011/07/11/quegli-eroi-del-43-sepolti-a-gela/
Nella
battaglia gli americani persero circa 10.000 uomini. Fu quindi necessario
costruire un Cimitero di guerra nel quale furono sepolti 3.090 soldati
americani, 500 soldati tedeschi e 3.350 italiani. Vi furono inumate anche due
tenenti donne e due crocerossine.
Nel
1947 i militari americani seppelliti nel cimitero di guerra furono esumati e
trasportati negli Stati Uniti. Il resto delle salme fu traslato nel cimitero
americano di Nettuno.
Castelluccio –
Gela – Il Monumento ai Caduti della Divisione Livorno
L’aeroporto
continuò ad usato dai dirigenti dell’ENI (Ente Nazionali Idrocarburi) come
aeroporto privato per i frequenti viaggi negli stabilimenti ANIC della zona.
Enrico
Mattei, Presidente dell’Eni, usò la pista di Ponte Olivo per il suo viaggio
della morte. Alle 7,30 del 27 ottobre 1962, decollò per l’ultima volta
dall’aeroporto di Ponte Olivo per Catania un Morane-Saulnier MS. 760 Paris,
aereo privato dell’ENI. L’aereo, dopo la tappa a Catania, riprese il volo e
precipitò vicino Bascapè.
Enrico Mattei vicino
all’aereo Morane-Saulnier MS. 760 Paris
I resti dell’aereo
vicino Boscapè (Pavia)
Con l’Ing. Mattei
morirono:
il giornalista americano
(del TIME Life) William
e il pilota
Irnerio Bertuzzi
Secondo alcuni
testimoni, il principale dei quali era il contadino Mario Ronchi,
che in seguito
ritrattò la dichiarazione, l’aereo sarebbe esploso in volo.
Si potrebbe
scrivere un libro sull’episodio che
rappresenta uno dei “Misteri d’Italia”.
Nel 2012, una
sentenza di un processo collegato alla scomparsa del famoso giornalista
Mauro De Mauro che
indagava sull’episodio, ha riconosciuto ufficialmente che
l’ing. Mattei fu
vittima di un attentato.
"La
causa scatenante della decisione di procedere senza indugio al sequestro e
all'uccisione
di Mauro De
Mauro fu costituita dal pericolo incombente che egli stesse per divulgare
quanto aveva
scoperto
sulla natura dolosa delle cause dell'incidente aereo di Bascapè, violando
un segreto
fino ad allora rimasto impenetrabile e così mettendo a repentaglio l'impunità
degli influenti
personaggi
che avevano ordito il complotto ai danni di Enrico Mattei, oltre a innescare
una serie
di effetti a
catena di devastante impatto sugli equilibri politici e sull'immagine stessa
delle istituzioni".
In 2.199 pagine, depositate questo pomeriggio, i giudici della prima sezione
In 2.199 pagine, depositate questo pomeriggio, i giudici della prima sezione
della Corte
d'assise di Palermo ricostruiscono così l'omicidio del giornalista Mauro De
Mauro, sequestrato da Cosa nostra il 16 settembre 1970 e mai più tornato a
casa.
Pur assolvendo l'unico imputato, Totò Riina, il collegio presieduto da Giancarlo Trizzino,
Pur assolvendo l'unico imputato, Totò Riina, il collegio presieduto da Giancarlo Trizzino,
a latere
Angelo Pellino (estensore della motivazione) ricostruisce il torbido contesto
in cui il
cronista del quotidiano "L'Ora" pagò il suo scoop sulla morte del
presidente
dell'Eni,
Mattei, simulata da incidente aereo nei pressi di Pavia il 27 ottobre 1962.
"La natura e il livello degli interessi in gioco -scrive il giudice Pellino- rilancia l'ipotesi
"La natura e il livello degli interessi in gioco -scrive il giudice Pellino- rilancia l'ipotesi
che gli occulti mandanti del delitto debbano
ricercarsi in quegli ambienti politico-affaristico-mafiosi su cui già puntava
il dito il professor Tullio De Mauro (fratello del giornalista, ndr) nel 1970.
E fapresumere
che di mandanti si tratti e non di una sola mente criminale.
Non per
questo deve escludersi qualsiasi responsabilità di elementi appartenenti a Cosa
Nostra,
stante il livello
di compenetrazione all'epoca esistente e i rapporti di mutuo scambio
di favori e
protezione tra l'organizzazione mafiosa e uomini delle istituzioni ai più
disparati livelli".
https://www.ferraraitalia.it/personaggi-lomicidio-di-mattei-un-colpo-di-stato-ignorato-140234.html
La
pista, dopo la scomparsa dell’Ing. Mattei, rimase inutilizzata per circa 40
anni ed oggi è terreno agricolo.
SCHEDA
AEROPORTO : PONTE OLIVO:
Codice:
IATA –
Codice
: ICAO –
TIPO
: MILITARE, fino al 1943
PRIVATO, fino al 1962
STATO
: ITALIA
REGIONE:
SICILIA
CITTA’
: GELA
POSIZIONE
: PONTE OLIVO – a 9 km da Gela
UTILIZZATORE:
REGIA AERONAUTICA
ENI
REPARTI:
41° STORMO BOMBARDAMENTO TERRESTRE
51° STORMO CACCIA TERRESTRE
ALTITUDINE:
ASML 40 M
PISTE
– ORIENTAMENTO (QFU) – 06/24
LUNGHEZZA : 880 m
SUPERICIE : TERRA BATTUTA
Aeroporto di Ponte Olivo in Sicilia,
1943. In "With Every Letter", l'ingegnere dell'esercito Tom
MacGilliver aiuta a ricostruire questo aeroporto e l'infermiera di volo Mellie
Blake ...
07/11/1940 - Gela - Il colonnello
Pezzi dopo una ricognizione aerea a Ponte Olivo, 1940
Un
aliante Waco entra per atterrare su una pista di aerodromo. Questo è
l'aeroporto di Ponte Olivo, in Sicilia, nell'autunno del 1943. L'aeroporto era
una base importante, e presumibilmente molto meglio nominato della striscia
temporanea di Gozo.
Ponte Olivo :
Aerei tedeschi distrutti
----------------------------------------------------------------------------
-
Le stragi dell’Aeroporto
di Santo Pietro – il Racconto di Giuseppe Giannola – L’aeroporto di Santo
Pietro – Il Borgo Ventimiglia
Si
tratta dell’aeroporto 504, denominato 50, tavola n. 19 dagli Alleati aeroporto
di Biscari ma che in realtà si trova nell’altopiano di Santo Pietro in
territorio di Caltagirone (prov. di Catania).
Un
sito gestito dai tedeschi e con la funzione di pista ausiliaria per i caccia.
Nella struttura non si trovavano reparti fissi dell’aviazione, come per
l’aeroporto di Ponte Olivo, ma di difesa della contraerea che era costituita da
tre batterie della Milizia e dai reparti del regio Esercito che facevano parte
della difesa fissa.
Reparti
di difesa che erano comandati dal Maggiore Quinto e costituiti:
-
Dall’11°
compagnia del IV battaglione del 120° reggimento fanteria;
-
Una
compagnia del 153° battaglione mitraglieri;
-
Due
batterie da 149/12.
Il
tutto per un totale di circa 500 uomini.
A
difesa dell’aeroporto c’era anche il gruppo mobile “H” del Tenente Colonnello
Cixi, che era dislocato a Caltagirone. Aveva l’incarico d’intervenire a difesa
dell’aeroporto di Santo Pietro ed era composto da:
-
9a
compagnia del 76° reggimento fanteria, rinforzata da un plotone mitraglieri;
-
Un
plotone mortai da 45, un plotone mortai da 81 del 76° reggimento fanteria;
-
3°
compagnia del CIII battaglione controcarri;
-
7°
batteria del 54° reggimento artiglieria;
-
2°
compagnia carri “Fiat 3000”.
Il
giorno10 luglio 1943, i reparti della difesa fissa avevano cercato di contrastare
i reparti di paracadutisti statunitensi che erano scesi nella zona. Il giorno
13 l’aeroporto fu sottoposto ad un intenso fuoco d’artiglieria nemica e alle
15,00 l’artiglieria dell’aeroporto aprì il fuoco su elementi del 180° “Renimental Combact team” che si trovava a
Piano Stella.
La
mattina del giorno 14 il sergente West salì con i suoi uomini sulla collina
dove era posto l’aeroporto e fu attaccato dal fuoco dei mortai. Ma dopo un’ora
gli americani si trovarono all’interno della struttura e catturarono i
difensori.
Ai
prigionieri, italiani e tedeschi, vennero tolti gli scarponi, le uniformi e gli
oggetti di valore sotto la minaccia delle armi.
Una
parte dei prigionieri, 38 uomini tra cui due tedeschi viene fatta camminare per
alcune centinaia di metri. Nei pressi di una radura i prigionieri vennero fatti
allineare per ordine del capitano John Compton, comandante della Compagnia “A”
del 180° Reggimento di fanteria Usa. I prigionieri, inerti, increduli, vennero
abbattuti a fucilate.. tre riuscirono a fuggire (Virginio De Roit, Silvio
Quaiotto ed Elio Bergamo). Riuscirono a nascondersi tra i cespugli sulle sponde
del torrente Ficuzza. Gli americani aprirono subito la ciaccia sparando come
impazziti contro i cespugli ed utilizzando anche i lanciafiamme. I fuggitivi
riuscirono a tuffarsi nelle acque del piccolo torrente ma Bergamo venne ucciso
da un preciso colpo di fucile alla testa, De Roit e Quaiotto riuscorono a
fuggire. Si rifugiarono presso una casa di contadini che li ospiteranno
tenendoli nascosti sino alla fine delle ostilità.
Un
secondo gruppo di nove prigionieri venne condotto verso le retrovie
americane. I prigionieri sono scortati
da sette soldati alleati comandati dal
sergente Horace West.. Lungo il cammino si aggiunsero altri 37 prigionieri tra
cui due tedeschi.
La
testimonianza di quei momenti fu raccontata dall’aviere Giannola:
«[...] Dopo
quattro giorni di combattimento avevamo alzato le braccia[...] Mentre gli
americani ci spogliavano io pensavo alla festa, pensavo a casa. Poi abbiamo
camminato sotto il sole; saremo stati in cinquanta, tutti senza scarpe, a torso
nudo, in mutande o con i pantaloni corti. Dopo qualche ora ci hanno fatto fare
una sosta, stavamo seduti in un campo all’ombra degli ulivi. [...]
Tempo un quarto
d’ora e ci siamo alzati di nuovo: ci hanno fatto mettere su tre file. [...] A
quel
punto gli
americani hanno cominciato a sparare. Sono stato colpito subito: un proiettile
mi ha spezzato il polso e mi sono buttato a terra. Ho fatto solo in tempo a
fissare l’immagine di quel sergente gigantesco, con il tatuaggio sul braccio,
che impugnava il mitra. Poi i corpi degli altri mi sono caduti addosso.
[...] Sono rimasto
immobile per un paio d’ore, finché il silenzio non è diventato totale.
Lentamente, quasi paralizzato dalla paura, ho spostato i corpi e mi sono
alzato. Ho fatto solo in tempo a guardarmi attorno ed è arrivata la fucilata.
Ricordo il botto e il calore che mi bruciava la testa. Sono caduto, sorpreso d’essere
ancora vivo. Il proiettile mi ha preso di striscio [...]. Con la faccia a terra
credevo di non avere più scampo, invece nulla. Non so quanto tempo sia passato.
Mi dicevo: non muoverti. Ma avevo sete. Il polso spezzato e la ferita alla
testa mi bruciavano. Il dolore ha superato la paura. Mi sono mosso carponi,
temendo un altro sparo. Ho camminato così fino ad una strada sterrata. [...] È
passata un’ambulanza e si è fermata. Si sono resi conto che ero un italiano, ma
mi hanno dato da bere e bendato le ferite con attenzione. Poi a gesti mi hanno
fatto capire di restare vicino alla strada: “verranno a prenderti”. [...] È
arrivata una jeep con tre soldati. Quelli sono scesi, penso mi avessero
scambiato per uno di loro. Mi parlavano sorridendo, poi si sono accorti che non
capivo. Li ho visti guardarsi in faccia, quello con il fucile ha indicato
all’altro la jeep, lo ha mandato via. È rimasto solo, in piedi, di fronte a me.
Io ero seduto, lui
mi fissava. Poi ha imbracciato la carabina. Ha mirato al cuore e ha sparato”.
Giannola
non morì, questo fu un vero miracolo era
la terza fucilata che subiva. Venne raccolto da un’ambulanza, per ironia della
sorte, americana che lo trasportò in un ospedale da campo. Da questo campo
iniziò una lunga odissea per gli ospedali nel Nord Africa. Giannola per
l’esercito era disperso e accusato di diserzione. Rientrato dalla prigionia
denunciò l’accaduto ma non fu creduto.
Ma
a Biscari il giorno 15 era accaduto qualcosa che svelerà la dinamica della strage.
Il
cappellano militare lungo la strada che da Biscari portava all’aeroporto, notò
un gruppo di corpi. Era addetto anche al triste servizio di sepoltura e quindi
fermò l’automezzo per verificare. Notò che quei corpi presentavano tutti delle
ferite d’arma da fuoco all’altezza del cuore e che alcuni presentavano dei
macabri e chiari segni di colpi sparati da distanza ravvicinata alla testa.
Poche
ore dopo l’assassinio dei 37 prigionieri da parte del sergente West, il
capitano Compton ordinò l’esecuzione di altri 36 prigionieri di guerra
italiani. Per tutto il pomeriggio questi soldati italiani avevano tenuto in
scacco la sua unità del capitano Compton con un nutrito fuoco di
mitragliatrici.
Quando
i soldati americani si avvicinarono al bunker, da dove avevano sparato per
tanto tempo le mitragliatrici, videro uscire due uomini. Uno era in borghese,
con uno straccio bianco attorno ad un fucile e subito dopo ben 40 persone delle
quali alcune sempre in abiti borghesi.
Il
generale Bradley venne a conoscenza dei due tristi episodi e ne parlò con il
generale Patton il quale gli disse di far dire ai responsabili di quegli atroci
atti che “quei prigionieri erano cecchini
irregolari e che avevano tentato di scappare”.
Il
Generale Bradley, con grande onestà, fece aprire un inchiesta e alla fine i due
responsabili furono processati da una Corte Marziale anche se in totale
segreto.
Dagli
atti del processo risulta che entrambi gli imputati portarono a giustificazione
che il Generale Patton, in un discorso
tenuto agli ufficiali della 45° Divisione di fanteria, prima della partenza
dall’Africa verso la Sicilia, aveva detto che.. “Se si arrendono quando tu sei a due-trecento metri da loro,
non badare alle mani alzate. Mira tra la terza e la quarta costola, poi spara.
Si fottano, nessun prigioniero! È finito il momento di giocare, è ora di
uccidere! Io voglio una divisione di killer, perché i killer sono immortali!”. Una affermazione contraria a qualsiasi norma
del diritto bellico , che ebbe le sue tragiche conseguenze nell’operazione
“Husky” e che purtroppo farà vittime anche tra i soldati nemici disarmati e con
le braccia alzate in Normandia nel ’44.
Il
sergente West venne condannato all’ergastolo perché il suo crimine “non fu perpetrato durante uno scontro a
fuoco, per cui era immotivato ed attribuito esclusivamente alla sua
efferatezza” mentre il Capitano Compton fu assolto poiché secondo la Corte
Marziale “aveva agito conformemente agli
ordini ricevuti”.
West nel 1944 venne liberato e mandato al
fronte.
Il
4 dicembre 2016 l’aviere Giuseppe Giannola di Palermo è morto. Nel 2012 fu
insignito dell’onorificenza di
ufficiale della Repubblica Italiana.
In
Italia di questo avvenimento non c’è traccia nei resoconti ufficiali perché gli
Stati Uniti mantennero il più stretto riserbo sull’accaduto. Dopo sessant’anni
grazie all’attenta ricerca del Senatore Augello, si fece luce sulla vicenda e
sui nomi di quei poveri soldati che furono sottratti ad un immeritato silenzio.
Codice
IATA: -
Codice
ICAO: -
Tipo
: Militare;
Stato:
Italia;
Regione:
Sicilia
Posizione
: Vicino Acate
Costruzione:
1941
Altitudine:
AMSL 270 m
Pista:
in Terra Battuta
L’aeroporto
prende il nome dal vecchio nome del Comune di Acate e dal vicino Bosco di Santo
Pietro.
Costruito
nel 1941 dalla regia Aeronautica come pista alternativa all’aeroporto di Comiso
e di Ponte Dirillo. Venne usato anch’esso per gli attacchi alle basi inglesi du
Malta. Vi fu stanziato il 153° battaglione Mitraglieri ed alcune unità tedesche
della 1. Fallschim-Panzer – Divisione Hermann Goring. Venne conquistato dagli
alleati che sbarcarono a Scoglitti.
L’aeroporto
prende il nome dalla piccola frazione, appartenente al Comune di Caltagirone e
distante circa 15 km da Acate. Aveva una pista in terra battuta lunga circa 3
km e si trovava nell’area retrostante l’attuale
Chiesa di San Pietro e la Caserma dei
Carabinieri, edifici che furono costruiti sul luogo dove sorgevano degli
hanger. Un pianoro delimitato dalle due strade Santo Pietro – Acate e Santo
Pietro-Bosco.
Il
nome di “aeroporto di Biscari” fu legato all’antica fase progettuale. Mussolini
durante la visita della Provincia di
Ragusa, tra le zone visitate ci fu anche quella di Biscari (Acate), avanzò la
proposta progettuale per la creazione di un aeroporto in contrada Bosco Piano,
a pochi chilometri da Biscari. Un aeroporto vicino alla Strada Statale
“Vittoria – Gela” (SS 115), in direzione dei Macconi. Iniziarono i lavori con
lo spianamento dell’area ma ben presto furono abbandonati e la pista fu adoperata solo per casi di
emergenza. Si pensò di costruirlo in contrada Piano Stella, a circa 7 km da
Biscari, cioè vicino al Borgo Ventimiglia.
Un
borgo rurale realizzato nel 1939 per volere di Mussolini e le cui case
coloniche furono affidate a 40 coloni provenienti in massima parte da
Caltagirone. L’obiettivo della costruzione delle cose coloniche, che
costituivano il Borgo, era legato alla messa a coltura dei fertili terreni
circostanti. Anche questo progetto fu scartato.
L’ultima
soluzione fu quella di realizzarlo a 7 km a nord di Borgo Ventimiglia, nei
pressi della frazione di Santo Pietro, conservando sempre il nome originario di
“Campo d’Aviazione di Biscari”.
In
realtà fu scelta la frazione di Santo Pietro perché proprio in quella zona, per
volere del Regio Commissario di Caltagirone, Benedetto Fragapane, doveva
sorgere la città giardino “Mussolinia” in onore del Duce. Il 12 maggio 1924 fu
in realtà posta la prima pietra e si crearono delle strutture che finirono con
l’essere utili al campo dell’aviazione.
Borgo Ventimiglia
– Caltagirone
Borgo Santo Pietro
http://www.lagazzettadelcalatino.it/nel-borgo-di-santo-pietro-la-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo
uniti/
La lapide in memoria dei Caduti a Santo Pietro
------------------------------------------------------
-
L’Aeroporto di Comiso –
Canicarao – La falsa Pista – Case Don Pietro – Marchese Trigona – Le spie
Inglesi nascoste nel castello – L’aeroporto dopo la Guerra – LAI – L’aeroporto
base dei Missili Cruise – L’attività pacifista di Pio La Torre – Il Movimento
Pacifista – La Verde Vigna – La Pagoda della Pace di Comiso – Morishita Gensko –
L’aeroporto oggi
La
politica di espansione verso l’Africa messa in atto dal governo di Mussolini si
basava sul presupposto della creazione di una serie di avamposti militari che
permettessero un controllo militare sull’isola di Malta. Un’isola in mano agli
Inglesi e quindi al centro di movimenti della flotta britannica che sin dalla
seconda metà dell’Ottocento controllava le uniche due vie d’accesso nel
Mediterraneo: lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez.
Furono
create le piste di Ponte Olivo, di Santo Pietro e di Comiso, quest’ultima in provincia di Ragusa, forse fu la più importante.
La
scelta dei comandi militari cadde sulla provincia di Ragusa perché
geograficamente più a sud del Paese e perciò la più vicina alle coste del Nord
d’Africa.
Una
scelta che aveva anche delle basi storiche. Durante le guerre puniche (III – II
secolo a.C.) dalle coste della Sicilia Sud-Orientale partirono le flotte romane
per la conquista di Cartagine e successivamente in epoca bizantina, l’imperatore
Giustiniano salpò dalle stesse spiagge per andare a combattere i Vandali nel
Nord-Africa e questo nel 533 d.C.
La
nuova strategia militare da alcuni decenni si era perfezionata e l’aviazione ne
era una componente importante.
Fu
così che nella metà degli anni Trenta si pensò di costruire nella zona della
provincia di Ragusa un aeroporto.
Naturalmente
ci fu un ampio e anche aspro dibattito sulla scelta della località in cui
costruire la struttura.
Nel
depresso sud la presenza di un aeroporto avrebbe avuto risvolti importanti sia
dal punto di vista sociale che economico.
Il
senatore Filippo Pennavaria, artefice di tanti atteggiamenti ostruzionistici
nei confronti della città di Modica, Capitale dell’antica e prestigiosa “Contea
di Modica”, cercò di fare cadere la scelta del sito nel territorio di Ragusa.
Un sito ben identificato sull’altipiano dei Monti Iblei e cioè sulla “Piana
dell’Annunziata” mentre i comandi dell’Aeronautica centrarono la loro
attenzione su un area posta a un 1,5 km da Comiso, in Contrada Canicarao.
Canicarao
Anche
la zona di Canicarao, che ricade nel Comune di Ragusa, fu scartata dai tecnici
militari perché ritenuta pericolosa per la presenza di un sistema collinare a
ridosso delle “Case di Don Pietro”.
Furono
fatte altre visioni del territorio e alla fine fu scelta la contrada “Cannamellito”.
Una vasta pianura, posta a circa 3 km da Comiso, e che ricadeva nel territorio
del Comune di Vittoria.
L’aeroporto
occupava una superficie pianeggiante di circa 146 ettari. I terreni appartenevano
alle famiglie Giacchino Iacono di Vittoria, Nunzio Iacono di Comiso e
Caruso di Comiso. Naturalmente i terreni
furono espropriati.
Sembra
che il via definito per la realizzazione dell’aeroporto sia avvenuta durante la
visita di Mussolini in Sicilia nel 1934.
In
realtà il terreno che era stato proposto in contrada “Canicarao” nella Tenuta
“Don Pietro” era stato, con piccoli spianamenti, adoperato per la creazione di
una pista d’atterraggio d’emergenza per aerei in difficoltà. Una pista creata
dall’esercito italiano. Terreni privati che appartenevano al Marchese Emanuele
Trigona che s’impegnava a mantenere liberi da colture e dotandoli di opportune
segnalazioni.
Nel
1935 iniziarono i lavori per la costruzione dell’aeroporto militare. I lavori
non furono facili perché la realizzazione dell’opera fu accompagnata da accessi
procedimenti giuridici.
Il
19 settembre 1935 la pista doveva essere già completa perché il campo ricevette
la denominazione di “Enrico Gabbana”, un sergente fascista ucciso durante la
guerra in Libia.
La
denominazione fu cambiata in “Vincenzo Magliocco”, generale fascista ucciso
nella guerra d’Etiopia, il 15 novembre 1936.
Nel
giugno del 1937, l’archeologo comisano Biagio Pace, riordinò l’assetto
territoriale della Provincia di Ragusa per eliminare una situazione che
risaliva al periodo feudale e che era svantaggiosa per la popolazione di
Comiso.
Si
emanò la Legge n. 952 dal titolo “Modificazioni
alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria,
Biscari (oggi Acate) e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e di
Caltagirone, in provincia di Catania”.
La
legge fascista attribuiva al Comune di Comiso un aumento della sua superficie
territoriale di 2269 ettari. In questi ettari c’erano 620 ettari che
appartenevano al comune di Vittoria che naturalmente non accettò il
provvedimento. Un rifiuto legato non
tanto alla diminuzione del suo territorio ma perché in quei famosi 620 ettari
c’erano compresi i 146 ettari di Contrada “Cannamellito” dove era in
costruzione l’aeroporto. Un rifiuto deciso malgrado l’assegnazione al Comune di
Vittoria, per la perdita di una parte del suo territorio, di 1140 ettari
provenienti dal vicino come di Biscari (Acate).
Nell’estate
del 1937 Mussolini visitò la provincia di Ragusa e naturalmente si recò a
Comiso per vedere e rendersi conto dei lavori del costruendo aeroporto che
comunque procedevano velocemente. In occasione di quella visita fu posta sul
prospetto principale del palazzo Comunale una lapide di marmo, che fu asportata
dopo la caduta del fascismo, che riportava: “L’anno 1937, XV E.F., Mussolini spezzando la superstite servitù del
feudo ampliava il territorio di Comiso destinata a sentinella del
Mediterraneo”.
Il
14 agosto 1937 fu inaugurato l’aeroporto, anche se i lavori di costruzione
(probabilmente gli ultimi dettagli) non erano completi infatti la base venne
dichiarata formalmente “Campo di Manovra”.
Nell’inaugurazione
il duce dichiarò che la struttura
“rappresentava il centro geografico dell’Impero e che il fascismo l’avrebbe
trasformata in una fortezza inespugnabile”.
La solenne cerimonia si svolse nella Piazza
Fonte Diana gremita di gente esultante.
Il
15 luglio 1938 la voce “campo di manovra” fu sostituita da quella di “aeroporto armato di 3a classe” e il
titolo confermato alla medaglia d’oro Vincenzo Magliocco, palermitano e
generale di brigata aerea morto in “Africa Orientale Italiana” (il 27 giugno
1936 a Lekempti, Etiopia Occidentale).
Nel
1939 l’aeroporto fu ultimato e nel 1940 Mussolini ordinò di attaccare l’Egitto
che era un importante base inglese (l’Italia entrò in guerra nel secondo
conflitto mondiale il 10 giugno del 1940). Gli inglesi non solo respinsero
sempre gli attacchi italiani ma si spinsero anche in Libia, allora colonia
italiana, riuscendo ad occupare parte del territorio. Nella base si trovavano
il 4°Stormo, il 9° Gruppo caccia e il
23° Gruppo caccia che nel gennaio 1941 cambiò la propria denominazione in 156°
Gruppo Autonomo Caccia Terrestre che aveva in dotazione i caccia biplani CR 42.
Il 6 ottobre 1941 arrivò nella base anche il 10° Gruppo che vi stazionò fino al
gennaio 1942.
Nel
gennaio 1941 nella base s’insediò il X° Corpo tedesco da bombardamento con 5
batterie contraeree Flak da 88 mm.
4° Stormo a Gorizia
Noi in cielo e il cielo
per noi
La presenza di un fronte nel Bacino del
Mediterraneo rese l’aeroporto di Comiso un punto strategico importante sia come
base di partenza per le missioni sia come struttura di “pronto soccorso” per i
velivoli in difficoltà e costretti ad atterraggi d’emergenza. Non furono rari i
casi di atterraggi di velivoli appartenenti alle basi della Sardegna o
dell’Italia Meridionale che erano stati colpiti in volo.
Il 29 giugno 1940 il 4° Stormo di Gorizia
ricevette l’ordine di trasferirsi a Comiso. Il 30 giugno decollò da Mirafiori
(Torino). Fece tappa a Campiglia Marittima, Capodichino, Reggio Calabria e
arrivò a Comiso la mattina del primo luglio.
Il 2 luglio cominciarono subito le operazioni su
Malta con decollo da Comiso.
Dodici C.R.42 del IX Gruppo al comando del magg.
Botto scortarono due S. 79 che avevano il compito di eseguire una ricognizione
fotografica sul campo di Hal Far.
L’indomani nove C.R.42, sempre al comando del
magg. Botto, scortarono due S79 in volo di ricognizione. Invece di dirigersi
direttamente su Malta, i due S 79 volteggiarono al largo dell’isola mettendo
naturalmente in allarme la contraerea maltese. Uno dei due ricognitori si
avvicinò a La Valletta e venne subito attaccato da due Hurricanes nemici. L’S79
fu colpito e precipitò in fiamme mentre il magg. Botto inseguì il caccia nemico
inglese fino ad abbatterlo. L’S79 colpito riuscì a rientrare a Comiso.
La mattina del 4 luglio la missione era
impegnativa… ben 24 C.R.42 del IX Gruppo decollarono dalla base per dirigersi
sull’aeroporto di Hal Far dove erano schierati gli aerei inglesi.
In prossimità dell’aeroporto maltese i piloti
Botto, Biffani, Stauble, Mauriello, Vaccari e Salvatore, si buttarono in
picchiata sull’aeroporto scorati a quote diverse da sei aerei della 73° Squadriglia
(a seicento metri più in alto), sei arei della 97° Sq (a duemila metri di
quota) e sei aerei della 96° Sq (a quattromila metri di quota sempre più in
alto).
Una vera azione di eroi perché malgrado la forte
reazione della contraerea inglese riuscirono a colpire, e quindi mettere fuori
uso, otto aerei, un bombardiere e sette Gloster.
Nel gruppo italiano furono colpiti due aerei
della 96° Sq e il C.R.42 di Salvatore che fu colpito nel bilanciere con
conseguente perdita degli alettoni. Nonostante i danni riportati gli aerei
italiani riuscirono a rientrare nella base di Cosimo.
Il giorno 5 luglio nessuna missione perché era di
“allarme a terra” prevedendo una possibile reazione inglese.
Il 6 luglio il pilota Antonio Larsimont
Pergamenill ( pluridecorato asso della Regia Aeronautica conseguendo un totale
di 7 vittorie aeree accertate, una probabile e quattro in collaborazione.
Decorato con Medaglia d’oro e quattro d’argento al Valore Militare) scortò con
nove aerei due S.79 in ricognizione su
La Valletta e Marsa Scirocco. Nel pomeriggio il magg. Botto con ben 24 C.R.42
scortò 30 aerei S.79 in azione di bombardamento su La Valletta, Micabba e Hal
Far.
Il 7 luglio il magg. Botto scortò con nove C.R.
42 due formazioni di S. 79. La pronta e immediata reazione della controaerea
inglese mise in difficoltà la copertura. Nel rientrare alla base di Comiso un
S. 79 venne abbattuto dai caccia inglesi.
Con la guerra in Libia il IX Gruppo, sempre di
stanza a Comiso, ricevette dal 1° Stormo, che aveva la base a Trapani Milo,
cinque C.R.42 della 384° Squadriglia.
Gli aerei presenti nella base di Comiso diventarono trentatré.
9 luglio 1940 si effettuarono dei voli di
vigilanza sulla linea di costa Capo
Passero – Gela – Canale di Sicilia e l’indomani si svolse l’ultima azione del
gruppo su Malta per scortare tre Squadriglie di cinque S. 79. Dopo il decollo
l’appuntamento con i bombardieri era stato previsto a quota 2500 metri.
Purtroppo gli S 79 arrivarono con quasi un’ora di ritardo e il magg. Botto fu
costretto a rientrare per motivi di autonomia. Sono sei caccia, che partirono
successivamente, riuscirono ad agganciare i bombardieri e a scortarli
sull’obiettivo. Nell’azione due S 79 furono abbattuti.
L’11 luglio il IX Gruppo con i suoi trentatré CR
42 lasciò la base di Comiso per trasferirsi in Libia. Il trasferimento fu
accompagnato dai Ca 133. La prima tappa fu a Pantelleria e il giorno
successivo, scortati da tre Cant. Z-506, raggiunsero Castel Benito (un
aeroporto di Tripoli costruito dagli italiani). Il IX Gruppo raggiunse
successivamente Berka dopo una tappa intermedia a Tamet. A Berka sugli aerei
CR$2 vennero montate delle nuove carenature con filtri antisabbia, necessari
per proteggere il motore e sulle derive venne dipinto il distintivo del Gruppo
cioè la gamba di ferro nera in campo triangolare bianco.
Fiat CR 42, marche 96-2 MM5605 della 96° Squadriglia (foto
del 1940)
Si notano di due distintivi del gruppo:
quello ufficiale del IX Gruppo, il Cavallino Rampante bianco
in campo nero, e quello
ufficioso della Gamba di Ferro.
La Gamba di Ferro identifica la Squadriglia mentre il
Cavallino Rampante il Gruppo (IX).
Il 23 dicembre 1940 il IX Gruppo cominciò ad
effettuare il rientro in Italia dalla Libia con destinazione Gorizia. Dal 10 giugno
al 31 dicembre 1940 i piloti dello Stormo avevano effettuato ben 540 sortite
per un totale di 4877 ore di volo. Nelle operazioni erano riusciti ad abbattere
95 aerei nemici in 40 combattimenti e danneggiandone altri in volo, a
distruggere 12 velivoli a terra oltre a numerosi mezzi meccanici.
Il 27 settembre 1941 il IX Gruppo, di stanza a Gorizia, comandato dal coll.
Leotta, ricevette l’ordine di trasferirsi a Comiso dove arriveranno il
pomeriggio del 29.
Gorizia, 27 settembre 1941 – IX Gruppo, allineato sul prato erboso di
Merna,
in partenza per Comiso con scalo a
Ciampino
Gorizia, 27 settembre 1941
Il gen. Felice Porro intrattiene i
piloti prima della partenza per Comiso.
Alla sinistra del gen. Porro,
Leotta.
In fila, da sinistra, Rossi (4°),
Gherà (5°), D’Agostinis (8°), Tessari (9°).
All’estrema destra della foto,
Annoni.
Comiso - 22
luglio 1943
Un
Supermarine Spitfire Mk.V
del No. 243 Squadron della RAF in manutenzione a Comiso.
In primo piano la
fusoliera di un Messerschmitt Me 109G appartenente al 6/JG53.
Bf
109 G-6/R6 Stab. I./JG53
Aerei tedeschi colpiti nella base
di Comiso, estate 1943
https://www.pinterest.co.uk/pin/826269862859753159
Nel
1941 Hitler decise di mandare in aiuto dell’esercito italiano in Libia un corpo
specializzato nella guerra nel deserto. Reparto che era al comando del
feldmaresciallo Erwin Rommel. Il corpo d’armata tedesco, “Africa Korps”, passò
da Comiso più volte per poi trasferirsi, via aereo, in Africa.
Il
28 dicembre 1941 il podestà di Comiso, Bellassai, propose di erigere presso
l’aeroporto un cimitero dove seppellire tutti i soldati tedeschi morti in
guerra. Una proposta che non ebbe seguito.
Nel
febbraio del 1942 il maggiore Rosi, comandante dell’aeroporto, si lamentò dei
gravi atti compiuti dalle truppe tedesche che lasciavano i locali della “Regia
Scuola d’Avviamento Professionale” in “pessime condizioni, con suppellettili
divelte o danneggiate”.
Le
stesse truppe tedesche spesso si resero artefici di atti delinquenziali nei
confronti della popolazione. Il 26 ottobre 1942 “6 militari tedeschi non identificati, nel tentativo di entrare
nell’abitazione del mugnaio Orazio Guccione, di anni 59, gli spararono due
colpi di pistola uccidendolo sul colpo. Successivamente tentarono un’estorsione
nei confronti di Salvatore Sallemi. Quindi in un’abitazione vicina rubarono tre
galline, due conigli ed altri generi alimentari”.
Malgrado
la presenza di altri piccoli aeroporti militari, quello di Comiso, per l’intensificarsi della
guerra in Africa, diventò un importante scalo strategico militare. La sua
importanza non poteva quindi sfuggire agli Alleati.
Le
prime incursioni alleate sull’impianto “Magliocco” colpirono sia militari, in numero sempre
crescente, sia civili.
Nel
1941 ci furono le prime incursioni aeree sull’aeroporto che causarono la
distruzione di diversi aerei e la morte di parecchi militari
Tragiche
furono le incursioni avvenute poco tempo prima del fatidico 10 luglio 1943
quando gli Alleati sbarcarono sulla costa meridionale dell’isola.
26 maggio e 17 giugno
1943… “ 26 maggio… mancava poco alle
10,30 e il cielo sembrò oscurarsi. Uno spettacolo terrificante si presentò agli
occhi della popolazione civile. Una quantità enorme di aerei, le famose
fortezze volanti della R.A.F., disposti in formazione da combattimento, piombò
sulla città, diretta verso l’aeroporto. A un certo punto gli aerei cominciarono
a vomitare bombe ancora prima di giungere sulla verticale dell’aeroporto. Un
vero bombardamento a tappeto che fece subito le prime vittime fra i civili,
contadini principalmente, sorpresi a lavorare nei campi adiacenti alla zona
militare. La contraerea oppose una tenue resistenza essendo stata colta di
sorpresa, mentre moltissimi aerei vennero distrutti a terra ancor prima che
potessero prendere il volo. I pochi che ci riuscirono furono decimati dai
caccia nemici che scortavano i bombardieri inglesi. In pochi minuti l’aeroporto
divenne un ammasso di rovine fumanti con corpi orrendamente mutilati sparsi un
po’ ovunque. Molte le vittime anche tra gli operai civili che lavoravano all’intero
dell’aeroporto.”.
Quella
data del 26 maggio 1943 segnò l’inizio dell’operazione “Husky”, il nome
convenzionale con cui venne indicata l’operazione di sbarco in Sicilia da parte
delle truppe Alleate.
“17 giugno…. Alle 11,00 circa, se ne verificò un altro, ancor più micidiale e
sanguinoso. I morti, stavolta, si contarono a decine e i feriti a centinaia,
moltissimi fra la popolazione civile. L’aeroporto venne letteralmente raso al
suolo”.
Altro
attacco all’aeroporto il 9 luglio verso le ore 16.. gli alleati, una flotta di
60 aerei inglesi, sganciarono sul “Magliocco” 109 tonnellate di bombe.
L’indomani
sulle colline di Cutalia gli scrivani del “Distretto Militare” di Ragusa,
mandati a fronteggiare i paracadutisti americani, furono sterminati. Tra i morti
due comisani, ex allievi del Ginnasio di Comiso, Salvatore Salvo e Giuseppe
Barone.
Gli
americani entrarono a Comiso l’11
luglio, verso le ore 11. Era la 45° Divisione, proveniente da Santa Croce
Camerina, e fu accolta con manifestazione di giubilo dai Comisani. Gli
americani naturalmente presero possesso dell’aeroporto. Quel giorno era la
festa del Patrono San Biagio che non si svolse per il susseguirsi degli eventi
bellici.
Prima
della fine della guerra l’aeroporto di Comiso subì un ultimo bombardamento…non
degli alleati ma dai tedeschi che lo avevano usato in passato come base.
L’8
settembre 1943 fu firmato dal generale Badoglio l’armistizio e subito dopo un
armata tedesca, credendo che il “Magliocco” fosse ancora agibile, lo bombardò
con grande intensità.
Aeroporto di Comiso – Anni 40 – un
aereo tedesco colpito
CONTRADA “CANICARAO”
Fra
i territori che furono proposti per la costruzione dell’Aeroporto di Comiso,
come abbiamo visto, c’era anche la Contrada “Canicarao”, ricadente nel Comune di Ragusa
anche se posta a poca distanza dal Comune di Comiso.
“Canicarao”
era un feudo dei Trigona, Marchesi di Canicarao e di Noto. Un feudo di circa
800 ettari che era suddiviso in 12 aziende a giacitura varia dal punto di vista
planimetrico. La costruzione dell’aeroporto fu proposta nei terreni
dell’azienda “Don Pietro” che era costituita da una parte, retrostante agli
edifici, collinare e da una vastissima pianura che delimitava con la vecchia
strada che da Comiso conduceva a Chiaramonte Gulfi attraverso la contrada
“Cifali”. Un azienda quella di “Don Pietro” che secondo i miei studi era
appartenuta ad un Don Pietro da Moach.
Nel
feudo era presenta la famosa “Casina”
com’era indicato il castello o Torre dei Marchesi dove si trovavano sia gli
appartamenti nobiliari che i magazzini. Un vasto cortile o baglio, all’interno
della struttura, era il luogo d’incontro dei “massari” e degli affittuari dei
vari appezzamenti.
L’aeroporto
fu costruito in contrada “Cannamellito” ma la “Piana di Don Pietro” continuò ad
essere usata soprattutto dai tedeschi. Avvenimenti che mi furono raccontati dai
vari massari o contadini che vissero quei tragici giorni di guerra. Quando gli
alleati, prima dello sbarco, iniziarono già da tempo a sorvolare la zona per
colpire l’aeroporto di “Cannamellito”, i tedeschi misero dei finti aerei di
legno sulla piana e la sera l’illuminavano con riflettori e torce per dare la
sensazione a un aereo in volo di trovarsi sopra una vera e propria pista.
Negli
anni sessanta fu ingaggiato dal marchese, tramite l’amministratore Gioacchino
Lastrucci, un trattorista di Modica, Don Angelo Gulino. Le sue mansioni erano
quelle di custode, trattorista e addetto al servizio irriguo. Nelle arature dei
terreni dell’azienda Don Pietro trovò spesso dei residuati bellici e anche
negli anni ’80 fu trovata una bomba.
Don
Angelo ha passato la sua vita nell’azienda di Torre di Canicarao e mi ha
rilevato aspetti, notizie che sono sconosciute a tanti.
Ho
lavorato anch’io, per circa nove anni, nell’azienda (diventata agriturismo) che
si era ridotta a un teatro di miserie umane.. le uniche voci che riecheggiavano
nel vasto cortile erano: “lascia che bruci tutto”..”di ambiente non si mangia”…
“non so se hai diritto ai permessi o alle ferie”… ecc. lasciamo perdere quello
che doveva essere un immenso patrimonio culturale si è perduto per sempre per colpa di chi non
ama l’ambiente e non protegge la cultura spinto da avidità di potere e denaro.
Mi
sono sempre chiesto come mai il castello, posto a poca distanza dalla Piana di
Don Pietro non fu mai bombardato… C’erano gli ufficiali tedeschi che erano
ospiti del marchese nel castello e dormivano nelle stanze poste sopra l’ingresso del cortile. Le truppe tedesche dormivano
parte all’aeroporto e altre in baracche che erano poste nel terreno sottostante
alla strada che costeggia il castello.
Il
motivo mi fu spiegato ancora una volta dai “massari” , veri scrigni di sapere
antico.
Il
castello fu adibito successivamente ad agriturismo e dove era posta la cucina c’era in origine
un deposito di carrube. Un vano molto ampio e contraddistinto da un altezza
notevole. Sul pavimento c’era una botola che immetteva in un sotterraneo. I massari mi rilevarono che in quei
sotterranei per tanto tempo furono nascosti due spie inglesi. E’ vero ? Non so…
Però quando furono fatti i lavori per trasformare il vecchio magazzino in
cucina, i sotterranei furono colmati….
Ritornando
alla pista di “Don Pietro” sembra che i terreni della piana furono
utilizzati dal regio esercito come pista
d’atterraggio per aerei in difficoltà ancora prima della costruzione dell’aeroporto
in contrada “Cannamellito”. Il marchese aveva dato la disponibilità di quei
terreni impegnandosi a lasciarli liberi da colture e a provvedere alla loro
segnalazione.
Un’antica foto della case della Tenuta
“Don Pietro” prima che venissero
orrendamente restaurate.
Sulla sinistra della
stradella parte della Piana di Don Pietro
L’AEROPORTO DI COMISO DOPO
LA GUERRA
Naturalmente
alla fine della guerra la struttura aveva subito danni gravissimi ma che
potevano essere riparati per creare anche un aeroporto civile. Fu avanzato,
anche se timidamente, un progetto che non riuscì ad avere seguito. Nel 1947 fu
prospettata la possibilità della costruzione di un aeroporto civile a Gela.
Il
Comune di Comiso, supportato dai cittadini,
approvò nel febbraio 1947 una delibera con la quale protestava contro la
presunta costruzione dell’aeroporto civile di Gela ..”una minaccia possibile alla riconversione del Magliocco” e
impegnava il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi; il ministro della
Difesa, Luigi Gasparotto e il Ministro dell’Interno…..Mario Scelba, a
pronunciarsi contro questa decisione.
Una
richiesta logica dato che la spesa di ripristino della base di Comiso sarebbe
stata minore rispetto alla costruzione di un aeroporto ex-novo.
Nel
1949 si formò il “Comitato pro-aeroporto” a cui aderirono il senatore Salvatore
Molè (PSI), l’onorevole Emanuele Gurrieri (DC), diversi deputati regionali,
sindaci, semplici cittadini e anche l’avvocato Saverio Castellet, legale della
Lai (“Linee Aeree Italiane”) cioè la compagnia di bandiera allora in servizio
in Italia.
Douglas
DC-& marche I-LINE
Il
Comitato, con il supporto del Comune, inviò al Prefetto e al Questore la
richiesta di rimessa a punto del “Magliocco” e la sua trasformazione sia in
aeroporto civile che in scuola di pilotaggio.
Naturalmente
la richiesta era accompagnata dalle previsioni che la presenza di un aeroporto
avrebbe favorito, in tutta la provincia di Ragusa, uno sviluppo sociale ed
economico. L’accordo con la Lai consentiva il collegamento con i più importanti
scali italiani.
Il
progetto fu approvato e dopo tre anni di lavoro, l’11 maggio 1952 il Questore
Lorenzo Calabrese comunicò al Prefetto Arnaldo Adami che, in seguito
all’accordo tra Lai e Comune di Comiso, i voli sarebbero iniziati dal giorno
successivo 12 maggio. Ci fu l’inaugurazione a cui presero parte il ministro del
Lavori pubblici Salvatore Aldisio, l’assessore regionale Silvio Milazzo,
cittadini entusiasti, sindaci, ecc. I voli venivano effettuati con un bimotore
da 50 posti.
La
tratta fu chiamata “Rotta dell’Oleandro” e
consentiva ai passeggeri di raggiungere aeroporti importanti come Milano,
Firenze, Torino e anche internazionali come Parigi, Lisbona, Atene e anche del
Nord-Africa tra cui Tripoli, Tunisi, Il Cairo.
Bisogna
dire che in quel periodo siamo, negli anni ’50, l’aereo non era molto
utilizzato. La gente provava l’esperienza del volo come divertimento o viaggio
premio e molti avevano paura.
L’aeroporto
civile ebbe vita breve perché dopo appena cinque mesi chiuse. Era il 12 ottobre
1952 e ci furono dei mancati pagamenti finanziari da parte del Comune di
Comiso, circa 8 milioni di lire dovuti dai comuni iblei alla Lai.
In
realtà i problemi per l’aeroporto erano incominciati subito perché un mese dopo
l’inaugurazione, il 14 giugno 1952, il direttore dello scalo “Magliocco”, Libero
Belgiorno, chiese ai sindaci dei Comuni di Comiso e di Vittoria, Francesco
Morso e Filippo Traina, di riparare la strada provinciale che conduceva alla
struttura. Si trattava della sistemazione del tratto di strada tra Vittoria e
Roccazzo, per consentire di ridurre il tempo d’arrivo all’aeroporto favorendo
l’arrivo per i passeggeri e per gli automezzi adibiti al trasporto merci.
Il
Comune di Vittoria chiese alla Regione, allora guidata da Franco Restivo, una
sovvenzione per la realizzazione dei lavori stradali. Il finanziamento non
arrivò e il 6 ottobre 1952 il questore Calabrese comunicò al Prefetto Adami la
cessazione dei voli dal 12 dello stesso mese.
Passarono
tre anni e i voli ripresero.
Tra
l’1 marzo 1954 e il 17 gennaio 1955 i comuni ricadenti sul territorio
dell’aeroporto versarono le somme dovute alla Lai: Comiso pagò 2.700.000 lire,
Ragusa e Vittoria 900.000 lire, Modica e Scicli 600.000 lire. La Regione
Siciliana,, con un provvedimento dell’Assemblea Regionale del 12 novembre 1954,
seguito da una circolare del 19 gennaio 1955, attivò la concessione di
contributi alle Camere di Commercio per finanziare servizi di collegamento
utili allo sviluppo economico della Sicilia, dunque anche al “Magliocco”.
Il
5 aprile 1955, il prefetto di Ragusa, Francesco Boccia, sollecitò alla Lai il
ripristino dei collegamenti aerei con Comiso. La riapertura avvenne il 25
giugno 1955, dopo ben tre anni di fermo. Erano previsti due voli: uno alle 7,45
per Catania e scali successivi a Palermo e Roma; l’altro alle 17,30 da Catania.
I
passeggeri scarseggiarono. Un rapporto del direttore Belgiorno indicò in 222 i
passeggeri partiti e 229 quelli giunti a Comiso nel luglio del 1955 cioè dopo
circa un mese di attività.
Nel
1957 si ebbe un incremento con circa 3.000 passeggeri e 40 q.li di merci
trafficate (31 q.li quelle scaricate e 9 quelle esportate).
Ma
nell’anno successivo il traffico crollò paurosamente… l’aeroporto fu utilizzato
solo da 500 passeggeri e da un traffico merci di appena 3 q.li.
Si
fece un ulteriore sforzo incrementando o rafforzando i voli verso Roma e Napoli
che, con opportune e studiate coincidenze, permettevano ai passeggeri di
prendere gli aerei per Boston, New York o per il SudAmerica.
Nel
1958 il Magliocco cessò nuovamente l’attività per ripartire dopo otto anni nel
1966 con la ristrutturazione della pista che raggiunse una lunghezza di 1,740
km.
Nel
1965 l’aeroporto fu riaperto per merito di un’altra società aerea, l’ATI. A
maggio 1965 l’ATI inaugurò la linea Palermo-Comiso, (con Fokler 27 ?) e viceversa.
Nel
frattempo s’insediò il 41° Stormo dell’Aeronautica di Catania che fece la sua
base nell’aeroporto fino al 1973.
Nuove
prospettive nel tessuto sociale ragusano, sviluppo dell’agricoltura,
dell’industria e del turismo. L’aeroporto tirò avanti per un po’, anche per
merito dei contributi dell’Amministrazione Provinciale, degli Enti Locali e
naturalmente della Regione.
Nel
1970 ci fu un transito di 9000 passeggeri e nel 1971 un traffico merci di 80
tonnellate. Furono incrementati i voli per Roma e Milano.
Dopo
sette anni, nel novembre 1972, fu nuovamente chiuso al traffico civile… la
linea era passiva e l’ATI non poteva più sovvenzionare o mantenere quel ramo
improduttivo.
L’AEROPORTO DI COMISO BASE
DEI MISSILI CRUISE
Poi improvvisamente negli anni Ottanta l’aeroporto tornò alla ribalta con toni allarmanti,
apocalittici… e questo non senza ragione.
La
Nato il 12 dicembre 1979 rese noto un documento con il quale annunciava
l’installazione in Europa di 572 missili Cruise. Una risposta allo spiegamento
sovietico di missili SS-20 e Backfire collocati nei Paesi aderenti al Patto di
Varsavia.
Tra
le basi indicate per la collocazione dei missili Cruise fu indicata la base di
Comiso. Una scelta legata alla sua importante posizione geografica che avrebbe
agevolato attacchi mirati sulle coste del Nord Africa e verso l’Ucraina e
l’Ungheria.
La
scelta fu agevolata dalla presenza di una struttura efficace ed esistente e
soprattutto di proprietà del Demanio Militare.
L’ufficiosità
da parte della Nato era stata preceduta il 3 dicembre da un dibattito alla
Camera dei Deputati sull’eventuale appoggio alla decisione dell’Alleanza
Atlantica.
Il
presidente del consiglio Francesco Cossiga ricordò nel dibattito che
“elementi essenziali della linea politica del nostro
Paese sono la sicurezza, garantita da una alleanza difensiva dei paesi a regime
di democrazia pluralistica, il mantenimento dell’equilibrio delle forze,
l’impegno costante per la distensione e per i negoziati e gli accordi per il
disarmo”. E
per questo motivo pur auspicando che “al
più presto […] la stessa decisione della Nato diventi superflua, essendosi
conseguito il risultato negoziale della distruzione degli esistenti sistemi
nucleari sovietici di teatro a lungo raggio che sono a base dello
squilibrio", si
annunciava l’accordo del Governo italiano alla decisione della Nato. La mozione venne
approvata con 328 voti favorevoli e 230 contrari.
Il
lungo processo che aveva portato a quella decisione affondava le proprie radici
nel desiderio da parte dello Stato italiano di svolgere un ruolo di primo piano
nello scacchiere internazionale. Una volontà accresciuta dalla mancata
partecipazione dell’Italia al vertice Nato del gennaio 1979 tenutosi in
Guadalupa e al quale parteciparono Jimmy Carter (Presidente degli Stati Uniti),
James Callaghan (Primo ministro della Gran Bretagna), Helmut Schmidt
(Cancelliere della Germania) e Valéry Giscard d'Estaing (Presidente della
Francia). In quel meeting fu stabilita l’opportunità da parte della Nato di
schierare i missili in Europa.
Proprio
in quell’occasione il Cancelliere tedesco Schmidt pose come condizione
necessaria, affinché acconsentisse allo schieramento di armi nucleari nella
Germania Federale, il non essere l’unico paese ad ospitarle. Fu questo il tema
principale dell’incontro con il Presidente della Repubblica Italiana Sandro
Pertini nel luglio del 1979, alla vigilia dell’insediamento del governo
Cossiga, esecutivo sostenuto da una maggioranza composta dalla Democrazia
Cristiana (DC), dal Partito Liberale Italiano (PLI) e dal Partito Socialista
Democratico Italiano (PSDI).
Il 19 agosto 1981 il Consiglio dei Ministri, governo Spadolini, decise di
localizzare la base NATO a Comiso presso il semi-abbandonato aeroporto. Avrebbe
accolto 112 missili Cruise a testata nucleare. Sarebbe diventato la più grande
base aerea d’Europa.
Pio
La Torre, segretario regionale del PCI..” “Negli ultimi anni
sono accaduti in Sicilia fatti gravissimi. Il potere mafioso ha rialzato la
testa e abbiamo assistito a una sequenza drammatica di omicidi politici
culminati nell'assassinio del presidente della regione, Pier Santi Mattarella.
Da quel momento si è accelerato il processo di degradazione della vita politica
e delle stesse istituzioni autonomistiche. Il già insufficiente apparato
produttivo dell'isola è duramente scosso dalla crisi economica, mentre lo Stato
si dimostra sempre più impotente di fronte alla violenza criminale e mafiosa
che ogni giorno semina terrore e morte. E come non vedere il pericolo che la
trasformazione della Sicilia in una gigantesca base di guerra spingerebbe alle
estreme conseguenze i processi degenerativi già così allarmanti?”.
(Articolo
di Pio La Torre apparso sull’Unità dell’11 ottobre 1981 con cui denunciava
chiaramente il collegamento fra sottosviluppo, mafia e missili).
Nella
regione erano attivi movimenti di protesta: il Centro Peppino Impastato aveva
promosso il comitato “Sicilia per la pace” che aveva organizzato una mostra
fotografica, una raccolta di firme e una serie di incontri nelle scuole
e il PCI
nella primavera del 1981 aveva proclamato una manifestazione che si sarebbe
svolta nell’ottobre successivo a Comiso. Ma era un movimento che mancava di un
vero e proprio coordinamento.
A
Comiso il sindaco socialista e gli assessori cercarono di convincere i comisani
che la militarizzazione avrebbe portato immensi benefici alla città come
ricchezza, benessere, posti di lavoro, commerci.
Il
presidente della regione, Mario D’Acquisto, “consultato” da Palazzo Chigi a
decisione già presa, e questo nonostante le sue prerogative istituzionali, non
protestò.
Un
ministro della repubblica, mantenendo l'anonimato, aveva seminato un certo
scompiglio raccontando ai giornalisti che il governo aveva tenuto per sei mesi
la scelta di Comiso nel cassetto, per un calcolo elettorale: aveva evitato così
che i partiti di sinistra, e in particolare i comunisti, facessero della lotta
antinucleare il cavallo di battaglia delle elezioni regionali che si erano
svolte in primavera. Fioccarono le smentite, ma i documenti del congresso americano confermarono
che in effetti la scelta di Comiso fu tenuta a lungo segreta. Già a partire dal
gennaio del 1981 gli Usa insediarono uno staff tecnico per soprintendere al sopralluogo
del sito. Comiso era stata preferita ad altre due basi del Mezzogiorno sia per
le migliori condizioni dei sistemi di collegamento e sia per la disponibilità
immediata di una vasta area demaniale che avrebbe evitato le lunghe procedure
di esproprio a danno di privati.Quando il Governo annunciò ufficialmente la
scelta di Comiso iniziarono le prime manifestazioni. A Comiso l’ex
sindaco Giacomo Cagnes, fondò il Cudip, il Centro unitario di iniziativa
pacifista che cominciò un lavoro di collegamento tra tutte le associazioni
pacifiste a antinucleari, anche europee. Le preoccupazioni crebbero il 19
agosto del 1981 quando durante un esercitazione militare della VI Flotta degli
Stati Uniti al largo del Golfo della Sirte, in Libia, vi fu uno scontro a fuoco
tra flotta americana e flotta libica. “Per mostrare i muscoli” a Gheddafi, il
Pentagono e la Casa bianca avevano voluto che le manovre aeronavali si
svolgessero in quel tratto di Mediterraneo che i libici considerano interno
alle proprie acque territoriali. Ci fu un duello aereo: i caccia americani
alzatisi in volo dalla portaerei Nimitz abbatterono due caccia libici. Quella
scintilla rischiò di infiammare il Mediterraneo, evocò improvvisamente lo
spettro di una guerra, che in quelle ore sembrò materializzarsi a poche decine
di miglia dalle coste siciliane, a mezz'ora di volo da Comiso. I dirigenti
libici pronunciarono frasi minacciose verso la Sicilia, definendo la progettata
base nucleare di Comiso una spina nel fianco del loro paese;
significativamente, aggiunsero che la Libia, per difendersi, non avrebbe
esitato a bombardare la Sicilia. Parole che fecero molta impressione perché
dimostrarono che gli oppositori della base non esageravano dicendo che i
Cruise, se pure puntati, secondo i piani della Nato, solo contro l'Unione
Sovietica e in funzione puramente difensiva, avrebbero cancellato ogni progetto
siciliano di collaborazione commerciale con i paesi del Nord Africa e del Medio
Oriente.
Sulla
base di queste preoccupazioni, il 7 settembre, Pio La Torre presentò alla
Camera dei Deputati una mozione con la quale chiese al Ministro degli affari
esteri e al Ministro della Difesa di “non
avviare la costruzione della base missilistica a Comiso […] specie dopo le
ultime positive offerte sovietiche per l’immediato avvio di trattative per la
moratoria nucleare in Europa” e chiedeva al Governo di fare la propria “parte
in positivo, affiancandosi a quei governi dei paesi europei che stanno premendo
sull’amministrazione americana perché si arrivi subito alla trattativa”.
Nelle
settimane e nei mesi successivi al suo ritorno in Sicilia, Pio La Torre ripeté
con martellante insistenza, in ogni occasione, la sua denuncia, arricchendola
di motivazioni nuove, suggestive, allarmanti. Il dirigente comunista si impegnò
a spiegare alla gente nei termini più semplici in quale modo la costruzione
della base avrebbe scatenato interessi mafiosi e avrebbe limitato la libertà di
tutti. Fu così, man mano che questo messaggio si diffuse, che il movimento
pacifista e il movimento antimafia si saldarono, dando vita a una ribellione
delle coscienze, a una mobilitazione di massa che, prima in Sicilia e quindi in
tutta Italia, avrebbe assunto dimensioni senza precedenti. “Due fatti accaduti nei giorni scorsi -
scrisse La Torre in un articolo pubblicato su Rinascita il 4 dicembre 1981 - gettano una luce sinistra sui gravissimi
pericoli che incombono sull’avvenire del popolo siciliano. Mi riferisco, in
primo luogo, a quanto si è appreso a proposito delle manovre militari con
esercitazione nucleare svoltesi nella Sicilia orientale e nel corso dei quali
si sono verificati alcuni incidenti con il ferimento di due militari. Questo episodio
ci fa intravedere come vadano al di là di ogni immaginazione le minacce che
l’installazione della base missilistica a Comiso fa gravare sulla Sicilia. Il
secondo fatto è la rentrée nella scena politica del ben noto Vito Ciancimino e
le grottesche dichiarazioni che ha pronunziato di fronte al congresso della DC
palermitana”. Al congresso
provinciale della Democrazia cristiana, riunito alla Zagarella, nel grande
albergo che fu degli esattori Salvo, aveva preso la parola Vito Ciancimino,
uomo allora molto discusso ma ancora libero, potente e influente nel suo
partito, rilasciando una dichiarazione di guerra armata contro il terrorismo.
Dalla tribuna congressuale, Ciancimino dichiarò: “Se
è vero, come hanno riferito i giornali, che nuclei armati di brigatisti sono
stati costituiti nella nostra terra, a questo punto noi, autentici interpreti
della coscienza e della fierezza, della passione, della storia, ma soprattutto
del coraggio del popolo siciliano, annunciamo con la chiarezza del sole della
nostra terra che non accettiamo provocazioni, non siamo disposti a tollerare
che i nostri figli, le nostre mogli, i nostri parenti, i nostri amici cadano
dilaniati da stragi in una piazza come piazza Fontana o in una stazione come
quella di Bologna. Questa è guerra bieca e vile. E chi ci chiama a combattere
con le armi, troverà armi e chi intende seminare morte troverà morte. Perché
noi siciliani vogliamo essere il baluardo insormontabile nella difesa della
democrazia e della libertà”. Quella frase minacciosa destò clamore e
inquietudine, perché molto si era ipotizzato e discusso, durante i tenebrosi
anni di piombo, di un sostanziale monopolio della violenza illegale in Sicilia
decretato e imposto dalla mafia. Questa barriera mafiosa, si credeva da più
parti, aveva impedito al terrorismo eversivo rosso e nero di manifestarsi
nell'isola. Le parole di Ciancimino, anche perché pronunciate da un uomo
circondato da una fama sinistra e notoriamente legato a interessi mafiosi,
sembrarono confermare quell'ipotesi. “Le cose dette da
Ciancimino – fu il commento di Pio La Torre nell'articolo per Rinascita
sopracitato - ripropongono acutamente la questione dell'utilizzazione, che
ancora oggi viene fatta in Sicilia, dal terrorismo mafioso quale strumento di
lotta politica al servizio di tenebrosi disegni reazionari”.
La
minaccia mafiosa “Sulla Sicilia
– proseguiva
La Torre - gravano oggi tre minacce: gli
effetti della crisi economica, il dilagare della violenza criminale e mafiosa e
il suo intreccio col sistema di potere egemonizzato dalla DC, e infine, la
trasformazione dell’isola in avamposto dello scontro tra i blocchi militari
contrapposti. […] È in queste condizioni che il governo italiano ha deciso
l’installazione a Comiso della più grande base missilistica d’Europa
trasformando così la Sicilia in un avamposto dello scontro atomico. Sorge,
pertanto, l’interrogativo angoscioso: quale destino si intende riservare al
popolo siciliano in un Mediterraneo già attraversato da tensioni e da focolai
di guerra estremamente pericolosi? La scelta di Comiso, all’estremo lembo sud
dell’Italia, ci dice che gli ordigni che vi si vogliono installare sono rivolti
verso Sud. È qui, infatti, che può scoppiare quella guerra atomica limitata di
cui parlano gli attuali governanti americani. La Sicilia, rischia, quindi, di
diventare bersaglio di ritorsioni in uno scontro che va ben oltre i confini e
la concezione difensiva del Patto atlantico ed è contrario agli interessi
nazionali. Va rilevato, inoltre, che se dovesse realizzarsi la decisione di
installare a Comiso la base dei missili Cruise si accentuerebbero tutti i
processi degenerativi delle stesse istituzioni autonomistiche. Ecco perché in
Sicilia, più che altrove, balza al primo posto l’esigenza di dare vita ad un
grande movimento per il disarmo e per fare del Mediterraneo un mare di pace.
Noi ci inseriamo nel grande movimento che si sta sviluppando in tutta Europa
con l’obiettivo di arrivare attraverso il negoziato a ridurre (fino all’opzione
zero) le basi missilistiche a Est e Ovest. In questo contesto chiediamo al
governo italiano di non dare inizio alla costruzione della base a Comiso. Il
successo eccezionale della marcia per la pace svoltasi a Comiso l’11 ottobre ha
dimostrato che questa impostazione conquista le coscienze dei siciliani, uomini
e donne, giovani e anziani, borghesi e proletari, al di sopra di ogni fede
politica e religiosa”.
Il
carattere unitario della protesta fu politicamente sottolineato dalle azioni
del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, il socialista Salvatore
Lauricella, che approvò un programma di iniziative unitarie e si fece promotore
della nomina del 1982 in Sicilia come “anno della pace”.
17
gennaio del 1982 il Pci siciliano aprì a Palermo i lavori del IX Congresso
Regionale. Nel corso del suo discorso d’apertura, La Torre sottolineò come
fosse d’obbligo continuare nella mobilitazione che sin lì aveva portato alla
creazione di numerosi Comitati unitari, alla organizzazione di numerose “manifestazioni nelle scuole, nei posti di lavoro, nei
quartieri delle grandi città e nei principali comuni”. “Abbiamo apprezzato la proposta del
Presidente dell’Ars, il compagno Lauricella, di fare del 1982 l’anno della pace
del popolo siciliano. […] Occorre chiamare il popolo siciliano a dire “no” a un
destino che, prima ancora di farla diventare bersaglio della ritorsione
atomica, trasformerebbe la nostra isola in un terreno di manovra di spie,
terroristi e provocatori di ogni risma al soldo dei servizi segreti dei blocchi
contrapposti. Ne trarrebbero nuovo alimento il sistema di potere mafioso e i
processi degenerativi delle istituzioni autonomistiche, mentre la Sicilia
sarebbe condannata alla degradazione economica e sociale. […] Tutte le
formazioni politiche, sindacali, culturali e religiose possono dare il loro
contributo”. La data fissata
per la nuova grande protesta nel territorio di Comiso fu il 4 aprile del 1982,
domenica delle Palme. La Torre marciò alla testa di un corteo formato da
centomila persone: una fiumana umana mai vista nella cittadina iblea,
appartenenti a vari gruppi, dalle Acli ai sindacati, dal PCI alla DC, giovani,
vecchi e ragazzi provenienti non solo dalla Sicilia, ma dall’Italia e
dall’Europa. Quasi centomila cittadini della provincia di Ragusa avevano
firmato la petizione popolare con la quale si chiedeva al governo di sospendere
i lavori di costruzione della base per agevolare così una ripresa delle
trattative di Ginevra sul disarmo e una più efficace legislazione antimafia.
Fra i cinque milioni di siciliani, quella petizione aveva ottenuto un milione di
firme; era una valanga umana che avanzava e minacciava di travolgere tutti gli
equilibri politici consolidati.
“La campagna –
spiega La Torre in un’articolo “Firmare per Comiso“, pubblicato postumo su
Rinascita del 14 maggio 1982 – tende a dare concreto sblocco positivo ad un
movimento che è andato crescendo in maniera impressionante nel corso dei mesi.
Chiedere al Governo la sospensione della costruzione della base a Comiso non è
una trovata propagandistica e tanto meno lo strumento per fare un po’ di agitazione.
[…] Quando nell’agosto scorso […] il Governo Spadolini fece la scelta di Comiso
per l’istallazione della base per i missili Cruise, nessuno si aspettava che in
Sicilia si sarebbe sviluppato un movimento di opposizione dell’ampiezza che via
via si è andato disegnando. […] Il movimento di lotta contro la installazione
della base è via via dilagato in tutta la Sicilia richiamando l’attenzione di
tutte le forze pacifiste italiane ed europee. […] Dopo un primo incontro
tenutosi nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, si è avuta la
partecipazione di ben quindici delegazioni europee e mediterranee alla
manifestazione del 4 aprile […]. Siamo impegnati in un grande movimento
unitario politico e di massa, non fuori o addirittura contro le istituzioni […].
La questione di Comiso sta diventando una bandiera di lotta per tutte le forze
di pace italiane ed europee: la sospensione della costruzione della base
missilistica a Comiso è una delle risposte urgenti che l’Italia può dare per
creare le condizioni più favorevoli alla ripresa e al successo del negoziato,
per salvare l’Europa dalla catastrofe della guerra atomica […]. Nei prossimi
mesi è previsto un susseguirsi di manifestazioni a carattere internazionale a
Comiso e a Palermo, ad iniziativa di organizzazioni politiche, culturali e
religiose”. Manifestazioni
a cui La Torre non potrà prendere parte. Rimarrà infatti vittima di un agguato
mafioso il 30 aprile dello stesso anno, insieme all’autista e compagno di
partito, Rosario Di Salvo.
Pio La Torre e Rosario Di Salvo
http://archivio.blogsicilia.it/linvasione-dei-100mila-nella-comiso-dei-missili
Riporto
un brano dell’orazione funebre tenuta da Enrico Berlinguer in Piazza Politeama
a Palermo il 2 maggio del 1982. “Pio La Torre
aveva compiuto la scelta di un ritorno, ben sapendo che si trattava della
scelta di un posto di lotta e di lavoro pieno di difficoltà […] Tutti hanno
visto in lui un grande animatore, un protagonista della battaglia per Comiso,
per stornare dalla Sicilia la terrificante minaccia della distruzione atomica,
per preservarne la pace. Per questo scopo, egli, da un lato ha saputo
mobilitare a fondo, ampliante, il Partito Comunista e gli strati popolari da
esso influenzati; per altro verso, ha ricercato il collegamento e l’unità con
altre forze politiche ed ideali, che, pur muovendo da impostazioni differenti,
convergono su questi obiettivi di pace: nel reciproco leale rispetto
dell’individualità e autonomia di ogni forza diversa”.
Pio La Torre
e Berlinguer
http://www.minimaetmoralia.it/wp/palermo-come-roma/
La
base fra il 1983 ed il 1988 fu quindi velocemente interessata da una notevole
somma d’investimenti per la realizzazione di gran parte delle infrastrutture
tra cui quelle progettate per lo stoccaggio delle testate nucleari.
Da quel momento fino agli accordi di Pace tra
USA e URSS del 1987, Comiso continuò ad essere il centro e meta della lotta da
parte di pacifisti di tutto il mondo.
https://www.peacelink.it/pace/a/40245.html
Pacifisti
che si accampavano ai margini del “Magliocco” conducendo vita comunitaria
mentre troupe televisive e giornalisti erano sempre presenti vicino alla base.
Nonostante
gli appelli di pace, i dibattiti anche nelle sedi istituzionali e l’impegno
dell’esercito pacifista, nel marzo 1984 giunse all’aeroporto la prima
batteria di 16 missili e fu dichiarata operativa.
Bunker
Bunker
Prima
di quel fatidico marzo 1984, nell’agosto e nel settembre 1983, in occasione dei
“blocchi nonviolenti” davanti ai cancelli dell’aeroporto, i pacifisti subirono
le rabbiose cariche delle forze dell’ordine.
I
pacifisti, chiamati dai comisani i “figli dei fiori”, nella loro filosofia
della non violenza erano andati avanti creando anche una vera e propria base
logistica.
I
manifestanti, che si erano ormai allontanati dai partiti, facevano parte dei movimenti nonviolenti
italiani storici: Movimento Non violento, il Movimento Internazionale per la
Riconciliazione, la Coop. Campo Internazionale per la Pace e il Movimento
Internazionale delle donne che presero il nome di “La Ragnatela”.
I
pacifisti acquistarono accanto alla base due terreni: la Verde Vigna e la
Ragnatela.
Il
terreno della “Regnatela” fu espropriato per la ricostruzione della pista dell’aeroporto
civile e le donne del movimento ricevettero un rimborso che fu utilizzato a
sostegno di attività per la pace di altri gruppi di donne.
La “Verde
Vigna”, fabbricato e il terreno di 9630 mq, fu acquistato con i fondi
dell’obiezione di coscienza alle spese militari (OSM) delle campagne 1982/83 e
mediante la campagna d’acquisto di un metro quadrato che coinvolse centinaia di
persone per un totale di ben 989 proprietari.
Questa
operazione riuscì ad impedire l’allargamento della base militare e questo in un
periodo in cui il movimento della pace era mobilitato contro il cosiddetto
“equilibrio del terrore” che rischiava di portare il mondo in un nuovo conflitto. Nato e Patto
di Varsavia si confrontavano disseminando l’Europa di missili nucleari.
Terreno che riuscì a superare anche i vari tentativi di
esproprio per la nuova costruzione della pista. Troppo difficile, quasi
impossibile, poter contattare il migliaio di proprietari sparsi in tutto il
mondo.
I
pacifisti locali (di Comiso, Ragusa, etc), fra i quali multi-proprietari e/o
che hanno convissuto portando avanti lavori di sistemazione abitativa e
agricola, sono ancora presenti e hanno formato un gruppo che desidera attrezzare
la Verde Vigna a centro di documentazione e formazione. Inoltre si intende promuovere un modo di vita alternativo,
non consumistico, incoraggiando energie dolci e l’agricoltura biologica.
Fra
i pacifisti un grande uomo, il monaco buddista Morishita Gensko, che con il suo canto
accompagnato dal suono di un tamburello
battuto a ritmo regolare, si schierò davanti ai cancelli della base, a fianco
dei pacifisti, e si stendeva con loro a terra per impedire l’ingresso nella
base degli automezzi che trasportavano i missili. Morishita non è più andato
via da Comiso ed costruì una Pagoda che è chiamata la “Pagoda della Pace”, sita
in contrada Canicarao, e dall’alto della collima prega per la pace del mondo.
http://www.davidemoltisanti.com/namu-myo-ho-ren-ge-kyo/
http://www.route121.org/2018/04/pagoda-della-pace-uno-dei-pochi-tempi.html
http://www.cosmoibleo.com/it/monumenti/comiso-la-pagoda-della-pace/
I
comisani alla fine si rassegnarono e accettarono i Cruise fino a quando il
grande Michail Gorbaciov nel summit di Washington firmò il trattato per la
messa al bando delle forze nucleari a raggio intermedio.
I
missili furono tolti grazie all’accordo INF (Forze Nucleari Intermedie) tra
Reagan e Gobaciov.
Gli
storici affermarono che l’accordo INF fu raggiunto grazie alla presenza dei
missili a Comiso e anche le dichiarazioni di Gorbaciov, ben documentate
(Wittner, New York), dimostrarono il ruolo fondamentale che ebbero le lotte non
violente in Italia e anche in altri paesi.
Il
26 marzo 1991 venne rimossa l’ultima batteria di missili da crociera e la base
venne chiusa. Erano allora visibili i bunker, oggi forse spariti per la
creazione del nuovo aeroporto, che accolsero le testate nucleari.
La
base lentamente tornò alla normalità, fu smilitarizzata e dopo breve tornò alla
ribalta internazionale diventando nel 1999 centro di accoglienza per 5.000
kosovari in fuga dall’ennesima guerra. Una guerra scoppiata in modo duro e
cruento nell’ex Jugoslavia. Alla fine della guerra ritornarono in patria e
l’aeroporto fu nuovamente abbandonato…. Ricordo una vero e proprio paese in
quell’immensa base.
I
lavori dell’odierno aeroporto, intitolato dal 7 giugno 2014 a Pio La Torre,
iniziarono il 23 ottobre 2004 e furono completati nel marzo 2007. Nacque dalla
preziosa collaborazione istituzionale fra l’ENAC, Regione Siciliana ed il
Comune di Comiso. Molti edifici della vecchia base furono demoliti e venne creata una pista lunga 2,538
km.
Fu
inaugurato il 30 maggio 2013 e da quel giorno ha sempre più ampliato le sue
rotte.
Gestito
dalla “So.A.CO. S.P.A.” – Società Dell’Aeroporto
di Comiso “Pio La Torre”.
“Aeroporto
degli Iblei” –
Destinazioni:
-
Dusseldorf – Weeze;
-
Dublino;
-
Milano Malpensa;
-
Bruxelles Charleroi;
-
Francoforte Hahn;
-
Roma Fiumicino;
-
London Stansted;
-
Pisa;
-
Milano Linate.
http://www.aeroportodicomiso.eu/it/voli-it/destinazioni-it
https://www.sicilyrentcar.it/autonoleggio-comiso-aeroporto/
Un
passo decisamente importante per Comiso e per la Provincia di Ragusa. Luoghi
che offrono scenari di cultura eccezionali ma è anche vero che le vicine
Province di Enna, Caltanissetta e Agrigento hanno la possibilità di usufruire
dell’Aeroporto di Comiso per un ulteriore sviluppo turistico.
-----------------------------------
-
L’Aeroporto di Gerbini - Ferrovia Catania Palermo – Eugenia Corsaro,
di 12 anni, martire della resistenza catanese, sabotò da sola la base – Le
catanesi, Martiri della Resistenza, dimenticate - Lo zuccherificio di Motta Sant’Anastasia –
Sentenza del Consiglio di Stato – Zuccherifici nel Meridione - Carburante dall’alcole in epoca fascista (la
tesi di un laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania, nel
1940) – Il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania e dell’Alto Simeto –
Geometra Sciuto Sebastiano, n. 62 dell’Albo dei Geometri di Catania
La
base di Gerbini era una struttura militare della Regia Aeronautica e fu usata
durante la seconda guerra mondiale sia dagli arerei italiani che dai tedeschi
della Luftwaffe. Si trovava in contrada Gerbini di Paternò, nella Piana di
Catania a circa 22 km ad ovest della città.
La
base era costituita da una serie di campi agricoli che furono sistemati in
piste di atterraggio e parcheggi. La base era distinta in due settori distinti,
Gerbini Nord e Gerbini sud ed era servita dalla stazione ferroviaria di Gerbini
senza considerare che a pochi km è presente anche la Stazione ferroviaria di
Monta Sant’Anastasia.
Le
fonti storiche riportano che la pista, lunga circa 1 km, fu adoperata per gli aerei in missione su
Malta e per colpire i convogli navali britannici nel Mediterraneo.
Fino
al 1941 vi fu di stanza il 37° Stormo e nel 1942 diventò la base del 132°
Gruppo Autonomo Aerosiluranti al comando del capitano, poi maggiore, Carlo
Emanuele Buscaglia con la 278°
Squadriglia e la 281° Sq.
Fu
anche la base di alcuni aerei tedeschi. Appartenevano a Gerbini anche i campi
satelliti di San Salvatore (Scordia), Finocchiara, Signonella e Spina Santa.
Dopo
l’entrata in Sicilia delle truppe alleate, nel luglio 1943, la base fu occupata
proprio dalle truppe alleate che l’adoperarono per la loro avanzata verso il
continente.
FOTO DI: REDDOG1944.COM
Sono
presenti delle casematte e due di esse si trovano nel territorio di Motta Sant’Anastasia
di cui una è a due piani ed è visibile dalla strada per andare alla base di
Sigonella subito dopo il passaggio a livello. Attorno all’aeroporto erano
presenti tutta una serie di piste satelliti.
https://www.freeforumzone.com/lofi/IDENTIFICAZIONE-LUOGHI-Carri-Armati-SICILIA-1943/D9424272-6.html
La traduzione di quanto scritto nell'immagine dice:
Campi di volo di Gerbini (nota 39: Wenk, Intervista del 6 ottobre 2006; Hinsley et al., Lo spionaggio britannico nella Seconda guerra mondiale, volume III, parte 1, pag. 84)
La base più importante della Luftwaffe ed FW-190 in Sicilia era l'insieme degli aeroporti vicino Gerbini, sul lato est dell'isola. Era costituita da un aeroporto principale, che aveva una vera e propria pista, e molti campi di volo satelliti che si trovavano a distanza di pochi chilometri. Gerbini aveva nove setelliti dalla fine di giugno, ed altri tre furono aggiunti nei primi giorni di luglio, con altri in fase di sviluppo quando gli Alleati invasero la Sicilia. L'aeroporto di Catania fu anche usato dalle unità di FW-190 tra maggio ed i primi di giugno del 1943. Un pilota che operava su uno dei campi satelliti di Gerbini nell'estate del 1943 diceva: "Gerbini era un aeroproto che era collocato sostanzialmente in un piano erboso, con alberi che crescevano lungo i lati. Stavamo in semplici baracche. Faceva molto caldo e c'era un'alta probabilità di contrarre le pulci. Questo è il motivo per cui invece prendevamo le nostre coperte e le appendevamo tra gli alberi per dormire. ... L'aereo era collocato tra gli alberi ed era coperto con vegetazione: non avevamo reti mimetiche.".
Campi di volo di Gerbini (nota 39: Wenk, Intervista del 6 ottobre 2006; Hinsley et al., Lo spionaggio britannico nella Seconda guerra mondiale, volume III, parte 1, pag. 84)
La base più importante della Luftwaffe ed FW-190 in Sicilia era l'insieme degli aeroporti vicino Gerbini, sul lato est dell'isola. Era costituita da un aeroporto principale, che aveva una vera e propria pista, e molti campi di volo satelliti che si trovavano a distanza di pochi chilometri. Gerbini aveva nove setelliti dalla fine di giugno, ed altri tre furono aggiunti nei primi giorni di luglio, con altri in fase di sviluppo quando gli Alleati invasero la Sicilia. L'aeroporto di Catania fu anche usato dalle unità di FW-190 tra maggio ed i primi di giugno del 1943. Un pilota che operava su uno dei campi satelliti di Gerbini nell'estate del 1943 diceva: "Gerbini era un aeroproto che era collocato sostanzialmente in un piano erboso, con alberi che crescevano lungo i lati. Stavamo in semplici baracche. Faceva molto caldo e c'era un'alta probabilità di contrarre le pulci. Questo è il motivo per cui invece prendevamo le nostre coperte e le appendevamo tra gli alberi per dormire. ... L'aereo era collocato tra gli alberi ed era coperto con vegetazione: non avevamo reti mimetiche.".
L'aeroporto di Catania, fotografato dall'alto nel 1943.
I campi che ospitarono la base oggi sono fertili terreni agricoli e
agrumeti. Ricordo di aver rilevato diversi agrumeti nella zona di Gerbini tra
cui un vasta coltivazione di pompelmi. Sono rimasti dei piccoli muretti
paraschegge che sorgevano accanto ai parcheggi degli aerei e un tratto della
pista in macadam di Gerbini Nord. Nei pressi dell’ex base Gerbini c’è oggi Sigonella,
la base aerea che ospita il 41° Stormo A.S. “Athos Ammannato” ( pilota della regia Aeronautica
decorato con la Medaglia d’oro al valore militare ed alla memoria) dell’Aeronautica
Militare Italiana. Nella base è stanziato anche personale militare e civile
della Marina Militare USA in appoggio alla 6a Flotta Americana del
Mediterraneo.
Inaugurazione Base
di Gerbini
Bombardamento
della base aerea di Gerbini
Gerbini – Un
pilota italiano e un maggiore di Marina del Giappone
Vicino
all’aeroporto c’è la Stazione ferroviaria di Gerbini, stazione intermedia della
linea Catania-Palermo.
La
stazione di Gerbini fu costruita nell’ambito della linea ferrata che collega Palermo,
Agrigento e le stazioni interne della Sicilia con Catania e Messina. Un
collegamento importante soprattutto con Catania per la presenza del Porto che
consentiva il commercio dello zolfo proveniente dall’area centro-orientale
dell’isola. La stazione venne costruita in prossimità della strada statale
SS192, nel comune di Paternò, molto distante da ogni centro abitato ma vicino
proprio all’aeroporto militare di Gerbini. La stazione fu inaugurata nel 1870 in
concomitanza con l’apertura dell’esercizio della tratta. In passato ha avuto un
ruolo di una certa importanza ai fini della circolazione ferroviaria fino a
quando la linea era esercitata a Dirigenza Unica in quanto stazione presenziata
da un Dirigente Movimento. Dalla metà degli anni ottanta diventò impresenziata
ed esercitata in telecomando dal DCO.
La
stazione di Motta si trova sempre sulla linea ferroviaria Catania –Palermo.
Venne costruita nell’ambito del progetto di costruzione di ferrovie realizzato
prima dalla Società “Vittorio Emanuele” e poi proseguito con la “Società per le
Strade Ferrate della Sicilia”. La stazione venne costruita nella Piana di
Catania, molto distante dal centro di Motta S.A e in prossimità della SS 192.
Fu inaugurata nel 1870 con l’apertura della tratta Palermo –Catania. Una
stazione importante soprattutto con lo sviluppo agrumicolo della Piana di
Catania.
Diventò
stazione di diramazione quando fu costruita la linea per Regalbuto inaugurata
nel 1934, fino a Schettino e solo il 4 febbraio 1952 venne aperta la tratta
fino a Regalbuto.
Negli anni '50 una ALn56 serie 1000 sosta nella
stazione di Regalbuto
La
linea per Regalbuto fu chiusa nel1986.
La
diminuzione del traffico e la chiusura della linea per Regalbuto ridussero l’importanza
della Stazione di Motta e nel 2005 assunse la funzione di posto di movimento
per essere il 17 settembre del 2006 nuovamente ritrasformata in stazione.
La
stazione, forse anche per la sua posizione in aperta campagna, non ha mai avuto
un elevato traffico di viaggiatori. L’orario ferroviario del 18 novembre 1938
riportava la fermata di 4 coppie di treni locali e di una coppia di treni
diretti (Catania – Palermo). Nel 1975 l’offerta di servizio riportava la
fermata di 8 treni provenienti da Catania ( tra cui un espresso e tre diretti)
e 5 provenienti da Palermo o Agrigento. Nel 1981-83 prevedeva la fermata di 11
treni viaggiatori provenienti da Catania e di 8 provenienti sempre da Palermo o
Agrigento. C’era naturalmente anche la fermata per i viaggiatori da e per
Regalbuto prima che la linea venisse soppressa. Il traffico merci era invece
molto consistente per i prodotti agricoli (ortofrutticoli, in particolare
agrumi). Agli inizi degli anni ottanta anche il traffico merci si è ridotto
soprattutto dopo la chiusura della stazione di Carcaci. Nel 1995 si prevedeva
solo un treno merci da Messina e due tradotte in arrivo da Catania e una sola
tradotta per Acireale in senso inverso e con effettuazione periodica.
Stazione di Motta sant'Anastasia (Ct)
EUGENIA CORSARO
Gerbini
ha una martire della Resistenza dimenticata da tutti…
Eugenia Corsaro…
la dodicenne invisbile che sabotava la Luftwaffe nazista.
In
uno straordinario articolo di Gabriele Ruggieri, del 25 aprile 2016, si
rievoca questa figura strappata alla vita nel momento della sua
gioventù.
Il
partigiano Nunzio Di Francesco, originario di Linguaglossa e detenuto nel campo
di concentramento di Mauthausen, la definì “la più giovane martire della
Resistenza italiana”.
Fu
giustiziata dai soldati nazifascisti mentre tentava di tagliare i fili della
corrente elettrica nella base aerea di Gerbini (Catania).
Il
Di Francesco era riuscito a superare la prigionia a Mauthausen e aveva fatto la
guerra di liberazione nelle Brigate Garibaldi in Piemonte fino alla sua cattura
dai nazisti.
Raccontò
l’episodio di Eugenia Corsaro ad Angelo Sicilia, direttore artistico della
Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo ed autore dell’opera “Testimonianze
Partigiane”.
Nell’opera
c’è la storia della Resistenza Catanese ed Eugenia Corsaro, quasi estromessa e
sconosciuta per i suoi dodici anni, occupa un ruolo importante a fianco delle
altre eroine catanesi.
“Essendo
piccola di statura, raccontò Sicilia, Eugenia era quasi invisibile alle
sentinelle naziste. Il suo compito era quello di tranciare i fili elettrici che
portavano la corrente elettrica all’aeroporto militare di Gerbini. Da qui si
alzavano in volo gli aerei della temuta Luftwaffe tedesca per le azioni
militari su Malta e sulle navi britanniche nel Mediterraneo”.
In
quei tempi la resistenza siciliana operava con diversi gruppi organizzati. Uno
di questi agiva nella zona della base aerea con diverse azioni di sabotaggio ai
danni dell’avamposto nazifascista messe a segno spesso dalla Corsaro che a soli
12 anni mostrava un gran coraggio.
Durante
una di queste operazioni fu scoperta dai nazisti che, dopo averla catturata, la
giustiziarono sul posto.
Un atto eroico da
parte di uno dei tanti personaggi sconosciuti che la nostra storia ci riserva.
Una
rappresentante della Resistenza che prese le basi proprio dall’isola, grazie al
sacrificio di tanti cittadini.
«Sappiamo da fonti
scritte e orali che i nazisti causarono centinaia di stragi nell'Italia
continentale
- conclude lo scrittore - ma in
realtà la stagione delle stragi la iniziarono in Sicilia. La divisione
corazzata Goering, che causò
decine di eccidi, specie in Toscana, cominciò questo tragico rituale in
Sicilia. A Mascalucia,
con quattro civili uccisi e a Castiglione
di Sicilia, dove i morti furono sedici». E ancora prima dello
sbarco degli alleati tante furono le ondate di arresti e deportazioni «al
confino e sulle isole, come a Ventotene o addirittura in Africa. E tanti i
sacrifici di piccoli eroi comuni come Eugenia».
I
documenti di archivio dell’UDI (Unione Donne Italiane) di Catania rilevano i
nomi e le storie di 15partigiane
catanesi: Beatrice Benincasa, Giuseppa Castorina, Nunzia
Ciraldo, Eugenia Corsaro, Graziella D’Amico, Francesca Gazzo, Maria Giudice,
Graziella Giuffrida, Maria Grillo, Frida Malan, Agata Malerba, Francesca
Mancuso, Carmela Mangiù, Giuseppa Marchesa, Elvira Miano, Milizza Monastra,
Rosa Mollica, Franca Pennisi, Grazia Privitera, Grazia Risiglione, Rosa Vanni.
Il ruolo delle donne non era solo
quello di mere combattenti o staffette: tenevano sempre alto il morale degli
uomini con iniziative marcate da una sensibilità propria delle donne. Così
descrive le partigiane la curatrice e organizzatrice della mostra Maria Nunzia
Villarosa, funzionaria archivista dell’Archivio di Stato. Nei pacchi da inviare
alle brigate, continua Maria Nunzia, le donne mettevano sempre dei libri di
lettura e nell’inverno del ’44 organizzarono il Natale partigiano, aggiungendo nelle
“buste della spesa” dei pacchetti regalo.
Accomunate
dalla speranza di non dover mai
uccidere un nazifascista, da tutte le testimonianze delle
partigiane emerge un approccio alla resistenza volto ad una lotta non violenta,
senza armi nè scontri fisici, ma con una sviluppata capacità di dissimulare,
nascondere e confondere.
Lo Zuccherificio di Motta Sant'Anastasia
L’aeroporto
di Gerbini fu anche costruito per la sua vicinanza alla Stazione ferroviaria di
Motta Sant’Anastasia. Vicino alla stazione l’ex zuccherificio di Motta
Sant’Anastasia.
Una
struttura non so se ancora oggi esistente e che negli anni 70 era circondata da
rigogliosi agrumeti.
Alcuni
cittadini di Motta mi riferirono che lo zuccherificio fu realizzato prima della
guerra per coltivare nella Piana di Catania la barbabietola da cui estrarre lo
zucchero. Non so se ciò sia vero perché mancano riferimenti storici ben
precisi.
La
sua attività fu molto importante per l’economia agricola della zona ma poi la
guerra e finì con l’essere utilizzato come campo di prigionia per le persone da
deportare sempre tenendo in considerazione una sua costruzione in epoca
fascista.
Finita
la guerra … la triste decisione risalente agli anni sessanta…. Chiusura perché
antieconomico !!!!!! Alle spalle della drastica decisione di chiusura ci fu
probabilmente l’obiettivo degli industriali di concentrare la coltivazione
della barbabietola nelle zone della Pianura Padana.
Il
manifesto contro la chiusura dello stabilimento, in cui lavoravano molti
cittadini di Motta S.A. e che aveva
ripreso a funzionare da appena 4 anni dalla fine della guerra, fu firmato da
varie organizzazioni ed è emblematico di una situazione tipica della Sicilia….
In
realtà non si sa molto su questo stabilimento perché molti lo indicano come
“birrificio” altri come “consorzio” e altri ancora….”granaio”.. sembra quasi
che si sia voluta perdere la memoria storica di questo importante edificio dove
aveva sede un’attività di lavorazione che era una delle più importanti del sud
Italia.
Ci
sono delle testimonianze storiche del sig. Francesco Catania di Motta
Sant’Anastasia (1920) che narra la storia delle deportazioni durante il periodo
della guerra e cita anche il zuccherificio.
Catania Francesco
nato a Motta Sant’Anastasia l’8/8/1920
Data d’ Internamento
: 15 Ottobre 1943
Motivo : IMI
(Militare Italiano Internato)
Luogo di
Internamento (campo):
Stalag Stalag
XVIID (398) – Pupping Linza (Austria)
Numero prigioniero
: 7040
Tipo di Lavoro
coatto: Miniera
(ANRP – ITS – Archives Bad Arolsen: ITS/KLD/ Hoppergarten
----------------
Luogo di
Internamento (campo): Campo per lavoratori coatti non individuato
Tipo di lavoro
coatto: Lavori di campagna – zuccherificio – segheria
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelo Alfonso, nato
ad Agrigento, 06/gennaio/1920
Data di
Internamento: Settembre 1943
Motivo: IMI
(Militare Italiano Internato)
Luogo di
Internamento (Campo): Stolag XB/Z Wietzendorf
Numero
prigioniero: 174178
(ANRP- ITS- …)
-----------------
Luogo di
Internamento (campo): Kaserme Salzwedel
Tipo di Lavoro
coatto: zuccherificio
Luogo di lavoro
coatto: (impresa) Zuckerfabrik Salzwedel
----------------
Data di
Internamento : 6 gennaio 1944
Luogo di
Internamento (campo) : Vecchio Teatro Strobeck Halberstadt
Tipo di lavoro
coatto: Muratore
Luogo di lavoro
coatto: (impresa) Maurer Fritz Schandenberg &Arthur Schmidt
-----------------
Luogo di
Internamento (campo): Italiener –Hotel zur Tanne Wegeleben Halberstadt
Tipo di Lavoro
coatto: Fabbricazione Ali per Aerei
Luogo di lavoro
coatto: (impresa) Junkers Flugzeug-und Motorenwerke AG
(ITS – Archives Bad Arolsen Doc. NO. 70952655#1,
ITS/KZD/2.1.4.1., ORDNEr 43; Namensliste der Stadt Wegeleben Italiener
Hotel zur Tanne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo
stabilimento sorgeva in contrada Piraino a sud ovest della Stazione Ferroviaria
di Motta Sant’Anastasia.
Non
ci sono riferimenti storici in merito alla costruzione dello zuccherificio. Si
tramanda che nello stabilimento furono deportati dai nazisti i prigionieri di guerra prima dei loro
trasferimenti nei campi di concentramento in Germania.
Lo
stabilimento fu costruito dalla Società “Siciliana
Zuccheri” nel 1955 Probabilmente
durante la seconda guerra mondiale nell’area del futuro zuccherificio doveva
esserci un capannone, probabilmente collegato all’utilizzo dell’adiacente
Stazione Ferroviaria di Motta Sant’Anastasia, o un piccolo zuccherificio,
costruito in epoca fascista, e che fu utilizzato successivamente come
temporaneo luogo di detenzione dei prigionieri di guerra.
In
quest’ultimo caso la Società “Siciliana Zuccheri” probabilmente ristrutturò il
vecchio zuccherificio per dare inizio a un ciclo di produzione più moderno.
Non
sono riuscito a trovare altre notizie storiche sul zuccherificio di Motta S.A.
anche se anni fa, nella mia attività di topografo, rilevai alcuni capannoni
dell’industria in completo abbandonato che dovevano essere sottoposti a vendita
giudiziaria. Ricordo una persona che mi rilevò come l’antico zuccherificio
fosse un azienda fiorente dove vi lavoravano circa 500 persone in ciclo continuo e in un capannone vidi una
serie di turbine per la produzione di energia.
Ho
trovato un antico documento giuridico risalente al 25 febbraio 1963 e che cita
lo zuccherificio di Motta Sant’Anastasia in una vertenza risalente al… 1960
quando l’azienda era ancora in attività o stava per cessarla.
Si
tratta di una sentenza del Consiglio di Stato
sulla decisione su tre ricorsi presentati nel 1960 dalla:
Compagnia
Industrie Saccarifere S. Eufemia Lamezia (C.I.S.S.E.L.)
Contro
Il Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste e il Ministero della Industria e del Commercio
nel 1° ricorso;
Contro gli stessi
Ministeri e i Prefetti di Cosenza, Matera e Taranto, nel 2° ricorso;
Contro gli stessi
Ministeri e il Prefetto di Catanzaro, nel 3° ricorso
E Nei Confronti
Nel 2° ricorso –
la SpA “Zuccherifici Meridionali”
Con sede legale a
Policoro e sede amministrativa e commerciale in Milano;
nel 3° ricorso –
della Società “Siciliana Zuccheri”
zuccherificio di
Motta Sant’Anastasia
non costituito in
giudizio
Per l’Annullamento
Il 1° ricorso del
decreto con il quale era stato adottato il piano di coltivazione
della barbabietola
da zucchero per l’annata agraria 1959/60;
2° ricorso, contro
i provvedimenti ministeriali nonché dei decreti dei
Prefetti di
Taranto, Matera, Cosenza con i quali venivano ripartiti tra
la C.I.S.S.E.L. e
la Società “Zuccherifici Meridionali” i contingenti di
barbabietola per
l’annata agraria 1959/60;
3° ricorso, contro
il provvedimento contenuto nel telegramma del
Ministero
dell’Agricoltura nel quale si disponeva tra l’altro che sul
contingente di
2.200.000 q.li di barbabietole attribuiti alla
prov. di
Catanzaro, 300.000 q.li vengano destinati alla
Zuccherificio di Motta Sant’Anastasia e del conseguente
decreto del
Prefetto di
Catanzaro.
La Sentenza:
in conseguenza dei
principi dianzi svolti, i ricorsi debbono essere perciò
accolti, con
l’annullamento degli atti impugnati, salva la dichiarazione
di cessazione
della materia del contendere per i provvedimenti che in
pendenza di
giudizio sono stati annullati d’ufficio.
Il Consiglio di
Stato con ordinanza Plenaria….
Dichiara cessate
la materia del contendere sui decreti del Prefetto di Cosenza
e del Prefetto di
Matera.
Accoglie i ricorsi
contro tutti gli atti impugnati, che annulla.
Il
zuccherificio di Motta Sant’Anastasia era uno dei più importanti del martoriato
meridione d’Italia anche se quello di Lamezia risaliva al 1941 ed era da circa
15 anni che svolgeva la sua attività.
Lo
zuccherificio di Policoro (“Zuccherifici Meridionali”) risaliva al 1955 cioè lo
stesso anno dello stabilimento di Motta S.A.
Nello
schedario dei Zuccherifici Italiani
Nel
1960
-
N.
48 – Cirio – Capua – Napoli – (costruito nel 1937)
-
N.
57 – C.I.S.S.E.L. Villanova – S.Eufemia Lamezia - CZ
-
N.
65 – Siciliana Zuccheri – Motta Sant’Anastasia – CT;
-
N.
66 - Zuccherifici Meridionali – Policoro
– MT;
-
N.
68 – Italiana Industria Zuccheri – Rendina – Potenza (costruito nel 1959)
-
N.
70 – CISSEL – Strongoli – Catanzaro (costruito nel 1959)
-
Gli
Zuccherifici in attività in Italia sono 75
Nel
1974
-
N.
29 – Cirio – Sacam - Capua
-
N.
36 – Zuccherifici Meridionali – Policoro – MT
-
N.
38 - Italiano Industria Zuccheri –
Rendina
-
N.
40 – ESAC-CISSEL – Strongoli - Catanzaro
-
N.
45 – Cavarzere Produzione Industrie – Incoronata - Foggia (costruito nel 1961)
-
N.
46 – Eridania – Rignano – Foggia (costruito nel 1962)
-
I
zuccherifici in Italia sono 58 (hanno cessato l’attività la CISSEL e la
Siciliana Zuccheri);
nel
1994
-
N. 13 – SFIR – Incoronata – Foggia (è l’unico
zuccherificio in attività nel Meridione d’Italia e in precedenza della Società
“Cavarzere Produzione Industrie”)
-
I
zuccherifici in attività sono 23.
Nel
2003
-
N.
3 – SFIR – Incoronata - Foggia
-
I
zuccherifici in attività…19
Nel
2006
-
Nessun
zuccherificio in attività nel Meridione d’Italia- La Società “SFIR” trasferì
l’attività da Incoronata a Pontelagoscuro (Ferrara) dove era in attività un
zuccherificio sin dal 1899.
-
I
zuccherifici in attività …6
Durante
il periodo fascista, fra il 1938 e il 1941, nell’Italia Meridionale sorsero tre
zuccherifici: Capua, Battipaglia e Sant’Eufemia Lamezia.
Il
governo fascista agevolava la produzione di alcool per carburante da
barbabietole, melasso e sorgo che fu effettivamente prodotto in piena guerra
nel 1942-43. Su 1600 tonnellate di melasso prodotto, 735 furono destinati alla
produzione di alcool per combustibile e il resto fu trasformato in zucchero,
alcool butilico, surrogati di caffè, lievito e glicerina.
Nel
1925, sulle pagine del quotidiano “Sole” e di altri giornali, il politico
Marescalchi auspicava che anche l’Italia doveva adottare provvedimenti analoghi
a quelli attuati dalla Francia e da altri Paesi. Suggeriva di destinare i
200.000 ettanidri (un ettanidro corrisponde a 100 litri di alcol anidro) di
alcool da melasso che servivano per la produzione di bevande alcoliche, alla
produzione di carburante e di lasciare all’uso alimentare solo l’alcol di
secondaria categoria cioè quello prodotto da vinacce, vino e frutta.
L’obiettivo
dell’indipendenza produttiva trovò un tipico riflesso anche in una tesi di
laurea del 1940.
Il
laureando Giuseppe Leonardi, della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Catania, nella dissertazione “La Coltivazione della barbabietola e l’industria zuccheriera in
Italia”, presentata nell’Anno Accademico 1939-40 (“l’ottavo dell’epoca fascista” come cita la dicitura del
frontespizio della tesi), con relatore il prof. Gustavo Cumin, dedicò il III
Capitolo al “Contributo della bietola
alla battaglia per l’Autarchia – Utilizzazione dell’alcole come carburante”.
Scrisse
con toni entusiastici che “.. dopo le obbrobriose
sanzioni ginevrine un imperativo si è posto al nostro paese: Produrre da sé ! Come
raggiungere questo scopo ? Con l’Autarchia. Autarchia è la parola in cui si
fonda la sicurezza e la vera indipendenza del Paese. Ogni ramo dell’attività
economica si è uniformato a questa parola di ordine. L’agricoltura, che
costituisce la branca principale della nostra economia, non poteva rimanere
estranea e la bieticultura che di essa è parte preponderante ha risposto in
pieno all’appello, dando, oltre allo zucchero come prodotto commestibile,
l’alcole come carburante”.
Un
dato deve lasciare riflettere sulla “voce attiva del bilancio Statale” perché nel 1939 il gettito totale dell’accisa
sullo zucchero fu di ben 1 miliardo e 200 milioni… una cifra che fu superata
solo dall’imposta sulla ricchezza mobile.
Volantino dei produttori di Barbabietole
La
creazione dello zuccherificio fu legata alla paziente e costante attività di bonifica idraulica e irrigua, che si
prolungò nel tempo, creando un polo agricolo tra i più importanti della Sicilia
e del Meridione.
Nel
dopoguerra la zona della Piana era soggetta a frequenti esondazioni, la
concentrazione delle precipitazioni erano collocate fra i mesi di Novembre e
Gennaio, che ricoprivano d’acqua circa 10 – 15 mila ettari di terreno. Era
preclusa, almeno fino a primavera, qualsiasi tipo di coltivazione e a questo
aspetto si aggiungeva il rischio, sempre presente, della malaria. Il disordino agrario era aggravato dalla
presenza del latifondo che impedivano qualsiasi razionale intervento di
sistemazione agraria.
C’erano
degli interventi di bonifica legati al prosciugamento di piccoli stagni e
paludi per motivi igienici sanitari e fu solo il promulgamento del R.D. del 13
febbraio 1933 n. 215 che l’attività dei nascenti consorzi di bonifica fu
regolarizzata e anche successivamente ampliata con opere di irrigazione, di
trasformazione fondiaria di pubblico interesse, di strade, canali, ecc.
L’attività
di bonifica, caratterizzata ora dall’ampliamento dei suoi obiettivi, determinò
la creazione di nuovi comprensori e accanto all’intervento diretto dello Stato,
che si era reso attivo attraverso i Geni Civili nella eliminazione dei
territori malarici, si formarono anche dei Consorzi di proprietari che fu
stimolata e accompagnata dall’Istituto Vittorio Emanuele III per la Bonifica
della Sicilia.
Nel
1940 si costituì in Sicilia l’”Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano”
con compiti di assistenza ai proprietari nell’opera di trasformazione agraria,
di vigilanza e di esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica. Con
l’istituzione di quest’Ente furono individuati ben 25 comprensori per una
superficie totale di oltre un milione di ettari.
A
partire dagli anni ’50 i comprensori
furono modificati in conseguenza dell’obiettivo raggiunto, il prosciugamento
delle zone paludose; della presenza dell’espansione urbana dei centri abitati che occupavano adesso
terreni in precedenza classificati di bonifica idraulica e delle nuove norme
sulla bonifica montana redatte dalla Regione Sicilia.
La
Regione Sicilia, con Decreto Presidenziale del 22 ottobre 1947 n. 588 “Costituzione del Comitato Provvisorio
Regionale per la Bonifica”, delegò al Comitato Regionale per la Bonifica il
compito di fissare le direttive e di coordinare quindi l’attività di bonifica.
Il
Comitato aveva una sua notevole
importanza sui viari piani operativi:
generali di bonifica, di riordinamento delle utenze irrigue, regolatori dei
bacini idrografici, di determinazione e di modifica dei perimetri dei
comprensori di bonifica.
Nel
1960 la superficie compresa nei perimetri consortili ammontava a circa 800.000
ettari e con il passare degli anni aumentò sempre più tanto che nel a974
raggiunse 1.300.000 ettari.
Dal
1950 l’attività dei Consorzi, che fu
spesso affiancata per l’intervento finanziario dalla ex Cassa del Mezzogiorno,
raggiunse risultati eccellenti con la costruzione di dighe, reti irrigue,
strade, linee elettriche, acquedotti rurali, sistemazioni idrauliche,
rimboschimenti, impianti produttivi, strutture di commercializzazione, ecc.
tutte opere che portarono ad una profonda trasformazione del paesaggio agricolo
ed alla formazione di medie e piccole imprese che davano lavoro.
Tre
furono i consorzi artefici con la loro operatività della trasformazione in
termini produttivi della Piana di Catania:
-
Consorzio
di Bonifica dell’Alto Simeto;
-
Consorzio
di Bonifica della Piana di Catania;
-
Consorzio
di Bonifica Alto Simeto – Bronte
-
-
tutti entrati accorpati con DP del 23 maggio 1997 al “Consorzio di Bonifica 9
di Catania” ed soppressi dall’Art. 2 dello stesso decreto.
È
nel periodo intorno agli anni ’50 che s’inserisce quindi la costruzione del
zuccherificio quando la zona fu interessata da ingenti opere idrauliche che
videro il loro completamento con la realizzazione di opere di adduzione,
ripartizione e distribuzione delle acque irrigue del Sistema Salso-Simeto e del
Sistema Ogliastro che nel complesso delimitavano un territorio irriguo di circa
53.000 ettari.
Si
creò un rete di canalette d’irrigazione che partendo dal canale principale di
quota 100 m s.l.m. si distribuiva sulla piana permettendo l’irrigazione.
canalette d'irrigazione
Di
questa rete irrigua, costituita da canalette in cemento, ben 700 km furono
tracciati, sempre partendo dal canale di quota 100 m, dal geometra Sciuto
Sebastiano inscritto all’Albo dei Geometri di Catania con il n. 63. Il padre
della topografia e con cui ho collaborato nel suo studio tecnico per oltre un
decennio.
La
qualità delle barbabietole prodotte, la vicinanza ad una stazione ferroviaria
permetteva la facilità del trasporto del
prodotto finito. Ma negli anni sessanta
fu decisa la sua chiusura perché forse le barbabietole dovevano essere prodotte
solo in Veneto. Ci fu allora una promessa ai lavoratori dello zuccherificio di
Motta S.A…. “lo stabilimento subirà una
conversione per la produzione di birra…con conseguente produzione di luppoli
nel territorio…!!!!”.
Non
so se sia vero ma sembra che uno stabilimento per la fabbricazione della birra
fu fatto anche con i finanziamenti dell’ex Cassa del Mezzogiorno. La presenza
delle fabbrica prevedeva una coltivazione estensiva del luppolo che non partì
anche perché non so se la coltivazione sia adatta all’ambiente siciliano…. La
fabbrica non iniziò nemmeno l’attività…
Concludo
la mia ricerca con una piccola citazione sugli zuccherifici di Lamezia e Strongoli.
La
loro vita è emblematica di un Meridione da sempre sfruttato e ingannato..
Lo
stabilimento della “CISSEL” (Compagnia Industrie Saccarifera Sant’Eufemia
Lamezia), edificato begli anni ’30 dai fratelli Massara che erano originari di
Limbadi (Vibo Valentia). Un vero gioiello produttivo… un milione e duecento
mila quintali di bietole lavorate in ogni stagione saccarifera… ventila
quintali di bietole lavorate al giorno….
Cento camion al giorno in arrivo nel piazzale per portare via lo
zucchero raffinato… ottocento litri di nafta bruciata ogni giorno per fare
funzionare l’impianto….Sembra quasi un bollettino di guerra… ma non è così….. è
un azienda che dà lavoro a ben 600 operai più l’indotto esterno
http://fattoadarte.corriere.it/2011/01/12/salvare_lo_zuccherificio_di_la/
Meridione : La vita è una
questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma
non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.













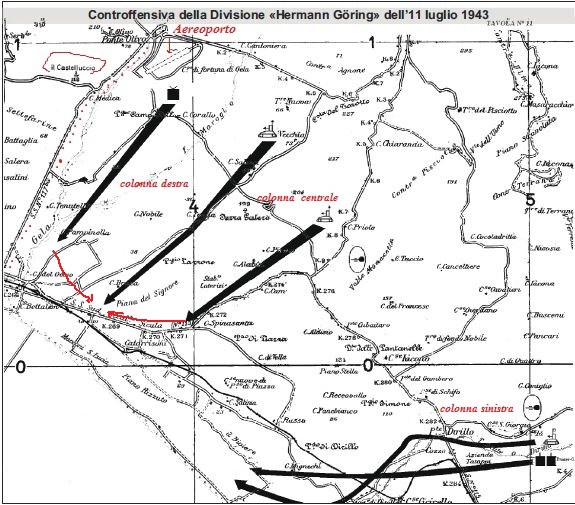














































































































Commenti
Posta un commento