Enciclopedia delle Donne (Sesta parte) - Le Poetesse Siciliane del Risorgimento
“Le donne
siciliane dei secoli passati spesso ci sorprendono.
Scivolano fuori
dalle caselle stereotipate in cui per pigrizia le rinchiudiamo,
spargono attorno a
loro indizi in attesa di qualcuno che sappia
raccontarne la
storia”.
........................................
Indice:
1.
Introduzione
La donna siciliana vista da Jean Pierre
Houel
L’Elenco delle Donne Siciliane del Risorgimento
Il Manifesto del 1848 delle Donne Siciliane contro l’oppressione
politica e sessista con la creazione della “dignità conforme” ovvero delle “pari
opportunità”.
2.
Rosina
Muzio Salvo – La Legione delle Pie Sorelle -
La collaborazione con importanti riviste pedagogiche – Alcune pubblicazioni poetiche e letterarie. –
Fu accusata con il principe Vergata di cospirazione.
3.
Giuseppina
Turrisi Colonna “La Rivoluzionaria” – La sorella Anna o Annetta, pittrice. Due
donne unite nella vita e nella morte, morirono a distanza di tre giorni l’una
dall’altra.
4.
Letteria
Montoro – Il suo romanzo storico “Maria Landini” –
5.
Concettina
Ramondetta Fileti - Poetessa di grande ispirazione, dotata di grande
sensibilità e di forti sentimenti patriottici.
6.
Lauretta
Li Greci – la sua poesia di grande spiritualità, morì all’età di sedici anni.
7.
Mariannina
Coffa – L’amore per il musicista Ascenzio Mauceri – Fu costretta a sposare il
ragusano Giorgio Morana – Fu definita la “poetessa maledetta” – Morì in misera
e solitudine.
-----------------------------------------
1.
Introduzione
Negli
anni settanta del XVIII secolo Jean Pierre Houel, nel suo Grand Tour, incontrò
a Girgenti (Agrigento) due nobili signorine che “sanno leggere e non
scrivere, per evitare che segretamente possano comunicare con gli uomini”.
Negli
stessi anni Patrick Brydone, viaggiatore scozzese, citò donne con maggiore libertà nel resto d’Italia e sulle “ serali
passeggiate alla marina, l’odierno Foro Italico, a luci spente per meglio favorire
gli intrighi amorosi”.
Nella
Sicilia dell’Ottocento la donna aveva un
posto inferiore nella società dove era emarginata, succube del marito e
costretta ad occuparsi solo di faccende domestiche.
Houel
riportò un avvenimento che lo colpì a tal
punto da riportarlo nel suo diario.
Il
viaggiatore francese si trovava ad Adrano e alloggiò a Paternò presso i cappuccini “qui fui ospite dei
frati minori”.
“Fui
ricevuto grazie all’invito di un religioso che incontrai appena arrivato ad
Adernò e che mi aveva riconosciuto per avermi visto in un altro convento del
suo ordine.
Questo
procedimento ricorda molto l’ospitalità degli antichi, i quali alle porte della
città pregavano gli stranieri di venire ad alloggiare presso di loro.
Il giorno seguente, che era una domenica, mi recai alla messa celebrata da quei bravi religiosi (ad Adrano): vidi delle persone conciate in maniera stranissima che correvano dall’altare maggiore alle cappelle laterali, facevano profonde genuflessioni e recitavano brevi preghiere. Stupito dal loro modo di vestire e dal loro andirivieni continuo, pensai in un primo momento che dovesse trattarsi di povere disgraziate; infatti, malgrado la singolarità dell’abbigliamento, riconobbi in queste figure delle donne, che, per espiare enormi peccati, vestite da penitenti, si rivolgevano a tutti i santi per trovarne uno benevolo. Seppi invece che si trattava di una manifestazione di devozione del tutto ordinaria, in quanto quelle brave donne sono persuase che più santi si pregano tutti insieme, più si guadagnano indulgenze e aiuti dal cielo. Seppi anche che quell’abito, che mi sembrava adatto a delle penitenti, altro non era che il palandrano, cioè il mantello col cappuccio dei loro mariti, che queste donne indossavano per andare a messa, poichè marito e moglie che devono avere tutto in comune, come si sa, hanno un solo vestito per tutti e due; chi resta in casa lo presta a chi esce e la domenica se lo scambiano a turno per andare in chiesa. Mentre ero tutto intento ad osservare quelle donne, ne vidi altre tutte avvolte in un lenzuolo bianco, le cui estremità erano attaccate e passate dietro nella cintura, mentre il resto pendeva fino all’orlo della sottana e risaliva fino alla testa. Si veda la figura cinque, dove si scorgono gli angoli inferiori del lenzuolo riportati davanti e fissati alla parte ripiegata e pendente, in modo che il vento non la sollevi. È così che queste donne vanno vestite sia in chiesa, sia quando escono per sbrigare qualche commissione; cosa che non capita spesso, perchè questo popolo povero, privo di tutto e senza cognizione nè desiderio di niente, ama solo il piacere di far nulla, il “dolce far niente”, come dicono gli italiani. Nessuno di loro uscirebbe dalla sua casupola se non lo spingesse la necessità di andare a messa e di procurarsi da mangiare. Sotto il lenzuolo o il palandrano, le donne hanno di solito i piedi nudi; la stessa ragione le spinge a fare a meno delle scarpe come del vestito: la più nera miseria.
Si racconta che quando la Sicilia era governata dai baroni, qualche secolo addietro, era così povera che in alcuni luoghi, e particolarmente ad Adernò, la plebe non aveva neanche di chè coprire la sua nudità; le donne per pudore non osavano più andare in chiesa. In quel periodo divenne baronessa di Adernò una donna assai dotata di sensibilità; non potendo vestire tutte queste poverette, fece dire loro, e lo proclamo’ in un editto, che una donna che uscisse di casa avvolta nel lenzuolo del proprio letto, sarebbe considerata vestita molto decentemente; che la regina bianca, madre di San Luigi, si vestiva sempre così; che, per togliere loro ogni scrupolo, essa stessa si vestirebbe col suo lenzuolo e che da allora in poi andrebbe così abbigliata a messa e alla processione nei giorni di festa. Fece come disse e tutte le donne della sua baronia si affrettarono ad imitarla. Non c’è bisogno di dire che si tratta di una favola: chiunque cada in miseria vende le lenzuola prima ancora dei calzoni o della gonna e un popolo miserabile dorme bene anche sulla nuda paglia”.
Il giorno seguente, che era una domenica, mi recai alla messa celebrata da quei bravi religiosi (ad Adrano): vidi delle persone conciate in maniera stranissima che correvano dall’altare maggiore alle cappelle laterali, facevano profonde genuflessioni e recitavano brevi preghiere. Stupito dal loro modo di vestire e dal loro andirivieni continuo, pensai in un primo momento che dovesse trattarsi di povere disgraziate; infatti, malgrado la singolarità dell’abbigliamento, riconobbi in queste figure delle donne, che, per espiare enormi peccati, vestite da penitenti, si rivolgevano a tutti i santi per trovarne uno benevolo. Seppi invece che si trattava di una manifestazione di devozione del tutto ordinaria, in quanto quelle brave donne sono persuase che più santi si pregano tutti insieme, più si guadagnano indulgenze e aiuti dal cielo. Seppi anche che quell’abito, che mi sembrava adatto a delle penitenti, altro non era che il palandrano, cioè il mantello col cappuccio dei loro mariti, che queste donne indossavano per andare a messa, poichè marito e moglie che devono avere tutto in comune, come si sa, hanno un solo vestito per tutti e due; chi resta in casa lo presta a chi esce e la domenica se lo scambiano a turno per andare in chiesa. Mentre ero tutto intento ad osservare quelle donne, ne vidi altre tutte avvolte in un lenzuolo bianco, le cui estremità erano attaccate e passate dietro nella cintura, mentre il resto pendeva fino all’orlo della sottana e risaliva fino alla testa. Si veda la figura cinque, dove si scorgono gli angoli inferiori del lenzuolo riportati davanti e fissati alla parte ripiegata e pendente, in modo che il vento non la sollevi. È così che queste donne vanno vestite sia in chiesa, sia quando escono per sbrigare qualche commissione; cosa che non capita spesso, perchè questo popolo povero, privo di tutto e senza cognizione nè desiderio di niente, ama solo il piacere di far nulla, il “dolce far niente”, come dicono gli italiani. Nessuno di loro uscirebbe dalla sua casupola se non lo spingesse la necessità di andare a messa e di procurarsi da mangiare. Sotto il lenzuolo o il palandrano, le donne hanno di solito i piedi nudi; la stessa ragione le spinge a fare a meno delle scarpe come del vestito: la più nera miseria.
Si racconta che quando la Sicilia era governata dai baroni, qualche secolo addietro, era così povera che in alcuni luoghi, e particolarmente ad Adernò, la plebe non aveva neanche di chè coprire la sua nudità; le donne per pudore non osavano più andare in chiesa. In quel periodo divenne baronessa di Adernò una donna assai dotata di sensibilità; non potendo vestire tutte queste poverette, fece dire loro, e lo proclamo’ in un editto, che una donna che uscisse di casa avvolta nel lenzuolo del proprio letto, sarebbe considerata vestita molto decentemente; che la regina bianca, madre di San Luigi, si vestiva sempre così; che, per togliere loro ogni scrupolo, essa stessa si vestirebbe col suo lenzuolo e che da allora in poi andrebbe così abbigliata a messa e alla processione nei giorni di festa. Fece come disse e tutte le donne della sua baronia si affrettarono ad imitarla. Non c’è bisogno di dire che si tratta di una favola: chiunque cada in miseria vende le lenzuola prima ancora dei calzoni o della gonna e un popolo miserabile dorme bene anche sulla nuda paglia”.
La
Sicilia diede ai moti risorgimentali numerose personalità non tutte ricordate
nei libri di storia. Fra queste figure molte erano donne umili e comuni, delle quali nessuno parla o ricorda
il loro notevole impegno se non in brevi momenti culturali.
Uno
dei tanti torti a danno delle donne ma anche all’oggettività della narrazione
storica che è spesso manipolata senza scrupoli cancellando importanti
tradizioni ed aspetti a vantaggio di comuni stereotipi spesso non rispondenti
al vero.
Per
un piccolo momento queste figure rivivranno, saranno ricordate grazie alla mia
ricerca. Non sono uno scrittore ma una semplice persona che ama comunicare gli
aspetti della mia amata Terra da cui spesso sono stato tradito. Le mie ricerche sono tratte in parte dal mio archivio e da internet con collegamenti a biblioteche, consultazioni di libri,
ecc. Gli spunti sono poi da me assemblati
in modo da dare un quadro quanto più possibile completo di ogni singolo personaggio, avvenimento storico o luogo. Quadro che potrà essere poi ampliato da un
ipotetico lettore. Sono stato accusato di copiare… naturalmente le mie ricerche
sono tratte da lavori svolti da studiosi che grazie al mio studio saranno divulgati ulteriormente evitando che si
perdano nella giungla di internet. La cultura non ha prezzo e non è un monopolio.......
Scusandomi
per questa piccola divagazione riporterò nella ricerca alcune figure femminili
che agli ideali del Risorgimento diedero linfa, sacrifici e qualcuna anche la
vita. A causa della sua condizione di donna emarginata.
“Né trastullo ne servo il nostro sesso/col forte salga a dignità conforme”
“Basta con il vecchio e noioso titolo di bel sesso. Vogliamo uguali
diritti”
diceva la giovane poetessa Giuseppina Turrisi Colonna
in una frase riportata nella sua “Ode alle donne siciliane” con la quale
incitava le conterranee ad un risorgimento politico e della loro condizione
femminile, indicando, ed è stupefacente, il
termine di “dignità conforme” per indicare le odierne pari
opportunità. Qualcuna di queste letterate partecipò anche attivamente alla
resistenza antiborbonica.
Il 20 giugno 1848 un gruppo di ben 136 signore
siciliane, di ogni età, si riunì presso l’abitazione, a Palermo, della Duchessa
Guidolfi (un nome probabilmente di copertura) dopo aver compilato e affisso un
manifesto indirizzato alle “generose donne di Sicilia” incitandole ala
Risorgimento ed alla ribellione contro l’oppressione politica e sessista che le
vedeva inserite nella società
“come fiori di un bel giardino”
, o “semplice ornamento della terra”
rivendicando di essere invece
“l’anima, la vita
del mondo incivilito”
e
chiedendo in quella occasione di poter partecipare al voto elettorale, ben
mezzo secolo prima che nascesse in Inghilterra il noto movimento delle
“Suffragette”.
“Generose donne di
Sicilia !
E’ sonata l’ora
del nostro risorgimento !
Il 12 gennaro non
fu, per noi, ma per quelli ingrati che ora ci disprezzano!
Sia questa leale
protesta il guanto di disfida.
Tremito i perfidi
!
La nostra voce
atterrerà l’impudente loro orgoglio.
Sia uno il voto
della Isola intera.
Guerra agli
oppressori !
E voi, generose
donne palermitane, riunitevi il 20 giugno
andante alle ore
due pomeridiane nella casa della Duchessa Guidolfi.
Là sarà decisa la
causa della nostra indipendenza.
Là sarà rovesciato
l’impero che gli uomini esercitaron
sopra di noi.
Là accenderemo il
sacro fuoco della libertà e della virtù.
Bando allo
arbitrio”.
Il 16 giugno 1848, secondo la “Tribuna delle Donne”,
edito a Palermo nel n. 1 del 21 giugno 1848, i manifesti si leggevano in ogni “cantonale”
di Palermo.
Nel
giornale ipotizzarono un parlamento composto da tre generi: maschile, femminile
e neutro. Azioni ed idee che scandalizzarono il sistema sociale del tempo creando
dei problemi nel governo Siciliano di Ruggero Settimo e Mariano Stabile.
Entrambi i personaggi politici, con
grandi idee, furono costretti ad emarginare la singolare pubblicazione con la
quale le esponenti del movimento femminile invocavano le pari opportunità e il
sostegno delle esponenti dell’alta Italia. Donne che eressero a loro eroina la donna
forse più emancipata del tempo, George Sand.
Non
furono solo letterate o pensatrici le donne siciliane che ebbero un ruolo
fondamentale nei moti risorgimentali.
E’
giusto ricordare, anche poche parole, altre donne che lasciarono la loro
impronta sulla storia della Sicilia:
-
Lucia Salvo, cameriera di Siracusa che si trasferì a
Palermo diventando la staffetta dei cospiratori portando, nascoste sotto
l’ampia gonna, le armi per i rivoltosi:
-
Antonia Cascio, a Messina con a capo 200 popolane partecipò
con coraggio ai moti del 1820, 1848 e 1860, meritandosi un bqacio da Garibaldi
e salvando la vita a Francesco Crispi,,,,, morì a 108 anni;
-
Testa di Lana, una pastora che in abiti maschili, con
pistole, sciabola e pugnale, alla testa di 20 uomini impegnò duramente i
soldati borbonici;
-
Peppa la Cannoniera, rubò un cannone alle truppe
borboniche per utilizzarlo con grande perizia contro di loro;
-
Caterina Serretta, prima donna affiliata alla
Carboneria;
-
Rosa Donato, armata di cannone al sopraggiungere
delle truppe nemiche, vistasi perduta, con coraggio fece esplodere tutte le
munizioni riuscendo a salvare la propria vita e causando la morte di numerosi
soldati borbonici;
-
Le donne di San Birillo di Catania che misero in fuga le truppe borboniche con
le sole urla, disorientandole;
-
Andreana Sardo riuscì ad evitare che i soldati borbonici
incendiassero la biblioteca Universitaria di Catania;
-
Ippolita De
Stefani da Santa Ninfa; Lina Oliveri da Naso; Giuseppina Bolognani di
Barcellona Pozzo di Gotto; Santa di Liberto Miloro; Santa Astorina di Palermo;
-
Marianna Giacalone e Lorenza di Paola, di Marsala, che
partirono con Garibaldi nel corso della seconda impresa garibaldina nel 1862;
-
La
baronessa Dorotea Fardella raccolse fondi per sovvenzionare le imprese
rivoluzionarie del 1860 in provincia di Trapani;
-
Angelina Damiani di Marsala intenta a raccogliere fondi con cui
sovvenzionare la discesa di Garibaldi in Sicilia nel 1860 e nel 1862;
-
Adelaide Forte Bonanno che preparò armi,
munizioni, coccarde e bende per la rivolta del 7 aprile 1860;
-
Anna Scarpitta, vedova Parrinello, che nella sua casa
del Cassero ospitò nel 1860 Rose Montmasson, unica donna partita da Quarto,
moglie di Francesco Crispi;
-
Maria De Nigris, con il marito Vito Rodolico, rifocillò,
nella sua casa dell’odierna via dei Mille, molti garibaldini appena sbarcati e
fornì loro dei viveri e dei sigari.
-----------------------
2.
Rosina Muzio Salvo
(1815 – 1866)
letterata
palermitana, partecipò alle lotte risorgimentali del Sud. Fu attiva nella
dissidenza antiborbonica e nella propaganda progressista che si preparava ai
successivi moti risorgimentali. Partecipò ai tumulti del’48 con la sua
personale esperienza di associazionismo femminile dedita alla beneficenza ed
all’educazione popolare. Tutto quello che scrisse risultò dalla critica di scarso interesse,,,,,,
Nacque
a Termini Imerese (1815 – 1866) ed ebbe un ruolo importante nel periodo del
Risorgimento esprimendosi nella narrativa, nella poesia e negli scritti
pedagogici.
L’ambiente
in cui visse era particolarmente vivace dal punto di vista politico e
culturale. Il centro di Termini Imerese, posto a pochi chilometri da
Palermo, presentava un aspetto sociale
molto vivace ed anche nella sua famiglia erano presenti discussioni politiche
che infiammavano gli animi del tempo perché mettevano in risalto una Sicilia in
condizioni economiche e sociali drammatiche tanto da essere definita
“polveriera
d’Italia”.
Il
padre, Giuseppe Salvo di Pietraganzili, era un tenente colonnello della “Valle
di Mazzara”.
Malgrado
il suo ruolo nella monarchia, non mostrò mai delle precise idee filoborboniche.
Un riferimento che fu dedotto analizzando le sue amicizie tra cui spiccava
quella di Nicola Palmeri che fu uno dei protagonisti della
Riforma
Costituzionale del 1812.
Il padre fu sempre un punto di riferimento importante per Rosina, come dimostrano le sue dediche letterali, e alla precoce morte della madre, Giuseppina Sciarrina, il legame con il padre si fece più intenso data ancora la sua età giovanile (12 anni).
Un
altro legame importante nell’ambito famigliare fu quello con il fratello,
Rosario Salvo di Pietragnazilli, otto anni più giovane di lei, anche lui come
Rosina animato da idee liberali. Fu un attivista della causa unitaria tanto da
affrontare successivamente l’esilio e s’impegnò in studi di carattere storico.
Un
bellissimo rapporto tra Rosina e Rosario che considerava e stimava la sorella
per il suo importante impegno civile e da emulare nelle sue espressioni
letterali. Ebbe della sorella un vero e proprio culto anche dopo la sua morte.
(Rosario
raccolse i necrologi apparsi subito dopo la morte della sorella e ne curò la
pubblicazione in un libro dedicato a lei “Elogi Funebri”. Molti anni
dopo, in ricordo della sorella, ormai dimenticata, scrisse un libro “Le donne della Rivoluzione –
Rosina Muzio Salvo” – 1910)).
Rosina
mostrò sempre per il fratello una forte preoccupazione legata al suo esilio e
quindi alla condizione di fuggiasco a rischio della morte. Una paura che
traspare nelle sue poesie civili dove la figura del fuggiasco era sempre
presente in una Palermo dove tutte le
menti erano fuggiti oltre lo Stretto.
Furono
i nonni che si occuparono all’inizio della formazione culturale della ragazza
per poi affidarla ad un Istituto religioso di suore di Termini Imerese. Di
questo istituto non si hanno riferimenti in merito ma sembra che sia stato uno
dei Collegi di Maria molto diffusi nel territorio.
(Istituti
gestiti da suore e fondati sul mutuo insegnamento. Consentivano l’istruzione
alle fanciulle che sceglievano di fare un voto anche temporaneo. Le famiglie
delle fanciulle pagavano una retta in base alle loro disponibilità finanziarie
ed alla provenienza sociale).
La
ragazza entrò subito in conflitto, per il suo carattere ribelle, con il mondo
religioso.
Derideva
le suore scrivendo dei piccoli versi incisi sugli stipiti della porta del collegio
e fu quindi espulsa dal “monastero” dopo tre anni dal suo ingresso.
Venne
quindi affidata ad una nobildonna francese, madame Chateauneuf, dalla quale
imparò l’inglese ed il francese. Conoscenza delle lingue molto importante
perché gli permisero di studiare la letteratura europea. Non ricevette alcun
insegnamento sulle lingue classiche e sulla metrica. Anche se il processo
culturale non fu completo, raggiunse
un processo formativo valido ed in ogni
caso lontano dall’analfabetismo di cui soffrivano la maggior parte delle donne
siciliane.
La
sua continua ricerca di cultura gli permise successivamente di colmare le
lacune formative in merito ad alcune conoscenze.
Appena
diciottenne sposò il barone Gioacchino Muzio Ferrero e diventò quindi baronessa
Muzio Salvo e con questo nome si sarebbe firmata nelle sue espressioni
letterarie. Suo marito era di circa otto anni più grande ed apparteneva ad una
nobile famiglia proveniente dalla Lombardia al seguito di un certo Tommaso che
acquistò alcuni feudi (Grottarossa, ecc.).
Successivamente la famiglia acquistò sempre un maggiore prestigio
ricoprendo importante cariche nel Regno di Sicilia (giudice portolano, diversi
Senatori di Palermo, giudice delle appellazioni in Palermo, giudice della corte
pretoriana e del tribunale del Concistorio). Acquisirono i feudi di Coscaina, Manganelli, Ioanello,
ecc.).
Il
marito era appena uscito da un
esperienza in seminario, interrotta per contrarre il matrimonio, che gli
aveva fatto raggiungere una discreta formazione culturale.
Rosina
nello studio del marito aveva a disposizione una vasta ed aggiornata biblioteca
tra cui dei testi di importanti esponenti della letteratura come Foscolo,
Parini ed Alfieri.
Testi
che attirarono l’attenzione della scrittrice dato che si trattava di autori che
erano lontani dalla formazione culturale delle donne del tempo per le loro
ideologie perché inducevano al “male” e quindi censurati…
Il
marito non diede molta importanza alla tipologia di letture della moglie dato
che i testi, secondo la consuetudine del tempo, erano poco adatti ad una donna.
Diverse volte chiese aiuto al marito per
l’apprendimento della metrica ma ricevette sempre la medesima risposta:
“non gli sembrava
di aver sposato una poetessa”.
Il
barone con il suo atteggiamento ostile, tipico del tempo perché era un male
sociale vedere “una donna scrivere in versi”, finì con lo spronare
ulteriormente Rosina nella sua vena poetica anche se in verità non incoraggiò
le sue scelte ma nemmeno le ostacolò… in definitiva non diede troppa importanza
alle vocazioni letterarie della moglie.
Rosina
sapeva benissimo di avere una scarsa conoscenza metrica e decise di rivolgersi
ad un canonico di Termini Imerese, Agostino Giuffrè, che la indirizzò negli
esercizi poetici e nello studio attento dei maggiori scrittori italiani. La
scrittrice amava la lettura dell’Alfieri a tal punto che fu conquistata non
solo dalla poesia civile ma anche da una forte carica di
autodeterminazione che ricorda quella
del famoso scrittore astigiano.
Nei
suoi scritti si manifestano chiaramente dei toni alfieriani che sono singolari
per una donna del tempo.
A
cavallo e da sola raggiungeva don Giuffrè per studiare versificazione. Rosina
si era sposata nel 1833 e fino al 1839 la coppia risiedeva a Termini Imerese.
Si trasferirono a Palermo e l’anno successivo Rosina cominciò a pubblicare le
sue espressioni poetiche su alcune riviste.
Nel
frattempo aveva avuto quattro gravidanze e in tre casi soffrì la perdita
prematura dei figli. Riuscì a superare
il parto solo Concettina a cui Rosina si dedicò in maniera totale e che sarebbe
diventata in seguito la moglie di Luigi Sampaolo, il primo biografo della
scrittrice.
Il
legame tra Rosina e il marito non fu un matrimonio che potremo definire felice
e la loro unione non durò a lungo e nel 1843, dopo dieci anni di matrimonio e a
quattro anni dal loro trasferimento a Palermo, si lasciarono. Rosina con la
figlia Concettina rientrarono nella loro casa natale di Termini Imerese e le
fonti non citarono il motivo della separazione. Alcune fonti indicarono una
vedovanza della scrittrice che venne smentita dall’epistolario della stessa
baronessa.
(Ci sono delle lettere, successive al rientro
a Termini Imerese di Rosina e della figlia, scritte al marito e catalogate
nella Biblioteca comunale di Palermo. Lettere che non furono pubblicate ed è un
vero peccato…).
La
scrittrice non sembrò particolarmente colpita dalla separazione perché la sua
vita continuò in maniera normale anzi subì un maggiore impegno culturale nella
produzione artistica con collaborazioni giornalistiche e letterarie. Si recava
spesso a Palermo dove frequentava ambienti e circoli intellettuali impegnati
nelle lotte risorgimentali.
Malgrado
questi suoi impegni non fece mai mancare l’affetto per la figlia.
La
sua frequentazione degli ambienti culturali non destò scandalo, come spesso
avveniva. Grazie alla sua libertà si dedicò ad azioni caritative,
all’insegnamento e a varie pubblicazioni senza chiedere il relativo permesso al
marito.
Fu ammessa nel circolo di intellettuali di
Palermo che frequentavano il salotto d’Albergo e che si riunivano attorno a
Francesco Paolo Perez (1812 – 92) e alla
“Ruota”, un famoso foglio progressista politico
e classicista in letteratura.
Francesco Paolo Perez
La
“Ruota” era una rivista dello
schieramento progressista della Sicilia. Nella redazione figuravano esponenti
di cultura della Palermo del tempo: i fratelli Benedetto e Giovanni Castiglia,
Emerico e Michele Amari, Francesco Paolo Perez, Pietro Lanza di Scordia, Vincenzo
Errante. Erano solo alcuni dei collaboratori dell’importante rivista.

Un
momento di vita in cui la scrittrice si unì alla causa unitaria ed entrò in
contatto con altre letterate che si trovavano nella capitale del Regno in un periodo
vicino all’insurrezione palermitana.
Il
12 gennaio 1848 scoppiarono nell’isola i tumulti e Rosina Muzio Salvo non potè
seguire gli altri membri del suo gruppo e cercò di crearsi un suo percorso
personale di partecipazione.
Molti
esponenti del suo gruppo culturale sposarono la ribellione rispondendo ai proclami che erano stati pubblicati in
precedenza sulla rivista.
Secondo
gli storici il movimento rivoluzionario del’ 48 fu promosso in prevalenza dalla
classe intellettuale e molte delle classi sociali dell’isola non parteciparono
direttamente alla gestione dell’insurrezione dato che vivevano in una crisi
sociale che s’era aggravata nei disordini di quei mesi e che risaliva a lunghi
anni di malgoverno borbonico.
In
questo clima anche la componente femminile era ai margini della scena politica,
infatti l’assemblea dei rivoltosi fu eletta solo dai cittadini maschi alfabeti
che avevano compiuto i 21 anni.
Eppure
le donne con grande coraggio seppero organizzarsi per contribuire alla causa
creando un esperienza di associazionismo femminile con la nascita della:
LA LEGIONE DELLE PIE SORELLE
Un
associazione che univa molte donne, tra
cui Rosina Muzio Salvo, promotrici di
attività rivolte alle classi povere.
Donne
che diedero un contributo importantissimo nella sommossa siciliana.
Per
Rosina Muzio, che fino a gennaio era stata nel gruppo degli intellettuali poi
confluiti nell’assemblea della rivolta, fu una forma di partecipazione politica
che si esprimeva, anche se in maniera circoscritta, secondo modi d’agire utili alla collettività,
la più bisognosa, e quindi apprezzati dalle istituzioni.
La
Legione delle Pie Sorelle entrò in attività verso ottobre del’ 48 in uno momento
avanzato della rivoluzione.
Un
associazione di matrice religiosa, dedita ad opere di carità e in particolare
all’educazione popolare.
Era regolata da una rigida struttura interna,
stabilita da un regolamento ispirato a principi democratici. Riuscì a contare
ben 1.200 consorelle che erano suddivise in 12 centurie. A capi di ogni centuria
c’era una direttrice mentre la guida dell’intera associazione era affidata ad
un presidente generale che era affiancato da una segretaria.
Erano
previsti anche una bibliotecaria, una tesoriera, una cassiera ed un cappellano.
Le
cariche avevano una durata annuale e vi si accedeva grazie ad un elezione
diretta.
Rosina
Muzio Salvo ricopriva la carica di segretaria mentre la presidentessa era la
principessa di Butera e di Scordia.
(La
principessa di Butera doveva essere Eleonora Spinelli, principessa di Scalea; e
moglie di Pietro Lanza Branciforte, figlio di Stefania Lanza Branciforte,
principessa di Butera).
La
scrittrice si occupava di redigere gli atti delle assemblee che venivano poi
pubblicati sul giornale dell’organizzazione.
Decisivo
nella nascita della associazione fu il cappellano, padre Antonio Lombardo.
Padre
Lombardo, prima del ’48, aveva ricoperto la carica di ispettore degli asili
infantili nelle “Scuole Pie” di Palermo.
Padre
Lombardo per la sua partecipazione alla
rivolta abbandonò l’abito senza abbandonare il suo grande interesse per
l’istruzione come testimonia il suo primo articolo che fu pubblicato sulla
rivista dell’associazione. Anche gli articoli successivi evidenziarono sempre
la tesi rivolta a difendere la causa dei rivoltosi.
Dai
verbali delle assemblee appare come le
consorelle procedettero in maniera autonoma nel loro lavoro.
I
loro obiettivi dichiarati erano:
«la pratica di
ogni sociale virtù, l’applicazione della pietà cittadina; il culto della [...]
suprema legge morale; e la cultura e il perfezionamento del Sesso Gentile»
Si
autotassavano e raccoglievano fondi che venivano impiegati per il mantenimento
di un istituto di educazione femminile per la fanciulle del popolo in
difficoltà; nel sostentamento delle vedove e orfane (di preferenza per causa
della “patria”); nella promozione di asili per l’infanzia e nell’acquisto di
pubblicazioni utili per l’istruzione delle stesse fanciulle.
Le
loro iniziative erano tipiche della beneficenza: lotterie, spettacoli teatrali
e musicali, questua casa per casa, pubblicazione di una rivista.
Tutto
il ricavato di questo operare andava a beneficio dell’istituzione che riuscì ad
instaurare anche dei dialoghi con altri organismi urbani.
La
corrispondenza tra la Rosina Muzio e la principessa di Butera fa luce su questi
dialoghi con il consiglio civico, il ministro dell’istruzione e dei lavori
pubblici, la “commissione per l’azienda gesuitica” che era stata prevista dal
governo per la gestione dei beni della Compagnia di Gesù di Palermo che era
stata sciolta tre mesi prima della costituzione della Legione.
Un
lavoro prezioso per le donne della legione che furono indicate come le “donne
della rivoluzione” perché aiutavano ed assistevano i feriti, prendevano
cura delle loro famiglie e colmavano un assistenza sociale che risaliva al
malgoverno borbonico ancora prima della rivoluzione. Si preoccuparono anche di
recuperare importanti fondi per sostenere le donne di Messina che era caduta
sotto le armi dei Borboni.
Le
colleghe di Rosina Muzio Salvo dimostrarono una grande sensibilità soprattutto
nell’istruzione delle fanciulle. Capirono come l’istruzione fosse il “mezzo
fondamentale per cambiare radicalmente o parzialmente la loro posizione nella
società”.
Auspicavano
con la loro attività un senso di rinascita sociale non solo dal loro
oppressore, i Borboni, ma anche dalla condizione femminile aggravata in particolare dal malgoverno
borbonico con la carenza d’istruzione.
Un
brano pubblicato sulla “Legione” dal titolo
“Anche noi siam
risorte !”
La sicula rigenerazione portò seco pure il nostro risorgimento.
Noi per lo addietro sesso avvilito e negletto per causa di governo dispotico,
che vuole l’abbrutimento de’ suoi popoli per meglio soggettarli ed opprimerli,
non cercò mai di migliorare la nostra condizione. E noi, figlie d’Italia, ci
mostrammo in cultura assai inferiori alle nostre sorelle italiane. [...] Ora
però che migliori forme di governo ci reggono, ora però noi si permette la
nostra associazione, noi possiamo mostrare ai nostri sposi, ai nostri fratelli,
alle sorelle italiane tutte, che non siamo figlie degeneri d’Italia [...]. Or
che l’educazione sarà considerata come una parte principale della legislazione,
vasto campo ci si apre dinanzi, in cui debba esercitarsi e debba la nostra
collaborazione..”
“La Legione delle
Pie sorelle”, a. i, nn. 3/4, 6 novembre 1848.L’articolo è
firmato da Annetta Rini, una consorella, e da Lombardo, il cappellano della
Legione.
Le aspirazioni pedagogiche delle palermitane rimasero in gran parte sulla carta nonostante gli sforzi della Legione perché troppo legate alla situazione rivoluzionaria e la formazione delle donne siciliane non fece in verità molti progressi.
Rosina
Muzio negli anni cinquanta in poi ritornò sul rapporto tra educazione femminile
e società attraverso due scritti; “Lettere a Faustina” in merito all’educazione
e “Prese Morali.”.
Scritti
che s’inserirono in un periodo caratterizzato da una profonda riflessione
pedagogica sul ruolo della donna che vedeva
in due pedagogiste, Caterina Franceschi Ferrucci e Giulia Molino Colombini,
le massime esponenti del tempo
Pedagogiste
che la Muzio aveva probabilmente conosciuto grazie alla sua collaborazione con
la rivista “La Donna” di Genova.
Le
esponenti della Legione si assunsero le responsabilità di alcuni problemi del
contesto urbano. Malgrado il loro
impegno sociale di carità non riuscirono ad inserirsi pienamente nel lavoro
sociale come invece avveniva nelle altre città d’Europa.
Gli
atti pubblicati nel giornale dell’istituzione dimostrarono come ben presto la
legione perse la sua importanza come partecipazione femminile.
Ben
presto il numero delle consorelle
cominciò a scendere tanto che il numero legale per
dichiarare aperta l’assemblea veniva di volta in volta abbassato.
Molte
le donne che rifiutarono l’incarico per il quale erano state democraticamente
elette. La comunicazione, di solito per iscritto, recava motivazioni di ordine
familiare.
Anche negli anni successivi problemi simili penalizzeranno l’impegno socio-politico femminile.
Anche negli anni successivi problemi simili penalizzeranno l’impegno socio-politico femminile.
La
composizione dell’associazione era molto varia dato che vedeva la
partecipazione attiva di donne appartenenti alla nobiltà , molte delle quali, come la Rosina non si
segnalarono come baronesse.
La
differenza rispetto alle associazioni femminili inglesi e tedeschi fu legata
alla trasparenza e per questo motivo fu all’inizio della sua attività. poco
perseguitata dalle forze di polizia. Infatti l’associazione siciliana
pubblicava regolarmente gli atti degli incontri e le iniziative promosse nel
territorio.
La
seduta inaugurale della Legione, secondo gli atti pubblicati sul primo numero
del giornale (21 ottobre 1848), si tenne il 27 agosto 1848, l’ultima il 3
dicembre dello stesso anno (sul n. 7-8, 2 «gennaro» 1849).
Il
3 dicembre 1848 svanì l’impegno sociale della Legione che probabilmente operò in
silenzio forse nella clandestinità.
Il
problema sociale a Palermo e nella provincia era molto grave e difficile da
gestire.
Il
governo rivoluzionario cominciava ad avere delle divisioni al suo interno e
questo non gli permetteva di affrontare la grave crisi sociale cercando di
portare delle iniziative sociali. In
questo clima di profonda confusione anche le pie sorelle che tanto combattevano
per l’istruzione delle donne furono costrette a ritirarsi.
Eppure
queste donne continuarono fattivamente la rivoluzione. Gli atti della riunione,
redatti da Muzio Salvo, si arrestano a due mesi dalla fine del periodo
rivoluzionario che ebbe luogo nel marzo del’49 quando le truppe borboniche rientrarono
all’interno del capoluogo siciliano.
I
proclami della Legione erano ancora presenti nel territorio…”“la
pratica di ogni sociale virtù, l’applicazione della pietà cittadina; il culto
della […] suprema legge morale; la cultura e il perfezionamento del Sesso
Gentile” e dovevano ora dare fastidio al nuovo ordine
costituito dato che proprio nel 1849 la principessa di Butera fu condannata
all’esilio insieme con il marito. In merito ad alcune richieste per permettere
il ritorno della coppia a Palermo, il
luogotenente dei Borboni, Carlo Filangeri, inviò al ministro Cassisi Giovanni,
Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia che chiedeva ragguagli
proprio sulla coppia, una lettera nel
quale dichiarava:
«Eccellenza la
Principessa di Butera spiegò durante i passati rivolgimenti passi rivoluzionari
non inferiori a quelli del marito. Fu essa che organizzò un Club di donne che
propalava oscene e sovversive dottrine sotto il nome di Pie Sorelle, di cui
avea la presidenza. Costei vi aveva qui continui omaggi della fazione
demagogica, era centro d´intrigo di quanti vagheggiavano qui il ritorno dei
passati disordini, e partendo si avea una tacita ovazione dei novatori».
«Ciò premesso io sarei d´avviso di non permettersi di far
tornare in Sicilia questa Signora».
Il manifesto delle donne siciliane, che nei moti del
1848 erano state considerate le “donne della rivoluzione, perché aiutavano i
feriti, si prendevano cura delle loro famiglie, raccoglievano fondi per gli
orfano e vittime della repressione”, era da tempo presente nelle strade di
Palermo..” “È
un’ubbia del volgo, è un pregiudizio che sente di rancidume quello che la donna
è solo fatta pel domestico focolare”. “Or che l’educazione sarà considerata
come una parte principale della legislazione, vasto campo ci si apre dinanzi,
in cui debba esercitarsi la nostra collaborazione”.
Mentre
in alcune zone d’Italia le leghe femminili mantenevano spesso l’anonimato per
non mettere a rischio la propria reputazione con il loro impegno politico e
sociale, per la lega di Rosina Muzio, forse a causa dell’ispirazione religiosa
e dalla presenza del cappellano, non aveva lo stesso problema perché garantiva
la moralità dell’associate e questo comportamento, quasi di sfida, dava
fastidio al governo borbonico.
Il
giornale “La Legione delle Pie Sorelle” non ospitava interventi letterari.
Rosina
Muzio Salvo per le sue espressioni
letterarie collaborava con un’altra
testa “L’Educazione popolare”, i cui proventi erano devoluti alla creazione di
asili infantili.
L’amministrazione
della rivista era nelle mani di Gian Battista Castiglia e la Muzio figurava tra
i suoi collaboratori. Nella rivista scrisse alcuni contributi in versi con i
temi della patria e della libertà, un discorso poetico come impegno civile.
Nella
rivista pubblicò un articolo contro Giuseppe La Farina, allora ministro della
guerra. In quell’articolo la scrittrice siciliana accusò “d’incompetenza un
autorità della Rivoluzione” che aveva ascoltato in un discorso pubblico. In
quell’articolo dimostrò un’attenzione costante alle iniziative del
governo e una non trascurabile padronanza del linguaggio politico.
Giustamente
manifestò il suo pensiero critico mettendo in discussione un esponente della
propria corrente politica. Un aspetto molto rilevante perchè proveniva da una
donna del XIX secolo e che scatenò numerose polemiche sulla stessa rivista dove
venne difesa dal suo amico Pardi anche lui collaboratore della stessa rivista.
Nel
1852 la scrittrice fu implicata nell’attività patriottica lungo l’asse Palermo,
Termini e altri paesi della provincia. Un attività che aveva avuto origine
nella casa di Giuseppe Vergara principe di Craco.
(Giuseppe
Vergara, principe di Craco, nacque a
Palermo il 26 agosto 1812 e morì a Taranto il 9 marzo 1893. Patriota del
Risorgimento, garibaldino. Sposò in prime nozze a Napoli il 2 marzo 1840
Mariannina Del Core – morta a Napoli il 16 agosto 1858 – e in seconde nozze a
Genova nel 1859 Chiara Balbi – nata a
Genova nel 1825 e morta dal Alessandria d’Egitto nel 1904).
Craco (Matera) –
La città fantasma
La città fu
abbandonata nel 1962
Giuseppe
Vergara era figlio di Francesco Vergara Caffarelli ( nato a Craco il 7 marzo 1778 e morto a
Palermo il 5 dicembre 1849) e della nobile Giulia Garsia (nata a Palermo il 17
febbraio 1778 e morta a Palermo il 18 agosto 1846, figlia di Girolamo Marchese
di Savochetta e Barone di Nixima e della nobile Eleonora Grugno dei Duchi delle
Gaffe, vedova di don Girolamo Reggio marchese della Ginestra).
La
famiglia Vergara apparteneva all’aristocrazia napoletana e si rifugiò in
Sicilia con il Re e la Corte nel 1799 al
tempo della breve Repubblica Napoletana. Rimase in Sicilia anche dopo la
caciata dei francesi e il ritorno a Napoli del re (Ferdinando IV ovvero
Ferdinando I di Borbone).
Quando
Ferdinando IV si rifugiò nuovamente in Sicilia, dopo l’invasione francese del
1806, Napoleone affidò il regno di Napoli al fratello Giuseppe. Quando Giuseppe
Napoleone diventò Re di Spagna, il regno di Napoli fu affidato a Gioacchino
Murat nel 1808. Murat promulgò subito un decreto contro gli “emigrati
napoletani, ostinati a restare in istato di guerra contro la loro patria”.
Gli
“emigrati napoletani” furono quindi dichiarati “sudditi ribelli”
e stabilì la confisca dei loro beni con successiva assegnazione ad altre famiglie filofrancesi (“ tutti i
beni degli emigrati, situati nelle due Calabrie, nella provincia di Basilicata,
ne’ due Principati, ne’ tre Abruzzi e nel contado di Molise”.
Francesco
Vergara non ritornò nel continente nel 1809 e quindi considerato da Murat un
ribelle con conseguente confisca dei beni. Il re Ferdinando IV per
indennizzarlo della rovinosa confisca, gli assegnò la direzione generale dei
Lotti che conservò fino al 1819, anno in cui fu esonerato pur conservando un
assegno annuo di 1800 ducati sopra i proventi del Lotto.
Ferdinando
IV, una volta tornato a Napoli, non fu generoso con il Vergata perché non gli
restituì i beni che erano stato confiscati dal Murat. Il comportamento del
sovrano borbonico era legato a due episodi che avevano avuto Francesco Vergata
come protagonista.
Il
sovrano rimproverò al Vergata la sua grande fedeltà alla regina Maria Carolina
d’Asburgo, malgrado fosse odiata dai siciliani, e l’accusa di un attentato
contro il Parlamento proprio nel giorno in cui si votava la nuova Costituzione.
I fatti narrano come il Vergata fece esplodere “una bottiglia di vetro
carica di polvere da scoppio e di mitraglia”.
Un
episodio gravissimo che portò al suo arresto e alla conseguente reclusione per
più di due anni.
Francesco
Vergara Caffarelli e la moglie Giulia
Garsia, palermitana, ebbero ben 10 figli/e: Disma, Eleonora, Teresa, Girolamo,
Domenico, Giuseppe, Filippo, Francesco Paolo, Luigi, Enrichetta. Tutti vissero tra alterne vicende caratterizzate anche da aspetti economici
negativi per cui si trovarono nella
necessità di prendere indirizzi di vita convenienti senza venire meno alle
antiche tradizioni nobiliari familiari.
Girolamo
ad esempio scelse la vita militare come ufficiale di marina servendo con onore
e fedeltà il suo re e nel 1860 fu uno dei pochi a rifiutare l’incarico di entrare
a fare parte nella marina Militare Italiana dando le dimissioni dal servizio.
Giuseppe
invece scelse la via della lotta politica per la liberazione della Sicilia e
dell’Italia. È il Giuseppe Vergata che incontrò i rivoluzionari di cui faceva
parte Rosina Muzio Salvo per lo sviluppo di piani segreti.
Giuseppe
Vergata scrisse il 6 giugno 1851 una lettera ai membri del Comitato Centrale di
Palermo in cui dichiarava che:
“Vi avverto che il
Comandante di marina che andiede a consegnare il vapore
in Londra, che
speriamo non darli come mi dite, è uno dei nostri siciliani che
serve devotamente
e di cuore Ferdinando Bomba. Esso è mio fratello
Girolamo Vergara.
Il nascere è un caso.
Io non rispondo
che di me; ma vi prego di non maledire quel cognome che
portano che si sanno
tutto sacrificare alla Sicilia”.
(Il
re Ferdinando II prese l’appellativo di “Re Bomba” per la feroce repressione
che fece in Sicilia con il bombardamento di Messina che causò centinaia di
morti. Il merito al vapore ormeggiato a Londra la storia è complessa.
Nell’aprile del 1851 il brigantino borbonico a vela “Generoso”, al comando del
capitano di fregata Girolamo Vergara, venne inviato a Londra con a bordo un
equipaggio destinato al armare la pirofregata a ruote “Fulminante” che era
stata comprata dal Governo provvisorio Siciliano che si era costituito durante
la ribellione del 1848 – 1849 e trasferita alle autorità del Regno delle Due
Sicilie dopo una lunga vertenza giudiziaria. Il destino della nave e dei denari
rimasti, frutto di una sottoscrizione siciliana, commosse i patrioti
dell’isola. La nave, il cui nome originario era “Bombay”, era stata richiesta
dal Governo Siciliano ad un armatore di Londra “sotto la vigilanza di tre
speciali commissari forniti dei denari opportuni; il principe di Granatelli (Franco
Maccagnone), il principe di Scordia e Butera (Pietro Lanza) e lo
Scalia (don Luigi Scalia). Ma nell’azione legale che seguì i
commissari furono pressati dalla diplomazia borbonica e cominciarono a
tentennare anche perché avevano avuto i loro beni sequestrati in Sicilia.
A
Londra ed a Malta erano custodite ben 200.000 onze del Governo provvisorio
Siciliano ma sia i denari ed anche un
forte quantitativo di armi che si trovavano a Malta furono consegnati al
governo borbonico napoletano. Si cercò di bloccare il trasferimento della nave
al governo borbonico facendo ricorso ad ogni azione legale, la spesa per
l’acquisto era stato sostenuto da un fondo nazionale siciliano, ma fu tutto
inutile).
La pirocorvetta
“Fulminante”
La
Rosina Muzio salvo faceva parte di questo comitato di liberazione presieduto da
Francesco Vergata e , come già esposto, fu implicata nell’attività patriottica.
Una
delle iniziative consisteva in contatti con i Mazziniani di Genova, che
inviavano segretamente propaganda e dei giornali da distribuire. Si dovevano
anche collocare i coupon spediti da Rosolino Pilo che venivano acquistati per
pagare il prestito mazziniano contratto a Londra per finanziare i moti
risorgimentali, altri progetti prevedevano l’organizzazione di moti, ma a causa
di un infiltrato la polizia borbonica ne venne a conoscenza facendo scattare un
feroce repressione comandata dal famigerato capo della polizia.. Maniscalco
Salvatore… di Messina…..
Salvatore
Maniscalco
Capo della Polizia
Borbonica
Vi
furono degli arresti a Palermo, Termini Imerese, Cefalù. Le cedole con i
conteggi della sottoscrizione erano state mandate a Rosina e non furono quindi
trovate. Fu arrestato Francesco Vergata ed anche la sua amante Teresa Musso,
che venne rinchiusa in quello che era definito il “più spaventoso carcere di
Sicilia” cioè il carcere dei Dammusi di Monreale. La donna non rilevò nulla
di quanto era a conoscenza ed infatti nelle lettere dei patrioti era chiamata
la “eroica donna”.
Complesso
abbaziale benedettino di Monreale. Vista dall'alto con porzione visibile della
torre del carcere e porzione dell'edificio carcerario. Fotografia di Levy et
ses fils - Parigi (non datata).
Carcere che fu
abbattuto nel 1860
Malgrado
il rischio di essere scoperta ed arrestata,
la scrittrice continuò la sua attivitò propagandistica e di collegamento
fra i rivoltosi. Dopo l’unità d’Italia il suo impegno politico cominciò a
declinare e fu sempre meno incisivo.
Probabilmente fu delusa dagli avvenimenti post-unitari.
In
merito alla sua produzione letteraria collaborò con due rivista genovesi,
rivolte all’educazione della donna e al suo ruolo nel nascente stato italiano:
le due riviste erano “La donna” di Mercantini (Genova, 1855- 57) e “La Donna e
la famiglia” (Genova, 1862).
Tra
le sue opere più significative:
-
Il
romanzo “Adelina” del 1846, che narra la storia d’amore tra la giovane Adelina
e Carlo, un esule polacco. Una storia che ispirò Giovanni Verga nella creazione
del personaggio di Maria in “Storia di una Capinera”.
-
Una raccolta di “Prose e Poesie” (Palermo
1852);
-
Diversi
racconti e romanzi tra cui: Matilde e Bice (Palermo 1857); Giannetta (Palermo
1858); Dio Ti Guardi (Milano 1860) e Le Due Contesse (Milano 1865).
Morì
a Termini Imerese nel 1866
Romanza
Ahi
quante volte all’aura,
Che mi
lambiva il viso
Dei tuoi
sospir , conquiso
Balzava
forte il cor,
E
d’ogni cura immemore
Viveva
per l’amor!
Nei
lumi tuoi specchiandomi,
L’immago
mia vedea,
Ed
ebbra a te dicea:
« lo
son felice appien. »
Vidi
mia viva immagine
Incisa
nel tuo sen….
Ma
assisa sotto il salice,
Quando
dicesti: « Addio! »
La
terra a me spario,
Sugli
occhi scese un vel:
Quindi
gli apersi…. al misero
Ch’è
mai la terra, il ciel?
(2 agosto 1841)
--------------
La
delusa
Là
dov’è ’l ciel più fulgido ,
Fragrante
più ’I sentier,
Ove più
Palma innalzasi
Su i
vanni del pensier;
Tra le
carole l’alito
D’amore
mi creò ,
E di
sventura il turbine
Nel
duol m’inabissò.
Speme
di gloria invasemi ,
Ed
ebbra di desir ,
Di
tante pene immemore ,
Vivea
nell’avvenir. . . .
Stoltezza!
più non s’agita
A quel
sorriso il cor;
Ch’è
mai, ch’è mai la gloria,
Se non
l’abbella amor!
(30 maggio, 1842)
---------------
Siciliani
Havvi
un divino senso, un’armonia
Tra
cuore a cuore; una possente, arcana
Voce
fraterna, che ad amar ne, sforza!
O tu, il
cui nome tra gl’incensi e gl’inni
Una
gente codarda al cielo estolle ,
Dorata
plebe , ascolti tu tal suono?
Ascolti
tu la disperata madre,
Ch’urta,
rompe la folla , si gridando:
«
Rendetemi il mio figlio! Ahi! con quest’occhi
Da un
ribaldo, da un demone assalito ,
Cader
trafitto il vidi! » Il grido ascolti
D’una
gente raminga , senza un tetto
Che la
ricovri, un pan che la disfami?
L’irrequieta
, baldanzosa turba ,
Nel cui
cipiglio è fitto un pensier truce,
Pensier
di sangue, non iscorgi?… Ahi tutti
Sul tuo
capo ricadano i misfatti!
E di
chi è mai la colpa, se nel sangue
Una
sfrenata plebe si gavazza,
Sfamando
il duole, l’innasprita rabbia
Di
vedersi qual gregge vilipesa?
E
mente, e core forse il ciel concesse
A te
soltanto, e l’umile genia
D’ogni
luce privò? Di questo suolo,
Di
questo ciel, che onnipossenti fiamme
Nell‘anime
trasfonde, non è figlio
Il
derelitto vulgo? Or questo foce,
Che per
immensi campi spaziando,
È fatto
divo dallo studio, e l’arte;
Questo
foce compresso, alfin prorompe
Rapidissimo,
e tutto incende, e strugge!
O stuol
patrizio, a cui fortuna arrise,
Non
vedi tu quanta miseria accogli
Tra
l’immense dovizie? Orsù , tracanna ,
Tracanna
il nappo di tuo folle orgoglio…
Ebbro
n’esulta… ma non senti a tergo
Una
voce tremenda che ti grida:
« Di
tua possanza è già caduto il regno? »
Dal
Tamigi al Sebeto in ampie sale
Radunansi
i fanciulli, un amoroso
Sacro
ministro alla virtù li educa,
Mentre
una donna con soave affetto
Libri,
lavori appresta, e quanto puote
L’intelletto
avvivar, rendere un giorno
Utili
quelle braccia, quelle menti
A se
stessi, alla patria. Ai pensier casti
I
fanciulli nudriti, ed al lavoro,
Del
delitto le vie fuggono adulti.
Or
mentre ovunque alla virtù s’educa
L’infima
plebe, su di cui pietosa
Veglia
l’illustre gente, alle rapine
Alle
bestemmie, al sangue, tra noi cresce,
Educasi,
s’inspira! Amor, pietade,
Non
sole preci, è del Signor la legge. –
Va dal
tapino, ne raccogli i nati,
E in
terra un serto, in cielo un seggio avrai.
(2 dicembre, 1843)
Romanza
Ogni
fior mi sorridea ,
Ogni
suono mi beava,
Quando
in mente risplendea
Un
angelico pensier.
Carolando
a me d’innanti ,
S’involò
l’ebbrezza arcana ,
Spine
acute, laceranti
M’ingombrarono
il sentier.
È pur
questo il cielo mio,
Tutto
luce , tutto amore;
Questo
il caro suol natio ,
Questi
i fior ch’amavo un di.. . .
Ma
qual’ombra errante affiso
Gli
astri, il cielo, il colle, il prato,
Da
quell’estasi diviso,
Tacque
il mondo, e disparì!
(Febbraro , 1845)
-----------------------
3.
Giuseppina Turrisi
Colonna (Palermo, 1822 – 1848)
È
una delle autrici più celebrate
dell’Ottocento Siciliano per il suo grande spessore culturale.
La Turrisi insieme ai suoi fratelli (Antonio e Nicolò) ed alla sorella
Annetta fu educata in una famiglia molto colta. La madre Rosalia Colonna
(figlia di Luigi Colonna Romano, barone di Cesarò, e di Giuseppina Anfossi) era
anche una persona colta ed energica. Curò personalmente l’istruzione dei
figli/e a cui trasmise i suoi stessi ideali: l’amore per l’arte, la cultura e
la patria. Tutti argomenti che diventarono oggetto di conversazioni nell’ambito
familiare e sociale. Il peso della madre nell’educazione della figlia fu molto
rilevante anche in considerazione della prematura scomparsa del padre il
consigliere Turrisi Mauro, barone di Buonvicino e di Gurgo.
Giuseppina e la sorella
Annetta nacquero a Palermo nel Palazzo Asmundo, oggi Museo Nazionale, come testimonia una lapide posta sulla
facciata principale,
Palermo
– Palazzo Asmundo
Giuseppina vene educata non solo all’arte del ricamo,
alla musica o al francese, elementi importanti nell’ottica di un buon
matrimonio, ma anche ad un educazione approfondita rivolta allo studio del
greco, del latino e del toscano, grazie anche ai suoi precettori. Studiò anche
l’inglese come testimoniano le sue traduzioni degli scritti di Byron.
La madre in quest’ottica assunse un atteggiamento in
controtendenza rispetto ai suoi tempi e non sacrificherà le capacità artistiche
della figlia a questioni venali, come la ricerca di un buon matrimonio, e la incoraggiò
sempre anche nei momenti di maggiore sconforto. Molte delle liriche della
Turrisi furono infatti rivolte alla madre.
Il
suo poetare, nelle molteplici tematiche, permettono di studiare la Sicilia
dell’epoca e soprattutto di apprezzare il suo grande impegno sociale.
Una
figura che suscita ammirazione per il suo idealismo puro verso la sua terra
ricco d’impeto e a volte, per gli insuccessi, ricco di scoramento.
Appare
il patriottismo di una ventenne che, come disse uno studioso, “non vuole
stare al suo posto”.
“Una
giovane che scrisse e bene della Sicilia del XIX secolo e sognò la gloria.. uno
scandalo per la donna del tempo che parlava in perfetto toscano pur essendo
nata e cresciuta in Sicilia dove all’epoca era in uso solo il dialetto; che
parla di politica e di Patria, anche se questi argomenti non erano adatti ad
una signorina; che tesse senza complessi di sorta, amicizie con noti
intellettuali dell’epoca, superando i confini geografici e culturali dell’isola”
Apparteneva
a quella generazione che fu definita dallo storico francese Jules Michelet come
“misteriosa”, perché “amava i sogni, disprezzava il successo e
serviva la causa più con il sangue che con la vittoria”.
È
strano eppure non è conosciuta da molti e non solo .. ma nella didattica scolastica
non rientra nei piani di studi letterali dell’Ottocento…. Se ne sta perdendo la
memoria….
Il
suo maestro fu l’abate Giuseppe Borghi e all’età di quattordici anni compose
alcuni inni religiosi ispirati a quelli del Borghi e agli “Inni Sacri” del
Manzoni. Inni composti dalla Turrisi con un grande spirito civico, quasi “eroico”
e quindi lontani dallo stile del suo maestro.
Studiò
le lingue antiche e approfondì con grande impegno lo studio della letteratura
europea contemporanea. In questi studi fu agevolata dal salotto letterario
della famiglia Turrisi che era frequentato da famosi letterali siciliani ed
italiani di passaggio dell’isola.
Il
Di Carlo scrisse che “in quella casa si studia con serietà d’intenti, vi si
ha il culto del sapere, delle scienze e delle lettere, delle arti belle, delle
grandi idee di Patria e libertà”.--- Ideali sempre vivi nella breve esistenza
di Giuseppina a cui consacrò il suo grande ingegno culturale”.
Dopo i primi componimenti filosofici e religiosi,
eseguiti tra il 1836 ed il 1841, Giuseppina si dedicò con sempre maggiore
entusiasmo agli argomenti patriottici e civili. Sembra che “lo spirito
guerriero” della giovane Giuseppina riuscì ad emergere grazie al contributo
del suo nuovo precettore Francesco Paolo Perez. Oltre ad alcuni passi
inneggianti all’unità d’Italia risaltano anche dei versi che mettono in
evidenza il ruolo delle donne nella società e criticano l’aspetto sociale della
Sicilia del tempo caratterizzato da un torpore lontano dal valore,
dall’animosità, dal senso di ribellione espresso nella storia dai Vespri
Siciliani o dalle imprese di Giovanni II Ventimiglia o di Ottavio d’Aragona.
Riuscì a
crearsi delle amicizie, anche epistolari, con i più importanti italiani
dell’epoca. Giuseppina e la Annetta conobbero Massimo d’Azeglio
durante un viaggio che l’illustre
scrittore fece in Sicilia nel luglio del 1842 e grazie proprio al D’Azeglio
ebbe inizio una cordiale corrispondenza tra la stessa Giuseppina e il milanese
Tommaso Grossi, autore di una famosa novella dal titolo “Ildegonda” del 1820.
Un
grande riconoscimento giunse dall’Accademia Aretina di Scienza , Lettere ed
Arti, che la inserì tra i suoi membri.
Il
contatto con il mondo culturale fiorentino fu agevolata anche da un suo breve
soggiorno nella capitale toscana nel 1846 che fu l’unica esperienza di vita lontano
dalla sua terra.
Firenze – Dipinto
di Giovanni Signorini (XIX secolo)
Firenze – Veduta
della città con il fiume Arno da Ponte Vecchio
verso Ponte delle
Grazie – Giovanni Signorini – 1850
Firenze – I fuochi
d’artificio sul Ponte alla Carraia per
la
Festa di San
Giovanni – Giovanni Signorini
Un
viaggio, passando per Napoli, compiuto assieme alla madre ed al fratello
Giuseppe per motivi di salute. Le fonti
citano per la ricerca di un clima più salubre per la sua salute non ottimale
dato che soffriva di un aneurisma al cuore ed era di corporatura molto gracile.
A
Firenze ebbe la possibilità d’incontrare molti intellettuali dell’epoca (Niccolini,
Guerrazzi, Giusti). Fu un importante esperienza che le aprì ulteriormente il
suo impegno verso l’idea nazionale.
I
momenti di quel viaggio resteranno per sempre nel suo cuore e li riportò nelle
lettere inviate alla sorella e pubblicate per la prima volta nel 1875.
Nella
città toscana perfezionò la lingua toscana e si parlò di un eventuale amore
verso il drammaturgo Giovanni Battista Niccolini. Notizia che risultò non
veritiera.
Nel
luglio, sempre del 1846, pubblicò per Le Monnier un volumetto di liriche che
ebbe un gran successo in Italia e che fu commentato da letterati famosi. Ad
agosto la famiglia tornò in Sicilia dietro la pressione di Nicolò Turrisi, che
alla morte del padre, aveva assunto l’incarico di guidare la famiglia.
Nel
1847, il 29 aprile a Palermo, sposò il
nobile Giuseppe De Spuches, principe di Galati, letterato, poeta e grecista,
archeologo.
Don Giuseppe De
Spuches e Ruffo (1810 – 1884)
Duca di Caccamo e
Principe di Galati
(Figlio di Antonino,
principe di Galati, e di Marianna Ruffo, figlia
del Marchese
Girolamo Ruffo e di Carmela Di Benedetto.
Pretore di Palermo
fino al 1860 e Deputato del Regno d’Italia nel Parlamento di Firenze.
Allo
scoppio della rivoluzione a Palermo nel gennaio del 1848, la famiglia si
rifugiò nella villa paterna di Castelbuono.
Castelbuono –
Palazzo Turrisi Colonna in Corso Umberto I
Giuseppina
aspettava un figlio ma la malattia al
fegato s’era aggravata. Portò a termine
una gravidanza difficile e diede alla luce una bambina che morì poche ore dopo
la nascita. Un grande dolore….
Tre
giorni dopo il parto, il 17 febbraio 1848 Giuseppina Turrisi Colonna moriva
colpita da aneurisma… aveva ventisette anni. Venne sepolta nei sepolcri delle
Cappuccinelle a Palermo.
Il
marito ne pianse la grave perdita e gli dedicò
cinque elegie latine “Carmina latina e graeca”. Le fece erigere un monumento del Pantheon di
San Domenico, opera dello scultore Valerio Villareale.
L’espressione
letteraria della Turrisi assume una maggiore importanza considerando anche
l’epoca in cui visse.
Siamo
in epoca risorgimentale caratterizzata da rigidi schemi culturali dai quali la
Turrisi, grazie anche alle sue doti personali e alla situazione economica della
sua famiglia, s’allontanò.
Siamo
ancora lontani dalla proclamazione del 17 marzo 1861 del regno d’Italia e in
presenza di un Italia frammentata geograficamente e con diversi orientamenti
culturali.
La
società doveva affrontare problemi diversi ma tutti importanti:
-
Costruire
o formare un senso d’appartenenza nazionale;
-
Creare
le basi economiche, sociali della nuova società;
-
Incrementare
l’alfabetizzazione.
L’alfabetizzazione
era un aspetto importante perché aveva
come obiettivo educare la gente la sacrificio per la nazione. Un risultato
decisamente irraggiungibile nell’abbruttimento dell’ignoranza.
L’istruzione
impartita alle fanciulle in questo periodo, facile intuirlo, è soprattutto di
tipo pratico e teorico.
Le
fanciulle , anche quelle di buona famiglia, erano chiamate a gestire la casa e
a “conoscere” quelle aspetti
familiari come la funzione materna e quello della “massaia”.
Le altre discipline, soprattutto quelle
umanistiche, erano espresse attraverso contenuti che erano selezionati in base
al cattivo pregiudizio sulle capacità intellettuali femminili. S’insegnava la
corretta espressione femminile attraverso testi che erano per certi versi
depurati delle parti che venivano considerati inappropriati alla sensibilità e
al decoro femminile.
Un aspetto della cultura che potremo definire
conservatrice , chiusa al rinnovamento sociale.
C’era nel tempo un volume “Degli Sudi delle donne”
dove l’autrice Caterina Franceschi Ferrucci (1803 – 1887) descriveva un vero e proprio
repertorio di libri adatti alla formazione, secondo l’età, delle educande. Un
testo molto in uso nel XIX secolo.
Un
trattato di quattro volumi
Caterina
Franceschi Ferrucci
Socia
corrispondente della Regia Accademia delle Scienze di Torino
Altro
testo della stessa autrice
Un’altra
pedagogista, Ginevra Canonici Fachini (1779 – 1870) analizzò i romanzi
contemporanei per poi valutare la lettura se adatta o meno alle fanciulle
secondo la fascia d’età. Nello stesso tempo fece un elenco dei romanzi ritenuti
adatti alla lettura delle fanciulle.
Una
pedagogia ottocentesca molto limitata dove veniva quindi prefissato uno schema
di studio legato ad un pregiudizio biologico in cui l’ingegno femminile è meno
predisposto ad uno studio intenso ed approfondito degli aspetti della vita.
Un
pregiudizio che si trascinerà nel tempo se è vero che nel 1904 venne pubblicata
un opera dal titolo “L’inferiorità mentale delle donne” scritto da
Moebius.
Paul Julius
Moebius
Nei
classici della letteratura si cercava di esporre solo una morale e gli
scrittori diventavano dei simboli. Così Dante simboleggiava il riscatto nazionale
senza andare troppo nel dettaglio; Petrarca
nel suo formulario amoroso o ancora con la sua canzone eroica e il
Leopardi per la sua malinconia.
Lo
studio dello stile era scoraggiato,
vietato alle donne che si volevano dedicare alla prosa. Si dovevano adattare
delle forme standardizzate e poca attenzione si prestava nell’insegnare le
regole dell’ortografia e della punteggiatura.
Si
ha la visione di una donna, anche se istruita, considerata estranea al “genio” letterario e questo non
per un aspetto legato al suo ruolo sociale di subalterno all’uomo ma proprio
per una differenza biologica rispetto all’uomo.
La
Turrisi mise in discussione questi
discriminazioni che erano fortemente radicate.
Quelle
poche letterate che emergevano erano destinate al dilettantismo obbligato come
conseguenza di un’istruzione deficitaria e inferiore rispetto agli uomini.
La
diffusione dell’istruzione mise in discussione tutto questo teorema mostrando
come la scrittura poteva essere espressa, anche con risultati maggiori rispetto
agli uomini, anche dalle donne.
Fu
proprio grazie alla rivoluzione che le donne siciliane colsero l’occasione per
uscire dalla sfera opprimente della vita privata e riuscire a sperimentare,
anche se per breve tempo, la loro vita pubblica rivolta al sociale.
Senza
nulla togliere alle altre letterate la Turrisi era un caso particolare perché
aveva avuto una formazione culturale ed
aveva degli spazi temporali da dedicare alla letteratura.
La
Turrisi parlò più volte di una “cella solitaria”… stato obbligato di
prigionia ?
Un
allusione forse metaforica intesa come ridotta libertà di cui soffrì più volte.
Una
stanza ora segreta, oscura, solitaria, cara ma su tutti “segreta cella dei
pensieri” indispensabile per avere un luogo dove riflettere, pensare e
plasmare attraverso la scrittura le sue riflessioni.
La
Turrisi ricevette rispetto alle sue colleghe una cultura o un istruzione
decisamente superiore che potremo definire da uomo.
Questa
cultura finì con l’opprimerla e le fece presagire infausti destini.
Ricevette
dei riconoscimenti che furono lontani da quelli ottenuti dalle colleghe e diede
vita a delle liriche di grande senso poetico.
Il
suo canzoniere è diviso in più filoni : personale, sulla natura, storico-civile,
letterario e religioso.
Le
poesie includono molte liriche dedicate alla famiglia, agli amici, ai conoscenti
e a se stessa.
Nelle
liriche di carattere familiare, molto criticate, emergono sentimenti come l’amore, la stima,
la riconoscenza verso i genitori ed anche altri argomenti.
In
queste liriche la poetessa si libera da aspetti schematici s’abbandona a
momenti di forte riflessione personale che rilevano punti di vista in alcuni
casi femminista.
Nella
lirica “Per le Nozze della sorella” col principe di Fitalia, colpisce una
terzina che a prima vista potrebbe sembrare banale ma che ha accenti molto
rivendicativi:
Vien, dolce amica
de be’ giorni miei,
Vieni, e come il
ciel vuole, a lui ti giura,
A Lui che, spero,
intenderà chi sei.
La
poetessa augura alla sorella che il marito sappia comprenderla nel suo essere.
Nella
lirica c’è anche una riflessione sulla Sicilia del tempo che viene descritta
con un tono malinconico per le sue condizioni così lontane dall’illustre
passato:
a queste terra
d’ogni oltraggio inulta
Invidii almen per
noi le tele e i carmi
Ogni terra più
libera e più culta.
Scrisse
anche delle liriche ispirate alla natura.
Uno sguardo amorevole alla natura che ha una sua origine nel suo studio
dei classici e di vari scrittori contemporanei. In questi versi troviamo spesso
degli stili leopardiani come nella lirica “Una sera d’Autunno” dove la natura
serena è il simbolo di una fugace felicità.
È
presente la luna, l’astro notturno, che osserva dall’alto gli eventi degli umani ed il loro destino, un tema
ricorrente nella poesia leopardiana.
Ma
la lirica della Turrisi è originale e nuova perché la luna è benevola ed non è
sempre indifferente agli eventi umani.
Sembra
vegliare sul “dolce sonno eterno” e il suo fulgore, la sua luminosità
aggiunse una nota di pietà umana all’astro, la cui luce, debole e declinante,
sembra rendere un ultimo e mesto tributo alle “poetiche ossa “ della scrittrice
che immagina “nei campi” il proprio sepolcro.
Dolce Luna
d’Autunno ! Oh quando bianca
Sarà la chioma, e
vacillante il piede,
Ringiovanir potrà
l’anima stanca,
Se il tuo raggio
purissimo rivede:
Ma se per me la
tomba si spalanca,
E d’ogni mal fra
poco avrò mercede,
Ohimè non chiudian
le poetiche ossa
In un Chiostro,
nei campi io vo’ la fossa.
Nei campi, fra
l’erbette, i fior, gli augelli
Quel dolce sonno
mi sarà più grato;
Che val la pompa
di superbi avelli ?
Meglio un sasso di
lagrime bagnato,
Della mia vita gli
angeli più belli
Su questo
chineranno il volto amato;
Su questo i lauri
fioriran, su questo
L’astro d’amore
splenderà più mesto.
La
Patria è presente in tutte le tematiche trattate dalla poetessa. Scrisse molto
pensando alla Patria sebbene le liriche patriottiche non siano molte.
In
queste liriche traspare tutta la passionalità, la voglia di vivere, di fare,
insomma lo “spirito guerriero” della Turrisi spesso represso dalla sua
condizione di donna, dalla scarsa visibilità che ebbe il suo scrivere nella
remota Sicilia. Questo sia per le convenzioni sociali dell’epoca sia per lo scarso riscontro delle sue non trascurabili
doti
letterarie.
I
toni battaglieri si alternano a toni malinconici che sono anche la conseguenza di un isolamento,
dell’anonimato.
Ci sono degli aspetti di critica come nella
lirica “Alle donne siciliane” dove rivolge un appello caloroso alle sue
conterranee affinchè smettano di stare al posto e di “nascondersi nelle loro
stanze”, ed “abbiano il coraggio di insorgere, di appropriarsi di quella
cultura che ormai da troppo tempo viene loro preclusa, trasformandosi nei nuovi
baluardi di speranza per la Sicilia”:
Perché l’umil cure
e l’ozio indegno
Tolgon fuoco
all’ingegno
Se qui, di senno e
di virtù colonna,
Qui preparava Nina
Disdegnando la
gonna,
Al divino Alighier
l’arpa divina ?
Deh,mel credete,
ch’io favello il vero,
Il celarsi è
vergogna,
Sorgete, o care, e
nella propria stanza
Per voi torni
l’ardire e la speranza.
In
occasione della drammatica epidemia di colera del 1837, causa della morte di
migliaia di persone in Sicilia, Giuseppina riuscì ad esprimere la sua forza
d’animo in versi incitando i suoi siciliani a ritrovare la speranza per
risorgere in nome della patria. Per questo motivo invita le donne ad osservare
il comportamento delle antiche eroine come Giovanna d’Arco o Giuditta.
La
sua è un’invocazione a reagire, a riprendere quell’orgoglio, la forza ed anche
l’audacia del loro genere di fronte ad una società che le regola al ruolo di
silenziose spettatrici.
Spetta alle donne, scrive Giuseppina, far ritrovare
alla Sicilia l’antico splendore e la grandezza di un tempo, purtroppo perduti,
e questi propositi li esprime nell’ode Alle donne siciliane,
scritta quando, nel 1843, da Parigi le chiedono – prestigioso riconoscimento –
un componimento da includere nel Parnaso italiano dei poeti
contemporanei. Per lei, femminista viva e originale alla stregua di tante
altre patriote e letterate del suo tempo, “né trastullo né servo è il nostro
sesso”, e l’educazione dei figli è un compito nobilissimo, in quanto è la madre
che plasma i futuri cittadini. Quindi, la “somma virtù” muliebre è indispensabile
alla patria, che ha bisogno di nuova linfa, perché solo attraverso il
risorgimento morale si può raggiungere quello politico, ed è questo ideale -
tenuto sempre alto e fermo - di donna “eroica” che combatte per un’Italia
unita, a caratterizzare la sua corrispondenza con altre poetesse, a
distinguere i suoi articoli sul polemico giornale La ruota.
Lo
stesso impeto e la stessa sensibilità anche nei componimenti di carattere
letterario. Vengono ripresi grandi scrittori soprattutto quelli in cui il suo spirito
malinconico sia simile al suo.
Un
grande ammirazione da parte della scrittrice a George Byron, il poeta inglese
morto a 36 anni a Missolungi. Una vera e propria fonte d’ispirazione per la
poetessa.
Molti dei suoi componimenti furono ispirati al poeta
inglese che costituì per la Turrisi la personificazione di tutto ciò che
avrebbe voluto per sé; la libertà, l’idealismo, l’impero, la gloria.
Pregevole il suo impegno di rivolgersi alla sua
generazione con la nobile ambizione del fare, di quei giovani e soprattutto di
quelle donne, l’èlite da guidare e formare nell’amore della cultura, della
patria e della virtù, con l’intento di forgiare l’illuminata classe dirigente
dell’avvenire.
Credette fermamente e sinceramente in questa missione
ma il suo canto non ebbe un eco sufficientemente ampia per portarla a
compimento.
Non fu purtroppo attorniata da un vero e proprio
circolo di intellettuali per cui nessuno alla sua morte sviluppò ulteriormente
gli aspetti del suo moderno pensiero.
Pur essendo una donna nata nella periferia d’Europa,
pur essendo morta in giovane età, ha lasciato di sé un’importante eredità
culturale, che solo recentemente ha iniziato ad essere ricattata
definitivamente dall’oblio nazionale e regionale.
----------------------
A Rosalia Colonna Nei Turrisi Baronessa di Buonvicino
Me solo amor consiglia,
Me sol conforta amore;
Dei carmi d’ una figlia
Quale offerta più nobile
Più degna è del tuo core?
Oh se l’affetto vero,
Le immagini leggiadre
M’infiammano il pensiero,
È tuo l’ onor, la trepida
Gioia, diletta Madre!
Sai chi dell’ estro il foco
Mi desta, chi m’ inspira?
Per te, pel natio loco,
Per l’amor dei magnanimi
Sudo a temprar la lira.
Che vai, se tanto zelo
Strugge l’etate acerba?
Io sol vivere anelo
Per poco, e te fra l’itale
Madri lasciar superba.
***
Alla
sorella
Quel
di, che contemplal lieta e dolente
L’onesta
immago del Toscan Maestro,
Che a
me sì pueril d’ anni e di mente
Lo
stile invigorì, gli affetti, e l’estro;
I’
benedissi la virtù crescente
Del tuo
pennello generoso e destro;
Senza
pianto, gridai, senza contrasto
Sien le
tue glorie: ad ogni danno io basto.
Ma da
quel dì quanto sudasti, e quanto
Nella
mano crescesti e nell’ ingegno;
Tutto è
nell’ arte de’ tuoi dì l’ incanto,
E della
fantasia popoli il regno:
A te
scrivendo giorno e notte accanto,
Ogni
effigie che pingi, ogni più degno
Pensier
tolgo alle fiamme, chè non mai
Di te,
dell’opre tue paga sarai.
Questi
cari pensier tutti raccolti
In bel
volume fra i miei versi mira;
Molti
li lodan, li vagheggian molti,
Ma sol
l’ anima mia se n’empie, e spira.
REPORT
THIS AD
Un’eterea
sembianza, un di quei volti
Che sol
d’ aver sognato il cor sospira,
Qui
trova il cor. Più del soave
Albani
Celesti pingerai gli aspetti umani.
Deh
pennelleggia pur su queste carte
Le
vittorie d’Italia e di Triquetra;
È la
Patria dì noi la miglior parte,
E lo sa
chi per lei vivere impetra:
Pari
nel foco, nei pensier, nell’ arte,
In pari
uso volgiam colori e cetra:
Tu di
te stessa, o Cara; io degna sia
Del mio
Maestro e della Patria mia.
***
Ultimo canto di Lord Byron
È ver; posarsi ormai dovrebbe il core,
S’è mal gradito, nè più gli altri infiamma;
Pur, non amato, serberò d’amore
Viva la fiamma!
De’ miei verd’ anni ecco fornito il corso;
Non ha più fiori amor, non ha più frutto;
Deh che mi resta? col fatal rimorso
Lagrime e lutto !
Come vulcano solitario splende
Nell’ alma il foco, e mi consuma, e spira;
Non altra fiamma che l’ estrema incende
Funerea pira!
Ogni cresciuto, ogni crudel tormento,
Ogni speranza, ogni gelosa pena,
D’amor la forza più non reca, il sento,
Ch’ aspra catena.
REPORT
THIS AD
REPORT
THIS AD
Oh men leggiadra è qui la mente e l’ alma !
Dei molli affetti vincerò la possa,
Avrò, lo spero, degli Eroi la palma,
0 nobil fossa.
Oh Grecia! oh gloria! d’ ogni tema ignudo
Dell’ armi ascolto, delle trombe il suono;
Come Spartano sul difeso scudo,
Libero sono.
Desta, o mio spirto, — che la Grecia è desta! —
Desta il tuo foco, la virtù che langue!
Forte mi scuoti: a versar corro in questa
Impresa il sangue!
Vinci ogni affetto risorgente, indegno
0 fredda etate ! — se per te si sprezza
Il riso, il pianto, il simulato sdegno
Della bellezza.
Oh perchè vivi, se caduto piangi
Il fior degli anni? qui novelli onori
Frutta la morte — fra le achee falangi
Combatti e muori.
Facil si trova, e fia per te del forte
Bello il sepolcro — intorno guata e scegli;
Nè dal riposo d’ onorata morte
Fia chi ti svegli.
REPORT
THIS AD
***
Le
rimembranze
E del
viaggio fatlcoso anch’ io
Trascorrer
veggio il sedicesimo anno,
E sento
come fugge ogni desio
Nella
misera valle, ed ogni inganno:
Quanti
pietosi, ahimè, del viver mio
Conforto
vero, abbandonata m’hanno;
Quanti
che meco semplici fanciulli
Sorridean
nelle fole e nei trastulli.
Con che
dolcezza candide, serene
Di quei
primi anni mi rivivon l’ore,
Che s’
adornavan come liete scene,
Come un
bel sogno, come un dì d’ amore!
Di cari
eventi, di memorie piene
Ritornano
dolcissime nel core;
E quei
tanti discesi negli avelli
Ritraggon
vivi e favellanti e belli ! —
Tempo
felice ! a piè dell’ amorosa
Antica
fante m’ assidea le sere,
E commossa
intendeva e lagrimosa
Nelle
fole dolenti e lusinghiere,
E
ripeteva, come santa cosa,
Quei cari
nomi nelle mie preghiere;
Ed oh
con che pietà serbava in petto
I casi
d’ una pia , d’ un giovinetto !
Caramente
serrando nelle braccia
L’immagine
talor d’una fanciulla,
La
baciava per gli occhi e per la faccia,
E dì
fregi adornavale la culla.
Tempo
felice! d’aurei sogni in traccia
Nulla
pur sogno che t’uguagli, nulla
Di quei
ludi fu mai, di quella niente
Più
soave, più caro, e più innocente!
Poichè
d’ altri piacer, poichè d’ altr’ opra
La
verissima brama s’accendea,
Sopra
le carte meditando, e sopra
I miei
pensier, le notti producea:
E di
qual nei bei rischi il senno adopra,
Quella
trepida speme in cor sorgea,
E viva
in ogni loco, in tutte l’ore
Nel suo
segreto la nutriva il core.
Ed un
colloquio di che amor, di quale
Ritentami
pietà! — Pallido il raggio
Della
Luna piovea, le tacite ale
Scotea
ricca dei fior l’ aura di maggio;
E
sciogliean lamentando oltre il viale
Gli
usignoletti il flebile linguaggio,
Allor
che mesta una dolcezza move
Dal
ciel , dai fonti , e dall’ erbette nove.
Meco
seduta una gentil donzella,
Perchè,
diceva, nei severi studi
Perdi
il sorriso dell’ età novella,
Perchè
vogliosa ti travagli e sudi?
Qual si
legge sai tu, qual si favella:
Cessa
le cure faticose e rudi,
E
meglio godi ricreduta, oh meglio
Ai
passeggi, ai teatri, ed allo speglio! —
Io di
rincontro: il sai; dai teneri anni
Arcanamente
dentro il cor profondo
Un
amaro provai senso d’affanni,
Un
tedio lungo, un diffidar del mondo.
Nè
della giovinezza i dolci inganni
Mi
suadono il vivere giocondo;
Ma
nelle veglie della fida stanza
Mi
lusinga soltanto una speranza.
Ed
Ella: statti, chè per me non sono
Di così
dure tempre; alle amorose
Letizie
io credo: A te l’allór; tel dono
Se
invaghita ne sei; dammi le rose. —
A quei
detti fidenti, all’abbandono
Ahi
troppo avverso l’ avvenir rispose,
E al
primo voto, al primo dì d’ amore
Si
recise degli anni il più bel fiore. —
Misera!
e dalla lagrimata bara
Un nome
non avrai nei dì novelli,
Chè sol
dell’opre faticose, o cara,
Nei
volumi si vive oltre gli avelli:
Pel
dolce capo tuo, per ogni amara
Rimembranza
che al cor di te favelli,
Io
giuro meditar nei giorni mesti,
Perchè
un vestigio, un’ombra di me resti.
***
Alle
donne siciliane
No,
benchè il tempo muta
La
fortuna dei regni e delle genti ,
Non han
foglia perduta
Le tue
belle corone, o Patria mia!
I sensi
e le parole
Vivon
di quanti meditar nascosi
Negli
ozj generosi;
Vivono
ancor gli altissimi portenti
Dei
campioni vetusti,
Primieri
nei cimenti,
Fra
lance, e spade, e riversati busti
Deh sì
lieto per noi rifulga il sole;
Deh,
come il cor desia,
In noi
l’ardire dei Sicani Eroi,
L’antica
tempra si rifonda in noi!
Se la
benigna etade
I petti
nostri al paragon non chiama
Dell’
ira e delle spade,
Oh ne’
caldi pensier, nell’ opre oneste
Si
riconforti l’ alma !
Assai
più giova di tenzoni e d’ armi
La
bell’arte dei carmi,
Che il
sorriso di pace e gli ozj brama ,
E ne
lusinga e regge
A
magnanima fama,
D’ ogni
affetto maestra e d’ ogni legge.
Vile
chi sdegna la sudata palma!
Saprà,
nelle funeste
Cure
invilito, nei piacer bugiardi,
Come il
rossor, se pur l’infiamma, è tardi.
E da
quest’ almo suolo
Arditamente
d’ animosa donna
Aprivan
gl’ inni il volo.
Oh quel
vanto perchè più non s’ agogna
Da
libero pensiero?
Perchè
l’ umili cure e l’ ozio indegno
Tolgon
foco all’ ingegno
Se qui,
di senno e di virtù colonna,
Qui
preparava Nina,
Disdegnando
la gonna,
Al
divino Alighier l’ arpa divina?
Deh,
mel credete, eh’ io favello il vero,
Il
celarsi è vergogna.
Sorgete,
o care, e nella patria stanza
Per voi
torni l’ ardire e la speranza.
Giovinezza
non dura
Sulle
gote vermiglie e sul bel crine
Per
letizie o per cura,
E tutti
spegne dell’ etate il gelo
Quanti
florian diletti,
Finchè
si scavi all’ ultima percossa
Un
obbliata fossa.
Deh men
crudeli di quaggiù le spine
Il
bell’ oprar ne renda,
Ben
nate cittadine,
E del
loco natio l’ amor v’ accenda.
Più
sicure dovizie agli intelletti
Non
piovono dal cielo;
Nè
soave lusinga o dolce incanto
È qui
verace, ove sol dura il pianto.
Sicilia
in noi riscossa
Rintegrerà
l’ indomito ardimento,
Le
leggi sue, la possa.
Ahi !
smisurato divampava lntorno
Il
morbo furibondo,
E le
rapia l’ alme più calde, i primi
Esemplari
sublimi.
Senz’irà,
senza onor, senza cimenti
Un
popol si moria.
Derelitto,
sgomento,
Per le
case dolenti e per la via !
Quanti
del sogno ebe più ride al mondo
Eran
sul primo giorno
Quando
s’ affanna irrequieto il core
Nei
dolci voti e nel desio d’ onore !
0
sfortunati nostri,
Su voi
commosso qual fratel più sente
Deplorando
si prostri ;
Guati
la croce, e le glebe, e le pietre
Su pel
funereo loco,
E
d’uguale virtù, d’uguale affetto
Arda il
commosso petto. —
Pel
suol che vi nutria sì dolcemente,
E in
che durano pure
Quanti
amati lasciaste alle sventure,
Voi
lassù, redivivi Angeli, invoco:
Le
divine faretre
Torni
dei prischi Eroi, torni l’ etade.
***
L’addio
di Lord Byron all’Italia
Alfin
partia. Chi del crudel momento
Può
narrar le memorie ed il dolore,
E ciò
che disse ai monti, all’acque, al vento
Di quella terra ove lasciava il core?
Oh come quel dolcissimo lamento
Fu travolto per ira o per livore!
Qual menzognero addio sulle divine
Labbra pose un Francese, un Lamartine?
Di quella terra ove lasciava il core?
Oh come quel dolcissimo lamento
Fu travolto per ira o per livore!
Qual menzognero addio sulle divine
Labbra pose un Francese, un Lamartine?
Taci!
L’italo amor del mio Britanno,
Gl’itali
sensi, oh male, oh mal comprendi:
Non all’Italia no; ma frutteranno
Onta infame a te stesso i vilipendi.
Italia morta? e innanzi a te non stanno
Ancor vivi, temuti, ancor tremendi
Ugo, Alfieri, Canova’ e presso a questi
Sì magnanimi Eroi, dinne, che resti? —
Non all’Italia no; ma frutteranno
Onta infame a te stesso i vilipendi.
Italia morta? e innanzi a te non stanno
Ancor vivi, temuti, ancor tremendi
Ugo, Alfieri, Canova’ e presso a questi
Sì magnanimi Eroi, dinne, che resti? —
Quella
terra, quel ciel che l’innamora,
Pien di mille pensier, di mille affetti,
Giorgio saluta dalla mesta prora
Coi sospiri, coll’anima, coi detti:
Chi non sogna di te? chi non t’adora,
O bella Patria d’ animosi petti,
Bella Patria dell’arti! il viver mio
Tu che allegrar potesti, Italia, addio.
Pien di mille pensier, di mille affetti,
Giorgio saluta dalla mesta prora
Coi sospiri, coll’anima, coi detti:
Chi non sogna di te? chi non t’adora,
O bella Patria d’ animosi petti,
Bella Patria dell’arti! il viver mio
Tu che allegrar potesti, Italia, addio.
Italia!
Italia! com’è dolce il suono
Della celeste armonica favella!
Nel ciel, nelle odorate aure, nel dono
D’ ogni cosa gentil, come sei bella !
Di foco è l’alma dei gagliardi, sono
Di foco gli occhi d’ ogni tua donzella;
E da quegli occhi, da quell’alme anch’io
Se il bel foco ritrassi, Italia, addio.
Della celeste armonica favella!
Nel ciel, nelle odorate aure, nel dono
D’ ogni cosa gentil, come sei bella !
Di foco è l’alma dei gagliardi, sono
Di foco gli occhi d’ ogni tua donzella;
E da quegli occhi, da quell’alme anch’io
Se il bel foco ritrassi, Italia, addio.
Ahi !
per le sette cime e per le valli
Dei
famosi che avean la terra doma,
Più non s’urtan guerrieri, armi, cavalli,
Più non suona il trionfo Italia e Roma;
Nè più s’avventa ai minacciosi Galli,
Sanguinoso gli artigli, irto la chioma,
Il gran Leon di Marco, e steso e muto
Anco abborre l’Eroe che l’ ha venduto.
Più non s’urtan guerrieri, armi, cavalli,
Più non suona il trionfo Italia e Roma;
Nè più s’avventa ai minacciosi Galli,
Sanguinoso gli artigli, irto la chioma,
Il gran Leon di Marco, e steso e muto
Anco abborre l’Eroe che l’ ha venduto.
Venduto!
ahi rabbia! qual vergogna è questa,
Qual crudo patto, quale iniquo orgoglio !
L’italo sangue avrai sulla tua testa
O snaturato nell’ infame scoglio.
Tu le piaghe sanar d’Italia mesta,
Tu rialzar dovevi il Campidoglio,
Tu di Cammillo erede, il brando e il senno
Vendesti ai figli che scendean di Brenno.
Qual crudo patto, quale iniquo orgoglio !
L’italo sangue avrai sulla tua testa
O snaturato nell’ infame scoglio.
Tu le piaghe sanar d’Italia mesta,
Tu rialzar dovevi il Campidoglio,
Tu di Cammillo erede, il brando e il senno
Vendesti ai figli che scendean di Brenno.
Fioria
d’ogni virtù, d’ogni divina
Arte di pace questo suol fioria,
E il tuo brando recò fatal ruina,
E libertà peggior di tirannia.
Oh bugiardi Licurghi! oh Cisalpina,
Oh congrega di ladri, oh peste ria!
Fu per l’italo suol, fu crudo inganno
Se Marengo vincesti e l’ Alemanno.
Arte di pace questo suol fioria,
E il tuo brando recò fatal ruina,
E libertà peggior di tirannia.
Oh bugiardi Licurghi! oh Cisalpina,
Oh congrega di ladri, oh peste ria!
Fu per l’italo suol, fu crudo inganno
Se Marengo vincesti e l’ Alemanno.
Com’
aquila fra i nembi, o come lampo
Terribil passa, egli passò l’invitto;
E copre mesto, solitario campo
Il terror dell’ Italia e dell’ Egitto.
Io, benché tutto alla memoria avvampo
Di tanto Eroe, di sì fatal conflitto,
Io fremo, e dico: se vittoria il guida,
La comprò col delitto il parricida !
Terribil passa, egli passò l’invitto;
E copre mesto, solitario campo
Il terror dell’ Italia e dell’ Egitto.
Io, benché tutto alla memoria avvampo
Di tanto Eroe, di sì fatal conflitto,
Io fremo, e dico: se vittoria il guida,
La comprò col delitto il parricida !
Oh
perdona all’ ingrato! oh alfin riposa
Dopo tanto dolor, tanto contrasto,
E a più bei studi intenta, o Generosa,
Spregia l’armi crudeli e spregia il fasto:
Teco, Madre d’Eroi, teco avrò posa
Io che a soffrir la vita, ohimè ! non basto.
Ritornerò più grande; il cener mio
Qui dormirà compianto: Italia, addio.
Dopo tanto dolor, tanto contrasto,
E a più bei studi intenta, o Generosa,
Spregia l’armi crudeli e spregia il fasto:
Teco, Madre d’Eroi, teco avrò posa
Io che a soffrir la vita, ohimè ! non basto.
Ritornerò più grande; il cener mio
Qui dormirà compianto: Italia, addio.
Deh
posa, posa: troppo dolce e santo
È d’una pace desiata il raggio;
Ma pace bella d’ogni nobil vanto,
Non ozio d’infingarde alme retaggio.
Divina Italia! con che amaro pianto
Vado altrove a cercar lodi al coraggio;
Pur Grecia sogno, e mi vi chiama un Dio…
Addio, Patria mia vera, Italia addio.
È d’una pace desiata il raggio;
Ma pace bella d’ogni nobil vanto,
Non ozio d’infingarde alme retaggio.
Divina Italia! con che amaro pianto
Vado altrove a cercar lodi al coraggio;
Pur Grecia sogno, e mi vi chiama un Dio…
Addio, Patria mia vera, Italia addio.
***
All’Angelo
mio
Oh di
te nulla è più soave, oh nulla
Di te
più ride nella mente mia!
Tu mi
baciasti nella rosea culla,
Mi bacerai
nell’ ultima agonia:
Tu
spiravi alla tenera fanciulla
Pensier
celesti, amabile armonia:
Tu meco
in ogni tempo; ma nell’ ore
Più
solitarie più ti sente il core.
Quaggiù
non ti vedrò: quell’immortale
Beltà
sol degna è d’ ammirarsi in cielo;
Ma il
soffio leggerissimo dell’ ale
M’
agita, mentre io parlo, il crine e il velo.
Amar
dunque tu puoi cosa mortale,
Tu puoi
vegliarmi con fraterno zelo?
O mio
fedel Cherubo, o mio verace
Consolator
nei rischi e nella pace.
Quando
è il pensier più mesto e in sè raccolto,
Al mio
pianto risponde un suon di pianto;
Sento
una man che m’ accarezza il volto,
Sento
una voce che m’ invita al canto:
È la
tua man, la tua voce che ascolto,
Sei tu
che piangi all’ infelice accanto ;
Più
degli eterei balli, o giovinetto,
Ami i nostri
colloquj, il nostro affetto.
E tu
invisibil nella valle amara
Mi
seguirai, misterioso amico:
Oh mi
rendi, se il puoi, la vita cara,
La vita
che paventa il cor pudico.
O almen
di rose infiorami la bara,
Fa che
in terra non lasci alcun nemico,
Dammi
il bacio di morte: il volto mesto
Io sul
tuo collo piego, e in Ciel mi desto.
-------------------------
La
sorella Anna (Annetta) era nata anch’essa nel Palazzo Asmundo di
Palermo, il 4 agosto 1820.
Sin
da giovane si era dedicata alla pittura. Studiò i grandi maestri del ‘500 ed ebbe tre grandi artisti del tempo; Agatino
Sozzi, Giuseppe Patania e Salvatore Lo Forte.
Iniziò
a dipingere bellissimi ritratti tra cui quello della madre e della regina
Costanza d’Altavilla. Un quadro che raffigura la regina mente esce dal
monastero ed ispirato al terzo canto del Paradiso di Dante. Quadro che si trova
nel Palazzo della Società Siciliana di Storia Patria.
Quando
Annetta finiva di dipingere un quadro, molti dei suoi capolavori raffigurano
ambienti e vedute di Palermo, la sorella Giuseppina gli dedicava una poesia.
Un
autoritratto di Anna si trova nella Galleria D’Arte Moderna Empedocle
Restivo a Palermo. Sposo a Palermo nel
1843 Pietro Settimo, principe di Fitalia. Con la nascita dei figli “lasciò i
pennelli per sedere a studio della culla”.
Anche
Annetta come Giuseppina fu sfortunata perché morì di tisi a Castelbuono, 14 febbraio 1848, tre giorni
prima della morte della sorella,
Monumento funebre
ad Annetta Turrisi colonna
(Pantheon di
Palermo)
Annetta Turrisi
Colonna
“San Giovanni
della Croce”
Olio su tela – (66
x 52) cm – del 1836
Firmato in basso a
sinistra entro cornice a canna “ciaccata” in legno dorato
Annetta Turrisi
Colonna
“Madonna col Bambino
e San Giovannino”
Provenienza :
Monreale, Albergo dei Poveri
Collocazione:
Museo Diocesano di Monreale
Olio su tela –
Datazione : XIX secolo
Restauro : (24
Febbraio – 20 Maggio) 2014
Restauro eseguito
dal prof. Gaetano Correnti
Il dipinto è esposto
nella cappella Neoclassica del Museo Diocesano di Monreale.
È incorniciato
dall’originale cornice in legno intagliato e dorato.
Fu realizzato da
Anna Turrisi Colonna probabilmente durante la fase di
collaborazione e
apprendistato presso la bottega dell’artista
Giuseppe Platania
( prima de3l biennio 1836 – 37).
Il dipinto è copia
della Madonna d’Alba esposta alla National Gallery di
Washington e realizzata da Raffaello Sanzio intorno al 1511. La Madonna è
seduta in terra che tiene su una gamba Gesù Bambino, il quale gioca con San
Giovannino afferrandone la croce. Le figure sono inserite in un luminoso
paesaggio bucolico.
Il dipinto si
presentava in cattivo stato di conservazione. La tela, infatti, non manteneva
una sufficiente tensione sul telaio ligneo, nonostante la foderatura di inizio
secolo, e mostrava diverse cadute di colore. La lettura della cromia originale
risultava alterata dal degrado della vernice superficiale, divenuta giallastra,
e dai numerosi ritocchi ad olio, osservati con luce diretta e radente, segno di
una grossolana azione manutentiva precedente.
Durante
l’intervento conservativo è stata effettuata la rimozione dei depositi
superficiali incoerenti tramite pennello di setole morbide. La velinatura della
superficie pittorica è stata eseguita attraverso adesione di carta di riso con
colletta. Smontato il telaio originale, sono stati rimossi i depositi
superficiali incoerenti del verso della tela tramite l’uso di
aspiratori. È stata rimossa la vecchia tela da rifodero, il beverone
sottostante, ed è stata realizzata la foderatura con colla pasta. Infine, il
dipinto è stato montato su nuovo telaio ligneo ad espansione calibrata. Sono
state rimosse le vernici ossidate e i ritocchi alterati tramite applicazione di
miscele solventi organiche calibrate e testate in fase operativa. Si è
proceduto, quindi, alla stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colla di
coniglio e alla reintegrazione pittorica a tono delle piccole lacune e delle
abrasioni della superficie pittorica con tecnica riconoscibile ed equilibratura
tonale generale. Infine, è stata applicata su tutta la superficie vernice a
tampone e a pennello.
Le due Sorelle, Annetta e Giuseppina ?
È
questa la triste storia di due donne unite insieme nella vita e nella morte..
----------------------------------------
4.
Letteria Montoro
Era nata a Messina
il 19 aprile 1825, morta il primo agosto 1893. Una donna di altissima
intelligenza e di cuore immensamente benefico e generoso. Ella amò il
sacrificio sino all’eroismo, e benchè fornita di singolare bellezza nel volto e
nella gentil persona, compresse ogni sentimento dell’animo tenero e poetico, e
rifiutò i vari matrimoni che le si offrirono per rimanere in famiglia, la quale
aveva indispensabile bisogno di lei. Poetessa nata, scrittrice forbita e
gentile, di quando in quando, se le cure domestiche glielo consentivano,
affidava i suoi sentimenti alla carta, e scrisse parecchie poesie e qualche
romanzo senza pretesa di gloria; ma ciò malgrado molte sue composizioni ebbero
pubblicità, ed ella bentosto fu salutata poetessa […]. Il suo stile lo formò
soprattutto la lettura del leopardi, la cui patetica poesia prediligeva (Oliva
1954).
È un sintetico profilo dello storico messinese
Gaetano Oliva che riportò Letteria Montero, unica donna, nel suo libro sui
“Messinesi Illustri”.
Eppure
di lei si sono perse le tracce, la memoria storica.
La
sua lapide era posta nella cella sotterranea della Galleria Monumentale del
Cimitero di Messina. Il terremoto del 1909 distrusse ogni cosa facendo
sparire anche i resti mortali della
brava scrittrice.
Della
sua vita familiare non si sa molto. Era figlia di un esule, grazie alla
prefazione del suo romanzo “Maria Landini” dove affermò di
“aver ritratto
nella figura del proscritto Antonio il proprio padre”
Una
giovinezza trascorsa come molte altre donne dell’epoca nell’ambito familiare
nel segno dell’esclusione ma nello stesso tempo con gli ideali democratici.
Infatti
in base alle poche fonti, partecipò ai moti rivoluzionari del 1848 collaborando
al giornale patriottico “L’Aquila Siciliana”.
Un
giornale che era nato il 16
febbraio del 1848 durante i moti. Per
questa sua partecipazione alle idee rivoluzionare fu esiliata e a quanto sembra
continuò a svolgere un importante ruolo di mediazione e di contatto tra
confinati politici e strutture di governo..
Ritornò
a Messina negli anni ’50. ?
Nel
1863, trent’ottenne, scrisse un
componimento per la morte del fratello,
il sacerdote Francesco Montoro. Nel componimento appare la figura di una donna
che per consentire al fratello di svolgere diversi ed importanti incarichi pubblici,
si dovette occupare in prima persona della famiglia.
Una
donna che aveva accettato, dopo il periodo rivoluzionario, di vivere all’ombra
del fratello che era direttore del Collegio Peloritano messinese e direttore
spirituale del liceo ginnasio Maurolico.
La
lontana partecipazione ai moti rivoluzionari non erano però svaniti. La donna
vi aveva partecipato con una forte ideologia e convinzione ed ora con i nuovi tempi decise di continuare a fare
sentire la sua voce piuttosto che annullarsi completamente nelle sua attività
d’occupazione domestica che costituivano
“croce e delizia,
regno e prigione delle donne dell’Ottocento”.
Si
dedicò quindi ad iniziative filantropiche e
attività in campo educativo ed assistenziale.
Nel
1878 (?) scrisse un accorata ode “Sulla tomba della chiarissima Mariannina
Coffa poetessa netina,,”
“Nei trasporti
d’amore, nella conversazione con l’amata,
nei favori che ne
ricevi, anche negli ultimi,
tu vai piuttosto
in cerca della felicità di quello che provarla,
il tuo cuore
agitato, sente sempre una gran mancanza,
un non so che di
meno di quello che sperava, un desiderio di qualche cosa […]
la miglior parte,
la più dritta strada al piacere,
e a un’ombra di
felicità, è il dolore”.
Molte
delle poetesse del tempo pubblicavano a Palermo
e a Messina che dal punto di vista culturale era collegata a Napoli
verso cui i letterati messinesi si rivolgevano per pubblicare su periodici a
rilevanza nazionale.
L’attività
della Montoro non fu esigua perché si presentò molto diversificata tanto da
superare il ristretto ambito cittadino.
La
poetessa pubblicò spesso a Palermo per editori e riviste e ottenne, oltre lo
Stretto, l’inserimento nella “Strenna Filantropica”. Un progetto
fortemente voluto dalla duchessa Felicita Bevilacqua, che aveva richiesto per
la sua attuazione un fitto scambio epistolare tra le donne intellettuali di
ogni parte d’Italia.
Alcuni
scritti della Montero furono inseriti in volumi antologici di portata
nazionale: La Ghirlanda della Beneficenza, La “Strenna Filantropica”,
“Candia: scritti in prosa e in verso”, una pubblicazione di grande
rilevanza politica perché finanziata dal comitato filellenico messinese per
aiutare i combattenti cretesi del 1866.
La
Montoro doveva essere nota alle altre scrittrice siciliane del tempo che
incontrò nella testata giornalistica “La Donna e la famiglia” (del 1862
– 1864) dove scrissero Rosina Muzio Salvo, Concettina Ramondetta Fileti e Mariannina Coffa. Le tre scrittrice
probabilmente ebbero la possibilità di
leggere il romanzo della stessa Montoro , “Maria Landini”. Un romanzo
che fu pubblicato a Palermo, Clamis e Roberti, 1850.
Maria
Landini racconta l’intricata vicenda di una ragazza Maria che abbandona la
propria casa e i parenti per evitare l’unione con un personaggio ricco e
malvagio, il barone Summacola. La ragazza nella sua fuga rocambolesca viene aiutata
dalla famiglia di Roberto Altieri danneggiata dallo stesso barone.
Trama:
“
Roberto Altieri soccorre con la figlia Giulia una giovane sconosciuta, che si
saprà poi essere Maria. La coppia è afflitta perché l’altro figlio, Edoardo, è
stato arrestato da un malvagio magistrato, il barone Summacola; la madre Adelia
ne muore di dolore.
Inutilmente
gli Altieri avevano cercato di intercedere presso la corrotta nobiltà del
luogo; neanche il pontefice aveva dato loro ascolto. La storia di Maria e le vicende degli Altieri sono connesse in
vario modo: Eduardo aveva conosciuto casualmente Maria e se ne era innamorato;
la ragazza a sua volta era stata promessa dagli zii proprio a Summacola, ma
temendo il barone, del quale avvertiva la doppiezza, era fuggita nella notte.
Maria
era già sradicata dal proprio contesto familiare di origine perché figlia di un
esule, messo al bando per aver aiutato un uomo ingiustamente accusato; alla
morte del padre, impazzito dal dolore, Maria era andata a vivere a Roma dalla
zia.
Nella
sua fuga, che racconterà agli Altieri, la ragazza incontra un vecchio saggio;
questi le fornisce una scorta cui affidarsi durante il viaggio, un uomo
sfregiato di nome Lorenzo, che è in realtà Enrico, amico di Edoardo, riuscito a
sfuggire all’arresto. La cicatrice deriva da uno scontro con dei banditi.
Maria
e Lorenzo s’imbattono in un gruppo di armati, ma la ragazza riesce a fuggire,
arrivando stremata in un cimitero dove la trovano gli Altieri.
Mentre
Edoardo soffre nella terribile prigione di Castel Sant’Angelo Enrico, sotto le
spoglie di Lorenzo, elabora un piano per farlo fuggire, convincendo un
carceriere.
Dietro
tutte le mosse dei giovani ci sono i consigli del vecchio saggio, che altri non
è che il nonno di Enrico, Giovanni Martelli, uno uomo giusto costretto
all’esilio.
Edoardo
ed Enrico, ormai liberi, si recano un Francia; a Roma Roberto si batte in
duello con Summacola e lo sconfigge: questi si pente e rivela di aver
perseguitato gli Altieri poiché aveva amato senza speranza la moglie di
Roberto, Adelia. Nella conclusione Roberto e Giovanni Martelli si ritrovano,
gli esuli ritornano, e il magistrato si ritira in eremitaggio.”
Nella
trama sono facilmente riconoscibili elementi manzoniani anche se rivisti e con
nuovi sviluppi. Il matrimonio non è il fine ultimo della vicenda ma un male da
evitare. La protagonista non accetta le situazioni predisposte da altri ma
oppone ad essi la propria volontà d’agire.
I
parenti si mostrano propensi ad un unione della povera orfana con un
personaggio benestante anche se cattivo, tanto che la zia in maniera ipocrita
afferma…
“ coi tuoi
consigli e col tuo esempio lo trarresti al sentiero d’onore”.
La
zia esegue una forte pressione psicologia sulla ragazza con i suoi insistenti
ricatti sentimentali così violenti che Maria arriva a temere non l’ira della
donna ma piuttosto
“le sue parole
amorevoli”
che
richiamavano l’autorità del padre morto e di un Dio benedicente l’unione ma
immediatamente smascherati da Maria…
“Ah ! Il padre
avrebbe interrogato si i miei palpiti, ma non ha mai pensato dirigerli!”
“Dio ! Tu il cuore
creati libero”.
Maria
sembra in quest’ottica un anti-Lucia che
si mantiene distante da un atteggiamento acquiescente, tradizionalmente
femminile. L’unione d’interesse è vista come un “sacrificio di una vittima” e
“ferale olocausto”; una violenza terribile che, per quanto ammessa dalla
società, turba l’equilibrio naturale ed è infatti accompagnata, nel giorno
delle nozze, dallo scatenarsi degli elementi:
“ .. nel sibilo
del vento, che sordo e sinistro perturbava l’aere,
io sentiva il
preludio di eterna maledizione alla mia viltà. Io vile !
Io l’obbrobrio di
me stessa !... non sarà mai !
Una
Maria ribelle che affronta la fuga, le tenebre del bosco, il senso di rovina e
di distruzione che emana il paesaggio naturale e il suo fermarsi in un cimitero,
che simboleggia l’ingresso in un altro mondo, è una tappa cruciale di
morte/rinascita della protagonista. La protagonista ha abbandonato il cerchio
sicuro ma angusto della casa per fare ora esperienza nel mondo.
“ Agitata da
violente vertigini sentiva venir meno i miei sensi,
e non discernea
che la confusione di un sogno [..];
un fremito mortale
mi scuote le fibre […].
M’avvio tacita e
furtiva per le scale, ma da lì odo calpestio… misera me!
Mi arresto inosservata
penso,,, havvi nella casa un’uscita segreta,
vi traggo per buio
ed angusto corridoio:
la porta è
attraversata da una spranga…Dio, soccorso !
Che fare ?....
coraggio !
Mi pruovo piano di
trarre quella spranga dai buchi,
le mani tremano,
essa stride, sono perduta !...
ritta mi sto lì,
trattenendo financo il respiro, ma era silenzio,
nessuno avea
avvertito quel rumore: tento di nuovo, ecco sbarrata la porta..
che oscurità
intensa !
Qual tempesta di
affetti in me !....
brancolando
discendo gli ineguali scalini, balzo di terrore ad ogni passo,
disserro a stenti
il portone, ed eccomi nella strada […].
Il vento
imperversa orribile, e l’aere suona pianto !
Le tenebre
s’addensano sul mio capo !”
“Da circa due ore
io camminava per quella strada, e grosse gocce d’acqua
sentia spesso sul
volto. Una stella cercavano invano gli
occhi miei;
un negro manto
vestia la volta dei cieli, e gravando sulla faccia della
terra mi copria di
suo orrore come la notte del sepolcro [..].
La via ch’io
percorrea non la vidi più dritta e piana ma scoscesa,
m’incespava nei
suoi sterpi, pure il breve ma oramai speso lume dei lampi
guidava i miei
passi per istretto e irregolare sentiero”.
La
stessa Maria sembra più vicina alla figura di Renzo perché inizia un viaggio
attraverso la campagna italiana incontrando la miseria e la violenza, dove l’illegalità è imperante, un mondo
abitato da mendicanti e briganti nella quale si vive in una condizione di
costante pericolo.
Roberto
Altieri ascoltando le vicende della fuga di Maria
“Oh, anche per
mal’intesa affezione si domanda la schiavitù dell’affetto !...
M’interessa
l’udirvi, o giovinetta;
Se per poco tutti
vi somigliassero!”.
Maria
alla fine giunge in un ambiente sereno e il rischio non proviene certo dai banditi
anch’essi rifiuti di una società che li ha costretti ai margini. Risuonano le
parole del saggio, l’esule Martelli che esprime i valori dominanti della
società:
“Sì, figlia mia,
l’infelice ama l’infelice:
quelli non
avrebbero disfogato in voi l’odio che li martira,
si lo stesso delitto
pur li raccapriccia…. Anche il malvagio sente in sé quel
germe di virtù che
coltivato farebbe l’uomo sublime,
ma che in alcuni
spiriti violenti, esasperati dal vedersi languire
in mezzo
all’abbondanza della terra, vien soffogato dall’altrui
arroganza, ed essi
amano il vizio per sola ostentazione”.
Traspare
nelle pagine del romanzo una società
caratterizzata da un aspetto politico feudale improduttivo e vessatorio. Quando
racconta la storia del matrimonio tra Roberto e la nobile persiana Adelia, il
padre della sposa descrive la situazione negativa del suo paese, la Persia:
“Oppressa dagli
orrori d’una barbara feudalità,
senza forza e
concentrazione di potere,
senza istruzione
né progresso,
ella è abbandonata
come schiava ai capricci degli uomini […].
Ma il mio peggiore
dolore è nel considerare questo popolo,
su cui passano i
secoli, e non un pensiero,, non un palpito ne contrassegna
il passaggio: vero
frammento della massa orientale, l’inerzia sembra essere
l’elemento e lo
scopo del suo vivere,
il riposo l’unica
sua felicità, fosse pur quello della morte ! […]
sepolta nelle
rovine di sua gloria, giace sulla terra, grave,
stazionaria, ed
immensa “.
L’autrice
utilizza l’immagine di un paese lontano, dalle grandi tradizioni storiche, per
criticare la sua terra… statica, arretrata, inerte..
Sembra
quasi di rivedere l’immagine di Don Fabrizio, principe di Salina nel Gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo sincero discorso con il ministro
piemontese Chevralet.
La
ribellione di Maria (la scrittrice)
La
fuga dall’ambiente domestico è il mezzo per vedere da vicino e leggere gli
aspetti drammatici della società dal punto di vista sociale e politico. La ragazza è figlia di un esule e da tempo
posta quindi ai margini della società.. osservare, “toccare” la realtà da
vicino percependone le sofferenze, gli aspetti drammatici di una forte e
continua violenza sui deboli e la sopraffazione dei potenti che sono senza
regole e legge.
Durante
la fuga Maria incontra una donna costretta a mendicare perché il marito contadino
era stato ucciso dall’eccessivo lavoro..
“ Ella piangeva
stringendosi al seno quel pargoletto;
la sua figura era
squallida e trista, le sue vesti censiose,
e quel bambino
parea succhiare invece del latte il dolore della madre sua !
Ella mi vide, e mi
si avvicinò mostrandomi il volto pallido e magro del figlio,
e stendendo la
scarna mano con tal atto da ferirne il cuore !....
Scoppiando in
pianto la tapina mi raccontò la cagione di sua miseria;
mi raccontò
com’era stata sposa ad un contadino, il quale col suo
stentato sudore
procacciava appena un nero pane onde disfamare la
meschina famiglia,
e come finalmente morto per esorbitanti travagli
il marito, ell’era
costretta ad accattare un pane elemosinando!!!”
Episodi,
incontri vissuti durante la sua fuga che permettono a Maria di sviluppare una
vera coscienza sociale. Vive i personaggi, li sente suoi, c’è un grande legame
tra la sofferenza che sente in sé e nel reale e l’ideologia democratica e
risorgimentale. Prova dolore per chi è escluso dalla società per le sue idee
libertarie e chi è oppresso dalle prepotenze dei signori a qualunque classe
appartengano.
Le
due linee ideologiche del romanzo, la condizione di esule e la marginalità
della figura femminile, risaltano di continuo nel romanzo. Sole le idee che
permettono alla scrittrice di viaggiare nella realtà come a formarsi , a
prendere coscienza dei gravi problemi esistenti e di valutarne gli aspetti
nella loro problematicità sociale.
In
questo contesto s’inseriscono i personaggi appartenenti alla nobiltà ed al
clero, esponenti della classe dominante. Personaggi ambigui, corrotti, in
possesso di maschere intrise di un falsa ideologia di bene, e che utilizzano la
loro posizione solo per i loro tornaconti personali…… personaggi alleati tra di
loro sotto la maschera delle diversa ideologia…...(come sono vicini ai nostri
tempi…).
Il
tiranno e magistrato Summacola mostra in pubblico un atteggiamento saggio e
dignitoso….
“ l’alta sua fronte
splende di nobili pensieri,
e le sue labbra
sono atteggiate ad un benevolo sorriso”
ma
in privato ecco…. la completa trasformazione..
“allora getta
lungi da sé quel velo che ipocritamente l’avviluppava,
prorompe in
bestemmie, i suoi occhi lanciano velenosi sguardi
come ambissero la
potenza di inabissare l’umanità,
la sua fronte
dapprima serena ecco adesso corrugarsi,
e ripullulare in
essa avide le idee del delitto, del tradimento,
ed il sorriso
cambiarsi in un sogghigno colmo di fiele e di livore mortifero”.
Personaggi
con alte cariche politiche alleati tra loro
come il barone Summacola, il Cardinale Ministro di Polizia, lo stesso
Pontefice… tutti personaggi avvolti dal lusso ma nello stesso tempo da una
fitta penombra in scenari cupi. Tutti aspetti evidenti della loro personalità
impura.
“ Il pallido
chiarore della lampada si rifletteva incerta sugli apparti violacei
della stanza, ove
assiso sur una poltrona stava il Cardinale Ministro di Polizia
vestito della
porpora”…
“Coverto
dell’ermellino stava il Ponrefice assiso sur una specie di trono,
coi piedi poggiati
sopra un cuscino di velluto cremisino…”
Nel
racconto il pontefice, di fronte alle donne imploranti non trova di meglio che
rispedirle al Ministro di Polizia, e rivolgendosi ad uno dei suoi dipendenti
per liberarsi delle scomode questuanti….
“Accudite voi
sulla causa di queste infelici presso il ministro.
Così il Pontefice
con melliflue parole versò nei cuori delle donne quel
rivolo di speranza
che si intromette a prolungare il dolore”.
La
scrittrice era una cattolica e consapevolmente mette in scena un papa complice
di funzionari corrotti ed evidenza la precisa volontà di esporre una denuncia
sociale sulla corruzione del papato.
Un
racconto con una divisione tra buoni e cattivi, un ricco intreccio di
vicende e con un accorta trama ricca di
sospensioni per tenere desta l’attenzione del lettore, un linguaggio semplice.
Un
racconto che non è facile classificare anche se potrebbe rientrare tra i
romanzi popolari.
Non
propone soluzioni ai mali del mondo, come la presenza di un eroe capace di
cancellare dalla scena i malvagi per il
ritorno della legalità ma solo una figura femminile che, lontana dai canoni
romantici, porta avanti la sua battaglia personale con i suoi occhi e le sue
parole espressioni di un attenta analisi della società del tempo.
Dietro
il personaggio di Maria, coraggioso ed in grado di sfidare le convenzioni, è
agevole rintracciare la fisonomia dell’autrice, che condivide con la sua
protagonista la dolorosa esperienza dell’esilio, ed una conoscenza più profonda
delle cose umane. Tale cognizione del dolore e dell’emarginazione si converte
nel romanzo in capacità di agire nel reale e di vederlo senza illusioni.
Una
produzione letteraria inusuale e potremo definire innovativa. Un romanzo
popolare dove avventura e realtà si coniugano in maniera perfetta offrendo uno
spaccato di vita meridionale alle soglie dell’Unita d’Italia che non cambierà
nulla.
Una
figura di eroina inedita, la percezione di un disagio sociale sofferto in
maniere autentica e non con distacco per cui anche il bandito, come l’esule e
le donne, vivono una stessa esperienza di emarginazione e di esclusione sociale ed entrambi ambiscono
ad una forte volontà di riscatto.
Ad
aumentare l’importanza dello scritto è la stessa figura di donna, emarginata
perché tra l’altro non sposata, che ambiva ad essere scrittrice e che coltivava
la sua passione nei momenti residuali della propria attività di sorella, amica,
confidente, ai margini del quotidiano.
Nel 1865 fu l’unica poetessa messinese chiamata a
commemorare il centenario di Dante: in questo evento, la città di Messina riunì
i migliori intelletti della città fra letterati e docenti universitari. Per
l’occasione, Letteria scrisse un componimento intitolato Pel centenario di Dante Alighieri, sostenendo la
tradizionale immagine risorgimentale del Dante prefiguratore dell’Unità
d’Italia. Morì nel 1893.
“Il pensiero dell’anima”(1885), una delle poesie più famose e apprezzate della Montoro, costituisce
sicuramente la cifra più rappresentativa di questo suo “leopardismo minore”.
Eccone uno stralcio :
O peregrina
idea
Ove ti
aggiri e celi
Lungi
dal guardo mio! Qual erma sede
Solo
per te creata,
O quale
avventurata
Dell’immenso
universo ascosa parte
Di tua
presenza bei?
Dimmi
se vera è tua sostanza in questo
Moto
eterno dell’essere infinito,
O
vagheggiata invano dal pensiero
Ognor
tu fosti e sei. Qual nell’umana
O
celeste famiglia,
Qual
beltade alla tua si rassomiglia?
Diverse
fonti ne lodarono la bellezza, l’intelligenza e il suo impegno politico,
liberale ricco di combattività, spesso ribelle e che mal si accordavano al
contesto sociale, fortemente maschilista, del tempo.
L’epigrafe
che il triste destino ha cancellato facendo perdere anche le sue spoglie
recitava:
Qui per
volere del Comune/
l’ala
dell’oblio non graverà sulle ceneri/
di
LETTERIA MONTORO/
che
l’anima forte ed eletta/
trasfuse
in versi soavii ed in prose eleganti/
donna
di spiriti liberali/
confortò i fratelli che combattevano/
per la
redenzione d’Italia/
li
seguì nell’esilio/ e ad essi tornati in patria/
sacrificò
cristianamente la vita/ mirabile esempio di fraterno affetto!/
19
aprile 1825 – 1 agosto 1893
Messina – Il
Torrente Boccetta disegnato da J.L. Houel
Una
scrittrice dimenticata…
-----------------------------------------
5. Concettina Ramondetta Fileti
A Palermo, in via
Giuseppe Patania al numero civico 56 – 58, una lapide la ricorda con poche
parole..”murata una lapide che ricorda la casa ove ella nacque, fiorì e si
spense”.
Era nata l’uno gennaio
1829 a Palermo e morì l’uno gennaio 1900.
Esponente della nobile
famiglia dei duchi di Ramondetta di San Martino, figlia del Duca Francesco San
Martino Ramondetta e di Anna Felice Tarallo della Ferla.
Passò tutta la sua
vita nel palazzo che era stato anche dimora del pittore Giuseppe Patania.
Nello stesso palazzo
ricevette le lezioni del letterato e patriota Gaetano Daita suo maestro. Scoprì
subito in sé una vena poetica e ricevette gli incoraggiamenti di Tommaso Grossi, un famoso romanziere ed
amico di Alessandro Manzoni.
Anche lei, come le
altre poetesse del tempo, partecipò attivamente alle fasi risorgimentali che
videro la Sicilia e Palermo in
coraggiosi movimenti antiborbonici. Un gran numero di donne scesero in strada
ed anche la Ramondetta partecipò attivamente ai moti.
Nel marzo del 1849
fuggì di casa per aiutare i rivoluzionari nello scavo dei fossati di Sant’Erasmo
che dovevano ostacolare il ritorno delle truppe borboniche.
Quel momento della sua
vita fu riportato in versi descrivendo quella sua patriottica fuga:
«Lasciami in tutta
l' estasi di questo giorno di Paradiso: esso è il più memorabile della mia
vita, anzi solo oggi posso contare d' esser vissuta»
«Esitai al
pensiero di mia madre, ma mi feci coraggio all' idea che la patria vuol questo
servizio da me; e la patria è pur madre: voliamo!»
Nella
fuga da casa fu riconosciuta da una vicina di casa che la chiamò per nome.. ma
la Ramondetta rispose:
«Io non son io».
«Mentre andavo al
campo, pensavo tra me stessa: ora non dico soltanto parole, ora anch' io servo
la patria: finalmente l' affetto inesprimibile che ho per essa non starà più
nascosto nel mio cuore come l' amore della donzella di Shakespeare~ Il più
difficile ostacolo, che era quello di fuggire di casa, l' ho già superato, e se
tratto la zappa, servendomene per la patria mia, essa mi sembra più onorevole
della penna con cui Dante scrisse il divino poema»
«Un mio amico mi
presentò al quinto battaglione della guardia nazionale, a cui recitai un brano
del mio inno. Mi credetti veramente Giovanna D' Arco. Ma non ero armata? e un
cuore che palpita per la patria e per la libertà non vale assai più d' un
cannone?»
Non
è retorica perché i giovani di quel tempo erano capaci di manifestare
sentimenti molti alti e forti legati alla propria terra… La Sicilia.
Il
famoso letterato Luigi Natoli riportò quei giorni di drammatica resistenza
antiborbonica:
«Donne per natali
e per dovizie illustri, gentili giovanette educate fra gli agi e gli studi,
scesero nelle campagne con le donne del popolo; gli uomini, di qualunque
condizione, scavavano fossi ed elevavano trincee; le donne trasportavano la
terra; le loro mani si graffiavano, si laceravano, nereggiando di fango; le
loro membra gemevano sotto il peso inusitato; che importa? Il sole risplendeva
intorno, e gli inni di guerra risonavano sulla moltitudine operosa. Così le
donne si offersero alla patria fino agli ultimi giorni della rivoluzione;
quando ogni resistenza fu vana, e l' odiata bandiera sventolò nuovamente sui
bastioni; esse si ritrassero nelle case e attesero ed educarono i figli alle
future battaglie».
Luigi Natoli
(Palermo, 14
aprile 1857; Palermo, 25 marzo 1941)
Scrittore e
storiografo, autori di romanzi con lo pseudonimo di William Galt.
Figlio di Giuseppe
e Maria Lamantea, all’età di tre anni,
all’entrata di Garibaldi in
Sicilia, la madre
vestì tutti i figli di rosso e per questo motivo vennero confiscati i
beni alla famiglia
e mandati in prigione.
Il destino di
Luigi sarà sempre quello della libertà di pensiero e di non
Possedere mai
alcun bene. La povertà della famiglia gl’impedì di frequentare le scuole ma
studiò da autodidatta, frequentando biblioteche e dedicandosi alla continua
lettura di testi.
La
giovane Ramondetta partecipò attivamente
alla ribellione facendo circolare clandestinamente delle poesie
coraggiose ed ardite. Qualcuna era all’indirizzo di Ferdinando II:
«Ma trema! indarno
folle gioia ostenti: / gioir non può, fra un popolo che langue, / Re che spreme
dal cor d' oppresse genti / lacrime e sangue».
Malgrado
la sua azione eversiva non cadde nelle rappresaglie di Salvatore Maniscalco cioè
del capo siciliano della “polizia borbonica” che s’adoperava in una sfrenata
ricerca dei clandestini per poi punirli con feroci punizioni.
Nel
1850 sposò il cavaliere Domenico Fileti, ad opera del quale per otto volte
“Amore le sorrise,
e le cuna le infiorò”.
Malgrado
la famiglia, con l’arrivo dei primi figlie/e, la Ramondetta continuò nella sua
politica antiborbonica..
“non è ancora il
tempo di ritirarsi in casa e attendere all’educazione dei figli”.
Nel
1861 scrisse un inno a Garibaldi che fu musicato dal maestro Pietro Platania..
«Ha bionda la
chioma, purpurea la vesta, / brandisce la spada, l' Italia si desta».
La
composizione presenta altri spunti di natura politica:
«Di Roma e
Venezia, fratelli gementi, / Ei giura salvarvi, cessate i lamenti», e così il
braccio dell' invitto Nizzardo sostare «potrà quando Italia fia libera ed una».
Lo
stesso pensiero venne espresso in un inno dedicato a Vittorio Emanuele quando
il re giunse a Palermo l’uno dicembre 1860:
«Dal Campidoglio e
da Venezia bella / Italia griderem libera e forte».
Questi
inni non furono graditi dallo storico e sacerdote Isidoro Carini che pregò la
poetessa di sopprimerli perché suonavano
«condanna immeritata
al santo vecchio che regge da tanti anni la Chiesa”.
La
poetessa non accettò l’invito dello storico e questo malgrado la presenza nella donna di un forte
sentimento religioso che figurò nella canzone “A Maria Vergine” e che fu
musicata dal maestro Bernardo Geraci. Una canzone che veniva cantata negli anni
passati ogni 8 dicembre nella Chiesa dell’Olivella.
Dopo
il 1861, compiuta l’unità d’Italia, la
Ramondetta-Fileti esaurì la sua carica rivoluzionaria e si dedicò alla famiglia
ed ai valori sociali e letterali. Nelle sue poesie i sentimenti patriottici,
molto forti, vennero sostituiti da teneri e profondi sentimenti domestici.
Sono
questi componenti quelli maggiormente apprezzati dalla critica letteraria del
suo tempo.
Il
poeta Vincenzo Navarro le dedicò dei versi: Quest' angelo di amore e di
beltade / non canta di ruscelli, / di violette e ninfe e praticelli».
Il
letterato Ugo Antonio Amico nel 1906 scrisse: «Poche volte mi è avvenuto
legger versi così belli, casti, soavemente malinconici».
Nel
1877 morì la maggiore delle sue figlie, Annetta a soli 24 anni. Una perdita, un
lutto che annientò la sua vena poetica…
un dolore tanto forte da renderla incapace di esprimere i suoi sentimenti in
versi, in musica…
Un’altra
figlia della poetessa, Bianca, sposò Ferdinando Oddo che all’età di 14 anni si
era arruolato fra le truppe garibaldine. Il giovane nell’agosto del 1860 fu mandato
a combattere contro le navi borboniche nel porto di Palermo e “per coraggio
e fermezza militare” fu promosso sul
campo caporale.
Una via porta il nome della scrittrice ma
quanti leggendo il suo nome la collegheranno alla poetessa rivoluzionaria ?
Molte delle sue poesie patriottiche erano
antiborboniche dove traspare la visione di un governo che non risolve ma che
esaspera; di una Sicilia con gravi problemi economici; il parassitismo di una
corte indifferente alle sorti del popolo; l’immoralità e l’inettitudine di un
sovrano che ha ingannato i suoi sudditi e a sua volta si fa dominare da
collaboratori disonesti.
“La
Festa in Costume” componimento scritto
sotto lo svolgersi dei fatti dell’inverno 1855, quando il carovita determinò un
drammatico impoverimento della popolazione siciliana, raffigura una situazione
sociale molto caotica, che il re Ferdinando non riesce a controllare se non aggravando ulteriormente
il carico fiscale e chiudendosi nei suoi privilegi:
Chi ne‟ tripudi,
chi stolido esulta/E fa del riso omaggio a un vil tiranno? / Chi con gioia
sacrilega c‟insulta/ Fra tanto affanno? / Ferve la danza, brillano le faci;
/Della festa tu se‟ vanto e decoro, Fernando! Ah, ne‟ piaceri folli e mendaci/
Profondi l‟oro. / E chi con la pietà del volto scarno/Un pan ti chiede, un pan
che lo disfami,/ E chi prega, riprega, e sempre indarno,/ Ribelle chiami […]
Mira: nel giorno e nella notte oscura/ stuol di mendici innonda la cittade/
Nell‟ozio l‟artigian, della sciagura/ vittima cade. […] le mura sin, le messi,
/ l‟aria che Dio ci dà tu vendi a noi/ per impinguar Verri novelli, anch‟essi /
nemici tuoi (Ramondetta Fileti 1862, 83-84).
Eppure
questa rivoluzionaria Ramondetta riuscì a creare una serie importante di relazioni
con scrittori importanti del tempo come Tommaso Grossi e Niccolò Tommaseo. In
particolare con il secondo scrittore la poetessa instaurò una stretta
relazione a tal punto che la stessa
inviò al famoso scrittore una Canzone che il Tommaseo pubblicò nel suo volume
“La Donna”, accompagnando il componimento con lusinghieri commenti. Nel 1863 lo
stesso scrittore invitò la poetessa a partecipare alle feste indette per il
centenario del Savonarola.
I
figli della scrittrice raccolsero le lettere che gli inviarono personaggi
illustri del tempo: una lettera di Grossi, due di Tommaseo, undici di Giacomo
Zanella, ed altre di Atto Vannucci, Andrea Maffei, Giulio Carcano.
La
scrittrice non si allontanò mai da Palermo e questo aspetto dovrebbe fare
capire come la sua grande forza comunicativa delle sue idee e dei suoi scritti
abbia valicato lo stretto di Messina per raggiungere i grandi letterati del tempo e i relativi
circoli culturali.
La
Ramondetta partecipò fra l’altro alla “Strenna Femminile” forse per intercessione
della sua amica Rosina Muzio Salvo che conosceva la duchessa Felicita
Bevilacqua, promotrice del volume.
Una
“Grande poetessa in camicia rossa”.
-----------------------------
6.
Lauretta Li Greci
Era
nata a Palermo il 15 novembre 1833 e della sua famiglia non si sa nulla. Nel
Nobiliario Siciliano la famiglia viene citata come “nobile famiglia di
Siracusa, della quale, tra gli altri, notiamo un Francesco senatore patrizio di
detta città nel 1755 – 89 e senatore nobile nel 1808-09 ed un salvatore che
tenne quest’ultima carica in detta città nel 1811 – 12”.
Era
una bambina quando cominciò a scrivere in versi. Quest’aspetto, una grande
finezza stilistica e la dolcezza malinconica delle sue profonde riflessioni, le
diedero subito una grande notorietà.
Lauretta,
malgrado la sua giovane età, scriveva sempre pensando alla morte. La
consapevolezza di essere gravemente ammalata, colpita da un male come la tisi
da cui era difficile sopravvivere e quindi della sua imminente fine, guidava la
sua scrittura.
Una morte
quindi sempre presente nei suoi versi che cercò di nascondere con una tenerezza
sofferta, struggente. La povera Lauretta morì il 3 luglio 1839, aveva sedici
anni.
Malgrado la
sua breve esistenza riuscì a trasmettere nei suoi versi una sensibilità non
comune e una cultura notevole per una giovane del tempo tanto da lasciare un
impronta profonda nella letteratura dei
decenni successivi.
La sua morte
fu pianta da tanti intellettuali del tempo e da poeti non solo siciliani.
Un grande
tributo le fu dedicato dalla poetessa Rosina Muzio Salvo che le dedicò un
celebre carme:
“In Morte di
Lauretta Li Greci”
Il poeta Ettore Arculeo scrisse di lei:
“La sua vita fu
quanto il crepuscolo di un giorno e il suo passaggio su questa terra fu
come il trasvolare di un angelo fra gli uomini; ella non lambì il lezzo
della terra e, fortunata, non arrivò a comprenderne l’impurità e la sozzura“.
Fu
sepolta nella chiesa di San Domenico a Palermo,
nel Pantheon degli uomini illustri, dove un monumento, opera di Rosario
Anastasi, ne custodisce le spoglie.
Un
monumento che si trova difronte a quello dell’altra poetessa del tempo,
Giuseppina Turrisi Colonna, che la povera Lauretta aveva pianto, un anno prima,
con dolcissimi versi la sua immatura perdita.
Anche lei dimenticata e con una produzione poetica
molto difficile da reperire.
I versi che seguono sono contenuti in una silloge
poetica dell’amico Girolamo Ardizzone, che così la ricorda:
Conobbe il greco, il latino, il francese, lasciò molte
poesie inedite, fra le quali parecchi frammenti di una novella in versi
sciolti, Giovanna Greij, e alcune traduzioni di Saffo e di Simonide che
furono da me pubblicate nella Rivista Scientifica Letteraria ed Artistica per
la Sicilia, anno 1833.
Probabilmente, la storia di Lauretta Li Greci commosse i
palermitani al pari della sua poesia, tutta piena di sofferenza e presentimento
della sua fine prematura e ciò contribuì a tenere vivo il suo ricordo.
L’autrice viene ricordata nel Dizionario dei siciliani illustri,
cit., p. 293. Una sua lirica, Presentimento della morte, venne riportata da
Ettore Janni all’interno della sua antologia dei Poeti minori dell’Ottocento,
Rizzoli, Milano 1955.
Bellissima la sua poesia "Alla Luna" scritta pochi momenti prima della sua morte che non posso riportare perchè coperta da copyright.... (che strano modo di fare cultura...)
Bellissima la sua poesia "Alla Luna" scritta pochi momenti prima della sua morte che non posso riportare perchè coperta da copyright.... (che strano modo di fare cultura...)
---------------------------
7. Mariannina Coffa
nacque
a Noto il 30 settembre 1841, figlia dell’avvocato Salvatore Coffa, un
liberale nelle vicende politiche del
Regno di Napoli, e di Celestina Caruso.
Fu battezzata nella Cattedrale di Noto il 3 ottobre.
Noto (Siracusa) –
La casa natale di Mariannina Coffa
I
primi studi furono a Noto per poi passare, all’età di dieci anni, nel collegio
“Peratoner” di Siracusa, sotto la guida di Francesco Serra Caracciolo, dove incominciò a mostrare la sua vena poetica
scrivendo alcune poesie o “improvvisate”.
Nel
1854 – 55, all’epoca quattordicenne,
visse il dramma sociale del colera. Con la sua famiglia si trasferì nel
podere della Falconara dove Mariannina visse un periodo particolarmente
difficile non solo per la paura dell’epidemia ma anche per gli impegni politici
del padre che era legato ai liberali antiborbonici.
In
questo clima di turbamento Mariannina si rivolge spesso al Santo Patrono di
Noto, l’eremita San Corrado Confalonieri, perché interceda presso Dio per la
cessazione dell’epidemia:
Corrado,
oh no, la grazia / Non ci saprà negar. // Ei che nostra patria / Ricopre col
suo manto, / Ei che rimira il popolo / Fra tante angosce e in pianto, / Ei ci
vorrà protendere / La salvatrice man. // Salve, o celeste Spirito, / O nostro
Protettore / Fuga l’orrenda e squallida / Paura d’ogni core / E le dolenti
lacrime / Sian di contento alfin…
Per
favorire lo sviluppo della sua vena poetica fu affidata ad un canonico, Corrado
Sbano (1827 – 1905), famoso nel campo delle lettere verseggiatore. Il suo compito era quello di
fornirle le letture adatte, suggerire i temi delle sue composizioni e nel
correggere la tecnica di versificazione.
Don
Sbano, da canonico, la indirizzò nelle letture cattoliche e “sorvegliava” i suoi scritti poetici che
dovevano essere lontani dagli autori considerati “esagerati ed intemperanti”,
«Per letture e per
discorsi instillavo al suo cuore grande affetto alla religione, alla famiglia,
alla patria, alla virtù in genere; soprattutto l'amore ai miseri, degli
sventurati sopra la terra»
Don
Sbano venne accusato di aver soffocato, con le sue scelte, le naturali tendenze
poetiche della ragazza che avevano nell’effusione sentimentale di matrice
tardo-romantica le sua originaria espressione. Il canonico indirizzò la ragazza
nella lettura di autori classici che erano lontani dai suoi sentimenti e dal
suo spirito poetico. Il canonico sarà
comunque sempre un leale amico e confidente di Mariannina.
Da
giovanissima diede subito delle prove delle sue abilità di verseggiatrice e le
sue “Improvvisate” d’occasione deliziavano i salotti nobiliari della città nel corso di congressi politico – mondani.
Congressi
che nella città neatina costituivano momenti socializzanti, fiera della vanità,
occasioni di aggregazioni culturale.
I
successi poetici furono subito
apprezzati nella arcadica “Accademia dei
Trasformati” di Noto, di cui fece parte dal 1857, (Mariannina aveva
trent’anni), con il falso nome di “Ispirata”.
Fece
anche parte, dal 1958, dell’”Accademia Dafnica” e di quella degli “Zelanti”.
Nel
1859 la sua famiglia decise di impararle il pianoforte e per questo motivo
venne chiamato il giovane Ascenzo Mauceri (1830 – 1893). Il giovane Mauceri
fini con l’innamorarsi della ragazza fino a progettare il matrimonio.
Noto - Palazzo Mauceri
I
due s’erano incontrati in una delle serate di conversazione nei salotti
nobiliari di Noto nel 1852 e per Mariannina
fu l’incontro fatale dei suoi sogni. Venticinquenne
maestro di piano, patriota, compositore,
discreto musicista alla ricerca del successo e del benessere economico. Il
giovane si spostava spesso lontano dalla città per andare nel “continente” a
Napoli e a Firenze.
La
ragazza alimenta così nella malinconia della solitudine, nella svagata dolcezza
della fantasticheria adolescenziale, l’immagine del giovane che l’ha colpita. N
questo modo Mariannina è pronta ad innamorarsene quanto il Mauceri, tornato da
un lungo viaggio in Italia, le dà lezioni di pianoforte nel 1859. L’anno in cui, ancora diciottenne pubblica a
Noto i “Nuovi Canti” che seguono la pubblicazione delle “Poesie in differenti
metri” del 1855.
(“Nuovi
canti” che nel 1863 apparvero in un edizione a Torino presso la Stamperia
dell’Unione Tipografica Editrice).
A
quanto sembra la storia d’amore fra
Mariannina ed Ascenzio fu contraddistinta da esigui incontri, il
musicista viaggiava spesso ed era assente per lunghi periodi, e da una certa
incomunicabilità. Pressante lui e flebilmente esitante, paura di un possibile
divieto famigliare ed impotente nell’affermazione di sé, lei.
La
famiglia Coffa acconsentì fidanzamento per poi cambiare improvvisamente idea.
Il
rapporto fu quindi ostacolato dalla famiglia Coffa. La ragazza è bombardata da
lusinghe, rifiuti, menzogne che ne risvegliano la gelosia nei confronti di
presunte rivali; è minacciata di segregazione.
Ascenzio
le propone la “fuitina” ma per Mariannina questo significa disobbedienza ai
genitori, cioè la trasgressione di una legge morale e sociale estremamente
rigida, che le impone di non seguire l’amato in una fuga disonorante per il suo
nome, un azione che alienerebbe l’amore del padre e della madre.
Non
si conoscono i motivi del rifiuto della famiglia Coffa al fidanzamento tra
Ascenzio e Mariannina che decide di rinunciare per sempre al grande amore della
sua vita.
La
giovane percorre i sentieri della rinuncia e dell’acquiescenza rompendo il
fidanzamento con Ascenzio per sposare l’8 aprile 1860 il ricco proprietario
terriero ragusano Giorgio Morana.
Una
lettera di Mariannina, datata Siracusa 5 settembre 1859, alcuni mesi prima del
matrimonio con Morana, descrive l’amore che la poetessa nutriva per Ascenzio..
Ascenzio mio
Stanca del lungo e
penoso viaggio, e travagliata da mille indicibili dolori, non ho altro conforto
che ricordare gli ultimi istanti del nostro addio-istanti fatali la cui
dolcezza fu sogno, e la memoria tormento.Io scrivo e piango…ora che niuno mi
ascolta, ora che son libera di vagheggiarti nel silenzio della notte!…Ho tanto
bisogno di piangere, e di aprirti il mio povero cuore.Oh! potessero almeno le
lagrime rivelarti il secreto martirio dell’anima mia. Ascenzio! Comprendi tu la
potenza di questo dolore che m’agita, che in pochi giorni ha consunto le mie
vene, che mi ha tolto gran parte della vita?…Oh se al par di me senti questo
bisogno di piangere e di amare…oh Ascenzio, non obliarmi, non tradire le mie
speranze, il solo bene che mi lega all’avvenire. Noi saremo compagni nel
dolore, comprenderemo appieno i misteri delle anime nostre, e i voti, i sogni,
le rimembranze, saranno un’indistinta armonia che i nostri cuori ripeteranno
tra loro. Oltre il tuo amore che chiedere alla terra se non credo ai suoi beni?…un
deserto mi offrirebbe pur sempre l’immagine della patria mia, perché l’universo
è tutto racchiuso nel tuo sguardo-che vale ogni altro contento?…io sentirò i
tuoi dolori, sarò lieta del tuo sorriso; e quando un arcano desio ti sforzerà
al pianto, oh allora noi piangeremo insieme; e quelle lagrime non contaminate
dallo sguardo degli uomini, saranno una muta preghiera santificata dal silenzio
e dall’amore-così, paghi dell’oblio del mondo, vivremo nella solitudine dei
nostri affetti. ………Si è ormai compreso che la mia vita è potentemente legata a
questo terribile amore, che gli uomini non valgono ad estinguere-amore, non mai
diviso, che o non compresa, o compianta, trarrò meco alla tomba!...
Noto - Cattedrale
Il
matrimonio tra Mariannina Coffa e Giorgio Morana….
Sposai all’alba – la chiesa era deserta – camminavo come trasognata e mi pareva di non essere più sulla terra. Mio padre non mi accompagnò – non ebbi accanto un amico – da un lato avevo mia madre confusa e dolente anch’essa, dall’altro lato mio suocero, che col suo viso arcigno mi faceva spavento come l’angelo del male. Nicastro (don Sebastiano Nicastro) mi guardò commosso, e non ho obliato quello sguardo. Vi fu un istante in cui, senza parlarci, noi ci svelammo una lunga storia di dolori, di tradimenti, di miserie. Io ero impassibile –quando mi si pose in dito l’anello, Nicastro aveva gli occhi pieni di lagrime e non poteva leggere la lunga orazione latina di cui non compresi una parola. Terminata la cerimonia, ritornammo a casa; ma le strade erano ancora deserte perché di buon mattino. Presso la soglia della chiesa vi erano una povera e una fanciulla –forse avevano assistito alla cerimonia.
La vecchia ci si
accostò per chiedere l’elemosina e intanto diceva alla fanciulla:
“è una sposa, come
è bella, come è contenta”.
Povera donna! io non fui mai bella –
ma d’onde
argomentò la mia contentezza? –
ero vestita
modestamente e nulla in me addimostrava la sposa”.
Giorgio
Morana per fare tacere la vecchia donna implorante l’elemosina, le cacciò in
mano, con modi probabilmente buschi, una moneta. Mariannina alzò la testa
incontrando la sguardo della povera donna che smentì con gli occhi la bugia
detta per rimediare un’elemosina svogliata).
La
Scena del Pranzo
Giunte a casa trovai la sola famiglia Sierna, il Nicastro e il Notaro Luigi Perricone. Restammo tutti insieme pel pranzo. Mio Padre si sentiva poco bene, e pareva invecchiato di venti anni. Si pranzò; non vi era gioia, non accenti scherzevoli, eravamo come fantasmi – perchè l’amore non allegrava il convito. Ascenso, non oblierò mai le lagrime di mio fratello Peppino durante quell’eterno pranzo.
Era gioia – era
dolore?
La
Scena dell’Anello
Prima di partire Peppina (Siena) mi confessò tutto – essa era stata avvisata, sapeva pria di me l’intreccio del matrimonio, e aveva agito per la mia felicità. Mi donò un piccolo anello, che mi pose essa stessa al dito accanto a quello che mi si era dato in chiesa. “Così va bene, mi disse, accennando ai due anelli, l’amore e l’amicizia”. Ci guardammo, e forse si spaventò del mio sguardo, perché io mi tolsi dal dito l’anello di sponsalizio e lo conservai. “Pensi al passato? –mi disse sbigottita- alienati, hai fatto un sacrifizio, ed hai messo la pace nella tua famiglia”. Io non risposi, ma sin d’allora non portai più l’anello di gemme.
(Peppina Siena, l’amica fidata, con aria misteriosa e
insieme festante disse a Mariannina: “Bene, ora che è fatta, voglio proprio
dirti tutto: io sapevo dell’intreccio di questo matrimonio, quando tu non ne
sapevi niente…Se qualche volta ho esagerato nel riferirti qualche cosetta, devi
pur credere, io ho fatto per la tua felicità”.
Mariannina si passò le mani sull’abito da viaggio. “E’
tardi, devo andare”).
La Scena della treccia
Quando io guardo questi oggetti sì cari, dico talora a me stessa: conservò
Ascenso i miei capelli? O li distrusse inesorabile per distruggere con essi la
memoria di colei che lo aveva tradito?…Oh se sapeste: quando venni qui, quando
ero costretta a vestirmi con eleganza per ricevere le persone che mi
visitavano, io intrecciavo i miei capelli innanzi alla cognata che mi faceva
compagnia e mi amava come una sorella. Peccato!, mi disse un giorno, ti manca
quasi la metà di una treccia – e come è avvenuta questa disgrazia? – Disgrazia!
Aveva ragione. Balbettai alcune parole di scusa e mutai discorso.
(Ancora Ascenzio, la ciocca che gli aveva regalata. “Conservò egli i suoi capelli, o li distrusse inesorabile per distruggere con essi la memoria di colei che lo aveva tradito?”
(Ancora Ascenzio, la ciocca che gli aveva regalata. “Conservò egli i suoi capelli, o li distrusse inesorabile per distruggere con essi la memoria di colei che lo aveva tradito?”
Nei
primi giorni fu tutto un ricevimento di parenti ed amici, fra i quali venne
anche a renderle omaggio il Dott. Filippo Pennavaria, medico della famiglia.
Mariannina, sempre elegantemente vestita, veniva aiutata dalla cognata Lucia
Comitini (l’unica che le volesse un po' di bene). che, pettinandola, s’accorse
della ciocca di capelli mancante e, tutta stupita, le chiese: “Come ti è
capitata questa disgrazia?”
Ella trasalì,
inventò una scusa e, col cuore, ricordò quando s’era tagliata quella ciocca per
darla in pegno d’amore ad Ascenzio.
Mille idee e mille
pensieri invasero la sua mente
Con
il marito si trasferì nella casa del suocero a Ragusa.
Ragusa – La Cattedrale
di S.G. Battista
Sulla sinistra,
evidenziata in rosso, la casa in cui visse
Mariannina Coffa
da sposata.
Iniziò
per la ragazza un vita fatta di continue gravidanze annuali spesso difficili.
Due dei quattro figli morirono ancora in tenera età. A causa dell’ostilità pretestuosa dei parenti
ebbe delle difficoltà nello scrivere perché era una passione ritenuta riprovevole
e strumento di perdizione.
(In
realtà le ostilità nello scrivere erano legate al volere del marito e del
“terribile” suocero che “ritenevano
inopportuno per una donna la pratica delle lettere”. Alle sorelle del marito
era stato vietato categoricamente a leggere e a scrivere).
A
Ragusa in definitiva cominciò per
Mariannina un lungo calvario aggravato anche dal timore per la diffusione di
una nuova epidemia di colera conseguenza della precedente pandemia del
1854. Strappata dal suo ambiente
originario, incompresa da un marito che è indifferente, angariata da un suocero
avaro e gretto, un vero “demonio”, padre-padrone dispotico e violento, da parenti
invidiosi di una superiorità culturale
considerata indizio di immoralità, tra gente che “non parla la mia
lingua”, in un paese che è “per me una montagna di spine”, una “desolata landa
di ghiaccio”.
Naturalmente
in questo ambiente difficile, asfittico, Mariannina fa ricorso alle sue risorse
poetiche per non soccombere per avere degli stimoli di vita. Nelle ore
notturne, dopo le cure domestiche, seduta al suo scrittoio nel cerchio di luce
di una lampada ad olio, la donna crea
una stretta maglia epistolare nel
marzo1861 con vari scrittori: Giuseppe Aurelio Costanzo, con il spoeta siracusano Giuseppe Macherione, con il
catanese Mario Rapisardi e con il poeta e demologo di Acireale Lionardo Vigo
(anche lui come Mariannina membro dell’Accademia Dafnica e degli Zelanti) e con
altri letterati.
Grazie
alle ricerche dello studioso Stefano Vaccaro sono stati trovati dei documenti
che testimoniano un rapporto d’amicizia tra il barone Arezzo e la stessa
poetessa.
Mariannina
aveva una corrispondenza epistolare con un nobile ragusano, Giambattista Lupis,
al quale la poetessa chiese delle notizie in merito al “baronello”. Un termine
vezzeggiativo con il quale era solita identificare il senatore nelle sue
missive.
La
prima di queste lettere, scritta da Ragusa, riporta la data del 13 dicembre
1862 ed era indirizzata al Lupis al quale chiese se l’Arezzo in quel momento si
trovasse a Torino.
A
Mariannina non era sfuggita la notizia dell’elezione del barone Corrado Arezzo
del Spuches di Donnafugata a deputato del Regno, avvenuta il 7 aprile 1861.
La
prima sede della Camera del Regno era posta in Palazzo Carignano a Torino ed
era quindi comprensibile la domanda della poetessa rivolta a Lupis.
(Sia
Mariannina Coffa che il barone Corrado Arezzo furono legati da un’amicizia che
si sviluppò nell’ambiente filo-massonico di stampo spiritico-esoterico. Come vedremo la poetessa aveva delle forti
amicizie con i magnetisti Migneco e Bonfanti, medici che cureranno i suoi mali
fisici e psichici con tecniche quali il sonnambulismo, l’ipnotismo e il
mesmerismo. Mesmer sosteneva che il corretto funzionamento dell'organismo umano
è garantito dal flusso armonioso di un fluido fisico che lo
attraversa e che tale fluido si identificava con la forza
magnetica. Mariannina si credette per molto tempo perduta tra spiriti,
cabale e cose grottesche; allo stesso modo anche il barone Arezzo, massone, fu
affascinato dall’arcano mondo dell’occulto).
Un
documento, decisamente importante, confermerebbe l’esistenza dell’amicizia tra
la poetessa e il barone.
Si
tratta di una sottoscrizione risalente al 1892, di un atto finalizzato alla
realizzazione di un monumento funebre dedicato a Mariannina Coffa nella sua
città natale di Noto.
Il
barone fu tra i maggiori finanziatori del monumento avendo versato insieme a
Monsignor Vescovo e alla marchesa
Maurigi la cifra di 100 lire. la cifra più alta tra tutte le altre somme
versate. Tale esborso risulterebbe incomprensibile se le cause non fossero da
ricercare in un’amicizia, fino a pochi anni fa inedita, e maturata nel tempo e
in un contesto culturale comune ai due personaggi del tempo.
Tentò
di spezzare questo clima opprimente con un contatto chiarificatore con il suo
ex fidanzato Ascenzio durante una breve gita nel gennaio del 1863. Un contatto
che fu vano perché l’1 febbraio la poetessa tornò a Ragusa talmente desolata e
lacerata da, immotivati, sensi di colpa nei confronti dell’ex fidanzato da progettare il suicidio. Un idea insistente
che ritornò ciclicamente nelle sue pagine letterarie e nelle commoventi lettere
d’amore inviate sempre al suo ex fidanzato:
“Da un lato i
sogni della mia fanciullezza, l’amore, l’arte, l’avvenire
coi suoi profumi
di cherubino – d’altro lato l’amara realtà della
vita, la religione
della sventura, la fossa delle mie figliuole,
l’arpa senza
armonie, l’amore senza conforto [..].
Otto anni di
martirio, otto anni di guerra con vili armi, e
senza nobili avversari,
otto anni d’isolamento e di silenzio […].
Che fu la vita per
me ? quali gioie, quali compensi, quali soddisfazioni
mi ha dato ? […].
Talora il nostro
cuore rompe per poco la ferrea cappa che lo avvolge,
e tenta dare uno
sguardo alla vita vera […] e il quel
momento,
Ascenso, non
trovando che il nulla, non iscorgendo che
tenebre e
disinganni […] noi cerchiamo l’annientamento
di noi stessi, e
l’ultimo sonno ?
Una
depressione che troverà sfogo non solo nella preghiera di una morte invocata ma
anche in malesseri psicofisici che troveranno sfogo nell’isteria, nella serie
di disturbi nervosi e fisici che la colpiranno sin dal 1860.
Malesseri che si manifesteranno con
l’insonnia, continui vomiti biliari, anoressia e un “tetro malumore” in un “animo troppo per
sua sventura sensibile” e per la “malintesa e malaugurata virtù di soffocare
nel silenzio il continuo strazio che la struggeva”.
Tutti
questi aspetti non possono non minare la sua volontà di vivere e soprattutto di
scrivere in un animo così sensibile..
“ … e voi mi dite
di scrivere […]
E chi più di me ha
provato la poesia del cuore ?
Credete, anch’io
ho bisogno di scrivere, anch’io ho bisogno di versare
sulle carte questo
fuoco immortale che mi consuma lentamente le fibre;
e pure, non ne ho
la forza; l’anima mia è chiusa, i miei versi sono come
eco di vasta
solitudine che ripercote un lamento di persona moribonda”.
Una
realtà esterna che la condizionerà in maniera opprimente dove nessun psicologo
l’avrebbe potuta aiutare e che determinerà un aggravamento delle sue condizioni
fisiche.
Alla
fine dell’estate del 1864, in occasione della morte della sua terza figlioletta
di appena dieci mesi, mentre la stessa Mariannina era già nuovamente incinta in
attesa di un’altra bimba ( che purtroppo morirà anch’essa due anni dopo), si manifesteranno delle forti crisi
depressive che fanno temere la pazzia.
Il
medico ragusano Filippo Pennavaria descriverà le manifestazioni, i sintomi di
Mariannina in uno studio dedicato ai
fenomeni dell’isteria.
Il
Pennavaria imputava la malattia di Mariannina ad una forte fragilità emotiva di
una “sensitiva” autorizzando in questo modo la sua esclusione sociale della
donna che dovrebbe essere relegata nella ”zona franca della follia”.
La
donna deve quindi mascherarsi perché
“ Guai se altri mi
leggesse nel cuore !
Voi, Ascenso, voi
solo che foste l’amico dei primi anni,
conoscerete quale abisso
mi schiuda oltre la serenità del mio sorriso”.
Cominciò
ad avere una corrispondenza epistolare con l’ex-fidanzato ma con scarsi
risultati dal punto di vista sentimentale. Sperava nell’avere un conforto,
comprensione ma ricevette di continuo dei rimproveri per aver accettato il
matrimonio e quindi scarsa consolazione.
Eppure
le parole di Mariannina erano forti perché descriveva la miseria della sua
vita.. in una casa che era teatro di miserie umane con persone troppo legate ad
usi e consuetudini retrograde:
«Se sapeste quanto
soffro allorché mi è necessario prendere la penna! Gli occhi severi e maligni
di mio suocero mi seguono come per fulminarmi [...] Egli, il mio onorando
suocero, non fece apprendere alle sue figlie il leggere e lo scrivere, appunto
perché non fossero disoneste o cattive donne di casa».
Lettera del 17 gennaio 1870,
Sempre, negli ormai
ultimi anni a venire, conquistata dalla consapevolezza che non
“v’ha speranza terrena che valga a
sanare le piaghe dell’anima”,
confesserà all’amato
“la mia mente ha una confusione di
idee inesplicabile [..] né so
quando mi riavrò dalla tetra
oppressione che mi domina”.
La raccolta
di lettere che va dal 1869 al 1872 descrive anche l’ambiente ragusano dove
Mariannina è costretta a vivere. Narra
anche l’aspetto culturale ibleo che non risulta vivace e stimolante.
Ragusa è una città che a stento legge “L’eco dei Monti”, un periodico locale, e
“Effemeridi”, un altro giornale, per il quale un cugino di Mariannina cerca
affiliati a Ragusa. Un ambiente culturale che non è pronto a confrontarsi con
una donna intellettuale che verrà apostrofata sulla reale paternità di alcune
sue opere con pettegolezzi e maldicenze. Pettegolezzi che raggiungeranno il
culmine quando verranno pubblicate le “Ottave alla Vergine” nel 1869.
La corrispondenza
con gli amici di Noto, tra cui quella con la zia Vittoria, le “sorelle” cugine
Melodia e il cugino Peppino, mette in risalto le angherie di casa Morana che
avranno il punto culminante nella terribile demenza del suocero che chi
manifesterà con il rifiuto del cibo, negli insulti ad amici e parenti, nei
tagli ai viveri della famiglia e nel conservare o sperperare in luoghi ignoti
il denaro proveniente dalle forti vendite di frumento.
Mariannina è
in ogni caso una persona importante nella comunità ragusana e questo presuppone
la sua partecipazione alla vita pubblica che spesso cerca di elidere. Il
teatro, come le feste paesane, sono il luogo preferito di una falsa nobiltà
alto borghese che deve la sua ricchezza allo sfruttamento delle terre e nella quale
serpeggia una finta bonarietà e indulgenza dettata dalla più forte ipocrisia
che farà vittima anche la stessa poetessa.
Per uno strano gioco del destino Ascenzo Mauceri ricevette un
incarico ministeriale come ispettore scolastico proprio a Ragusa ma non si
faceva vedere da Mariannina che era molto addolorata per la perdita dei figli.
Per i fibromi all’utero,
di cui soffriva, conobbe il medico catanese Giuseppe Migneco, cultore del
magnetismo animale e massone come il suo allievo di Noto Lucio Bonfanti. Fu
proprio il Bonfanti che introdusse la Coffa nella “Loggia Elorina”. In questo
periodo della sua vita si notano dei precisi riferimenti alle sue esperienze e
credi misteriosofici (ai
misteri delle antiche religioni pagane).
Lasciò la casa del
marito per trasferirsi a Noto e seguire le cure del medico Bonfanti. Fu proprio
il medico ad ospitarla dato che i genitori di Mariannina si rifiutarono di
ospitarla. La cacciarono da casa scandalizzati dal suo comportamento.
L’amicizia con il dotto
e geniale medico Giuseppe Migneco, detto dai nemici “Cagliostro il piccolo”
originario di Augusta e poi residente a Catania, omeopata e magnetista, famoso
per le efficaci cure prestate in occasione delle epidemie di colera e più volte
esiliato per “l’esercizio di arte diabolica e di spiritismo”, la porterà nelle
terapie legate al sonnambulismo e del
magnetismo animale o messmerismo, anatemizzati dal Papa e
coltivati all’interno di associazioni massoniche democratiche.
Saranno questi i
sistemi, segni della successiva psicanalisi, ai quali la poetessa ricorrerà per
cercare disperatamente di curare le malattie ed i disagi del suo corpo e della
sua psiche. S’iscriverà a diverse Società occultistiche e teosofiche italiane e
straniere e, attraverso lo stesso Migneco e il suo discepolo netino, il dott.
Lucio Bonfanti, medico omeopata e democratico del 1860, sarà introdotta con
ruoli probabilmente di primo piano in logge massoniche
swedenborghiane, misticoteosofiche e magnetiste.
Ne
nascerà l’ultima straordinaria, purtroppo breve, stagione poetica, fitta di
riferimenti simbolici al “gran concetto” e improntata alla “protesta metafisica”,
dopo la prima giovanile
poesia
patriottica di maniera e l’intermedia fase intimista tardoromantica. Prostrata
dalle emorragie, probabile conseguenza di un cancro all’utero, abbandonerà la
casa ragusana del suocero rifugiandosi a Noto, nella casa dei genitori, che non
esiteranno a cacciarla via perché non ricada su di loro il disonore della
separazione dal marito e dai figli, e finirà i suoi giorni tra la fame e gli
stenti, assistita solo dall’anziano medico: nessun familiare vorrà pagare le
prestazioni di un chirurgo catanese il cui intervento avrebbe potuto
probabilmente salvarle la vita.
Pochi mesi prima di morire, quando la famiglia
ragusana le porta via il figlio che alleviava la sua solitudine e confortava i
suoi ultimi giorni di vita, grida in alcune lettere la sua ferma volontà di
divorziare, mentre quello del divorzio è un istituto ancora molto di là da
venire. La sua rassegnazione si trasforma in odio verso quei genitori i cui
voleri ha supinamente eseguito, la sua obbedienza filiale si tramuta in
desiderio di vendetta e giunge a invocare Dio perché le conceda ancora qualche
giorno di vita per rendere pubbliche le violenze, le manomissioni, le
subornazioni, le umiliazioni subite che la conducono alla morte.
Tra le sue ultime volontà, affidate al medico curante,
c’è che si ordinino le sue poesie secondo “L’immortal concetto”, tenuto avvolto
in una serie di allegorie e di simboli, non oscuri solo agli iniziati e
fraintesi da una critica per lo più locale, incapace di scorgere al di là della
facile chiave di lettura di stampo tardoromantico. Malgrado la fama di “pazza”,
spiritista e sonnambula diffusasi negli ultimi tempi della sua vita, la sua
città, memore di quanto da lei fatto quando fu tolto a Noto il capovallato in
favore di Siracusa, dichiarò il lutto cittadino e il Comune si assunse le spese
dei solenni funerali e le fece erigere la statua in marmo di Carrara sita
ancora ora in Piazzetta d’Ercole, mentre i “Fratelli” della Loggia Elorina, che
parteciparono al funerale della poetessa portando le insegne solenni, si
prendevano cura di farne imbalsamare il corpo. Nessuno della famiglia seguì il
feretro, ma una folla di autorità e gente comune accorsa a rendere l’estremo
commosso omaggio alla “Saffonetina”, che sfilava per l’ultima volta tra le
strade e i monumenti del “giardino di pietra”, la sua città barocca.
Nelle sue ultime lettere la Coffa espresse
tutta la sua violenta esasperazione nei confronti di quanti, genitori, marito e
parenti, imponendole la loro volontà e impedendole la libera manifestazione
della sua personalità, le avevano rovinato la vita.
Fu
additata a pazza e schermita non solo dai suoi famigliari ma anche dalla gente.
La povera Mariannina, un anno prima di morire, respingerà con fermezza queste
accuse con note di vibrante sdegno
“ Ma dunque non
volete affatto tacere. Gentaccia da trivio
e senza decoro,
fanciulli senza discernimento e
buon senso […].
Vili, svergognati,
gente senza onore e dignità!”
Mariannina
non era pazza, perché la follia è un esperienza di spersonalizzazione e per la
poetessa è invece il contrario per diversi motivi.
La
donna è un soggetto amoroso e l’isteria nelle sue manifestazioni assume un
linguaggio mediante il quale l’io soffocato si manifesta in una sfida mortale.
L’epos
esistenziale della scrittrice ricco di un grande sentimentalismo che la
contrappone ad una fredda realtà storico-sociale, si manifesta attraverso la
parola scritta. Una manifestazione analoga si trova nella poetessa inglese
Emily Dickinson (1830 – 1886) in cui il contrasto romantico artista- società
evidenzia il disagio d’una condizione femminile alienante estranea al mondo
interiore della donna che è considerata
inferiore e priva di diritti.
Le
estreme condizioni nelle quali versava la poetessa prima della morte,
abbandonata da tutti e poverissima, la spingono addirittura a pensare di
volersi separare definitivamente dal marito cosa inaudita e impensabile per la
Sicilia di fine Ottocento:
“(…) Io voglio
libertà, divisione assoluta, voglio svincolarmi assolutamente dalla famiglia
Morana, perché i nodi che non sono benedetti da Dio e dall’amore non possono
durare”.
Una
delle ultime missive riporta la data “13 Novembre 1877” ed è indirizzata a
Giovanni Di Pasquale, dove la poetessa si scaglia ancora una volta contro chi
le consiglia di ritornare a Ragusa dal marito, nonostante la salute malferma,
pur di non dare adito ad altri pettegolezzi infamanti. Con una irremovibilità
assoluta, dettata da un distacco mentale che ora si fa anche fisico, la scrittrice
ribadisce l’affezione a quella libertà d’azione da sempre agognata e finalmente
conquistata seppur ad un elevatissimo prezzo, alla quale non vuole rinunciare:
“Dalla vostra
lettera vedo che non discorrete affatto e non avete né logica, né buon senso (…).
Vi dico e vi ripeto per l’ultima volta che io non verrò mai più a Ragusa; né
c’è un marito, né cento mariti, né un milione di mariti che possano obbligarmi
a perdere la vita. (…) dopo questa malattia, io sento che esco dalla fossa –
era già morta per tutti ed ora voglio vivere a modo mio. (…) Penso ai miei
figli soltanto – e l’essere stata priva dei miei figli, appunto perché si
trovano in Ragusa, ha accresciuto in me l’antipatia, l’urto, il dispetto, il
disgusto – (…)”.
A
chiudere quest’ultima conclusiva sessione del carteggio vi è una lettera senza
data né firma destinata all’amata zia Vittoria alla quale Mariannina non
risparmia di descrivere le bassezze morali dei genitori che pensano alla figlia
soltanto come un peso economico, noncuranti della sua mortale malattia:
“In che fanno
consistere questo onore? Doveva servire solo ad assassinare, secondo il loro
capriccio, una figlia moribonda?… Ma a me poco importa perché sono cancellati
tutti dalla mia parentela, e le loro corna non mi pungono affatto. A tempo e
luogo daremo la risposta.”
Morirà
in completa povertà a Noto il 6 gennaio 1878, a soli 37 anni dei quali solo i
primi 15 vissuti serenamente.
La
donna che pensa, che vuole esprimere i suoi sentimenti era qualcosa d’inaccettabile
per la società del tempo. La gente l’additava come folle e alla fine abbandonò
il tetto coniugale e fu anche ripudiata dai suoi parenti più stretti.. una morte
in solitudine… abbandonata da tutti.. forse per questo passò nella storia come
la “poetessa maledetta”.
Alcune
città le hanno dedicato delle vie… una magra consolazione per una donna
distrutta dalla società del suo tempo.
La
scrittrice fu testimone oculare del suo tempo e dal suo palazzo di Ragusa seguì
gli eventi risorgimentali schierandosi contro la Roma papalina che ostacolava
l’unificazione. Descrive i momenti sociali vissuti non in maniera fredda, quasi
distaccata, ma li elabora e li rende
eterni con la sensibilità che solo una poetessa è in grado di possedere.
Mariannina
esprime anche il non peso sociale che le
donne avevano nel tempo .. nessun diritto di parola.
Una
parola soffocata da regole imposte prima dalla sua famiglia e successivamente
da quella del marito.
L’unico
mezzo per distrarsi da quella realtà ostica, difficile era la scrittura ma gli
è vietata perché il suo scrivere era considerato come un segno di rivolta
contro un sistema che ammutolisce tutti coloro che volevano esprimere in modo
libero il loro pensiero.
La
scrittrice si ribella malgrado il divieto imposto dalla famiglia del marito e
continua a fare poesia. La sua ostinazione la porteranno ad essere considerata
diversa dalle altre donne e vittima d’una società intollerante e repressa e per
questo condannata all’isolamento e al disprezzo totale.
Eppure
da giovane aveva accettato in silenzio la decisione della sua famiglia di
sposare un altro uomo pur di non andare contro il volere dei suoi genitori che
alla fine la isoleranno e la repudieranno.
Nonostante
tutte le avversità, Mariannina difficilmente desistette dal non perseguire la
sua indole di donna di cultura, affiancando alla produzione poetica numerose
altre attività, il che facevano di lei uno dei personaggi più culturalmente ferventi
di tutta Ragusa ma anche dell’intera Sicilia.
Ben
consapevole delle sue capacità, pur di non reprimerle, riuscì a ritagliarsi
degli spazi vuoti, segreti e rubati, continuando a scrivere di notte..
(«...Appassionata
delle arti belle e di tutto ciò che è nobile e gentile, ho dovuto scrivere di
nascosto, perché non si dicesse che non ero donna di casa...)
Singolare fu
l’amicizia che Mariannina portò avanti con un’altra donna importante di Ragusa,
la Beata Mariannina Schininà. Le due donne diventarono molto amiche e la
poetessa parlò di lei in alcune sue lettere definendola:
“buonissima giovane”.
“buonissima giovane”.
Nel
1871 entrambe furono nominate Ispettrici Scolastiche.
secondo
le nuove volontà statali di affidare l’istruzione primaria a quelle donne che
avessero un minimo di dimestichezza con la cultura, nella Coffa e nella
Schininà si possono ravvedere forti differenze di pensiero nonostante la
provenienza comune dalla medesima classe sociale. L’ispettrice Schininà
predisponeva che per prime venissero insegnate le cose religiose, poi a fare la
calza e i lavori domestici infine lo studio. Di tutt’altro avviso era la
poetessa che riteneva improduttivo istituire delle scuole pubbliche femminili
per far apprendere alle bambine attività che avrebbero comunemente imparato a
casa, col tempo, come le faccende donnesche. La Coffa avrebbe preferito far
conoscere la grammatica e le belle lettere alle allieve ma il suo grado
d’istruzione troppo elevato, e pertanto, poco compreso in quel clima ancorato
ad un retaggio obsoleto e arcaico fece evitare a Mariannina di rimarcare le
mancanze delle insegnanti e della Schininà stessa. Le lettere che fanno capo
agli anni 1873-1877 hanno per contenuto ricordi d’infanzia e raccomandazioni
varie. Con la morte del suocero avvenuta nel 1874 la Coffa approfitta del tempo
guadagnato per dedicarsi anche un’ora al giorno alla scrittura.
Nel XX secolo gli scritti di Mariannina furono letti
da uno dei più importanti filosofi del’ 900 italiano…Benedetto Croce che
commentò:
“…andando
al mio solito a caccia di libri vecchi, mi venne tra mano il volume delle
Poesie scelte di Mariannina Coffa, edito a cura del Municipio di Noto.
Possedevo della stessa autrice quello dei “Nuovi canti”…
La poetessa
Mariannina Coffa ebbe molta reputazione e molta ammirazione in
Sicilia; e, in verità, non mancò di una certa sua personalità, malinconica,
dolente e sospirosa, e di una continua gentilezza di tono che la distingue
nella turba delle rimatrici…”.
Una delle sue ultime lettere fu ancora rivolta ad
Ascenzio implorandolo di vedersi ancora una volta, di potersi riabbracciare per
alleviare i suoi dolori ma l’Ascenso che
lei conosceva non esiste più. È un
fantasma, è un uomo che gira il mondo, che ha continuato la sua vita dopo il
suo rifiuto e che rimane legato a lei solo da un piacevole ricordo.
Struggenti
le sue frasi..
“Noi,
Ascenso, eravamo nati per amarci: amarci di quell’amore che gli anni non
possono spegnere, perché le anime nostre troveranno sempre tesori sconosciuti
da esplorare!….
…Vi
prego Ascenso, vediamoci oggi stesso alle ore 22 a San Giovanni.
Sono troppo infelice, venite per pietà e poi non ci
vedremo mai più!”
Queste
le ultime parole che Mariannina scrisse al suo amato Ascenso che non andrà mai
a quell’appuntamento e i due non si rivedranno più. Il concetto di amore è
fondamentale nella vita e nella poetica della Coffa, un amore illusorio,
nostalgico, legato al passato e a qualcuno che spera la ami davvero per quello
che è, il suo è un amore destinato a non essere vissuto, un amore che invece di
salvare, distrugge.
----------------------
Importante è il commento che la stessa poetessa fa ai
versi del suo più celebre componimento “Psiche”:
“Li scrissi ieri
quasi in meno di mezz’ora, non so come li scrissi, mi venivano a diluvio e i
versi e le idee, né comprendevo ciò che scrivevo. Durante la notte una voce
continua mi ribatteva nel cervello la parola Psiche, psiche”.
I
carteggi privati ripercorrono i dissapori familiari che si instaurano tra la
Coffa e i genitori, acuiti dal divieto di questi di concedere una casa a Noto
nella quale fare dimorare la figlia che, quasi moribonda a causa di un
peggioramento di salute, deve abbandonare Ragusa. Alle sempre più invadenti
domande del canonivo Sbano riguardo i suoi rapporti con i dottori Bonfanti e
Migneco e con la medicina omeopatica la Coffa è risoluta a voler difendere
quest’ultimi rimproverando il canonico di dispensare consigli e opinioni
affatto richiesti. Il biennio ’76-’78 vedono una donna ormai stanca di lottare
contro familiari e sedicenti amici, che invece di comprenderla e aiutarla
insultano il suo buon nome ed onore con le più basse trivialità.
E’
la Mariannina della “denuncia” quella che scrive le ultime lettere e che,
dissipata ogni timidezza e accondiscendenza alle norme sociali, grida a gran
voce
“Io muoio
ammazzata!”,
avendo
peraltro l’intenzione di pubblicare l’Ode a Giuseppe Migneco e stamparne
dodici esemplari da fare avere agli “amici” netini che tanto hanno malignato
sul rapporto tra la poetessa e il medico.
“Maledizione!”
è
la parola che riassume le ultime epistole, nelle quali la coscienza di donna e
la lucidità d’intellettuale si palesano in maniera distinta e preponderante e
portano la scrittrice a ribellarsi alla tacita sottomissione all’istituto
familiare, all’infima borghesia che caratterizza un ambiente provinciale dedito
alle
calunnie e alle denigrazioni, alla medicina allopatica e alle convenzioni
sociali.
Psiche
Datemi l'arpa: un'armonia novella
Trema sul labbro mio...
Vivo! Dal mio dolor sorgo più bella:
Canto l'amore e Dio!
Psiche è il mio nome: in questo nome è chiusa
La storia del creato.
Dell'avvenir l’immago è in me confusa
Coi sogni del passato.
Psiche è il mio nome: ho l'ale e son fanciulla,
Madre ad un tempo e vergine son io.
Patria e gioie non ho, non ebbi culla,
Credo all'amore e a Dio!
Psiche, chi mi comprende? Il mio sembiante
Solo ai profani ascondo;
E nei misteri del mio spirto amante
Vive racchiuso un mondo.
Nei più splendidi cieli e più secreti
Sorvolo col desio:
Nata ad amar, sul labbro dei Profeti
Cantai l'amore e Dio.
Psiche è il mio nome: un volgo maledetto
Pei miracoli miei fu mosso a sdegno,
E menzognera e stolta anco m'han detto,
Mentre sui mondi io regno!
Eppur le voci d'una turba ignara
Fra i miei concenti oblìo:
Nello sprezzo dei tristi io m'ergo un'ara
E amor contemplo e Dio.
Psiche! Ogni nato colle ardenti cure
Di madre io circondai,
E il supplizio dei roghi e le torture,
Figlia del ciel, provai.
Nell'infanzia dei tempi, il gran mistero
D'ogni legge fu servo al genio mio:
Di Platone e di Socrate al pensiero
Svelai l’amore e Dio!
L'arte, le scienze, le scoperte, i lenti
Progressi dell’idea, chi all'uomo offria?
Io sui ciechi m'alzai, fra oppresse genti
Schiusi al pensier la via.
Psiche è il mio nome... il raggio della fede
Rischiara il nome mio:
E, Umanità, chi al nome mio non crede
Rinnega amore e Dio!
Ogni lingua, ogni affetto, ogni credenza
Col mio potere sublimar tentai:
Serbando illesa la divina essenza,
Forma, idioma ed essere mutai.
Or vittoriosa, or vinta, or mito, or nume,
Or sobbietto di scherno, or di desio,
Col variar di lingua e di costume,
Svelai l'amore e Dio!
Pria che fosse la terra, io le nascose
Fonti del ver mirai:
Vissi immortale fra le morte cose,
Me nel creato amai.
Eppur la terra non comprese ancora
Le mie leggi, il mio nome, il senso mio:
Conosce il mio poter... sol perché ignora
Che Psiche è amore e Dio!
Dio, Psiche, Amor! si vela in tal concetto
Il ver, la forza, l'armonia, la vita:
Son tre mistiche fiamme e un intelletto
Che un nuovo regno addita.
O Umanità! La scola del passato
Copri d'eterno oblìo,...
Quel Bene che finora hai vagheggiato
È Pische, è Amor, è Dio!
Farfalla innamorata
Ch'ergi le penne oltre le vie del sole
Pel tuo foco medesmo inebrîata,
Sibilla arcana per le tue parole,
Se il mistico pensiero
Che di cielo ti veste opra è del Nume,
Anch'io piango… ti adoro... e grido anch’io:
- Ecco un baleno dell'eterno vero,
Ecco una fiamma dell'etereo lume,
Ecco la creta che sospira a un Dio! -
Se l'anima potesse
Varcar la meta che le diè natura,
E gir soletta a quelle plaghe istesse
Da cui ne venne immacolata e pura,
Per gli occhi onde riveli
Fiamma cotanta io la vedrei rapita
Peregrinante a le commosse sfere,
E direbbe al pietoso astro de' cieli:
Deh, riprendi i miei sogni e la mia vita,
Ma non torni alla terra il mio pensiere!-
No, non fuggir... consenti
Che teco io sugga l'armonie passate,
E l'ebrezza dell'alma e i voli ardenti
Che mi fero in un gaudio amante e vate.
Lascia ch’io beva il riso
Di tue movenze allor che ti favella
Lo spirito accenso per virtu del core:
Lascia ch'io m'erga al sospirato eliso,
Ch'io voli in grembo a la perduta stella,
E gridi al mondo: - L’anima non more! –
La
triste storia di Mariannina Coffa fu raccontata anche in versi in lingua siciliana di Gaetano Passarello che
pubblicò nella sua raccolta “La carcarazzata”…
“ A Ragusa davanti
alla casa di Mariannina Coffa”
All’angulu di ‘na strada c’è ‘palazzu
ca pari ca vulissi arriparari
di tramuntana quannu c’è vintazzu
li massari ca stannu a raggiunari
di provuli, furmaggiu e di viteddi.
E’ na fudda d’ommini vistuti
di nivuru affumatu. Li cappeddi?
-Sunnu ppi cavaleri arrinisciuti.
Dicinu sti massari rausani
ca se li senti e si li vuoi studiari
pari s’ancora siculi e sicani
sunnu tinuti cca a rapprisintari.
Nuddu s’adduna di ‘na valatedda
unni c’è scrittu un nomu fimminili.
Cca parrunu di caciu e muzzaredda!
Hannu raggiuni, nun su cosi vili!
Ma ‘n ta dda petra quantu ‘n fazzulettu
c’è scrittu un nomu: Coffa Mariannina.
Arreri a stu barcuni avia lu lettu,
e di cca s’affacciava ogni matina.
Vardava u celu, la chiesa e la campana
E s’asciugava l’occhi lacrimanti.
Pinsava alla sua Notu assai luntana
E pinsava puru a lu so amanti.
Poi riturnava intra muta e stanca
E tanti versi amari idda scrivìa
Dicennu: Ascenzu miu, tuttu mi manca,
nun pozzu cchiù campari senza tia.
E morsi, e fu pp’amuri ca sinn’ìu!
Scrivennu versi chini di duluri.
Ora è luntana ed è vicina a Diu
E nui sintemu ancora lu so’ amuri.
Amici ragusani, spissu sentu
Ca tra li dui città, Notu e Ragusa,
c’è un rapportu d’amuri, un sintimentu.
E c’è sta puitissa, sta carusa
ca pari ca vulissi arriparari
di tramuntana quannu c’è vintazzu
li massari ca stannu a raggiunari
di provuli, furmaggiu e di viteddi.
E’ na fudda d’ommini vistuti
di nivuru affumatu. Li cappeddi?
-Sunnu ppi cavaleri arrinisciuti.
Dicinu sti massari rausani
ca se li senti e si li vuoi studiari
pari s’ancora siculi e sicani
sunnu tinuti cca a rapprisintari.
Nuddu s’adduna di ‘na valatedda
unni c’è scrittu un nomu fimminili.
Cca parrunu di caciu e muzzaredda!
Hannu raggiuni, nun su cosi vili!
Ma ‘n ta dda petra quantu ‘n fazzulettu
c’è scrittu un nomu: Coffa Mariannina.
Arreri a stu barcuni avia lu lettu,
e di cca s’affacciava ogni matina.
Vardava u celu, la chiesa e la campana
E s’asciugava l’occhi lacrimanti.
Pinsava alla sua Notu assai luntana
E pinsava puru a lu so amanti.
Poi riturnava intra muta e stanca
E tanti versi amari idda scrivìa
Dicennu: Ascenzu miu, tuttu mi manca,
nun pozzu cchiù campari senza tia.
E morsi, e fu pp’amuri ca sinn’ìu!
Scrivennu versi chini di duluri.
Ora è luntana ed è vicina a Diu
E nui sintemu ancora lu so’ amuri.
Amici ragusani, spissu sentu
Ca tra li dui città, Notu e Ragusa,
c’è un rapportu d’amuri, un sintimentu.
E c’è sta puitissa, sta carusa
C’a a stringiri stu vinculu cuncurri.
E’ comu l’acqua d’un ciumi ‘nto jardinu
C’arrifrisca dui spondi quannu scurri
Abbivirannu rosi e biancuspinu.
Ora non vi scurdati st’angiliddu
Ca scrissi tanti versi ‘nzuccarati.
Se ‘nta dda petra mittiti un ciuriddu
‘nforza l’amuri di li dui citati.
E’ comu l’acqua d’un ciumi ‘nto jardinu
C’arrifrisca dui spondi quannu scurri
Abbivirannu rosi e biancuspinu.
Ora non vi scurdati st’angiliddu
Ca scrissi tanti versi ‘nzuccarati.
Se ‘nta dda petra mittiti un ciuriddu
‘nforza l’amuri di li dui citati.
---------------------
Noto (Siracusa)








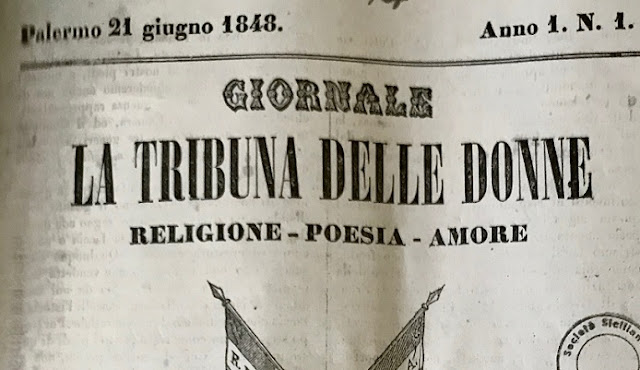






































































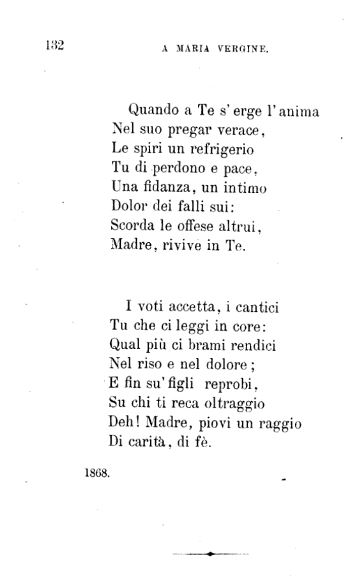































Commenti
Posta un commento