ALCARA LI FUSI (Messina) - I Luoghi dell'Eremita San Nicolò Politi - Il Monastero di S. Maria del Rogato - L'Eremo - L'Acqua Santa - La Grotta del Lauro - Borgo Stella, ecc.
1 - Il Monastero Basiliano di Santa Maria del Rogato;
1.a – La “Dormitio Verginis”
2 - Fra Lorenzo da Frazzanò e l’eremita Nicolò Politi – La loro amicizia
3 – La Grotta dell’”Aspicudd” sull’Etna, abitata da Nicolò Politi
4 – Verso l’Abbazia di Maniace
5 – La grotta del Cernaro (o del Giornale) di Maletto
6 – L’incontro fra San Nicolò Politi e San Lorenzo Ravi da Frazzanò
7 – L’arrivo di San Nicolò Politi ad Alcara – Cenni sul fiume Rosmarino e sull’idolo di Monte
Scurzi
8 – La Pietra dell’Eremo di san Nicolò Politi
8.a – L’”Acqua Santa”
9 – La morte dell’Eremita San Nicolò Politi
10 - la richiesta di canonizzazione di Nicolò Politi
11 – L’Antica Alcara
12 – San Luca da Demenna – cenni sul Mercurion
13 - I riferimenti storici su San Nicolò Politi
14 – L’Eremo di San Nicolò Politi
15 – Le reliquie del Santo – Il Libro di Preghiere – I furti
16 – L’Esame delle pergamene in parte trafugate
17 – I Documenti
18 – La Koimesis nell’arte
19 – Alcara Li Fusi (cenni di storia)
20 – La Grotta del Lauro
21 – Borgo Stella
22 – N. 3 Video su Alcara Li Fusi
1.
Monastero Basiliano di Santa Maria del Rogato
LA STRUTTURA
(Dott.ssa Musolino)
La Vergine è abbigliata con una veste di color porpora ed è avvolta da un manto scuro. Ha le mani incrociate sul ventre e il suo corpo è posto sorpa un catafalco di color amaranto e decorato da volute molto semplici.
Attorno alla Vergine si trovano gli Apostoli e i Dottori della Chuesa orientale che indossano il tipico Pallio Liturgico.
In alto si trovano due angeli che sorreggono una mandorla con all’interno il Redentore che tiene tra le braccia l’anima benedetta della beata Vergine raffigurata da una bambina in fasce.
Sullo sfondo della scena si trovano degli edifici con finestre bifore da cui alcuni personaggi assistono all’evento.
In alto l’iscrizione
“ H KOIMHCIC THC U_EPA!IAC "KO ”
“
dormitio della Santissima Madre di Dio ”
Ai lati del Cristo si trovano:sulla
destra : IC
dal
lato opposto : XC
Varie parti dell’affresco, lateralmente si presentano coperte dalla cornice in muratura che in alcuni punti si è staccata dal supporto murario mettendo in evidenza le tracce di altri affreschi tra cui un San Giovanni Battista e due volti forse da identificare con due monaci del monastero.
L’intera parete era quindi affrescata e successivamente l’unico elemento raffigurativo ad essere lasciato visibile, o ad essersi salvato dall’incuria fu proprio la preziosa “Koimesis”.
Sulla porta d’ingresso principale, sormontata da una piccola apertura di forma circolare, è posta
un’antica e semplice Croce greca, forse in origine dipinta, che in origine, ma di cui oggi,
non si vede altro che il legno.
Il 15 Agosto di ogni anno, la campana del Rogato richiama i fedeli alcaresi che si riuniscono
lontano 15 Agosto 1167.
La festività dell'Assunzione celebrata in occidente il 15 agosto, corrisponde alla festività ortodossa della Dormizione nella stessa data. Visti i resti dell'affresco conservati nella chiesa del Rogato, conformi alla tradizione figurativa bizantina della Dormitio Virginis, attorniata dagli Apostoli, che trasfigura la morte della Madre di Cristo in un sonno transitorio immune dalla morte, si potrebbe affermare come la chiesa del Rogato sia stata, nel corso di un millennio, al centro di un avvicendamento di culti, da quello ortodosso dei monaci basiliani a quello occidentale, con implicazioni sociali e storici da studiare.
La presenza del Santo Eremita Nicolò Politi fu giustificata dal fatto che viveva in una grotta posta nella Valle Calanna.
Il suo confessore fu proprio l’abate del Monastero del
Rogato, Cusmano (Gusmano, Cosmo, Cosmanus) detto il Teologo.
Padre Cusmano era quindi un monaco siculo, di cui non
si conosce la città natale, vissuto intorno all'anno 1167 e Abate del
Monastero di Santa Maria del Rogato presso la città di Alcara, dell'ordine di
S. Basilio. Fu ricordato negli annali storici successivi come uno dei maggiori
autori in lingua greco-medievale proprio a partire dal magnifico Inno Acatisto
al Santo (di cui purtroppo ci è giunto solo qualche frammento). Un autore
successivo, Placido Merlino, a metà del '600, citò la medesima figura del
Cusmano chiamandola "Don Urbano".
"Vita S. Nicolai Adernionensis Eremitae"
"Cosmani Theologi ad D. Nicolaum Eremitam, Hymnus"
Salve Nicola inclito
d’Alcara protettore
accogli i voti fervidi del nostro afflitto cuore,
dal trono tuo di gloria prega per noi Gesù.
O giovinetto angelico bello qual vago fiore
la tua innocente infanzia sacrasti al divo amore,
nell’aspre solitudini vivesti con Gesù.
Nelle più dolci estasi di fervida preghiera
la tua serafica anima fu in ciel da mani a sera,
impetra a noi colpevoli di non peccar mai più.
Di penitenza vittima in questo mondo triste
piangesti a calde lagrime le passioni di Cristo,
l’esempio tuo sì fulgiso ci sproni alla virtù.
Anche in Sicilia erano presenti le antiche Vie Francigene… le strade dei pellegrini che nel Medioevo si recavano a Messina per proseguire il pellegrinaggio verso Roma o altri luogo di culto. Molte di queste antiche vie furono cancellate dalle continue trasformazioni sul territorio (molte diventarono le attuali statali) ed altre sono delle vere e proprie trazzere. Archeologi, topografi e storici sono riusciti a ricostruire in Sicilia le reti delle antiche Vie Francigene:
2. Lorenzo Ravi da
Frazzanò e Nicolò Politi: l'amicizia fra i due Santi
L’amicizia
tra i due Santi fu narrata in uno dei
passi della vita di San Lorenzo.
Per
questo motivo le due comunità di Frazzanò, in riferimento a San Lorenzo, e di
Alcara Li Fusi, per San Nicolò Politi di cui è patrono, si gemellarono per la prima volta nel 1665 e
successivamente nel 1996 e nel 2000.
Come
abbiamo visto i due Santi s’incontrarono nel 1137. Entrambi giovanissimi ma
differenti nella loro personalità, nel modo di vivere e soprattutto nella
spiritualità.
Lorenzo
era un giovane austero, che spese la sua vita al servizio del prossimo, a
contatto con la gente, predicando e convertendo i peccatori.
Nicolò,
giovane bellissimo, timido e schivo, visse invece tutta la sua vita
nascondendosi agli occhi del mondo e celando quindi la sua vera identità. Un
atteggiamento forse anche legato ad un perenne intento di sfuggire alle
ricerche dei suoi genitor , che aveva abbandonato nel cuore della notte,
ma anche di dedicarsi in modo totale ed esclusivo alla preghiera e dalla meditazione.
Giovanni Petronio Russo
(Adrano, 24 giugno 1840- Adrano, 14 dicembre 1910; inventore, saggista ed
artista) descrisse San Nicolò Politi come
“Media è la sua statura, regolare delle membra,
gentile alle fattezze: bionde e inanellate ha le sue chiome, serena ed aperta
la fronte, nere le sopracciglia, vaghi lucenti e cerulei gli occhi; bianco e
rotondo il volto, rubiconde le guance, non grande ma profilato il naso”.
San
Nicolò (nato ad Aadrano nel 1117) era figlio di Almidoro ed Alpine Politi, una
nobile famiglia di Adernò e per evitare il matrimonio combinato dai
genitori con una ricca e nobile fanciulla,
fuggì a nord-est di Adernò rifugiandosi in una spelonca sull’Etna,
dove visse in penitenza per 3 anni.
3. La grotta è
detta di “San Nicolò Politi” ed è ubicata in contrada “Aspicuddu”.
In
tutta la cavità è presente un discreto stilicidio e nel lato Sud l’acqua si
raccoglie, nella galleria principale, in una pozzanghera fangosa.
Dopo
la pozzanghera la galleria si divide in due cunicoli che si sviluppano a
diversi livelli e, dopo pochi metri, si incrociano per svilupparsi in modo
separato prima di immettersi in un unico ambiente.
Alcuni
cunicoli hanno uno sviluppo cilindrico regolare, con diametro di circa 1 metro,
mentre il pavimento è costituito da lava rappresa. La
galleria bassa in direzione Sud ha l'aspetto tipico delle grotte molto antiche:
la volta e le pareti sono rivestite da una patina bianca di concrezionamento; i
piccoli brandelli di lava parzialmente rifusi che pendono dalla volta sono
anch'essi rivestiti da questa patina e a volte prolungati da brevi stalattiti;
il pavimento e la parte inferiore delle pareti sono invece scuri a causa del
fango trasportato dalle acque. In questa cavità sono stati rinvenuti frammenti
di ceramica attribuibili alla cultura di Castelluccio, ad età classica e
medievale.
Si CT 032: Grotta del Santo
Comune: Adrano (Ct)
Località: Lava Grande
IGM: 261 II SE M. Minardo (1969)
Latitudine N: 37° 42' 31"
Longitudine W: 14° 52' 35"
Quota: 1030 m s.l.m.
Sviluppo: 800 m
Dislivello: 20 m
Idrologia: Stillicidio intenso
Percorribilità: Buona
Andamento: Orizzontale
Terreno: Lave non datate del Mongibello recente
Percorribilità: Buona
Andamento: Orizzontale
Terreno: Lave non datate del Mongibello recente
Percorribilità: Buona
Andamento: Orizzontale
Terreno: Lave non datate del Mongibello recente
Al km 29 della SS 284 che da Adrano conduce a Bronte, si prende una strada verso Est
che attraversa la ferrovia Circumetnea all’altezza di un casello.
La strada conduce a Monte Turchio e dopo circa 3 km, in contrada Timpone, diventa una
carrareccia che, solo in alcuni tratti, è coperta da calcestruzzo.
Dopo altri 400 m si lascia sulla destra una breve strada asfaltata che conduce ad un pozzo, e si prosegue per 1.5 Km salendo attraverso le lave del 1595 (Lave del Gallo Bianco). Percorsi in totale 5 Km, a q 985, si lascia la carrareccia e si imbocca una traversa chiusa da una sbarra e orientata verso M. Minardo. 0.5 Km più avanti si incontra una dagala interamente recinta da un muro a secco e coltivata a mandorli e viti. Nella parte più alta di questa dagala si trova un secondo recinto, all'interno del quale si apre la grotta. Qui è stato eretto un altarino in memoria del Santo Nicola Politi, patrono di Adrano, che, secondo la tradizione, visse in questo luogo dal 1134 al 1137
Dal sito:
http://www.mungibeddu.it/MUNGIBEDDU/schede/032.html
Trascorso
questo periodo, Dio suggerì al giovane di lasciare la sua caverna dove i
genitori avrebbero potuto trovarlo e di andare verso Alcara, sotto il
monte Calanna, guidato da un’aquila celeste. In questo luogo sarebbe vissuto
fino alla morte.
Lungo
la strada, Nicolò si fermò nella chiesa di “quel
valorossimo di Maniace”.
4. Vero l’Abbazia di Maniace
Era
l’antica Abbazia di Santa Maria di Maniace con annesso convento Benedettino e
qui,
per
un caso fortuito o per volere del Signore, c’era anche frate Lorenzo Ravi da
Frazzanò.
Frate
Lorenzo era, reduce dall’Etna, dove aveva digiunato per 40 giorni, e si era
fermato all’abbazia di Maniace, prima di dirigersi, conforme al volere
del Signore, verso il monastero di San Filippo di Fragalà.
Abbazia di Maniace
San Lorenzo Ravi
da Frazzanò
Lorenzo Ravi
(Frazzanò, 22 ottobre 1120 – Frazzanò 30 dicembre 1162)
Monaco cristiano,
presbitero e venerato dalla Chiesa Cattolica ed Ortodossa
I suoi genitori, Cosmano Ravi e
Costanza Monaco, morirono nell’arco di tempo di un anno
Dopo la morte del padre, la madre
era già deceduta da un anno, nella vita del
giovane Lorenzo entrò un importante
figura femminile di nome Lucia.
Era una vicina di casa che, con
amore, si prese cura del giovane e sfortunato ragazzo.
All’età di sei anni chiese alla
madre adottiva Lucia di intraprendere lo studio delle lettere
umane e divine nel Monastero di San
Michele Arcangelo a Troina.
Troina – Monastero Basiliano di San Michele Arcangelo il Vecchio
successivamente ricevere gli ordini minori e maggiori.
I confratelli rimasero stupiti dalle virtù umane e religiose di Lorenzo, tanto che lo stesso
Niceforo (?), Vescovo di Troina, lo invitò subito a vestire l’abito monacale basiliano
A vent’anni Lorenzo era già sacerdote e subito si diffuse nel territorio la sua fama soprattutto
in merito alla sua fede ricca di penitenze che osservava dalla più tenera età.
pensieri di cielo", come riferisce l'antica leggenda greca.
Il giovane desiderava una vita da eremita e lasciò il monastero per vivere sei anni in
una grotta dell’Etna.
Per divina ispirazione fece ritorno al monastero di Troina per poi recarsi nel Monastero di Agira.
Agira –
Abbazia di San Filippo
La
tradizione citò il del suono delle campane che svanì solo quanto Lorenzo
abbracciò
i confratelli.
La santità di Lorenzo si diffuse in tutta l’area nebroidea e i fedeli, a costo
di gradi
sacrifici,
si recavano ad Agira per ascoltare la parola illuminata del sacerdote Lorenzo.
I fedeli,
grazie alla sua intercessione presso Dio, ottennero dei miracoli e delle guarigioni.
Dopo alcuni
anni di permanenza nel monastero di Troina, verso il 1145 e all’età di 29 anni
e con
il parere
favorevole dell’abate troinese Galieno e con Erasmo, abate del Monastero di
Agira, decise di lasciare il cenobio dell’Argangelo per andare a vivere in un
luogo solitario, in eremitaggio.
Non si
hanno riferimenti sul luogo in cui si recarono.
L’unico
riferimento fu la costruzione da parte di San Lorenzo della costruzione di una
piccola
chiesetta dedicata alla martire Santa Lucia. Probabilmente i tre mantennero nei
cinque anni
di permanenza, un certo contatto con il mondo esterno.
Nel 1150
San Lorenzo si congedò, tra le lacrime dei due abati, per andare a vivere in
completa solitudine in una grotta alle falde dell’Etna. Il sito rimase sconosciuto (forse la grotta
Del Cernaro o di Maletto ?).
5. Etna –
Grotta del Cernaro ( o del Giornale) di Maletto
L'ingresso inferiore immette in una
sala, il cui pavimento è ricoperto da terriccio e da alcuni massi crollati
dalla volta, dove si procede eretti. Verso monte la volta è assai bassa e
occorre procedere carponi per una decina di metri sino a raggiungere la base di
una scala di pietra dove si trova l'ingresso superiore, costituito da una
apertura nella volta. Poco prima di questa scala si trova una galleria lunga
circa cinque metri situata ad un livello superiore. Segue una galleria dalla
sezione quadrangolare. Più avanti si incontra un piccolo salto che dà accesso
ad una galleria, alta poco più di 2 m, molto ben conservata, di sezione
dapprima ellittica e quindi triangolare. Il pavimento è costituita da lava
scoriacea. Dopo circa 40 m la galleria, per circa 4 m, si articola su due
gallerie sovrapposte dove la volta è assai bassa. Si superano due buche
profonde più di 1 m, e si giunge in una galleria alta 5 m con sezione a goccia.
Continuando si raggiunge una lingua di lava che ingombra la galleria per una
decina di metri. Si osservano qui delle lamine distaccate dalla parete. La
cavità termina con la volta che degrada progressivamente.
Grotta di
scorrimento lavico lunga circa 160 m in lave preistoriche.
Sinonimi: Grotta
Giornale (o “Del Cernaro”)
Comune: Maletto
Località: Sciarella del Cernaro
I.G.M.: 261 II NE Bronte (1969)
Latitudine N: 37° 48' 13"
Longitudine W: 14° 55' 44"
U.T.M.:
Quota: 1400
G.P.S. (geo):
G.P.S. (utm):
Sviluppo: 165
Dislivello: 19,5
Idrologia: Stillicidio
Percorribilità: Buona
Andamento: Orizzontale
Terreno: Lave non datate del Mongibello antico
Da Maletto si percorre la strada
statale 284 in direzione di Randazzo sino al Km 7. Si imbocca una strada
asfaltata in direzione nordest e la si percorre sino a M. La Nave, un cono
avventizio di colore rosso, a 5 Km dal paese. Si prosegue per 500 m su una
carrareccia che costeggia dapprima le falde del monte e successivamente curva
sulla destra ed in leggera salita si addentra in un querceto e conduce ad un
cancello che delimita il demanio forestale. Alla destra del cancello si diparte
una mulattiera, transitabile con automezzi per fuoristrada, che si inerpica nei
boschi. Dopo 1 Km si incontra una diramazione ad angolo retto sulla destra. Si
percorre questa diramazione, molto erta, per 500 m, attraversando un
castagneto, sino ad un breve tratto in piano. Da qui si prosegue a piedi per
circa 150 m, in direzione est, mantenendosi in quota, sino a raggiungere una
radura. Qui si trova uno degli ingressi della grotta, poco visibile ma
segnalato da una piccola piramide di pietre. Più avanti si trova l'ingresso
inferiore.
Spirito Santo fra continue
lotte contro le tentazioni del maligno. In questa solitudine fu consolato dalla visita di
pii eremiti che come lui, dimoravano tra i boschi del vulcano, in grotte o in ripari di fortuna.
Fra questi eremiti ci fu anche San Nicolò Politi, tra l’altro contemporaneo di Lorenzo;
San Luca, abate di Sant’Elia in Calabria; con il quele scambiò “pensieri del cielo”
Nel 1155 fece ritorno nella sua natia Frazzanò ed entrò nel Monastero di San Filippo di Fragalà.,
“distante appena mille passi da casa sua”.
In questo
monastero in fermò per circa tre anni, facendo edificare a “Frainos”
(altro nome
di Frazzanò), una chiesa dedicata a San Filadelfo che fu arricchita di molte
reliquie.
La sua vita
nel monastero era intensa, dedicata alla parola del Vangelo ed alle numerose
visite dei
fedeli che chiedevano le Grazie.
Nei primi
anni del 1158 fu chiamato a predicare in alcune zone della Puglie e della
Calabria che
ancora non
si erano riprese dalla dominazione saracena..
Lorenzo
deide una grande prova di fede mostrando ai fedeli la Grazia di Dio.
Si recò a
Reggio in seguito alle suppliche dei
cittadini colpiti dalla peste.
In breve
tempo ridiede la salute del corpo non solo a chi lo invocava ma, come il
profeta Giona,
riportò i
peccatori, grazie alla penitenza, alla sincera conversione.
A Reggio
costruì ben tre chiese i cui ruderi sono sparsi per i colli della città.
Alla sua
partenza erano presenti il Duca, l’Arcivescovo Metropolita di Messina e
una gran
folla riconoscente al Santo per le sue intercessioni presso Dio.
Ritornò a
Frazzanò, nel piccolo borgo natio, dove si dedicò ancora con
maggiore fede ai divini misteri perché gli era
stata annunciata la sua dipartita
dal monto
terreno. Un anziano, con toni apocalittici, gli aveva riferito i voleri divini
ed anche
le
meraviglie che Dio avrebbe operato alla sua morte.
Le leggende
citarono come Lorenzo affrontò delle continue penitenze, sin da piccolo,
anche con
spargimento di sangue. Tutti riferirono il “prodigio della camicia”.
Il sangue
versato per tutta la notte, scomparve del tutto e la camicia del santo rimase
candida.
Secondo
l’agiografia laurenziana ci furono anche numerose visioni che costellarono
tutta la vita
di santità
di Lorenzo.
Nell’autunno del 1162 ritornò
definitivamente a Frazzanò ed ebbe appena il
tempo di vedere ultimata la nuova
chiesa di Tutti I Santi, da lui tanto desiderata
ad
honore della Santissima Trinità.
In questa chiesa si compirono
numerosi prodigi e Frazzanò diventò faro di luce divina per tutte
le comunità Nebroidee e non solo. I
fedeli ricorrevano a lui per avere delle Grazie sia per
la guarigione del corpo che per lo
Spirito. Nel Natale del 1162, dopo il Vespro del 30 dicembre, verso le 18,
l’angelo della morte venne a visitarlo nella celletta in cui viveva e dalla
quale non
usciva da circa tre giorni. Tre
giorni vissuti nell'ansia di
essere finalmente riunito al suo
Divino
Maestro, e nello sforzo di purificare ancora la sua anima con la penitenza,
per renderla
più degna nel presentarsi dinanzi al
trono dell'Altissimo.
Emise il
suo ultimo respiro ed il suo corpo cominciò ad emanare un soave profumo che
tutti, dall’abate di Frazzanò al più piccolo bambino” riuscirono a percepire.
Nella cittadina è rimasta una forte devozione
che dura da
circa otto secoli. Le reliquie sono conservate nella Chiesa che i frazzanesi
dedicarono
al loro Santo concittadino e patrono nel XV secolo.
Frazzanò – La Chiesa di San Lorenzo
6. L’Incontro tra
San Nicolò Politi e san Lorenzo Ravi da Frazzanò. La partenza dei due
Santi da Maniace verso Alcara e Frazzanò
Lorenzo, mosso da un sentimento istintivo, accolse il giovane con affetto, con molti atti di carità e simpatia fraterna. I due strinsero subito amicizia partecipando insieme alla Santa Messa e sedendosi vicini durante la parca cena. A tavola, durante la lettura della passione di Nostro Signore, Nicolò si turbò versando copiose lacrime per la sofferenza e la morte di Cristo. Lorenzo, insieme agli altri confratelli, ebbe modo di apprezzare la grande sensibilità e l’immenso amore che il giovane Nicolò serbava nell’animo. Tutti i confratelli, commossi, dissero tra loro:
“ Se costui così giovane rivela tanta perfezione, che sarà negli anni maturi?”
L’indomani, Lorenzo e Nicolò si avviarono insieme. Lorenzo, che già alla tenera età di sei anni era entrato in convento, conosceva i monasteri basiliani della zona ed indicò all’amico il monastero di S. Maria del Rogato, nei pressi di Alcara, come luogo nel quale avrebbe potuto recarsi per ascoltare la messa e comunicarsi . Il Monastero era guidato dall’abte Cusmano, detto il Teologo.
Gli parlò anche del padre Confessore, Cusmano di Alcara, uomo di grandi virtù ed abate del monastero, al punto di meritare l’epiteto de “Il Teologo”.
A padre Cusumano e a Lorenzo, Nicolò aprirà il suo cuore negli anni successivi, fino a poche ore prima della morte.
Quando i due frati giunsero a Portella Gazzana, si separarono con la promessa di rivedersi.
Portella Gazzana
(Longi)
Nel mese di luglio
si svolge a Portella Gazzana la festa
del grano ovvero “A Pisera”.
Dopo la raccolta del grano, i covoni sono lascati al sole per una ulteriore
maturazione. Si procede quindi alla pesatura con i cavalli che effettuano nell’aia
dei giri circolari per separare il frumento dalla spiga. Il grano pulito viene prelevato
per essere portato al mulino per la macina.
Frate Lorenzo
proseguì per Frazzanò mentre frate Nicolò per Alcara.
7. L’Arrivo di
Nicolò Politi ad Alcara
Il Santuario Eremo
di San Nicolò Politi nella Valle Calanna
appartenenti all’Appennino Siculo. Geologicamente sono costituite da roccia calcarea
dell’era Mesozoica e ricadono nei territori di Alcara Li Fusi e di Longi, centri entrambi
nella provincia df Messina.
Il rilievo calcareo presenta degli evidenti specchi di faglia che formano
delle bellissime pareti di roccia. Interessante è lo specchio di faglia a strapiombo della
Valle Calanna dove nidifica l’aquila reale. Su un versante si apre la Grotta del Lauro che
presenta stalattiti e stalagmiti. Sul versante nord-occidentale, a bassa quota, nidifica il
grifone che negli anni passati fu sterminato per un criticabile comportamento dei pastori.
Grifone che fu reintrodotto da poco tempo e con grande successo.
Sulla cima doveva sorgere un antica città greca (“ Krastos”). In lingua siciliana il termine
“Castrus” indica il maschio della pecora ma in questo caso il toponimo dovrebbe derivare dal
latino “castrum” che significa “fortezza”.
Rocche del Castro
Rocche del Castro e Rifugio del Sole
Rocche del Castro – Nel Regno dei Grifoni e dell'Aquila
Rocche del Castro – Nido dell’Aquila Reale
Nell’abbazia conobbe padre Cusmano che Nicolò scelse come suo confessore.
Grazie a questo codice fu possibile venire a conoscenza della vita esemplare e santificata di San Nicolò Politi, il cui sacrificio altrimenti sarebbe andato perduto.
Sempre attraverso questo codice si ebbero delle notizie sull’amicizia che legava il Santo di Frazzanò (Lorenzo Ravi) all’eremita di Alcara perché nessun altro autore, nemmeno il Gaetani, ne fecero menzione.
I biografi di S. Lorenzo curarono di riportare scrupolosamente i particolari ufficiali della sua vita e non mancarono di elencare tutte le sue opere di apostolato e di santità compiute sotto gli occhi di tutti. Però non potevano conoscere una vicenda così delicata e intima, come la sua amicizia con S. Nicolò.
Quest’amicizia faceva parte della sfera privata dell’uomo S. Lorenzo e, proprio perché privata, sfuggiva ai clamori della gente, al controllo dei contemporanei e soprattutto degli agiografi.
Solo padre Cusmano ne era a conoscenza così come della presenza dell’eremita che viveva nascosto tra i monti.
La tradizione sulla vita di S. Lorenzo, dunque, si biforca: da un lato, la biografia ufficiale, che lo descrisse santo e prediletto a Dio; dall’altro, gli appunti dell’abbate del Rogato, che immortalarono l’affetto amichevole di due uomini che percorsero il difficile cammino dell’ascesi e della penitenza per amore di Dio. Sarà padre Cusmano a far conoscere al mondo questa meravigliosa amicizia, sulla scorta delle confidenze che Nicolò gli fece in privato ed è per questo motivo che la sua amicizia con Lorenzo entrerà a far parte solo degli scritti della vita del santo di Alcara, che risalgono tutti al manoscritto di Padre Cusmano ed al suo inno in onore di San Nicolò.
“Un venerando Padre onorava a quei dì la religiosa famiglia basiliana. Egli era di penitenza esemplare, di specchiatissima condotta, di zelo instancabile, Amore
vole confortatore degli afflitti, maestro degli ascetici, salute ai peccatori, tutto fervore nelle concioni, promovendo generose offerte dei fedeli in più luoghi come per incanto avea fatto sorgere nuovi sacri templi , molti ne aveva restaurato. Avea liberato Reggio dalla pesre, e la fama di sua santità divulgatasi avea operato prodigi immensi a quantieziando da lontano partitisi chiedano il supremo soccorso in loro sollievo. La terra di Frazanò fu il fortunato paese che diedegli i natali, Lorenzo era il suo nome, poco dopo la sua prodigiosa morte, venne elevato all’onore degli altari. 25 primavere aveano ammirato il giglio di purità. l’adranita Penitente, nella grotta del Calanna: correa l’anno 1162. Lorenzo il santo, reduce dalle sue meravigliose fatiche, fattasi corona del merito acquistato per tante missioni, trovavasi per pochi dì tra i suoi correligiosi in s.Maria del Rogato. Nicola che ivi si porta periodicamente a chieder lume dal suo maestro in divinità, a purificarsi nel cuore con la più esatta delle debolezze…s’imbattè nel venerando Lorenzo”.
Lorenzo, in particolare, rimase colpito dal fisico invecchiato, imbrunito e malaticcio di Nicolò, dai suoi capelli lunghissimi ed incolti, dalla veste logora da mèndico, dalla spaventosa magrezza, indizi che svelavano a quali sacrifici si fosse sottoposto in tutto quel tempo per amore del Signore:
“Stupivasi Lorenzo; e à larga vena da gli occhi
mandava torrenti di tenerissime lagrime, vedendo in tale stato un nobilissimo
Cavaliere, che per amor di Dio, spogliatosi di quanto avea, rinunziò, fuggendo
il mondo con tutte le ricchezze, anche i propri genitori, e la sua destinata,
nobile, e virtuosa Sposa; e si confondea tra se stesso , pensando ch’egli non
avrebbe mai potuto, per poco tempo, non che per tutto il corso di sua vita,
sostenerlo così penosamente, e martirizzata, come la portava l’ammirabile
Anacoreta. Alla fine corse ad abbracciare Nicolò, e con tanto amore e spirito affetto
stringendolo, gli disse: Così ti riveggo caro Fratello in Cristo? In questa
forma ti trovo, amato mio Nicolò? O quanto può il santo amor di Dio, ò quali
fervori egl’infonde né cuori de’ Servi suoi! Ah, che io troppo
agghiacciato mi riconosco nel Divino Amore; ah, che troppo debole sono in
servirlo! Felice te, e fortunato Nicolò, che con tanto ardore, e vigor di
spirito, amante ti mostri, e servo fedelissimo del Signore”.
I due santi si abbracciano amorevolmente: era una festa ritrovarsi! Lorenzo, più tardi, espresse il desiderio di accompagnare l’amico nell’antro di Calanna.
Nicolò acconsentì e così Lorenzo sarà l’unica persona a vedere con i propri occhi, finché Nicolò visse, la roccia che fu, per tanti anni, il suo unico riparo. Nel vedere il cammino lungo e difficile per giungervi; la strada in pietra lavica che tagliava i piedi di Nicolò fino a procurargli delle ferite; le spine ed i rovi che gli si conficcavano nelle carni, senza che Nicolò facesse segno di curarsene minimamente, Lorenzo ebbe parole di meraviglia e di ammirazione. Ma quale, maggiore meraviglia provò nel vedere la spelonca in cui viveva Niccolò! Vi si accedeva con difficoltà da una piccola apertura, attraverso la quale giungeva solo una pallida luce: sembrava una tana per serpenti o per bestie selvatiche; d’inverno quel luogo era senz’altro freddissimo; d’estate, i raggi del sole lo trasformavano in insopportabile fornace. Nemmeno un mucchio di foglie alleviava il giaciglio della nuda terra e grossi, informi macigni, fungevano da guanciale. In un angolo della grotta stavano la catena ed il flagello con cui Niccolò soleva martoriarsi le carni in segno di penitenza. Le lacrime sgorgarono copiose dagli occhi di Lorenzo, nel vedere tanta desolazione. Niccolò rispose sereno che gli erano care quelle rigidezze, e che esse non potevano eguagliare il sacrificio di Gesù Cristo sulla Croce. Lorenzo ebbe allora, ancora una volta, per l’amico Nicolò parole di elogio e di ammirazione, insieme a tanta considerazione e dolore per la vita che gli conduceva. Insieme consumarono il pasto che l’aquila celeste, per benigno volere del Signore, portò loro; un pane bianco, al posto delle amare radici di cui soleva cibarsi Niccolò ogni giorno. Poi trascorsero il tempo meditando sulla Passione di nostro Signore Gesù Cristo e flagellandosi entrambi fino ad abbeverare l’antro del loro sangue innocente. Alla fine di una lunga notte di preghiere e discorsi, così Lorenzo si congedò dal confratello:
“un’altra volta ci rivedremo in cielo, o
Niccola; e ci rivedremo per sempre, per non separarci mai più innanzi al trono
dell’Eterno! Il nuovo anno troverà disanimata questa salma, l’anima sarà
svincolata dalle catene di questo corpo il dì 30 del prossimo dicembre. Mille
anni sembra a me il trascorrere di ogni giorno! Quanto ti sospiro o moneto
felice, che porrai termine alle lagrime del mio pellegrinaggio!”.
”deh! All’arrivo nella celeste Gerusalemme ti sovvenga di me; ivi stando di faccia a faccia, pregalo, prega tu il buon Dio, perché non cessi largirmi il suo supremo aiuto: e che sebbene rassegnato io sia nell’adempiere con rigorosa esattezza il suo voler divino, pure ah! Io bramo con ansia cocente l’ora che io giunga al suo santo regno!”
“Fratelli miei cari (Lorenzo rispose) non può la
lingua narrarvi, e appena la mente capisce l’asprezza del luogo, la rigidezza
dell’antro, l’amarezza de’ cibi, il fervore dello spirito, la crudeltà santa,
che usa con l’estenuato suo corpo; le discipline sanguinolenti, i disaggi osi
viaggi, il disprezzo di se stesso, il dormir sù la nuda terra; l’appoggiar
l’affannato capo su duri sassi, le lunghe vigilie, le fervorose orazioni, le
dolorose meditazioni di Gesù appassionato, la corrente delle lagrime, l’impeto
de’ singhiozzi, e l’abbondanza del pianto: Ma frà tanti rigori, e cordogli,
dopo le assaggiate amaritudini, che gli martirizzarono il corpo, o felice, e
cento , e mille beato di Nicolò (da voi sol conosciuto di vista) chi mi
potrà discrivere l’abisso, ch’egli gose di consolazioni celesti, le contentezze
di quell’anima, le delizie di quello spirito? E quì piangendo Lorenzo passar
non potea più oltre con le parole, essendogli impedite dalla corrente di un tenero
lagrimare: finalmente alle vive istanze di quegli stupefatti Religiosi,
proseguì il racconto: come Dio li provvide di un pane intiero, certamente del
Cielo, portato loro da un’Aquila, che lasciando la sua naturale alterezza, da
colomba comparve, e fedela ancella à prò del suo caro Romito, che con
tanti vezzi mostrò corteggiar, e servire. E sopra tutto, non potea finir di
esagerare il gusto, e le delizie, che loro apportò quel Celeste pane, poiché lo
stesso fù assaggiarlo, e restarne imparadisati”.
disse commosso –
Per recarsi
al Monastero del Rogato l’Eremita Nicolò Politi doveva attraversare il fiume
Fiumetto affluente dell’importante fiume Rosmarino (che la leggenda riporta “a piedi asciutti”).
Scafi nel Comune di Alcara Li Fusi. Lambisce Alcara e Militelòlo Rosmarino e, dopo
un percorso di circa 30 km, sfocia nel Mar Tirreno tra Sant’Agata di Militello e Torrenova.
(L’etimologia del termine “Ghida” è ignoto, forse di origine araba)
Il termine Rosmarino è invece legato alla presenza delle piante di rosmarino che,
soprattutto nel tratto inferiore del suo percorso, crescono spontanee sulle sue sponde.
e di parte della Calabria. Un percorso tra i rilievi montuosi dei Nebrodi che,
nel bacino in esame, superano i 1800 metri. La vicinanza al mare limita l’ampiezza del
bacino idrografico e quindi anche la portata che ha un carattere torrentizio legato alle condizioni climatiche della zona con piogge generalmente concentrate nei mesi invernali.
Il grande dislivello ha permesso alle acque di creare un ampio e profondo alveo che
presenta grandi massi erratici (massi di grandi dimensioni trasportati lontano
dal loro luogo d’origine) e un forte processi d’erosione dei suoi argini.
Gli altri corsi d'acqua vicini, scorrono paralleli gli uni agli altri e presentano caratteristiche molto simili (Furiano, Zappulla ecc.) I suoi affluenti principali sono: i torrenti Cudirì, Fiumetto e Fiere a sinistra e i torrenti Murazza, Sant'Anania, Stella e Niresa a destra.
Il corso del fiume negli anni passati, forse ancora oggi, è stato oggetto di attività estrattiva
molto intensa con danni ambientali incalcolabili.
Nell’ aerofotogrammetria sono evidenti le zone chiare oggetto di estrazione.
Sempre sul tratto terminale del Fiume Rosmarino si trova, sulla sinistra del suo coso, un monte
dall’aspetto conico posto vicino al confine tra i comuni di Militello Rosmarino e
Sant’Agata di Militello. Si tratta del Monte Scurzi, alto circa 494 metri e distante circa 2,5 km
dalla costa tirrenica.
montagne circostanti, era nell’antichità un punto strategico molto importante.
Nel sito, una stazione della tarda età del Bronzo inizi dell’età del Ferro, fu rinvenuto uno
dei più interessanti bronzetti del Museo d Siracusa. Un bronzetto dal carattere barbarico e
prodotto dall’industria sicula
È un idoletto bronzeo siculo, alto 10,3 cm ed è simile ad un altro idoletto rinvenuto nel
Mendolito. Simili nell’imperfezione della lega metallica, come della fusione, che
sull’occipite, sul dorso, nelle natiche ed in una coscia ha lasciato delle minuscole porosità.
La struttura craniale è diversa da quella del Mendolito. Il viso molto piccolo e molto
prognato (prominenza della mandibola, tipica delle scimmie), gote gonfie ed è
contratto in un ghigno, fra l’orrido ed il grottesco. Occhi naso e bocca sono
piccolissimi e la stessa bocca fu ottenuta con un breve colpo di punta. La chioma è trattata
con un raschiatoio, con una lunga falda occipitale tutta ripresa a fitti e minuti tratti di
bulino. Il torace piatto e trapezio, con capezzoli e l’ombelico punzonati ed è cinto da una
stretta fascia, appena avvertibile nella pessima fusione, e certo corrispondente
al cinturone, molto nitido invece nella figurina del Mendolito.
Nel dorso il solco spinale e la divisione dei glutei, come i particolari dei gomiti e
delle ginocchia sono indicati a punta. Il gesto delle mani è identico a quello del Mendolito.
Entrambe le statuine sono espressione di arte indigena e probabilmente raffigurano un
Indigeno, un Siculo, m in quello di Monte Scurzi è presenta una chioma greca.
Il bronzo di Monte Scurzi
Bronzo del Mendolito
derivati molti altri insediamenti. Il sito avrebbe avuto una continuità
di vita dalla fine dell’età del Bronzo, inizi età del Ferro, fino al V secolo a.C.
Infatti secondo l’archeologo Bernabò Brea, in una relazione del 1955, scrisse che:
“dal materiale rinvenuto è facile dedurre che il villaggio sorto in età pregreca è
sopravvissuto anche per i primi secoli di colonizzazione. Oltre ai reperti dell’età
del Ferro, abbondanti furono i frammenti di ceramiche ioniche del VI secolo a.C.
e forse anche dei principi del V secolo a.C.. Ma nulla attesta la continuazione dell’abitato
in età posteriore
8. La Pietra dell’Eremo di San Nicolò Politi
Plinio e Dionigi di Alicarnasso attestarono come l’eroe Patron Turio accompagnandosi ad Enea approdò sulla spieggia del Mar Tirreno in Sicilia, di fronte alle Isole Eolie, e sull’altura del monte abitò la città di Aòlunzio, e ai piedi ove si trova Alcara, costruì il castello che prese il nome del fondatore “Turiano”.
Il Beato guardava e pensava, nella solitudine delle pietre, degli alberi, del suono delle sorgine e del scorrere del fiume, nei lievi sibili delle aquile e dei grifoni, rifugiato in quel presagio che sapeva tanto di mistico. Il suo sguardo fissava quelle case quasi aggrappate alla rocca del castello Turiano.
Monte Soro
le gioie che si è lasciato definitivamente dietro…. guarda le due lampade, i genitori, che vanno
consumandosi e che forse guizzano per le ultime volte della nostalgia del figlio.
Due lacrime gli solcano timidamente le gote; il cuore è come attanagliato agghiacciato,
oppresso da una mano di ferro. Getta un profondo sospiro “
8.a L’Acqua Santa
“L’Acqua Santa”
di numerosi torrenti e smottamenti in vari punti del territorio.
Il maltempo isolò per due giorni il piccolo centro e distrusse un ponte ed
una edicola votiva rurale dedicata alla Madonna.
Fu allagata anche la grotta dell’Acqua Santa della prodigiosa fonte e la foto
ritraeva la statua del santo che galleggiava sull’acqua.
Va chiarito che l’immagine, pur mantenendo quel carico di indubbio pathos, di per se non è del tutto inconsueta per questo luogo, in quanto capita che nei periodi invernali le copiose precipitazioni penetrino nell’edificio dal cancelletto d’ingresso, oppure che l’abbondanza d’acqua proveniente dalla stessa fonte facciano allagare l’edificio fino al soglio di ingresso.
L’immagine comunque ha un fascino indiscutibile e se da una parte fa riflettere sugli effetti della già menzionata antropizzazione dei territori in relazione ai fenomeni atmosferici, dall’altra parte colpisce emotivamente l’idea che laddove in Alcara si ricordi il prodigio dell’Acqua Santa, soltanto l’immagine scultorea del Santo non sia stata completamente sommersa dalle acque limacciose penetrate all’interno dell’edificio, restando lì, ancora in quella posa, con quel libro in mano e la croce poggiata al petto, quasi a raccontare l’incrollabilità di quella fede, di quella perseveranza nella preghiera e quel desiderio di servire Dio che rivivono nel racconto della vita del Santo.
Sappiamo che si tratta di una statua ben solida in cemento e resina, realizzata qualche decade fa dal Prof. Nicolò Agliolo Gallitto, ma la suggestione che la foto lascia è notevole, come è pure ben chiaro che l’acqua l’abbia parzialmente sommersa fino a qualche ora prima che la foto venisse scattata.
Tuttavia il simulacro come il Santo ch’esso raffigura appare quasi nel “suo” elemento d’elezione distintivo: l’acqua. Acqua che nella storia, nella tradizione e nella leggenda di S. Nicolò Politi ricorre con indubbia frequenza: alla nascita, durante il suo cammino e nel giorno della “rogazione dei miracoli” che ne sublimò la santità a tal punto che da li a breve papa Giulio II ne autorizzò il culto.
Dalla pioggia alla santità, dalla tempesta alla speranza.
Lo sgorgare dell’acqua fu un vero prodigio. Sotto un macigno di pietra si trova una fonte di acqua salutare in un bacino concavo che ancora oggi, dopo secoli, gli abitanti di Alcara tramandano come espressione del miracolo di Nicolò Politi. Per questo motivo il luogo è chiamato “Acqua Santa”.
Rivolse lo sguardo verso la catena rocciosa, in cima al Monte Crasto e la falda calcarea del Calanna.
In questo punto notò una sagoma che volteggiava nell’aria, maestosa, spiegando le vigorose ali piumate. Si librava in volo come a giocare, compiaciuta di farsi vedere dagli occhi dell’Eremita che la seguiva in ogni suo leggiadro movimento fino al precipizio dove si trovava il suo maestoso nido.
S. P. Q. A.
(“Senatus Populus – Que
Alcariensis”
“Senato e Popolo di Alcara”)
Il Convento del Rogato
Il Luogo dell’Acqua Santa
Il Calanna dell’Aquila Reale

Era il territorio teatro delle sue preghiere e vi
dedicò circa trent’anni della sua vita, vivendo nella grotta dell’Eremo con
dure penitenze rispondendo al richiamo divino di proteggere la terra di Alcara
e gli Alcaresi.
9. La Morte dell’Eremita Nicolò Politi
Non vide l’aquila ma gli apparve un angelo che gli rivolse la parola recandogli la frase che il suo cuore aspettava con grande desiderio
Durante il cammino, forse a causa dell’ansia, si sentì venire meno e per un attimo ebbe la paura di non poter raggiungere il convento.
Si fermò sedendosi su un masso sull’angusto sentiero e la sete lo assalì a tal punto da screpolare le sue labbra.
Passarono due donne contadine che portavano in testa due ceste colme di mele.
Videro l’Eremita… si fermarono… una donna strinse la cesta al capo temendo l’Eremita fosse un ladro.. accellerò il passo con egoismo cercando una fuga e lasciando quindi la compagna indietro.
La compagna alla vista di Nicolò con il volto stanco ma sereno, capì nel suo animo come quella figura fosse un penitente di preghiera,,, si chinò .. pose la cesta colma di mele a terra e le offrì al pellegrino.
Un episodio che venne tramandato dalla memoria popolare e che venne considerato un miracolo. Si narra che i frutti posti nella cesta della contadina ingrata, quella che si era data con egoismo alla fuga, si trasformarono in serpenti mentre nella cesta della donna caritatevele, le mele si trasformarono in rose e meravigliosi fiori colorati. L’episodio venne ricordato con una piccola edicola che è posta sotto l’Eremo proprio nel luogo del supposto miracolo.
Nicolò riprese le sue forze e s’incamminò verso il Rogato.
Nel Convento padre Cusmano alla vista dell’Eremita capì subito come la sua vita non sarebbe stata lunga e ebbe la visione, la percezione di un uomo, figlio di Dio, smarrito sulla terra.
Lo confessò e gli chiese di accompagnarlo alla grotta ma Nicolò non acconsentì e ritornò alla sua povera dimora da solo.
I frati basiliani del Rogato nella festa dell’Assunzione, il quindici d’agosto, prima di celebrare la messa attesero invano la venuta di Nicolò.
Nicolò era morto nella sua grotta rendendo la sua anima a Dio in un luogo ricco di memorie e di ricordi.
“Nell’istante stesso in cui l’Anima di Nicola
lasciava la spoglia mortale, le campane di
Alcara, mosse da una mano invisibile, suonarono a
festa.
Al non mai provato spettacolo, gli alcaresi sono
sicuri che qualche grandioso avvenimento
loro si annunziava e molti pensano essere morto in
odore di santità qualche religioso
del vicino monastero del Rogato, alcuni dicono di
essere morto il teologo
Padre Cusmano che da tutti veniva salutato per
santo.
Avidi i molti di poter spiegare quel prodigio si
portarono al Rogato ed ivi trovarono
P. Cusmano che loro dice:
“Riferite ai vostri concittadini che oggi è volato
al cielo un vicino eremita:
Nicola Politi di Adrano”.
Ed ecco un uomo dal braccio assiderato, per nome
Leone Racuglia, impone a tutti il
silenzio, egli recava una stupefacente notizia:
“Cittadini osservate il mio braccio, non è che da
recente così divenuto;
di buon mattino cercavo alcuni miei buoi smarriti,
rinvenuto a stento il primo
seguivo a cercare l’altro verso le contrade del
Calanna: giunto ad una grotta
trovo segni di tracce umane, osservo là dentro e
vedo la figura di un uomo
genoflesso, appoggiato ad una Croce, teneva un libro
fra le mani…..”
quelli del Rogato, commossi e stupefatti, seguirono il Racuglia, passando lo
asciutto torrente e il fiume Ghida e si avviano alla grotta del Santo eremita.
Giunti dinanzi alla grotta Leone Racuglia grida:
Miracolo ! Miracolo !
Il suo braccio era guarito; alcuni del Clero entrarono nella grotta e con somma
delicatezza e venerazione mettono fuori il Santo Corpo e tutto quel popolo.
fremente di di gioia santa, ripetutamente grida in un palpito solo:
Evviva il nostro Santo Protettore !” (Monteleone).
Padre Cusmano salì sulla “pietra dell’Eremo”, una
“pietra” che era vissuta con il povero Eremita, e narrò la vita, le glorie e i
prodigi di Nicolò Politi.Poi volse lo sguardo verso Cammara e commosso
affermò:Quella contrada per Nicola fu Santa / sotto una
pietra vi è l’Acqua Santa”.
nell’Eremo della Val Calanna
(Disegno conservato nelle carpette della studioso Branchina nell’Archivio Parrocchiale di Adrano).
Il Santuario dell’Eremo alle falde del Calanna
dove San Nicolò visse per 33 anni
Dopo attimi di sbigottimento, i fedeli presi dalla
commozione, cominciarono anche a piangere perché quasi increduli del prodigioso
avvenimento.Si levò una voce unanine di ringraziamentoChiamamulu di nome paisanu,Viva Viva Diu e Santa Nicola,E quanti è bedda sta Parola !
10. La Richiesta di Canonizzazione
di Nicolò Politi
Chiesa di San Pantaleone
La Bolla di Canonizzazione per il Santo protettore fu consegnata ai due concittadini alcaresi:
*****
Diletti figli, salute e apostolica benedizione
il Beato Nicolò, visse una vita santa in una grotta vicino alla vostra città,
e voi, o meglio i Vostri maggiori, ebbero una grande venerazione per lui.
Ricevettero il corpo per collocarlo nella chiesa maggiore ma per una ragione più importante
fu collocato nella chiesa di Santa Maria del Rogato, la quale è oggi inabitata e per
timore che non si tenti di rubarlo, desiderate trasportarlo in città con intenzione di
celebrarne la festa anniversaria della sua beata morte il 17 ed il 18 di Agosto,
e ciò tanto in città come anche nella chiesa presso la grotta detta di
San Nicolò lo Zito, dove rese l’anima a Dio.
Ci avete pregato che questo vostro desiderio venga appagato dalla nostra
benignità apostolica. Non ben volentieri abbiamo accolto i vostri voti e vi permettiamo che
possiate trasportare il Corpo del Beato Politi dalla chiesa del Rogato alla chiesa della
vostra città; e vi concediamo la facoltà di poterne celebrare la festa del suo anniversario
il 17 ed il 18 di Agosto, tanto in città come in quella presso il luogo dove visse e rese
l’anima Beata a Dio, a vostro piacimento. Senza alcun pregiudizio dell’autorità
apostolica. Anzi con speciale grazia vi favoriamo ancora e in virtù di Santa
obbedienza decretiamo che nessuno degli ordinari cui spetta, abbia a impedirv di
celebrare la festa, sia direttamente che indirettamente, per mezzo di altri,
molestandovi, in qualsiasi maniera, tanto meno trasportarvi la festa collocandola in
altro tempo, nonostante disposizioni in contrario.
Dato in Roma presso S. Pietro sotto l’anello pescatorio
il 7 di giugno 1507, anno 4 (IV) del nostro Pontificato
Filippo De Senis
Ai diletti figli della Città e terra di Alcara, Diocesi di Messina
(Traduzione dell’originale eseguita da Padre Giudo Passalacqua)
Lo storico Montelone ricordò nelle sue
ricerche come il numero 7 nelle scritture e pratiche ebraiche fosse un numero
santo: San Nicolò Politi:-
Nacque nel 1117; -
Fuggì dal mondo a soli 17
anni d’età; -
Nel 1137 si trova nella
grotta dell’Etna -
Ogni 7 giorni della
settimana andava a confessarsi nel Convento del Rogato;-
Morì il 17 agosto del
1167; -
Venne canonizzato il 17
giugno del 1507; Dopo la consacrazione del Beato nel 1507,
cominciò ad essere celebrata la ricorrenza del Santo permessa dalla Santa Sede.La prima statua fu ultimata verso il 1518 ma
il popolo non aveva ancora una “vara” per portare in processione il Santo
Protettore.Il Morelli riportò come “ per la vara portantina vi provvide il Comune inviando a Catania alcuni
incaricatiche acquistarono una bellissima “Vara” di S. Agata
in legno pregiato con quattro colonne,con moderna tutta decorata, che ai catanesi non
serviva più in quanto per la loroPatrona ne avevano fatta costruire una da un certo
mastro Vincenzo ArchifelUn’altra tutta in argento inaugurata per la festa di
S. Agata il 4 febbraio 1519.La “Vara” acquistata dagli Alcaresi si
conserva tutt’ora e viene adoperata per la processione del Santo il 3 maggio.
L’ambiente in cui visse l’Eremita pulsa ancora
di vita, ha qualcosa di mistico che non è facile descrivere ma che si
percepisce soprattutto se si è dotati di una grande sensibilità.Nel 1993, erano passati ben 826 dal momento in
cui fu rinvenuto il corpo del Beato e la grotta, in cui visse, grazie alle
offerte degli Alcaresi era stata
modificata con la costruzione di un tempio. Fu eretto un altare, l’altare del
Calanna che per tre secoli fu meta di pellegrinaggi per ottenere grazie.
11. L’Antica Alcara e altre
notizie sull’Acqua santa e sul Monastero di San Barbaro di
secondo le fonti, l’edificio di culto più antico.
Secondo le ricerche di Mons. Gaetano De Maria, da un atto del Vescovo Guglielmo
di Messina, datato 1125, s’apprende come la Chiesa fu edificata
“a spese e con le oblazioni degli abitanti di Alcara”.
Nel 1131 il Vescovo Ugo la sottomise all’Archiimandrato di Messina, perché di rito
Greco. Nel 1144 era ancora alle dipendenze dell’Archimandrato, anno della
revisione dei privilegi ordinata da re Ruggero II. La struttura odierna è frutto di vari
interventi che si sono susseguiti nel tempo soprattutto tra il XIV e gli inizi del XV secolo.
Si narra come i genitori di San Nicolò Politi, prima della sua nascita,
si siano recati nella chiesa in pellegrinaggio. Giunsero da Adrano per chiedere
a San Nicola di Mira, allora molto venerato, la grazia di un figlio.
Di gran valore artistico il portale ad arco ogivale mentre l’interno,
ad unica navata, è completamente spoglio d’opere d’arte.
E’ dedicata a Santa Maria Assunta e custodisce al suo interno numerose opere d’arte.
Pietro D’Asero, si trovano la statua e le reliquie di San Nicolò Politi.
Una delle più pregevole opere d’arte dell’oreficeria siciliana opera di Paolo Guarna.
Nel Duomo si conserva un organo del XVII secolo e numerosi dipinti tra cui una pala
settecentesca di Filippo Tancredi che raffigura il “Ritrovamento del corpo di S. Nicolò”;
un Crocifisso ligneo; un antico pulpito in legno; e l’imponente altare centrale.
si trova nella Cappella del Santo Eremita e raffigura l’episodio del ritrovamento del corpo del Santo,
da parte del bovaro Leone Rancuglia, il 26 agosto 1167 nella grotta del Calanna.
L’episodio è raffigurato secondo una tradizione che si tramanda da secoli.
L’eremita è raffigurato genuflesso con un libro di preghiera aperto tra le mani e una
Croce appoggiata sul petto. Di fronte al Santo ci sono dei flagelli e una pergamena
con raffigurate le cinque piaghe di Cristo. Sullo sfondo è raffigurata una piccola
chiesa (la Chiesa del Rogato) la cui campana suona grazie all’intervento di un Angelo.
Nell’opera l’artista volle evidenziare due diversi ed opposti stati d’animo:
incredulità, ecc) rappresentato da una robustezza tipica dei contadini e con il
volto bruciato dal sole e contornato da una folta barba incolta e fitta; dall’altro lato la
bellezza dell’Angelo che con i suoi lineamenti delicati e con un gesto molto
naturale, incorona con una ghirlanda di fiori il Santo Eremita.
Nella parte alta del dipinto l’artista riuscì a creare, in una stretta superficie
uno spazio illimitato, dove si notano le figure del Cristo e della Madonna,
accompagnati da Angeli, che accolgono l’anima bambina del Grande Santo Eremita
pie Surdi sapphica metra canunt
(il termine “Rogato” deriva dal latino “rogare – pregare”. Quindi Maria del Rogato significherebbe: “o Maria che ha pregato il divin suo Figlio, o Maria della preghiera”.
Nel tempo di vita di San Nicolò Politi esistevano nel territorio di Alcara due Monastero Basiliani:
Santa Maria del Rogato;
San Barbaro di Dèmena o Demenna, posto nel feudo di San Giorgio, in
contrada
“Pascì” o “Paxì”.
Demenna era l’antica città posta sulle Rocche del Castro ? Non si hanno riferimenti
sicuri sull’anno di fondazione del monastero, probabilmente fu costruito vero la fine
dell’VIII secolo inizi del IX secolo dato che, dai pochi documenti, risulterebbe
preesistente alla dominazione araba. Durante la dominazione araba il cenobio,
la cui vita culturale e religiosa era molto fiorente, subì un drastico
declino. Il monastero era abitato da pochi monaci che conducevano una vita
contraddistinta da stenti e difficoltà. I monaci riuscirono a superare le difficoltà e
con l’occupazione Normanna il monastero era in condizioni pietose
il Conte Ruggero nel 1097 pose il convento sotto le dipendenze dell’Abbazia di
San Filippo di Fragalà e il suo abate Gregorio intraprese le opere di recupero
del monastero . nel giro di pochi anni il Monastero di San Barbaro ritornò al suo antico
splendore. Nel 1323 il monastero venne ceduto ad un nobile e potente feudatario, Giovanni di Forlì.
In cambio di due salme di frumento (circa cinque quintali e mezzo) all’anno.
Fu per il monastero un colpo mortale perché dopo cinque secoli di gloriosa vita, cessò di
esistere. Demenna sarebbe l’antica città fondata dai Bizantini e il cui termine deriverebbe dal greco “Lacedemonio (abitanti di Sparta) che dovettero abbandonare il Peloponneso nel VII secolo. Fu conquistata dagli Arabi nell’885 perdendo la sua grande importanza. Nel 920 era ridotta a un nucleo di poche case abitate e in quell’anno vi nacque San Luca di Demenna. Durante la dominazione normanna cessò di esistere come borgo autonomo. I pochi abitanti superstiti andarono a vivere a Turiano (Alcara Li Fusi) e a Longi. Alcuni studiosi affermarono l’esistenza di Demenna a circa tre chilometri a Nord-Est di Alcara Li Fusi, in una contrada che è detta “Dèmina “ o “ Lemina”, ricadente nella parte
Le rare campagne archeologiche dimostrano come la città si trovasse sulle Rocche del castro o comunque le stesse Rocche fossero il “kastron” principale della città di Demenna.
Non lontano da Demenna sorgeva il Monastero Basiliano di San Barbaro di Demenna.
La Val Demone era una delle valli in cui fu divisa la Sicilia durante la dominazione musulmana.
Non si hanno riferimenti certi circa l’etimologia del termine “Demona”.
La denominazione “Valle Deminae” apparve per la prima volta alla fine dell’ XI secolo, in periodo Normanno.
Secondo lo studioso Michele Amari il termine era d’origine greca ed indicava il nome degli abitanti del villaggio durante la conquista araba. Il termine sarebbe “perduranti” o “permanenti” (forse nella fede religiosa o nell’Impero) perché era legato al participio presente del verbo διαμένω (permanere, perdurare) del greco bizantino “tondemenon”.
divenuto in seguito città di Demona o Demenna.
Altra ipotesi potrebbe essere legata alla boscosità dei Nebrodi per cui il territorio sarebbe stato chiamato “Vallis Nemorum”, (Terra dei boschi).
Altra ipotesi potrebbe essere legata all’Etna ed in particolare ad una leggenda che vedeva il vulcano abitato da demoni e quindi luogo d’ingresso per il mondo degli inferi. Il territorio sarebbe quindi stato chiamato con il termine “Vallis Daemnorum” ed altri storici dal rinvenimento archeologico i alcuni reperti Lacedemoni, cioè degli abitanti di Sparta.
Mappa Borbonica con il Feudo San
Giorgio, dov’era presente il Monastero di San Barbaro di Demenna, evidenziato
in rosso
12. Nei Luoghi di san Nicolò Politi era nato un altro Eremita: San Luca di Demenna – Il Mercurion tra Lucania e Calabria
A Demenna era nato un altro eremita, poi santificato, San Luca (detto “di Demenna). Alcuni storici, tra cui il Santoro E, indicarono il luogo natale in Tauriana, piccolo centro in Calabria, figlio i Giovanni e di Tedibia e fratello di S. Fantino (uno dei maestri di San Nilo a Mercurion). In realtà Luca era nato a Demenna e fu avviato alla regola basiliana nel Monastero di San Filippo d’Agira dove si formarono molti monaci greci del X secolo. Fuggì da Demenna quando il centro fu occupato dai saraceni (si narra per sfuggire alle loro vessazioni) per recarsi a Reggio sotto la disciplina di S. Elia Speleota di Reggio. Profetizzando un invasione saracena si sposto verso Nord, nell’eparchia di Mercurion, al confine tra la Lucania e la Calabria, a Nola (l’odierna Noepoli) dove restaurò un’antica chiesa dedicata a San Pietro. Qui si stabilì con i suoi seguaci.
(L’area del Mercurio sarà oggetto
di una mia prossima ricerca)
San Giuliano che, negli anni successivi, ebbe un forte sviluppo culturale ed economico.
Questo sviluppo attirò le attenzioni di un “signorotto” locale, un certo Landolfo (erroneamente
identificato con Landolfo di Capua) che tento, con mille azoni di mandarlo in rovina.
Quando Ottone I attaccò la regione, Luca e i suoi discepoli si trasferirono ad Armento, dove fondarono
un monastero fortificato. Fortificò il castello e la Chiesa Madre di Dio, lasciandone la custodia ai propri discepoli. Durante una nuova invasione saracena, guidata dall’emiro Abu – I Qasim Ali, quando il nemico giunse alla porte del monastero, Luca con gli altri monaci a cavallo andarono incontro al nemico affrontandolo con una vera e propria battaglia.
Ci fu un terribile spargimento di sangue da ambo le parti.
Fondò intorno al 971 il celebre monastero dei SS. Elia ed Anastasio del Carbone, che divenne il quartiere generale di s. Luca sia come baluardo fortificato contro le incursioni dei Saraceni, sia come luogo dei molti miracoli, che egli vi operò.
In seguito venne raggiunto da sua sorella Caterina, rimasta vedova, e dai suoi due figli, i quali presero tutti i voti; Luca fece stabilire sua sorella e altre monache in un convento dedicato alla Madonna, che era stato saccheggiato dai saraceni nell'ultima invasione. Vene afflitto per tre anni da una malattia che lo faceva zoppicare, quindi gli venne annunciata la morte imminente da un angelo e si spense nel monastero di Armento nel 984, assistito e poi sepolto da San Saba di Collesano
Nel XIX sec. il paese di Armento fu saccheggiato dai francesi che distrussero il monastero dei Santi Elia e Anastasio e nel 1857 fu sconvolto da un terribile terremoto.
San Luca di Demenna in una edicola
votiva di Alcara Li Fusi
13. I Riferimenti Storici su San Nicolò Politi
siti evectus fontem poscit, monitusque baculo ferire silicem, e saxo
rivum, morbis etiam salutarem. Elicuit”
“… giunto nell’arida contrada rocciosa, cui gli antichi diedero il nome di
Acqua santa, tormentato dalla sete desiderava una fonte, e avvertito di
percuotere col bastone una pietra, fece sgorgare dal sasso una sorgente
capace di guarire le malattie”.
Riportò alcuni elementi importanti sulla vita del
Santo..
riprende il cammino affrettando il passo per poter compiere prima
dell’imbrunire l’ultimo tratto del suo viaggio e avanza fra sassi aguzzi
e rovi pungenti spesso costretto ad arrampicarsi su balze scoscese, ansante
per la stanchezza e con i piedi dolenti”.
Antonino Surdi di Alcara, riportò il miracolo dell’Acqua Santa nella sua prosa barocca
contorno, se potesse scoprire qualche segno d’onda corrente, o pur se nella
concavità di qualche sasso alcuna reliquia di pioggia trovar potesse stagnata;
e parendogli non esservi, né campo né luogo di potervi sgorgare in quelle
asprezze alcun rivolo, né in quei duri e grossi macigni rinvenire vestigio
di fonte veruno. Sentitosi consumare dall’urgente calor della sete, senza
speranza di poter quella discacciar dalle sue aride labbra, vedendosi abbandonato
da ogni mondano aggiuto, si volta all’immensa Provvidenza del suo
Signore e confidando fermamente in quella così tra sé ragiona:
Intanto una voce si udì dal cielo, che all’assetato Romito così disse:
Alzati mio caro: sorgi Nicolò, e col tuo bastone, in cui figurato porto quel segno,
nel quale si compì la redenzione del mondo; onde più che la verga di Mosè
prodigioso si sperimenta; batti quel sasso in nome dello Spirito Santo,
chè vedrai sgorgarne un’acqua meravigliosa, quale non solo servirà
per smorzar di presente, come anche per alleviar la tua sete, ma pure
avrà virtù per discacciar dà corpi di chi
devotamente l’assaggerà, ogni malore, ogni sorte di infermità.
Con grandissimo stupore. E non minor gioia inteso ciò dallo orante
Anacoreta, subito prese in mano il suo miracolo bastone, ed alzatolo verso
quel duro macigno, sì disse:
Nel Nome del gran Padre Iddio Creatore dell’universo, dalla cui
Onnipotenza con un solo fiato, sorse creato il tutto….”
Percuotendo con il suo bastone quel duro sasso, non come Mosè con due
colpi, ma con una sola percossa vide con ammirevole portento, e
grandissima consolazione del suo spirito sgorgare dal quel ruvido macigno
onde chiare, fresche e salutari.
O meraviglia della Divina Provvidenza!
Mira l’acqua Nicolò, e sorpreso da grandissima confusione, riconoscendo
con tutta proprietà in fonte i benigni soccorsi della provvidenza Divina sparge
dagli occhi suoi per tenerezza di quella sorgente, vivi tormenti di
devotissime lacrime….
Nicola s’inchina, ed assaggiando di quell’acqua miracolosa, la sua cocente sete
smorza e ristora.
NOTIZIE SULL’ACQUA SANTA MIRACOLOSA
L’Acqua Santa di Alcara, grazie ai suoi numerosi prodigi, destò scalpore in tutta la Sicilia e lo stesso Mongitore affermò che…
mentre camminava verso la Terra d’Alcara, arrivato al luogo oggi chiamato
Acqua Santa, riarso da ardentissima sete, invocato il divino soccorso,
batte col bastone un gran sasso, da cui sgorgò una fonte perenne d’acqua,
salutevole a molte infermità e tuttavia ritiene il nome d’Acqua Santa….”
La Sicilia in una
cartina, che evidenzia il sistema idrografico, del 1762
Uno studio più approfondito fu eseguito dal Ryolo nel 1794 quando citò l’aspetto” istorico – analitico delle acque minerali e termali di Sicilia (fonte dello storico Salvo Di Matteo nel suo “Historiae Siciliniae).
un po’ in tutti i luoghi della Sicilia, e sempre le loro virtù
“terapeutiche” erano riferite all’intervento della Madonna o di qualche Santo…
Da queste trattazioni si ricava la nozione di una regione copiosa di acque,
in molti casi dispensatrici di salute e spesso elevate da virtù
soprannaturali e gravide di meraviglia….”
Narrò di una testimonianza diretta quando il 18 agosto 1868, trovandosi in pellegrinaggio sull’Eremo di San Nicola sulle falde del Calanna, volle andare a visitare il luogo santo
“….Noi che abbiamo l’onore di scrivere queste pagine, visitammo
questa sorgente il 18 agosto 1868 con 15 nostri compatrioti adornesi.
Si denomina “Acqua Santa” perché oltre che per il suo nascimento fu
per preghiera del Santo, numerosissime grazie di guarigione si narrano
di fedeli i quali con devozione di essa hanno fatto uso:
quam (aquam) variis escinde vessati morbis,
aut doloriubus apotantes, sani effecti”.
(settima pubblicata in Palermo).
colla guida di un’aquila per venire ad Alcara eligendovi/
per Divina disposizione un luogo più sicuro di penitenza /
il Monte Calanna e vinceste Satana, per la strada che d’ingannarvi tentava /
Quindi afflitto dalla sete battendo per divin comando col vostro bastone una pietra /
che tanto tosto scaturì per “Voi” e per i vostri devoti /
acqua salutare che ne riporta sino ad oggi il nome di Acqua santa /
Imperatrice del Signore un luogo più sicuro per servirlo, per il trionfo del
comune nemico e per l’abbondanza della divina grazia…”.
I Poeti dell’Acqua Santa
14. Alcara Li Fusi - L’Eremo di San Nicolò Politi
15. Le Reliquie del Santo – Il suo libro di preghiere – i Furti
Si tratta di una testimonianza ufficiale prestata da alcuni giurati al fine di autenticare le pergamene, che attraverso vie traverse e difficili, nel 1674, il barone D. Giuseppe Spitaleri, adranita, insieme ai due concittadini Antonino Morabito e il sac. Don Mario Scalisi, erano riusciti a portare ad Adrano, prelevandole da Alcara.
I tre si erano recati da Adrano ad Alcara con la speranza di avere qualche reliquia del Santo. Gli Alcaresi si rifiutarono di consegnare una (o più) reliquia del loro Santo Patrono. Gli adraniti, perduta ogni speranza, stavano per ritornare ad Adrano quando il padre guardiano del Convento dei Cappuccini, Padre Antonio da Alì, forse per rincuorare i tre ospiti del suo convento, li portò in chiesa davanti all’altare del Crocifisso. Da un reliquiario, contenete un gran numero di reliquie di diversi Santi, prelevò il libro di orazioni di San Nicolò Politi e lo mostrò agli ospiti che rimasero increduli.
del terreno redatto dal Notaio Antonio Montone, redatto l’8ottobre proprio del 1574.
Il convento fu costruito in Contrada “Parattica” un luogo sacro dove sorgeva un tempio
greco dedicato ad una divinità femminile.
Con la costruzione su resti pagani si edificò il Convento cancellando ogni traccia
di paganesimo e la scultura della dea che chiamavano “Fortuna”
Si realizzò il desiderio degli Alcaresi che da tempo, circa otto anni, avevano avanzato la
richiesta di avere nel loro territorio i frati Cappuccini.
Nel 1568, per superare le difficoltà opposte dai Superiori, per i problemi della questua, la comunità
offrì la somma di 18 onze e, su richiesta, il frumento secondo le necessità.
Furono restaurati la preesistente chiesetta e i locai adiacenti e si creò un
“bel giardino deliziosa selva rigabile”.
ampliati negli anni 1624 (la Chiesa), 1656 (il Convento), 1673 (la Sacrestia),
1676 (la cornice dell’Altare Maggiore eseguita da Fr. Antonino da Troina).
I Frati si dedicarono ad un fervido apostolato anche nei paesi vicini e soprattutto nelle
campagne. Il convento era dotato di una ricchissima biblioteca come risulta da un
catalogo redatto nel 1844 e conservato presso l’Archivio di Stato di Messina.
La biblioteca rimase successivamente nel convento disabitato ed esposto ai continui
saccheggi. Nel 1866 ci fu infatti la soppressione civile dell’ordine.
Dopo la soppressione del 1866, nel 1892 l’orto fu venduto a privati mentre il Convento fu
affidato in uso al Comune che lo adibì in parte ad alloggio per i poveri, parte a stalle
e fienili. Nel 1940 (?) la biblioteca fu in parte recuperata e trasferiti nella Parrocchia di
San Pantaleone e nel Museo di Arte Sacra. Il Convento fu invece distrutto da un
incendio nel 1956 e il sito trasformato in Villa Comunale.
Chiesa di
Sant’Elia
con numerose statuette (che sono state rubate), paziente lavoro dei frati del XVII
Dalle fonti storiche sembra che le pergamene di Adrano non siano state custodite in modo accurato.
Il sacerdote Petronio Russo nel 1871 criticò la trascuratezza con cui venivano conservate le preziose pergamene e denunciò la scomparsa di nove fogli e mezzo delle diciotto pergamene che erano finite nelle mani del barone Spitaleri.
Una conferma sulla mancanza di rispetto storico fu legata agli studi del Matranga che nel 1874-75 visionò solo sette pergamene,
Nel 1994 le pergamene adranite erano nuovamente diciotto e custodite in un reliquario argenteo.
Una sorte peggiore colpì invece le pergamene che erano custodite in Alcara.
Secondo la numerazione dello studioso Luca Matranga dovevano essere diciotto…..
Furono infatti trafugate nell’agosto del 1978 insieme all’oro degli ex voto che erano cusstoditi nella cappella del Santo, nella Chiesa Madre di Alcara… reperti che non furono mai ritrovati.
16. L’Esame delle
Pergamene (in parte trafugate)
I frammenti superstiti e quelli che furono studiati dal Matranga farebbero parte di tre / cinque libri diversi secondo l’Ufficiatura greca utilizzata dal monaci basiliani.
San Nicolò era un basiliano “dal piccolo abito” e come tale seguiva gli schemi di preghiera dei basiliani con cui era ogni settimana in contatto grazie alla vicinanza del monastero basiliano di Santa Maria del Rogato.
Il Matranga, sacerdote di rito greco, nelle sue relazioni ricordò che per recitare l’Ufficio giornaliero occorrevano numerosi testi che variavano anche a secondo dei diversi periodi liturgici dell’anno.
Le pergamene adranite vennero studiate per la prima volta nel 1870 da padre Antonino Rocchi, basiliano del Monastero di Gottaferrata che le collocò tra l’XI – XII secolo cioè nel periodo in cui visse Nicolò Politi. Le classificò come parti di libri corali dell’Ufficiatura Greca, di cui l’Eremita si serviva. San Basilio aveva permesso a chi volesse condurre una vita ascetica in solitudine, di legarsi alla sua regola come un monaco anomalo, che non faceva vita comunitaria e che, per la forma tozza della sua tunica, veniva chiamato “del piccolo abito” (microu’ schematos”).
Padre Rocchi ed il Matranga giunsero a precise conclusioni.
Quest’ultimo le classificò apponendovi in modo progressivo delle lettere dell’alfabeto greco ed, in particolare, le maiuscole α βγδεζηθικλμνξο per i quindici frammenti alcaresi e le maiuscole
per le sette pergamene adranite che potè visionare.
Le pergamene A e α farebbero parte di un unico libro e per il Matranga risalirebbero al IX secolo o alla prima metà del X. Sono frammenti di alcuni Esapostilari, delle orazioni che servivano di solito per chiudere il Mattutino cioè le preghiere che precedevano le Lodi della mattina.
La pergamena A contiene un frammento dell’Esapostilario di San Giovanni Battista per la Festa della sua Concezione, del 23 settembre; due di Santa Tecla Protomartire (24 settembre);
quello di San Giovanni Evangelista (26 settembre).
La seconda parte della stessa pergamena, comincia con la chiusa dell’Esapostilario di S. Ilarione Anacoreta (21 ottobre), continua con l’invocazione a S. Alberchio Vescovo (23 ottobre) e termina con il titolo dell’Esapostilario di San Giacolo Apostolo il minore (23 ottobre).
La pergamena α si riferisce a diversi mesi:
- Febbraio con le orazioni di San Teodoro (giorno 7); San Policaropo e Filadelfo (giorno 23);
La pergamena contrassegnata da β, posta tra la seconda metà del X e la prima metà dell’XI secolo, contiene gli Esapostilari:
- Dei Santi Martiri e Confessori Guria, Simone e Abibo (15 novembre);
Si tratta di odi che appartengono all’Officiatura greca e si distinguono in tropari ed hirmi cioè unità ritmiche proprie dell’innografia bizantina.
A questa seconda parte appartengono ben 15 pergamene
ODE I
“ I popoli tremarono, le nazioni rimasero attonite, i possenti regni si prostarono, o tutta paura,
piegati dal timore del tuo Figlio;
venne infatti, il mio Re, depose il tiranno e liberò il mondo dai lacci della Corruzione;
il Cristo che abita i cieli, disceso tra gliuomini, santificò il tuo seno e lo rivelò intatto;
Tu sola, infatti, dopo il parto, generando il Creatore, sei rimasta gloria della verginità.
ODE III
Tu, o Cristo, che ti ergi al di sopra di ogni potenza,
dall’alto sei disceso sulla terra, spontaneamente, ed hai risollevato la natura dell’uomo
dall’abissale profondità della dannazione;
lontano da te, il santo non sussiste, o amante degli uomini.
O purissima Vergine, la natura umana accostandosi per te all’irrestibile fiamma
dell’amore di Dio, come un pane che cuoce sotto la cenere, si purifica,
come pure in Te infiammata da Colui che ti rese Immacolata.
Chi è mai costei che davvero è così vicina a Dio da travalixare tutte le schiere degli Angeli ?
È lei, la sola che risplende nel fulgore della Verginità. Come Madre dell’Onnipotente.
ODE IV
Colui che è assiso nella gloria si è chinato incontro agliuomini;
resosi visibile, ma restando invisibile nella natura della sua imperscrutabile divinità,
rivestito da te, o Vergine, nella sua umana natura, salva quanti ri risconono Vergine Madre di Dio.
Vergine, accolse nella sua carne chi carne non era, rendendo parte della propria natura il Figlio
da Lei generato, per cui uno ci appare, in due nature; Dio, rivestito di umanità, ed Uomo.
Impossibile da definire con la limitatezza della nostra mente.
Nell’Inno del Cusmano fu
riportata la formula di preghiera che fu trascritta dal Gaetani in un paragrafo
della sua opera “Viae Sanctorum Siculorum” (Palermo,1657)
ascolta la mia preghiera
or che mi trovo in questa solitudine,
finchè io tengo in Te riposte le mie speranze:
quando lascerò la vita, ti prego, accogli la mia anima
17. I Documenti
Documento n. 1
Supplica degli Alcaresi al Papa
Archivio Vaticano – Reg. Suppl. 1250 – pag. 301 – fascicolo XV – Libro X – anno V
(foto che si trova nell’archivio della Chiesa Madre di Adrano)
È la supplica degli Alcaresi al papa per la sanatoria in merito
al trasporto del Corpo di San Nicolò Politi dalla Chiesa di
santa Maria del Rogato alla Chiesa di San Pantaleone. La supplica
concerne anche la richiesta di autorizzazione per poter celebrare la
solennità del santo il 17 ed il 18 Agosto di ogni anno.
Un decumento risalente al 1507. Del IV anno, di pontificato di Giulio II.
come si rileva dalla nota di catalogazione della copia
nell’Archivio Segreto del Vaticano.
Traduzione del documento
“ Beatissimo Padre, morto un certo Nicola de lo cito, in una
grotta vicini ad Alcara, diocesi di Messina, distante circa tre miglia,
le autorità ed il popolo di detta terra, per la grande devozione che
avevano verso questo Santo a causa della sua buona vita, presero il
suo corpo dalla grotta con l’intenzione di trasportarlo e collocarlo nella
chiesa maggiore di Alcara. Cambiata poi idea lo portaronop in una chiesa
detta S. M. del Rogato esistente in un bosco.
Volendo però allontanare tale corpo dalla detta chiesa disabitata,
in mezzo ad un bosco, dubitando che esso poteva essere facilmente rubato,
lo rimossero di là e lo trasportarono e collocarono nella chiesa maggiore
(San Pantaleone). Ciò fu fatto senza la licenza della S.V. e della
Sede Apostoloica, per la qualcosa presentano questa supplica umilmente
ai Vostri Piedi affinchè la S. Vostra santità favorendo la loro
lodevole decisione e aiutandoli con speciali favori e grazie
conceda e permetta che detti esponenti possano rimuovere il suddetto
corpo dalla chiesa di San Pantaleone e abbiano la facoltà di celebrare a
loro piacimento la solennitù della Messe la festa anniversaria ogni 17 Agosto,
sia nella chiesa Maggiore che nella chiesetta presso la quale morì. Sarà
opportuno comandare a tutti gli ordinari dei luoghi che non li molestino giacchè
gli alcaresi operano regolarmente. Si degni la Santità Vostra di concedere
per grazia speciale tutto ciò detto con un suo Breve. Nonostante
qualunque cosa ci possa essere in contrario.
Questo privilegio è stato concesso giusto la supplica presentata al Papa
ed è stato concesso senza alcun pregiudizio nella città di
Roma nel mese di giugno 1507.
Et per Breve ed sine preiudicio concessum S. Card. Sancti Petri ad Vincula.
………………………………………
DOCUMENTO N. 2
***
Diletti figli, salute e apostolica benedizione
Ci avete esposto che un tale già defunto, Nicolò Politi detto
popolarmente il Beato Nicolò, visse una vita santa in una grotta vicino
alla vostra città, e voi, o meglio i nostri maggiori ebbero una grande
venerazione per lui. Ricevettero il corpo per collocarlo nella chiesa
maggiore ma per una ragione più importante fu collocato nella chiesa
di Santa Maria del Rogato, la quale è oggi inabitata e per timore che
non si tenti a rubarlo, desiderate do trasportarlo in città con intenzione
di celebrarne la festa anniversaria della dua beata morte il 17 e il
18 di Agosto, e ciò tanto in città come anche nella chiesa presso la
Grotta detta di San Nicolò lo zito, dove rese l’anima a Dio.
Ci avete pregato che questo vostro desiderio venga appagato
dalla nostra benignità apostolica. Noi ben volentieri abbiamo
accolto i vostri voti e vi permettiamo che possiate trasportare
il corpo del Beato Politi dalla chiesa del Rogato alla chiesa
della vostra città, e vi concediamo la facoltà di poterne celebrare
la festa del suo anniversario il 17 e il 18 Agosto, tanto in città
come in quella presso il luogo dove visse e rese l’anima Beata
a Dio, a vostro piacimento, senza alcun pregiudizio dell’autorità
apostolica. Anzi con speciale grazia di favoriamo ancora e in virtù
di Santa obbedienza decretiamo che nessuno degli ordinari cui
spetta abbia a impedirvi di celebrare detta festa, sia direttamente
che indirettamente, per mezzo di altri, molestandovi, in qualsiasi maniera,
tanto meno trasportarvi la festa collocandola in altro tempo,
non ostante disposizioni in contrario.
Dato in Roma presso S. Pietro sotto l’anello pescatorio il
7 Giugno 1507, anno 4 del nostro Pontificio
Filippo De Senis
Ai diletti figli della Città e terra di Alcara, Diocesi di Messina
(Traduzione dall’originale di Padre Guido Passalacqua).
…………………………………..
INNO IN ONORE DI SAN NICOLO’ EREMITA DEL TEOLOGO PADRE COSMANO
COMMENTO IN
HYMNUM SANCTI NICOLAI EREMITAE
Per cui io sospetto che Cosmano scrittore dell’inno fu uno dei monaci di quel monastero, si può
Pensare anche che costui fu colui che sopravvivendo all’eremita B. Nicola, come io sospetto, ne ricevette le confessioni infatti egli confessa di aver conosciuto la vita ascetica del Beato e anche molti miracoli che nessun altro racconta; è opinabile che Cosmano ricevesse queste confessioni dal medesimo santo asceta Nicola. Tuttavia mi è sembrato opportuno divulgare questo inno. Esso contiene grandi lodi del B. Nicola e ricorda molti miracoli da Lui fatti proprio come ci ricorda lo scrittore della vita. Per questo ho ritenuto degno di memoria quanto ho detto sopra e ho anche meglio compreso dopo aver letto l’inno.
(Traduzione a cura di Simone Ronsisvalle).
…………………………………….
DOCUMENTO N. 4
Il Caetani, attingendo a questa fonte di prima mano in quanto testimonianza diretta del confessore di san Nicolò, trasmise le notizie riguardanti la vita del santo arricchendole successivamente con i riferimenti ai miracoli operati dall’Eremita post-mortem, e con gli accenni agli avvenimenti successivi riguardanti il culto.
Il Caetano raccolse queste informazioni, come rilevl egli stesso nel commento conclusivo, in parte dalle lezioni dell’antico Ufficio del Politi, in parte “da un’altra vita del medesimo Nicola, di autore incerto ma degno di fede”.
Anonimo Monaco Contemporaneo
Nel tempo in cui regnava l’illustre Conte Ruggero, che con le armi aveva tolto al dominio dei saraceni la Sicilia, il Beato Nicola in Adernò nacque dalla famiglia dei Politi, genitori non infimi ma l’ebbe tra i primi del suo paese, ai quali non essendo a chi lasciare i beni e le fortune, Gesù Cristo e la sua Santissima Madre Maria, con molte preghiere, digiuni, elemosine, ebbero un unico figlio Nicola.
Il fanciullo progrediva con buon carattere e fu affidato ai maestri da cui fosse istruito nelle lettere.
Ma i genitori ormai temevano la fine della vita e pensavano che il figlio doveva sposarsi, volendo che Nicola fosse unito in matrimonio e quasi costringendolo, ma egli si rifiutava del tutto e non trovando altra via pèer sfuggire alla loro imposizione decise di prendere la fuga di nascosto a tutti, e infatti giorno e notte volgeva nella mente ciò che è scritto nel Vangelo: Se qualcuno vuole venire dentro di me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, le sorelle e i fratelli, non può essere mio discepolo.
Dunque nella notte che il volere di Dio l’aveva destinato, quando tutti erano andati a dormire e il sonno profondo li aveva afferrati, allora Nicola decise di lasciare la casa, la patria, i genitori e tutte le cose che sperava di avere, stimandoli in niente perl’amore di Dio.
Pensa alla fuga ed ecco che questa voce viene da lui dal cielo: Nicola alzati e seguimi.
Subito agli si alzò e seguì la voce che diceva: vieni con me e ti mostrerl un luogo di penitenza salvitica nel quale, se verrai, potrai salvare la tua anima.
Pertanto guidato verso una zona di media altitudine del monte Etna trovò una grotta coperta di rovi e si nascose in essa.
E quindi con digiuni, preghiere, e specialmente dandosi alla meditazione della Passione di Gesù Cristo, continuamente castigando il corpo con flagellazioni e altri tormenti, stette lì circa tre anni.
Ma poiché quel luogo gli sembrava pochissimo adatto ao suoi progressi ascetici, ed era vicino al paese natio, e i genitori cercavano il figlio, la Provvidenza Divina volendo allontanare di là Nicola, gli spedìun messaggero, con questi ordini:
Nicola non rimanere più qui infatti c’è chi ti cerca e se ti trovano
ti ricondurranno in patria e perderai ciò che hai cominciato.
Ma avviati verso il luogo che ti mostrerà, verso Alcara sotto il monte Calanna,
dove dimorerai finchè finirai la vita.
Apparda l’aurora Nicola, partito dall’etna inizia il suo viaggio verso il luogo che gli aveva rilevato l’angelo, ma quando giunse in mezzo alla selva il diavolo in veste di mercante gli va incontro e così gli parla:
dove ti dirigi o misero ?
E lui risponde:
verso il monte Calanna, verso Alcara dove sono stato mandato,
l’interrompe il nemico degli uomini:
vieni con me, infatti avrai migliore sorte, ti mostrerò le mie città e miei luoghi,
che ti darò se obbedirai alle mie parole: ivi vivrai fornito di migliori piaceri,
molto più lietamente che sul monte Calanna.
Udite queste cose, il B. Nicola pensando tra sé diceva:
chi è costuti che cerca di allontanrmi dal mio viaggio e mi promette
le sue ricchezze, e il suo pane da mangiare, e le sue vesti e i suoi piaceri di cui
godere in questo secolo; quanta carità mostra verso di me ?
Tosto richiamando nell’animo la Passione di Cristo e volgendo gli occhi al cielo disse:
Oh Signore Gesù Cristo, per le tue cinque piaghe e per la tua passione
concedi che sfugga ai lacci di questa tentazione;
Finita questa preghiera fu liberato da quel tormento e il diavolo scomparve dai suoi occhi.
Dunque compiuto il viaggio iniziato, giunse al luogo che oggi si chiama Acqua Santa, ivi stanco del cammino, afflitto dai tormenti imposti al suo corpo cominciò ad avere sete per la qualcosa sdraiatosi a terra e levati gli occhi al cielo, pregò Dio con questa preghiera:
Signore che un giorno dalla pietra facesti sorgare ricchissime fonti, concedimi,
ti prego, che qui possa trovare l’acqua con cui ristorare il mio corpo.
Detto ciò udì una voce dal cielo:
Alzato Nicola e il masso che vedi percuoti con il tuo bastone, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ed Egli ti darà quello che chiedi.
Come udì, così fece e subito l’acqua sgorgò dal sasso, dalla quale poi i tormentati da varie malattie e dolori, bevendo diventavano sani. Allorchè Nicola giunse al monte indicatogli passò la vita con grandissima astinenza di cibo, in continua preghiera a Dio, con abbondante versamento di lacrime.
Vi è sulla cima del monte un masso, all’ombra del quale recitava le sue preghiere a Dio. meditava sulle piaghe di Gesù Cristo, nel suo dolcissimo ricordo per lo più sette volte al giorno piangeva amaramente.
Gli davano cibo le radici delle erbe e talora il pane angelico. Fu solito mangiare una volta al giorno finchè visse. Rimase in quel posto per più di trenta giorni, ignoto a tutti tranne che a pochi uomini religiosi, avvicinandosi la fine della vita incontrò due donne cheportavano delle pere al mercato e in nome di Gesù Cristo chiese loro una piccola parte di quei frutti, una di loro si rifiutò, l’altra invece fu generosa.
Egli ringraziato Dio pregò per lei. Queste donne furono testimoni della morte e della vita del B. Nicola, infatti a quella che era stata generosa i frutti abbondarono per molti giorni, ma quelli della donna avara marcirono a tal punto di non essere più adatti all’uso.
Negli ultimi giorni del mese di Agosto un contadino di nome Leone, uomo di grande bontà, mentre si recava a cercare i buoi che pascolavano nella solitudine della selva, giune la dove il B. Nicola
aveva esalato l’anima e compiuto la sua vita, lo trovò con le ginocchia piegate e le mani appoggiate al bastone e con lo sgaurdo rivolto al cielo.
L’uomo a queste vista si spaventò e si mise a gridare:
ma chi sei ?
poiché nessuna risposta gli era data si accostò al cadavere e lo toccò con la destra e subito il braccio gli si seccò. Avvertito da questo prodigio, pensava tra sé che quello fosse certo un santo uomo. Dunque in fretta corse ad Alcara,narrò all’arciprete ed ai magistrati le cose vedute con stupore di tutti. Specialmente in quell’occasione le campane di bronzo delle chiese non spinte da alcuna forza umana avevano suonato.
Perciò il clero, i magistrati e il popolo guidati dal contadino a piedi nudi andarono in processione verso il posto dove si trovava Nicola e appena giunsero là, mentre Leone voleva mostrare il corpo estinto, distese il braccio rattrappito e lo sentì sano.
In primo tempo di pensò di onorare il B. Nicola col dedicare a suo nome una chiesa nel luogo dove era stato trovato il corpo. Mentre già si portava il corpo in Alcara, lungo il tragitto bisognava passare per la la chiesa di sant’Ippolito ma, mentre passavano oltre sentirono il corpo molto pesante da non potersi muovere più oltre, allora tennero tra il loro consiglio e decisero che il santo volesse al più presto essere condotto alla predetta chiesa di sant’Ippolito.
Avendo essi fatto chiamare molti dal paese e avendo tentato se per caso potessero avanzare verso di esso, fecero invano tale tentativo.
Lo stupore fra il popolo fu molto grande e ci fu gran disparità di pareri tra i capi; questa disparità di pareri fu risolta in modo grandioso da un fanciullo che era presente e stava tra le braccia della mamma. Egli si mise a gridare:
Portate il corpo alla chiesa di S. M. del Rogato,
dove spontaneamente Nicola si farà portare.
Presso questa chiesa vi era un monastero, tenuto dai seguaci della regola di S. Basilio, uomini molto religiosi e pii.
Uno di costoro, come c’è testimonianza, Nicola lo aveva scelto durante la sua vita come confessore: costui aveva annotato per iscritto alcune notizie della sua vita. A questo grido del fanciullino, preso come un miracolo, il corpo venne sollevato e subito senza impedimento si fece portare la, dove per 336 anni, del tutto privo di corruttela quasi vivente ed integro rimase, né fu oggetto di venerazione senza miracoli.
Ma poiché nell’anno della nostra salvezza 1503, il 10 maggio, tutto quel territorio vicino a S. M. del Rogato era travagliato da grandissima penuria di piogge, il popolo supplicando e invocando per nome i santi, si diresse con grande zelo verso quella chiesa. Subito, appena fu portato fuori il corpo del B. Nicola, come già da tempo con buoni risultati si usava fare, lo posero in cima all’altare, e scese giù una grande pioggia per mirabile beneficio di Dio e di S. Nicola.
Nel qual tempo, poiché moltissimi dopo pie preghiere con reverenza e selo si diedero a baciare le sacre reliquie, avvenne che una donna malfamata osò fare la stessa cosa; ma al suo accostarsi quel santo corpo si tirò indietro e non si lascil toccare, con grande stupore di tutti.
Fatto quindi il sacrificio della S. messa poiché riportavano girando le reliquie nella chiesa di S. M. del Rogato, sulla soglia della chiesa, poiché non c’è la facevano più a stare sotto quel corpo che
era divenuto di non normale pesantezza, i portatori furono costretti a fare una sosta e ad invocare la misericordia e la pietà da Dio immortale.
Essi ricevettero come lieto evento questo miracolo: in mezzo a quel popoloconfuso vi era un certo Giovanni Spitaleri che da gran tempo era tormentato dall’ernia tanto sporgente da non poter essere sostenuta dalla fascia, ad un tratto si sentì libero da quel male e quindi si mise a gridare “Misericordia” e a divulgare la sua guarigione tra il popolo accorso per vederlo. Frattanto un altro malato di ernia tra la folla era arrivato gridando”Sono guarito”. Ecco un terso che soffriva dello stesso male dice “Anch’io sono guarito”.
Perciò tra il grande stupore e commozione del popolo, parve molto a proposito a un frate dell’ordine di S. Francesco, uomo religioso e buono, fare una predica da un posto elevato.
Di tale predica la conseguenza fu che i cittadini di Alcara con fede solenne decisero di spendere tutto quanto si doveva, fino a che il Sommo Pontefice concedesse il permesso di venerare il Sant’Uomo. Scelti per lo scopo due uomini saggi il prete Antonio Rundo e un certo Giovanni Cuttone, costoro a spece pubbliche si recarono a Roma e cominciarono a trattare l’affare con richieste in forma di supplica, ma portata la cosa per le lunghe di giorno in giorno non arrivava il termine, consumarono il denaro, pensarono di ritornarsene, e si fermarono per caso alla locande e in quel luogo essendo tristi e pensierosi furono avvicinati da un povero con abito mal ridotto.
Egli cominciò ad interrogarli per sapere chi fossero e per qual fine fossero venuti a Roma, quale fosse il motivo di tanta tristezza.
Essi gli risposero benevolmente e lui li consolò dicendo:
non state tristi o fratelli, anzi andate sicuri: sulle rive del Tevere il vostro affare è
stato portato atermine e troverete il diploma di concessione presso il tale
di cui indicava il nome.
Dopo queste parole il povero uscì dalla locanda e non si vide più.
Quelli tornarono a Roma e trovarono vere quelle cose che il pellegrino aveva detto.
Infatti fu consegnato il Diploma Papale sulla facoltà di venerare le Reliquie del B. Nicola il giorno 7 giugno 1507 dal parto della Vergine essendo Pontefice MX, Giulio II.
Frattanto la fama del B. Nicola, per il gran numero di miracoli, si diffondeva assai in quelle zone e Gemburdo, Iovanni Sciarrae, Florino moltissimi accorrevano a Lui per invocare aiuti dalla sua Santità.
Ne invocarono dopo essere guariti, sani tornavano alle loro case, avendo reso molte grazie al Santo. Questo fatto fece desiderare fortemente agli adornesi, concittadini del B. Nicola, di volere essi in casa propria e presso di sé tanto ricco tesoro piuttosto che l’avessero altri.
Ma spesso avendo cercato di portar via il feretro, li fece scoprire la campanella della chiesa di S. M. del Rogato che raddoppiava da sola il suo suono. Destati da tale segnale gli alcaresi in fitta schiera accorrevano per difendere quello che era il loro diritto. Poiché il posto che era lontano dal
Paese e fra le selve sembrava dare occasioni per quelle incursioni. Allora fu deliberato dagli alcaresi di trasferire le reliquie del santo entro l’abitato e porle in luogo sicuro. Si diede tale incarico ad otto tra i principali cittadini del paese cioà:
il prete Pietro Rosato;
Giovanni Giamburdo;
Giovanni Sciarra
Marino Fiorito
Un altro Giovanni Sciarra
e tra altri di cui non si ricordano i nomi.
Costoro in una notte tempestata e buia presero con rispetto il corpo del B. Nicola, accompagnati da una luce divina, e lo deposro in paese nella chiesa di San pantaleone, senzacchè nessuno avesse sentore di ciò che avveniva.
Vi era un tale di Bronte che posseduto dal demonio da 14 anni e già da otto il suo corpo era quasi morto e privo di animo; costui riferiva che essendo stato portato presso il B. Nicola fu liberato dallo spirito cattivo e il demonio fu messo in fuga. Questi ed altri miracoli operò il B. Nicola e ancor oggi opera. Tutti sanno e tutti devono rendere grazie a Dio. Tra l’altro non si deve passare sotto silenzio il seguente miracolo: una donna era andata con altre sue amiche in una sua villa di campagna ed aveva lasciato a riposare sul letto il piccolo figliodi nome Matteo; ma al ritorno lo aveva ritrovato morto, costernata dall’angoscia e dal lutto la povera madre implora l’aiuto del Beato Nicola: chiede al santo la vita del figlio già morto. Chiese ed ottenne infatti il figlio in seguito alla preghiera materna come se si svegliasse dal sonno cominciò a parlare e a rendere grazie a Dio e a Nicola fino alla tarda vecchiaia.
La Baronessa di Militello Valdemone, infiammata di zelo per questo Santo Uomo, in seguito alla fama di tanti miracoli si recò da Lui per venerarne le reliquie poiché ancora il suo corpo si conservava nel predetto monastero.
Lei con grande seguito, portando con se anche il figlio fanciullo, desiderava portare a casa una particella di tanto tesoro e prese un pezzettino di osso dal braccio e se ne tornava a casa con cielo limpidissimo, ma ecco il tempo si oscurò e una fittissima pioggia di grandine cominciò a colpire tutti.
Il bambinetto venne accecato da un colpo di grandine allora quelli del seguito della baronessa pensarono di placare il santo con la restituzione del pezzetto di osso.
Lei accettò di restituire questa Reliquia del braccio e chiese in cambio il risanamento dell’occhio del bambino: l’esito fu felice e miracoloso. Oggi quel colle presso cui avvenne il predetto miracolo viene chiamato “Orbetto” per la cecità del fanciullo.
Queste cose sono state scritte a gloria di Dio Onnipotente, della B. Vergine Maria e del B. Nicola.
(Traduzione a cura di Simone Ronsisvalle).
In seguito a quella vita si aggiunsero moltissimi miracoli che poi ci toccò usare quando compilammo questa storia dei fatti del B. Nicola, dalle lezioni che si solevano recitare nel suo antico ufficio.
Noi pensiamo che la vita fu scritta dal suo confessore e anche, inoltre, da un’altra vita del medesimo B. Nicola composta da autore incerto ma degno di fede, eppure quest’ultimo racconta che il B. Nicola nacque al tempo del Conte Ruggero, tuttavia non capisco bene se il Conte Ruggero fratello di Roberto il Guiscardo, o meglio Ruggero figlio di lui che dopo l’anno 1130 fu fatto Re (Ruggero II).
Poiché infatti il conte Ruggero morì nell’anno 1101, il nostro Nicola doveva essere molto avanti nell’età nel 1167, non ci sembra che l’inizio della sua vita tochi il tempo del conte Ruggero, ma dell’altro Ruggero che fu conte finchè fu innalzato alla dignità di re.
Il B. Nicola in Adernò
È un paese sul monte Etna, il
nome antico di questo paese fu Adrano secondo la testimonianza di Diodoro, di
Plutarco, di Stefano. Non correttamente hanno scritto Hadranum Plinio e Silio a
meno che non si tratti di un errore degli editori. Sulla fondazione di Adrano
Diodoro dice queste cose:
Dionisio,
sulle falde dell’Etna in Sicilia costruì un paese che si chiamò Adrano
da un
tempio famoso.
Che secondo Fazello si chiama Arcara: Paese fondato da poco vicino la città di Calapta nel lato settentrionale della Sicilia.
Il Monte Calanna
Durante la vita del Santo si chiamava così ma nelle antiche lezioni dell’ufficio si chiamava Calapnis come si vede anche in un suo inno
Apparve una nuova stella finchè quel santo pervenne al luogo,
come si dice, che si chiama Calapni”.
Ma in un’antifona greca di S. Nicola lo stesso luogo è detto Calania.
Dove è detto che per 336 anni il suo corpo durò incorrotto.
Questo numero risulta storpiato in un altro esemplare nel quale è stato scritto che il corpo di S. Nicola per 507 anni rimase nel monastero del Rogato (il che vuol dire secondo questo ultimo autore che i 507 anni si contano dal momento in cui il corpo fu depositato a S.M. del Rogato al momento in cui il corpo fu trasferito alla chiesa maggiore di Alcara), ma la mente di un altro scrittore addirittura fece uno strano volo infatti scrisse che l’anno in cui agli alcaresi fu concesso di venerare le reliquie di S. Nicola (è ancora un altro) pertanto se i 336 anni comincia a contarli dall’anno 1503 nel quale anno il corpo del B. Nicola fu esposto sull’altare per ottenere la pioggia, troverai che egli morì nell’anno 1167 sotto il regno di Guglielmo il Buono.
…………………….
Orazione in greco rivolta a San Nicolò, riportata nella parte finale del manoscritto consegnato dagli Alcaresi al Caetani.
Un documento importante, che sarebbe importante recuperare considerando che disponiamo, grazie alle ricerche del Sac. Petronio Russo, delle indicazioni esatte sul luogo in cui presumibilmente trovarlo.
Il sacerdote adranita, nel 1873, cercando i documenti del Caetani in casa di questi, a Palermo, finì per trovarli nell’armadio A12 della Libreria del Collegio Massimo dei Gesuiti di Palermo, detto, ai suoi tempi, Collegio Nazionale.
All’inizio del manoscritto, Petronio Russo, riscontrò il seguente promemoria:
La vita del Beato Nicolò, mandata dalla terra di Alcara e da
restituire al padre Nicola Faranda.
Dopo una lunga intestazione che contiene notizie indicazioni più dettagliate su san Nicolò e su Alcara, segue quella narrazione della vita che si è riscontrato nel Documento N. 4.
Vi è un periodo, nota il Petronio, che il Caetani trascurò di riportare, in cui si accenna come
Essa è la seguente
O Nicola, cittadino adranita, che in Catania fosti gradito a Dio,
e abitando al Calanna inuna plaga montuosa, mirabilmente,
compisti la tua vita ascetica, operando molti miracoli:
anche ora onorato nella città dei Politi;
nel Monastero della Santissima Madre di Dio, prega per le anime nostre.
Questa preghiera è importantissima perché potrebbe essere un frammento dell’antico ufficio greco di san Nicolò, che il caetani utilizzò per attingere delle notizie inerenti alla vita ed ai miracoli dei Politi.
Un ufficiatura, che ritrovata, sarebbe la fonte più autorevole sulla vita del Santo Eremita. Sarebbe il documento più antico ed autorevole sulla vita di San Nicolò ed anche sul suo culto, visto che l’inno del Cusmano si possiede in traduzione italiano – latino.
Sempre il Caetani, nelle “Animadversiones in Vitam Sancti Nicolai Eremitae” (documento n. 4), nel punto in cui descrisse la giusta accezzione della parola “Calanna”, nel ribadire di aver letto nell’Ufficiatura Greca del Santo, accenna ad un’antifona greca che potrebbe essere quella su affermata.
I documenti sul Santo sono numerosi ed antichi e dovrebbe essere un motivo d’orgoglio siciliano cercare di recuperarli per arricchire la storia su un culto di un Santo Patrono Siculo.
18. la “Koimesis”
nell’Arte
proclamare il dogma secondo cui la Vergine fu
Assunta nella gloria celeste in anima e corpo
L’aspetto finale della vita delle Vergine non fu riportato nei testi ufficiali del Nuovo Testamento in cui dopo la “Pentecoste” sparisce dalla narrazione.
La figura di Maria risalta in modo particolare nella forte credenza popolare visto che la maggior parte dei credenti vedevano e vedono nella Vergine una reale figura materna.
La sua assenza nei testi fu colmata dalla stesura del “Transitus Virginis” attribuito a Leucio un discepolo di San Giovanni.
In questo scritto si rilevarono gli ultimi attimi di vita della Madonna
Nostro Signore Gesù Cristo decise di avere per sempre accanto a sé sua madre 4
E la Vergine, pur felice di ricongiungersi con il figlio
espresse il
“desiderio di rivedere gli apostoli”.
I quali, quasi volando raggiunsero la Vergine e aspettarono con Lei
fino al momento in cui Dio la richiamò a sé con anima e corpo.
La riflessione teologica sulla morte della Vergine sarebbe da collocare tra il IV – V secolo e per avere una rappresentazione artistica dell’argomento si deve aspettare il X secolo soprattutto per la sfera culturale bizantina per poi diventare un importante soggetto di numerose e pregevoli rappresentazioni artistiche.
Un argomento iconografico che fu successivamente copiato e adattato dagli artisti del mondo occidentale.
L’interesse per l’arte bizantina del X secolo non fu solo una moda e numerose furono le opere che presentarono un equilibrio artistico tra lo stile bizantino – orientale e quello occidentale.
La “Koimesis” fu fissata nella sua immobilità, grazie ad una composizione di figure e simboli che si affermarono nel corso dei secoli. Un momento divino ed umano interprete di numerose icone, tipiche raffigurazioni sacre utili per trasportare la figura rappresentata nel disegno all’idea che essa celava.
In tutte le raffigurazioni della Vergine la figura della Madonna è posta orizzontalmente nella seconda metà inferiore dell’icona in modo da evidenziare la sua componente umana e in collegamento con gli Apostoli, posti ai lati del letto in cui la Vergine è sdraiata.
La figura del Cristo è invece collocata al centro della composizione e rispetto alla figura materna crea una linea immaginaria verticale che collega l’umanità di Maria a quella divina nel Regno dei Cieli. Ci sono degli elementi che unirono le produzioni nonostante la naturale diversità stilistica degli artisti e del periodo in cui furono eseguite.
Maria è coricata su di un letto posto al centro della composizione. Ha gli occhi chiusi e il viso rilassato nel sonno di una morte che non potrà nulla sulle sue spoglie mortali. Il figlio Gesù Cristo è infatti accanto alla Madre e tiene in braccio un piccolo bambino/a stretto da fasce di tessuto bianco, rappresentazione simbolica dell’anima pura e senza peccato della stessa Vergine.
Gli Apostoli sono raccolti attorno a lei. Di particolare interesse sono due figure (probabilmente San Pietro e San Paolo) chinati sul letto della Madonna, in atto di cordoglio. Al di sopra della figura di Cristo vi sono degli Angeli che, oltre ad aver raccolto nel luogo del lutto i discepoli del Signore, porteranno poi anche l’anima e il corpo della Madre di Dio nell’alto dei Cieli.
Questa iconografia fu presa come modello, spesso riattata, a partire dai “lezionari bizantini del X secolo” e fu assunta nell’espressione artistica occidentale diventando il soggetto di
Di grande valore è una “Koemesis” incisa su tavola d’avorio risalente al tardo secolo X.
Icona del X secolo
Le vesti ed i drappeggi del letto, nonostante la staticità dell’immagine, sono molto accurati. San Pietro si trova alle spalle della Madonna mentre San Paolo, posto ai piedi di Maria, è cristallizzato in una dimostrazione composta di dolore.
Gli altri discepoli sono posti ai lati del letto ed evidenziano il loro cordoglio. Le figure poste tra i discepoli, la prima in alto a destra e la seconda in alto a sinistra, si coprono il volto con una mano per sottolineare l’imbarazzo della fragilità umana in contrasto con la serenità divina.
Cristo al centro della figura guarda la Madre mentre affida la piccola anima di Maria agli Angeli che fanno parte della veglia funebre.
Il tutto è inquadrato da una struttura elaborata come a sottolineare la memoria dei fedeli.
La seconda immagine è anch’essa un opera in avorio e risalirebbe all’XI secolo.
Dormitio Virginis
– XI secolo – Museo Hermitage
.La Vergine è assopita mentre l’apostolo Pietro è rappresentato vicino al volto di Maria come se stesse ascoltando le sue ultime e profonde parole. Gli altri discepoli sono invece ai lati della Madonna.
Un personaggio in primo piano a sinistra rispetto agli altri, scuote un turibolo mentre San Paolo è raffigurato nell’atto di abbracciare (o meglio di aggrapparsi ai piedi della Vergine) come a non volersi staccare da Lei. Un grande dolore per Paolo immerso nel piacevole ricordo della Madonna.
Anche in questo caso il Cristo è sempre al centro della scena ed anche in questa raffigurazione tiene in braccio l’anima della Madre.
A differenza dell’opera precedente anche l’Angelo posto a destra della raffigurazione tiene Maria tra le braccia mentre la porta in cielo.
Non si tratta di un errore stilistico ma la volontà dell’autore sconosciuto fu probabilmente quello di rappresentare due momenti successivi per suggerire all’osservatore quale sarebbe stato il destino di Maria. La terza raffigurazione, sempre in avorio, si trovava su un lato del cofanetto di Farfa.
In questo cofanetto fu rappresentata la “Koimesis”, espressione tecnica di una
“bottega… nella seconda metà dell’XI secolo”
Cofanetto-
Farfa; Dormitio Virginis
La storia del cofanetto è affascinante.
Fu
commissionato da un ricco mercante di nome Mauro
Discendente della stirpe amalfitana del Contes Maurones
La
rappresentazione presenta numerosi contatti stilistici con le raffigurazioni
Orientali e quindi con l’arte bizantina.
La
composizione è più semplificata rispetto alle precedenti ma il suo importante
significato non cambia. Le figure sono appena abbozzate nell’avorio come se
fossero solo tracciate.
Gli
Apostoli che circondano la Vergine sono rigidi nelle loro posizioni e il loro
dolore sembra essere rinchiuso all’interno della pietra. La figura sulla
sinistra, come nell’immagine precedente, ha un turibolo in mano, ma
stilisticamente è molto diversa. Infatti, sebbene nell’opera già citata manchi
una vera prospettiva, il modo in cui l’uomo viene rappresentato è molto fedele
alla realtà, mentre quello che si può osservare sul cofanetto di Farfa
trascende quasi la sfera fisica per assumere un significato maggiormente
simbolico: è un uomo che piange al cospetto della morte contro cui nulla può.
Nello schema
compositivo, la figura di Gesù Cristo ha subito una modifica nel modo con cui
viene solitamente rappresentato. Egli, infatti, pur rimanendo in posizione
centrale rispetto all’insieme di figure, è raffigurato mentre affida l’anima
della Madre ad un Angelo.
Un’altra
opera importante è il rilievo in stucco raffigurante la dormizione della
Vergine presso la cripta della basilica di San Pietro al Monte, in provincia di
Lecco.
Dormizione a
Civate
L’opera,
risalente probabilmente dell’ XI secolo circa, mostra due figure poste nella
parte sinistra della composizione. Le due figure sono rovinate e questo rende
molto difficile la loro identificazione.
La composizione, probabilmente a causa del poco spazio, appare molto
condensata, creando quasi un collegamento continuo tra tutte le figure.
Evidente è la mancanza di profondità nella rappresentazione del letto della
Vergine la quale, a differenza delle raffigurazioni precedenti, è avvolta in
quello che pare essere un sudario. Cristo, diversamente dalle immagini finora
analizzate, è raffigurato ai piedi del giaciglio della Madre mentre sorregge un
testo sacro con il braccio sinistro e la benedice con la mano destra. Questo
cambio di posizione suggerisce uno spostamento del punto focale dell’opera che
cade, in questo caso, sul corpo di Maria e rende l’insieme degli altri
personaggi una sorta di cornice.
Gli Apostoli che circondano la Madonna sono rigidi nella loro espressività,
dando all’osservatore la sensazione di trovarsi davanti all’immobilità dello
scorrere del tempo. Le vesti dei personaggi sono elaborate, ma al contempo non
trasmettono un senso di movimento.
Interessante da notare è anche la città rappresentata in alto a sinistra,
elemento che nelle altre rappresentazioni era assente. Secondo il racconto
tramandato dai testi apocrifi, nelle icone della «Koimesis»
apparivano due luoghi che videro la presenza della Vergine durante i suoi
ultimi momenti di vita terrena. Uno è Sion, nome poetico che si riferisce alla
città di Gerusalemme e l’altro è il Getsemani, un uliveto fuori dalla Città
Santa. In questa rappresentazione è possibile identificare Sion per degli
edifici che caratterizzavano la città.
Le opere che hanno come soggetto la morte della Vergine, però, non si sono
limitate ad avori o bassorilievi, ma sono state ampiamente trattate anche in
pittura e nei mosaici.
Acaya (Lecce) -
Dormitio Virginis Mariae - sec XII-XIII
L’affresco
si trova in una piccola chiesa bizantina rinvenuta nel lato nord dell’antico
maniero. Questa opera è forse la più antica rappresentazione della «Koimesis» che si può osservare ora in Italia ed è
databile nella seconda metà del Trecento.
Da un punto di vista compositivo, è possibile dividere il dipinto in due parti:
nella sezione inferiore Maria è posta al centro della scena, attorniata dagli
Apostoli. La Vergine, al contrario delle opere precedentemente analizzate, non
giace su di un letto bensì su una barella portata a spalla da due discepoli di
Cristo, probabilmente San Pietro (a destra) e San Paolo (a sinistra). In questo
affresco è difficile riconoscere le particolarità dei volti in quanto il tempo
ha deteriorato il colore e i tratti. Nonostante questo, se si osserva
attentamente la Vergine, è possibile notarne la calma e la compostezza dal modo
con cui tiene piegate le braccia in tacita preghiera. Gli altri Apostoli sono
disposti attorno alla processione funebre, ma i loro gesti sono rappresentati
in maniera statica. Nell’affresco, infatti, vi è un’assenza di prospettiva
tanto che Maria è posta sulla lettiga come se l’osservatore la stesse guardando
dall’alto. Sotto di essa vi è un ulteriore quadro, come a voler fare coesistere
insieme più momenti legati alla morte della Vergine. Nel testo apocrifo di
Giovanni, è possibile trovare il racconto secondo cui, durante la sepoltura
della Madonna, il sacerdote giudeo Iefonia cercò di profanare il feretro,
facendolo cadere a terra, ma un Angelo (molto probabilmente Michele) con una
spada di fuoco gli mozzò le mani.
Cristo, a differenza delle precedenti rappresentazioni, non è più accanto al
letto della madre, ma è raffigurato dentro la mandorla («vescica piscis») tenuta sollevata da due Angeli,
mentre sorregge tra le braccia l’anima di Maria, mostrandola agli osservatori
come monito di fede e speranza.
La forma
artistica più usata per rappresentare queste scene sacre è sicuramente il
mosaico, genere artistico di «monopolio bizantino», tanto a livello di
materiale quanto di specialisti.
Un esempio significativo a tal proposito è sicuramente la dormizione della
Vergine raffigurata nella volta del braccio occidentale della croce greca della
chiesa S. Maria dell’Ammiragliato – detta della Martorana - a Palermo.
Mosaici bizantini
con la rappresentazione della natività e la morte della Vergine.
Particolare
della Koimesis – Chiesa della Martorana -Palermo
Nell’opera
si nota innanzitutto lo sfondo oro. Tale espediente artistico è tipico delle
rappresentazioni
sacre di ambito bizantino e serviva a sottrarre la scena dal
flusso del tempo per affidarla ad una dimensione eterna e atemporale. Inoltre
questo colore è simbolo della divinità e per questo motivo non era presente
nelle vesti degli Apostoli e delle donne in quanto «semplici» esseri umani.
Maria è distesa sul letto con le mani allacciate al petto e un’espressione
serena, quasi sorridente. In questo mosaico si vede una costruzione della scena
con particolari attenzioni rivolte ai tessuti delle vesti e del letto su cui
giace la Madonna e si notano anche dettagli che nelle altre opere non si erano
visti. Ad esempio, sulla veste di Maria ci sono le tre stelle che, oltre a
testimoniare il dogma della verginità, sottolineano anche l’attenzione e la
perizia con cui l’artista ha lavorato.
Attorno a lei sono rappresentati gli Apostoli. Come nelle opere precedenti, San
Pietro è chinato sulla Vergine in attesa quasi di carpire le sue ultime volontà
prima che lei salga nell’alto dei cieli, mentre San Paolo è raffigurato ai
piedi della Madonna nell’atto ultimo di abbracciarle le gambe. E’ toccante
osservare come l’artista sia riuscito a immortalare la tristezza dell’ultimo
addio sul viso dell’Apostolo che, totalmente abbandonato in questa stretta,
sembra essere un uomo qualunque schiacciato da un incolmabile dolore. In questo
mosaico sono stati raffigurati anche altri personaggi quali i quattro vescovi
ricordati nell’opera «De Divinis Nominibus» dello Pseudo Dionigi Areopagita e alcune
donne che hanno vissuto con Maria gli ultimi tempi della sua vita.
Gesù Cristo, a differenza del rilievo in stucco presso la basilica di San
Pietro al Monte, è rappresentato in posizione centrale, accanto alla madre.
Egli le rivolge uno sguardo amorevole mentre porge l’anima all’Angelo Michele
che la trasporterà in paradiso. La veste di Cristo è blu e oro, mentre di
solito è blu e rossa. A livello simbolico, questi colori significano
rispettivamente il passaggio della creatura verso il divino, scevra della sua
carnalità (blu) e l’amore per il divino (rosso). Per l’assenza di prospettiva,
gli edifici posti dietro Maria, Cristo e gli Apostoli si presentano quasi senza
spessore e con una percezione di grandezza sfalsata. Le donne in alto a destra,
infatti, appaiono grandi quasi quanto la torre presente sulla sinistra del
mosaico.
19. Alcara Li Fusi (Cenni di Storia)
Nell’età del bronzo lungo a costa della Sicilia, secondo la tesi di alcuni storici fra cui Domenico Ryolo, erano presenti delle comunità di Sicani organizzate a piccoli gruppi capannicoli.
(Milazzo, Tindari San Biagio, Scodonì a Terranova, Monte Scurzi a Militello Rosmarino, San Teodoro ad Acquedolci e ai piedi del Monte della Madonna a Capo D’Orlando).
Tra il 1200 ed il 1000 a.C. (tra il finire dell’Età del Bronzo e l’inizio dell’Età del Ferro) ci fu l’invasione della tradizione diodorea. Gli indigeni che abitavano quei luoghi non accettarono il regime di sottomissione nei confronti del popolo invasore e si ritirarono nell’entroterra nei siti ontani ove era più facile difendersi.
Un nuovo aspetto culturale arricchì l’esperienza di vita degli indigeni. Capirono che era fondamentale per difendersi, fare delle comunità estese e nacquero i centri urbani costituiti da etnie e residenti.
È probabile che Alcara Li Fusi abbia avuto questa origine e legata, secondo il racconto mitologico, allo stesso fondatore della vicina città di San Marco D’Alunzio evocandone nella denominazione la patria.
Alcara Li Fusi e San Marco D’Alunzio sarebbero legate a quindi alla figura di “Patron”, nativo di “Thurios”, del quale si conoscono solo delle scarse notizie legate ai racconti di Dionigi d’Alicarnasso, e riprese da Virgilio nell’Eneide.
La flotta di Enea, fuggiasco dopo la distruzione di Troia, si trovava a navigare tra le isole di Eolo (Eolie) ed il sacro monte di ‘Aλοντιον” sui Nebrodi. Tra i compagni di viaggio di Enea c’era “Patron” che rimase affascinato dalla bellezza dei luoghi lussureggianti. Patron decise quindi di fermarsi nel sito insieme a qualche altro compagno di viaggio.
Questo sarebbe il racconto mitologico e nell’Eneide di Virgilio gli avvenimenti furono descritti nel seguente modo:
“ A Butroto, Enea si separò dal padre Anchise,
per avventurarsi all’interno del territorio sino a Dodòna, ve
si prometteva d’interrogare l’oracolo. Tornato indietro e riunitosi
con il padre, partì con una flotta alla volta d Onchesmo.
In questa località, i Troiani arruolarono il nocchiero-pilota Patron,
la cui perizia di navigatore consentì loro di attraversare indenni e celermente
il canale di Otranto.
(Butroto, sarebbe l’odierna Butrinto;
Dodòna è una città dell’Epiro famosa per l’oracolo di Giove che rispondeva
alle domande per mezzo delle vibrazioni delle foglie).
Virgilio, rispetto a Dionigi di Alicarnasso, aggiunse una notizia di grande importanza.
Patron era di nazionalità acarnana ( dell’Acarnania - ‘Akαρνανια – regione storica della Grecia che con l’Etolia costituiva un νομοs molto importante). Questa notizia escluderebbe quindi Patron come compagno di viaggio di Enea scampato all’incendio e distruzione di Troia.
La tradizione ad Alcara cita la fondazione del entro da parte di Patron. In merito, grazie al supporto delle fonti letterarie, la prima denominazione del centro fu proprio di Castel Turiano. Un segnale che fa capire come la comunità alcarese abbia voluto dare omaggio al suo fondatore Patron. Nel centro sono presenti i ruderi, molto suggestivi, di cuna fortificazione che fu chiamata castello Turiano.
Il Surdi riferì di aver visto un’iscrizione in lingua greca, su un materiale lapideo scolpito secondo la foggia di una pergamena arrotolata, che riportava:
“ερνμα προ του ταυριαυου επειτα ακαρετ, νυν αλκαρια”,
La guerra tra Achei e Troiani fu collocata (con naturale approssimazione) intorno al 1250 a.C. o, secondo altre fonti, tra il 1194 -1184 a.C.
Con questi riferimenti cronologici si potrebbe quindi affermare che Enea, insieme al nocchiero ingaggiato Patron, si trovasse a transitare con le sue navi nel tratto di mare antistante la catena montuosa dei Nebrodi e le isole Eolie (del mitico Eolo).
C’è da aggiungere che il nucleo antico di San Marco d’Alunzio (città fondata da Patron) risalirebbe ad un periodo compreso tra i secoli XII . XI a.C.
Il periodo di fondazione della stessa Alcara (come già citato, “Castel Turiano”) e di San Marco d’Alunzio quindi coinciderebbero.
Un ipotesi valida ?
Il toponimo di “Castel Turiano” fu mutato nell’anno 903, quando la nuova dominazione Araba, riuscì ad espugnar il luogo con l’occupazione delle città di Demenna (sulle Rocche del Castro dove era presente una fortificazione mentre la citta dove trovarsi poco a Nord dell’odierna Alcara ?) e di Turiano.
Il novo nome arabo dato al luogo fu quello di “Alcara” la cui semantica sembrerebbe fare riferimento e derivare sia dalla lingua greca che da quella araba.
In arabo sarebbe “al – Qarah” cioè “vicolo, quartiere fortificato”.
In greco sarebbe “αλκαρ” – “difesa, presidio, riparo” o “αλκη‘ – “valore, forza difensiva”.
Nel 1082 in epoca Normanna, il centro era chiamato “Alacres, Castellum Alcariae, Alkares”.
Nel 1812 “Alcara De Fusi” e successivamente “Delli Fusi” e infine “Li Fusi”.
I termine “Fusi” faceva riferimento alla fiorente attività artigianale legato all’uso del fuso, utensile conosciuto da tempi antichissimi in tutto il bacino del Mediterraneo, usato, in complementarità con la rocca, per la filiatura della lana greggia, del cotone e della canapa.
Una fiorente attività artigianale che ancora oggi vede impegnata delle maestranze locali, soprattutto femminili, che danno origine a pregiati manufatti tessili ricercati in goni parte dell’isola ed anche all’estero.
Alcara Li Fusi è anche famosa per la “a festa du muzuni”, di origine pagana, e che fu assorbita dal culto cristiano con una interpretazione originale ed al di fuori dagli schemi antichi del rito:
Omaggio alla Grande Madre nel Solstizio d’Estate
“Alcara Li Fusi compare nella storia della Sicilia con questa identità rituale, che nasconde all’uomo parte della sua genesi e provenienza, essendosi formata in epoche remote, figlia di una civiltà protostorica che affonda le sue radici nella tradizione umana di questo lembo di terra. Quel che ci arriva oggi è l’immagine rituale di una gens agricola, cresciuta nell’alternarsi del ciclo delle stagioni e che da esse traeva quella religiosità che ritroviamo oggi, tale e quale, nell’essenza del rito del “muzzuni”. Percorso spirituale che si contamina nel corso dei secoli solo nell’aspetto esteriore della mutazione del simbolo, mantenendo celato nel profondo la maternità della generazione”.
20. La Grotta
del Lauro
Un grotta ce presenta al suo interno innumerevole stalattiti, stalagmiti e colonne dalla forme più varie.
È anche presente una particolare tipo di concrezione mammellonare formata da più strati di calcite che è trasparente al suo interno.
La grotta s sviluppa nella roccia delle Rocche del Castro per una profondità notevole. L’impresso è molto ampio e a molti metri dal suolo. Si accede ad una prima caverna dalle dimensioni irregolari contraddistinta da una volta altissima ricca di stalattiti dalle strane forme. Da questa caverna si scende attraverso un percorso arricchito da stalattiti, stalagmiti , colonne e concrezioni di grande interesse geologico. Si giunge ad una seconda caverna, di notevoli dimensioni, anche ricca di suggestive formazioni colonnari stalagmtiche. Da questa seconda caverna iniziano una serie di cunicoli che procedendo a notevoli profondità, permettono di raggiungere altre caverne, alcune delle quali sono molto ampie.
Oltre che da un punto di vista geospeleologico la grotta del Lauro è interessante per la presenza in essa di due esemplari di “troglobie” di invertebrati miriapodi di alto interesse biologico che costituiscono un endemismo tipico ed unico della grotta: Entotalassinum Nebrodium e Beroniscus Marcelii.
Per visitare la grotta bisogna farne richiesta al Comune oppure all'Associazione Video Nature, in quanto l'accesso è sbarrato da un cancello che ne protegge le bellezze in essa contenute.
https://www.vivoinsicilia.it/grotta-del-lauo-il-viaggio-nelle-profondita-delle-rocce/
https://www.vivoinsicilia.it/grotta-del-lauro-il-viaggio-nelle-profondita-delle-rocce/
https://www.vivoinsicilia.it/grotta-del-lauro-il-viaggio-nelle-profondita-delle-rocce/
21. Borgo Stella
I “pagghiara” hanno una pianta circolare con un ingresso architravato e una copertura conica costituita da pali e rami di ginestra. Erano utilizzati come depositi di paglia e per il ricovero degli animali.
I casolari dei pastori hanno una pianta rettangolare e messi in opera con pietra squadrata. Generalmente costituiti da un unico ambiente e coperti da una travatura di pali e coppi siciliani.
...................................
22. Video
https://www.youtube.com/watch?v=c9k-_rC6i4U
https://www.youtube.com/watch?v=iLgptwP7Mho
https://www.youtube.com/watch?v=89x2vKWY3dY
.......................





























































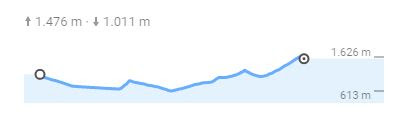











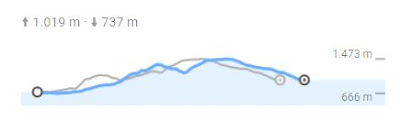








































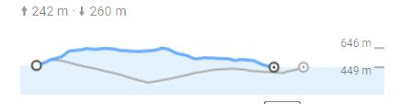











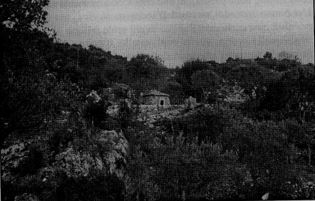






































































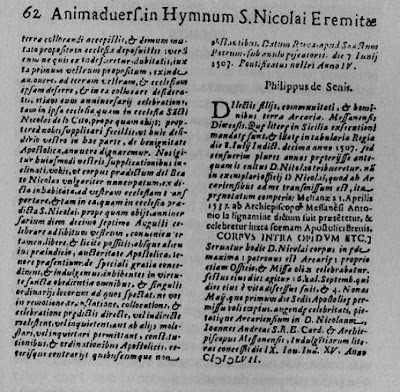

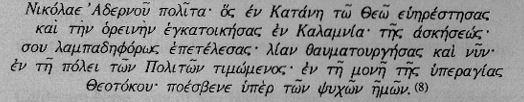




























Commenti
Posta un commento