La triste storia dell’etera Laide di Hykkara – La Prostituzione Sacra – Le divinità: da Inanna all’eroina Afrotide (?) - Un Piccolo viaggio anche ad Erice e Pantelleria. Enciclopedia delle Donne: X Parte
.........................Indice1.
Laide di Hykkara;2.
La Prostituzione Sacra –
i Templi – I CulitiSicca Veneria (Tunisia)Abido, governata da eterePyrgiLocri Epizefiri – I Reperti – Trono LudoviciPantelleria – Il santuario Tanit/Venere – Alcuni Aspetti
Naturalistici Unici tra cui gli StromatolitiEriceAbruzzo: Rapino , la “Tavola di Rapino” – La Dea di Rapino e
la Gemma di giovedì GraviscaPyrgi - Le LamineRoma: Festa delle Nonae Caprotine – La Bona Dea e le leggende
– Claudia Quinta, la vestale e l’altare a lei dedicato – Il culto della Bona
Dea – L’oltraggio di Publio Codio Pulco, amante di Pompea, moglie di Giulio
Cesare;Acca LaurentiaAfrotide, dea della bellezza e dell’Amore... Da Inanna..Ishtar,
Astarte..Atargatis ad Afrotide, un eroina ?Enheduana.. la prime scrittrice, del 2400 a.C., per i suoi
unni ad Inanna ...............................................................
La missione fu affidata ad Alcibiade, Nicia e Lamaco anche se il primo, dopo i primi scontri, fu richiamato in patria per rispondere alle accuse di eresia per aver profanato le Erme di Atene prima della sua partenza.
Gli ateniesi posero la loro base militare a Catania e si spostarono verso Segesta costeggiando con le navi tutta la costa tirrenica.
Si fermarono ad Himera, ma non furono ricevuti dato che la città era un alleata di Siracusa, e conquistarono Hykkara, nemica di Segesta, schiavizzando uomini e donne, tra cui l’etera Laide.
1.
Laide di Hykkara
Hykkara sarebbe
una città dei Sicani posta nella Sicilia Occidentale.
Una leggenda
riportata da Tucidide citò come Cocalo, figlio
del
ciclope Briareo e
re dei Sicani, ordinò la costruzione di una nuova città
fortificata che
doveva contrastare la vicina Segesta, città degli Elimi.
La costruzione fu
affidata a Dedalo che scelse la località,
fra Segesta e Panormos,
a cui diede il nome di Hykkara per ricordare il
figlio Icaro.
Secondo lo storico Timeo di Tauromenio il nome sarebbe da
collegare alla
presenza di un pesce molto diffuso nella zona che è
chiamato “Hykas o
Ikkaron” (l’Orata ?). La zona più pescosa del pesce citato si trovava
tra Capo Gallo e Carini e cioè vicino all’ Isola
delle Femmine,
in quello stretto
passaggio tra l’isolotto e la terra ferma.
Isola delle
Femmine
(a sinistra si
nota la Punta di Capo Gallo)
La città secondo
alcuni storici sarebbe stata invece fondata tra Isola delle
Femmine e Carini
ed uno dei villaggi si trovava probabilmente nel territorio
di Isola delle
Femmine. Tutta la zona è ricca di testimonianze archeologiche tra cui
Monte Colubrina,
Contrada Rosa, dove sono presenti resti
di strutture
murarie e frammenti di ceramica di varia epoca (dal IV al III) sec.a.C., individuabili
su vasto raggio, lungo le pendici occidentale del monte.
Tra
gli uomini e le donne di Hykkara catturati per essere schiavizzati, c’era una
bambina di sette anni, Laide (Λαίς, Láis) (Hykkara, 420
circa – Tessaglia, 340 circa).
La
bambina fu presa da un soldato di Nicia, un certo Poliknio, e venduta come
prostituta sacra nel tempio di Afrotide a Corinto.
Corinto – Resti
del Tempio di Afrotide
La
sua bellezza diventò così famosa che il pittore Apelle ne volle fare un’etera.Le
etère dell’antica Grecia erano cortigiane che instauravano con i clienti delle
lunghe relazioni. Erano spesso delle ex schiave molto colte che rispetto alle donne comuni ottenevano una maggiore
libertà perché potevano uscire liberamente, gestire i propri averi, partecipare
alla vita pubblica e ai simposi maschili.Queste
prerogative davano alle etere la possibilità d’esercitare una certa influenza sugli uomini (spesso politici ed anche
artisti) che frequentavano. Apelle s’invaghì della bellezza e intelligenza di
Laide e la iniziò alle arti della danza, musica e poesia e la raffigurò in
molte sue opere paragonandola a Venere.Altri
famosi pittori delle Grecia presero Laide come modella e la sua casa fu
frequentata da personaggi illustri del suo tempo come Aristippo, Demostene, Euripide.
Plinio la citò per alcuni scritti poetici da lei composti.Aulo
Gellio raccontò in “Notti Antiche” che Aristippo di Cirene scrisse per lei uno
dei suoi dialoghi. Si narra anche che Euripide, prima di pubblicare le sue
tragedie, chiedesse a Laide la sua approvazione. Demostene, il noto oratore, la
rifiutò dopo averla a lungodesiderata
perché gli sembrò troppo cara la richiesta che Laide gli fece... 10
Filippi o 10.000 dracme, per la sua
compagnia.Sembra
che Demostene abbia commentato..Io non compro così
caro un pentimento.Si
racconta anche che un re persiano s’invaghì di lei.I
nove vassalli dell’imperatore di Persia quando la videro rimasero incantati e misero ai suoi piedi le loro nove corone dicendole che
sarebbero stati i suoi schiavi e che avrebbero sempre ubbidito.
Ma Afrodite non poteva tollerare una bellezza che
potesse reggerle il confronto e mandò suo figlio Eros a colpirla con le sue
frecce fatate.
Laide,
in età matura, s’innamorò di Ippoloco, un giovane della Tessaglia. Lo seguì
nel
suo paese, non lo sposò e scelse una convivenza stabile con una
relazione d’amore duratura e profonda.
s’interessarono
a lei. E così la vita di Laide s’avviò per una triste fine.
Strano
destino quello delle donne nell’antica Grecia dove per essere libere, come le
etere, si dovevano sottoporre alla tutela di uno o più uomini. Le donne sposate
non
perdevano
l’onore e la dignità sociale, ma erano schiave vendute a un solo uomo e ad una società che non concedeva loro di
essere libere, di partecipare alla vita sociale, di avere cultura... insomma
inferiori in tutto e per tutto ma salve nell’onore.
Una
donna come Laide che svolgeva una vita con molteplici interessi culturali ed autonoma,
perdeva invece la dignità sociale vendendosi alla tutela degli uomini senza
i
quali non avrebbe mai potuto agire in quel modo. Tristi destini che sembrano
contrapposti e che venivano riservati alle donne che per questo diventavano
spesso nemiche tra di loro per difendere un briciolo “d’onore” tristemente ottenuto.
Ma
quale fu la triste fine di Laide?
Come
abbiamo visto in Tessaglia subì le
attenzioni degli uomini e questo provocò
l’ira
delle donne che l’uccisero a colpi di sgabello ( o di ex voto) durante un rito
femminile in onore di Venere. In questo rito gli uomini non potevano
partecipare perché l’avrebbero sicuramente difesa.
Fu
seppellita sulle rive del fiume Peneo dove fu eretta la sua tomba.
Fiume Peneo
La
città di Corinto, non avendo le spoglie di Leida, fece costruire sul Monte
Kranion,vicino
al tempio di Venere, un monumento in suo onore dallo scultore Turno. Un
monumento che fu descritto da Pausania..”una leonessa che
afferra o tiene con le zampe un ariete...”
Il sepolcro di Laide diventò durante il regno di
Adriano (117 – 138), tema d’incisione nelle monete corinzie. Una di queste
monete destò l’interesse dell’Eckel (1839) e si trova negli archivi di
Numismatik Lanz Munchen.
Corinto – Lais o Laide la cortigiana
Dritto: testa di Afrotide
Retro: Tomba, Monumento in onore di Laide
capitello dorico con ariete sdraiato sotto una leonessa.
La storia di Laide non finì con la sua morte.
Si narra come la Tessaglia fu punita dalla dea Venere
con una pestilenza a causa
dell’uccisione di Laida. Le donne che uccisero Laida
erano una quarantina e il suo compagno di vita Ippoloco si rivolse alla dea
della vendetta Nemesi che gli donò , in
cambio dei suoi servigi, forza ed abilità. Ippoloco
uccise tutte le donne responsabili dell’assassinio e non solo, ma anche i
mariti e i figli.
Ancora oggi il nome Ippoloco in quella zona della
Grecia viene pronunciato con timore.
Altri riferimenti
furono di Ateneo che citò il compagno di Laide con il nome di Pausania e
non di Ippolico:“ famosa cittadina della città dei Sicani Hycara fu
l’etera Laide... Timeo, a fugar ogni dubbio, nel tredicesimo libro delle sue
“Storie” asserisce che essa era di Iccara, in ciò concordando con Polemone, il
quale riferisce che essa venne uccisa da alcune donne in Tessaglia; essa s’era
innamorata di un Tessalo di nome Pausania, e per invidia e gelosia venne
colpita a morte con zoccoli di legno in un tempio di Afrotide. Dopo ciò, egli
continua, il luogo venne rinominato dell’Afrotide Assassina ....La sua tomba si
vede oltre il fiume Pencio, sopra ha una brocca per l’acqua, in pietra e reca
il seguente epigramma....Era il tempo nel quale l’orgogliosa Grecia, dal potere invincibile,venne resa schiava dalla divina bellezza di laide, la quale è qui, laquale Eros generò e Corinto nutrì;giace essa, adesso, nelle gloriosa pianure della TessagliaPer quanto detto, coloro, che dicono che essa venne
cremata accanto il boschetto corniolo, s’inventarono la notizia” (Ateneo, 589).
La tradizione riporta come Laide sia stata modella del
famoso pittore dell’antichità Apelle.
Alcune fonti citarono l’artista come vissuto nel IV
secolo a.C. mentre altri attribuiscono una data di nascita e di morte:
Apelle (Ἀπελλῆς, Apellês )
(Colofone,
375 – 370 a.C. – Coo, fine IV secolo a.C.).
Un artista che fu definito da Plinio il Vecchio “superiore
agli artisti precedenti e successivi”.
Anche l’Ariosto, nell’”Orlando Furioso” citò Apelle
Tutto trapunto con
figure belle, più che mai con pennel facesse Apelle
Accettando la nascita di Laida nel 420 a.C. ci
sarebbero almeno vent’anni di differenza tra il pittore e la donna
(considerando Apelle nato nel 400 a.C.) e
ben quarantacinque anni basandosi sulla nascita del pittore riportata da
alcuni fonti nel 375 a.C. circa.
È probabile come il pittore abbia conosciuto Laide nella
sua età matura e fu in ogni caso conquistato dal fascino che la donna, anche se
in età avanzata, mostrava e dalla sua intelligenza.
Una donna che s’allontanava dal tipico modello sociale
femminile e il pittore la immortalò in
alcuni dipinti. Un artista dotato di grande abilità nel disegno sia nel colore
che nella luce.
Adoperava solo i quattro colori fondamentali riuscendo
a trarre molteplici effetti coloristici. Eseguì molti quadri con raffigurazioni
mitologiche e personaggi del suo tempo (è probabile che qualcuno di questi sia
stato dedicato a Laide.
Si narrano su di lui una serie di aneddoti, a
testimonianza della sua tecnica e del suo amore per la precisione. Esponeva i
suoi quadri sul balcone e si nascondeva per sentire le critiche dei passanti.
In questo modo effettuò delle correzioni sui sandali
di una figura ritratta, in seguito alle critiche mosse da un ciabattino che
ammonì successivamente a limitarsi alla critica solo sulla scarpa.
Rimproverò un allievo di aver dipinto un’Elena più
ricca di gioielli e di sfarzo che esteticamente bella.
Si dice che non lasciasse passare un giorno senza
tirare una linea. Apelle un giorno si recò a casa del pittore Protogene a Rodi
per conoscerlo. Giunto a destinazione vi trovò una donna anziana che lo avvertì
della momentanea assenza del pittore. Apelle andò verso un cavalletto, prese un
pennello, e dipinse una linea colorata estremamente fine. Quando Protogene
ritornò, esaminò la linea e si rese conto che soltanto Apelle avrebbe potuto
fare un disegno così perfetto. Disegnò quindi una linea ancora più fine sopra
la prima e chiese alla sua serva di mostrarla all’ospite se fosse ritornato.
Quando Apelle tornò, gli fu mostrata la risposta di Protogene
ed Apella dipinse con un terzo colore una linea ancora più fine tra le prime
due, non lasciando spazio per un'altra.
Nel vedere questo disegno, protogene ammise la
sconfitta e uscì per cercare Apelle volendolo conoscere di persona.
I suoi quadri sono andati tutti perduti. Uno di questi
era “Afrotide sorgente dal mare” di cui si conoscono, attraverso le fonti, due
redazioni. Una alla quale Apelle stava lavorando quando morì ed una precedente
che venne menzionata da Plinio per aver usato come modella un’ex amante (Campaspe,
originaria di Larissa in Tessaglia) di Alessandro Magno per raffigurare Afrotide.
L’affresco, probabilmente staccato a massello, fu
fatto trasportare a Roma da Cesare che lo collocò nel tempio di Venere
Genitrix. Le fonti citano come l’affresco, al tempo di Nerone, era danneggiato
e fu ridipinto o addirittura rimpiazzato da una copia.
Raffigurava Afrotide Anadiomene che si levava nascente dalle acque
e si strizzava i capelli bagnati sollevando le braccia.
(Anadiomene infatti significa “nascente dal mare”)
Il Tiziano nel 1520 dipinse l’Afrotide Anadiomene
rifacendosi alle citazioni di Plinio che
descrivevano il quadro perché si trovava a Roma.
Il sepolcro di Laide diventò durante il regno di Adriano (117 – 138), tema d’incisione nelle monete corinzie. Una di queste monete destò l’interesse dell’Eckel (1839) e si trova negli archivi di Numismatik Lanz Munchen.
Corinto – Lais o Laide la cortigiana
Dritto: testa di Afrotide
Retro: Tomba, Monumento in onore di Laide
capitello dorico con ariete sdraiato sotto una leonessa.
La storia di Laide non finì con la sua morte.
Si narra come la Tessaglia fu punita dalla dea Venere
con una pestilenza a causa
dell’uccisione di Laida. Le donne che uccisero Laida
erano una quarantina e il suo compagno di vita Ippoloco si rivolse alla dea
della vendetta Nemesi che gli donò , in
cambio dei suoi servigi, forza ed abilità. Ippoloco
uccise tutte le donne responsabili dell’assassinio e non solo, ma anche i
mariti e i figli.
Ancora oggi il nome Ippoloco in quella zona della
Grecia viene pronunciato con timore.
Altri riferimenti
furono di Ateneo che citò il compagno di Laide con il nome di Pausania e
non di Ippolico:“ famosa cittadina della città dei Sicani Hycara fu
l’etera Laide... Timeo, a fugar ogni dubbio, nel tredicesimo libro delle sue
“Storie” asserisce che essa era di Iccara, in ciò concordando con Polemone, il
quale riferisce che essa venne uccisa da alcune donne in Tessaglia; essa s’era
innamorata di un Tessalo di nome Pausania, e per invidia e gelosia venne
colpita a morte con zoccoli di legno in un tempio di Afrotide. Dopo ciò, egli
continua, il luogo venne rinominato dell’Afrotide Assassina ....La sua tomba si
vede oltre il fiume Pencio, sopra ha una brocca per l’acqua, in pietra e reca
il seguente epigramma....Era il tempo nel quale l’orgogliosa Grecia, dal potere invincibile,venne resa schiava dalla divina bellezza di laide, la quale è qui, laquale Eros generò e Corinto nutrì;giace essa, adesso, nelle gloriosa pianure della TessagliaPer quanto detto, coloro, che dicono che essa venne
cremata accanto il boschetto corniolo, s’inventarono la notizia” (Ateneo, 589).
La tradizione riporta come Laide sia stata modella del
famoso pittore dell’antichità Apelle.
Alcune fonti citarono l’artista come vissuto nel IV
secolo a.C. mentre altri attribuiscono una data di nascita e di morte:
Apelle (Ἀπελλῆς, Apellês )
(Colofone,
375 – 370 a.C. – Coo, fine IV secolo a.C.).
Un artista che fu definito da Plinio il Vecchio “superiore
agli artisti precedenti e successivi”.
Anche l’Ariosto, nell’”Orlando Furioso” citò Apelle
Tutto trapunto con
figure belle, più che mai con pennel facesse Apelle
Accettando la nascita di Laida nel 420 a.C. ci
sarebbero almeno vent’anni di differenza tra il pittore e la donna
(considerando Apelle nato nel 400 a.C.) e
ben quarantacinque anni basandosi sulla nascita del pittore riportata da
alcuni fonti nel 375 a.C. circa.
È probabile come il pittore abbia conosciuto Laide nella
sua età matura e fu in ogni caso conquistato dal fascino che la donna, anche se
in età avanzata, mostrava e dalla sua intelligenza.
Una donna che s’allontanava dal tipico modello sociale
femminile e il pittore la immortalò in
alcuni dipinti. Un artista dotato di grande abilità nel disegno sia nel colore
che nella luce.
Adoperava solo i quattro colori fondamentali riuscendo
a trarre molteplici effetti coloristici. Eseguì molti quadri con raffigurazioni
mitologiche e personaggi del suo tempo (è probabile che qualcuno di questi sia
stato dedicato a Laide.
Si narrano su di lui una serie di aneddoti, a
testimonianza della sua tecnica e del suo amore per la precisione. Esponeva i
suoi quadri sul balcone e si nascondeva per sentire le critiche dei passanti.
In questo modo effettuò delle correzioni sui sandali
di una figura ritratta, in seguito alle critiche mosse da un ciabattino che
ammonì successivamente a limitarsi alla critica solo sulla scarpa.
Rimproverò un allievo di aver dipinto un’Elena più
ricca di gioielli e di sfarzo che esteticamente bella.
Si dice che non lasciasse passare un giorno senza
tirare una linea. Apelle un giorno si recò a casa del pittore Protogene a Rodi
per conoscerlo. Giunto a destinazione vi trovò una donna anziana che lo avvertì
della momentanea assenza del pittore. Apelle andò verso un cavalletto, prese un
pennello, e dipinse una linea colorata estremamente fine. Quando Protogene
ritornò, esaminò la linea e si rese conto che soltanto Apelle avrebbe potuto
fare un disegno così perfetto. Disegnò quindi una linea ancora più fine sopra
la prima e chiese alla sua serva di mostrarla all’ospite se fosse ritornato.
Quando Apelle tornò, gli fu mostrata la risposta di Protogene
ed Apella dipinse con un terzo colore una linea ancora più fine tra le prime
due, non lasciando spazio per un'altra.
Nel vedere questo disegno, protogene ammise la
sconfitta e uscì per cercare Apelle volendolo conoscere di persona.
I suoi quadri sono andati tutti perduti. Uno di questi
era “Afrotide sorgente dal mare” di cui si conoscono, attraverso le fonti, due
redazioni. Una alla quale Apelle stava lavorando quando morì ed una precedente
che venne menzionata da Plinio per aver usato come modella un’ex amante (Campaspe,
originaria di Larissa in Tessaglia) di Alessandro Magno per raffigurare Afrotide.
L’affresco, probabilmente staccato a massello, fu
fatto trasportare a Roma da Cesare che lo collocò nel tempio di Venere
Genitrix. Le fonti citano come l’affresco, al tempo di Nerone, era danneggiato
e fu ridipinto o addirittura rimpiazzato da una copia.
Raffigurava Afrotide Anadiomene che si levava nascente dalle acque
e si strizzava i capelli bagnati sollevando le braccia.
(Anadiomene infatti significa “nascente dal mare”)
Il Tiziano nel 1520 dipinse l’Afrotide Anadiomene
rifacendosi alle citazioni di Plinio che
descrivevano il quadro perché si trovava a Roma.
La tradizione riporta come Laide sia stata modella del
famoso pittore dell’antichità Apelle.
Alcune fonti citarono l’artista come vissuto nel IV
secolo a.C. mentre altri attribuiscono una data di nascita e di morte:
Apelle (Ἀπελλῆς, Apellês )
(Colofone,
375 – 370 a.C. – Coo, fine IV secolo a.C.).
Un artista che fu definito da Plinio il Vecchio “superiore
agli artisti precedenti e successivi”.
Anche l’Ariosto, nell’”Orlando Furioso” citò Apelle
Tutto trapunto con
figure belle, più che mai con pennel facesse Apelle
Accettando la nascita di Laida nel 420 a.C. ci
sarebbero almeno vent’anni di differenza tra il pittore e la donna
(considerando Apelle nato nel 400 a.C.) e
ben quarantacinque anni basandosi sulla nascita del pittore riportata da
alcuni fonti nel 375 a.C. circa.
È probabile come il pittore abbia conosciuto Laide nella
sua età matura e fu in ogni caso conquistato dal fascino che la donna, anche se
in età avanzata, mostrava e dalla sua intelligenza.
Una donna che s’allontanava dal tipico modello sociale
femminile e il pittore la immortalò in
alcuni dipinti. Un artista dotato di grande abilità nel disegno sia nel colore
che nella luce.
Adoperava solo i quattro colori fondamentali riuscendo
a trarre molteplici effetti coloristici. Eseguì molti quadri con raffigurazioni
mitologiche e personaggi del suo tempo (è probabile che qualcuno di questi sia
stato dedicato a Laide.
Si narrano su di lui una serie di aneddoti, a
testimonianza della sua tecnica e del suo amore per la precisione. Esponeva i
suoi quadri sul balcone e si nascondeva per sentire le critiche dei passanti.
In questo modo effettuò delle correzioni sui sandali
di una figura ritratta, in seguito alle critiche mosse da un ciabattino che
ammonì successivamente a limitarsi alla critica solo sulla scarpa.
Rimproverò un allievo di aver dipinto un’Elena più
ricca di gioielli e di sfarzo che esteticamente bella.
Si dice che non lasciasse passare un giorno senza
tirare una linea. Apelle un giorno si recò a casa del pittore Protogene a Rodi
per conoscerlo. Giunto a destinazione vi trovò una donna anziana che lo avvertì
della momentanea assenza del pittore. Apelle andò verso un cavalletto, prese un
pennello, e dipinse una linea colorata estremamente fine. Quando Protogene
ritornò, esaminò la linea e si rese conto che soltanto Apelle avrebbe potuto
fare un disegno così perfetto. Disegnò quindi una linea ancora più fine sopra
la prima e chiese alla sua serva di mostrarla all’ospite se fosse ritornato.
Quando Apelle tornò, gli fu mostrata la risposta di Protogene
ed Apella dipinse con un terzo colore una linea ancora più fine tra le prime
due, non lasciando spazio per un'altra.
Nel vedere questo disegno, protogene ammise la
sconfitta e uscì per cercare Apelle volendolo conoscere di persona.
I suoi quadri sono andati tutti perduti. Uno di questi
era “Afrotide sorgente dal mare” di cui si conoscono, attraverso le fonti, due
redazioni. Una alla quale Apelle stava lavorando quando morì ed una precedente
che venne menzionata da Plinio per aver usato come modella un’ex amante (Campaspe,
originaria di Larissa in Tessaglia) di Alessandro Magno per raffigurare Afrotide.
L’affresco, probabilmente staccato a massello, fu
fatto trasportare a Roma da Cesare che lo collocò nel tempio di Venere
Genitrix. Le fonti citano come l’affresco, al tempo di Nerone, era danneggiato
e fu ridipinto o addirittura rimpiazzato da una copia.
Raffigurava Afrotide Anadiomene che si levava nascente dalle acque
e si strizzava i capelli bagnati sollevando le braccia.
(Anadiomene infatti significa “nascente dal mare”)
Il Tiziano nel 1520 dipinse l’Afrotide Anadiomene
rifacendosi alle citazioni di Plinio che
descrivevano il quadro perché si trovava a Roma.
Specchio di bronzo del V secolo a.C.
Museo del Louvre
2. La
Prostituzione Sacra – I Templi
Lo studio degli storici s’incentrò sull’Afrotide
dell’Acrocorinto che era uno dei principali culti corinzi della dea a cui era
sta sempre collegata la pratica della prostituzione templare.
Il sesso come rituale religioso era una pratica assai
diffusa nelle religioni antiche tanto da fare nascere la figura della
prostituta sacra che, occasionalmente o stabilmente, era residente nel tempio
dove era al servizio della divinità e dei suoi fedeli.
Le fonti citano la sua presenza in molti paesi
soprattutto tra l’India e l’area mediterranea: Sumeri, Armeni, Babilonesi,
Fenici, Egizi, Greci ed anche Etruschi.
Tutti popoli che utilizzavano le prostitute sacre la
cui condizione sociale era molto diversificata dato che potevano essere delle
donne libere o anche delle schiave e in questo caso “regalate” alla divinità da
uomini e donne facoltosi.
In merito alle divinità, che richiedevano la
prostituzione, erano spesso femminili, ma non sempre e tra queste le principali
erano Ma, Astarte, Afrotide.
La funzione principale delle prostitute sacre era quella
di sacralizzare le forze che caratterizzano la vita dell’uomo.
Interessante è il racconto di Erodoto sui babilonesi e
proprio in merito al sesso nella pratica religiosa:
“É obbligo che ogni donna del paese, una volta durante la vita, postasi
nel recinto sacro ad Afrodite, si unisca con uno straniero. Molte che disegnano
di andare mescolate alle altre, in quanto orgogliose della loro ricchezza, si
fanno condurre al tempio da una pariglia su un carro coperto, e la se ne
stanno, avendo dietro di sé numerosa servitù. Per lo più il rito si svolge
così: se ne stanno le donne sedute nel sacro recinto di Afrodite con una corona
di corda intorno al capo: sono in gran numero, perché mentre alcune
sopraggiungono altre se ne vanno. Tra le donne si aprono dei passaggi,
delimitati da corde e rivolti in tutte le direzioni, per i quali si aggirano i
forestieri e fanno la loro scelta. Quando una donna si asside in quel posto,
non torna più a casa se prima qualche straniero, dopo averle gettato del denaro
sulle ginocchia, non si sia a lei congiunto all’interno del tempio. Nell’atto
di gettare il denaro, egli deve pronunciare questa frase: «Invoco per te la dea
Militta». Militta è il nome che gli Assiri danno ad Afrodite. La quantità di
denaro è quella che è. Non c’è da temere, infatti, che la donna lo rifiuti: non
le è permesso, perché quel denaro diventa sacro. Essa segue il primo che glielo
getta e non rifiuta nessuno. Dopo essersi data a quello, fatto un sacrificio
espiatorio alla dea, se ne torna a casa, e da quel momento non potrai offrire
mai tanto da poterla avere. Le donne che sono dotate di un bel viso e d’una
figura slanciata se ne tornano presto. Quelle, invece, che sono brutte
rimangono lungo tempo senza poter soddisfare la prescrizione di legge; alcune
infatti, aspettano anche tre o quattro anni. Una consuetudine simile a questa
si trova anche in alcuni luoghi dell’isola di Cipro.”
Queste donne godevano di un gran prestigio e
considerazione proprio in virtù della loro funzione sacra. Potevano anche
sposarsi e per l’uomo era un grande prestigio. D’altra parte molte di loro
riuscivano ad accumulare ingenti risorse economiche così come i santuari dove
prestavano la loro attività e che erano posti in posizione strategica lungo le
principali vie di comunicazione commerciale.
Molti di questi santuari, proprio per le loro ricchezze,
erano spesso oggetto di razzie da parte di popoli nemici.
In merito alle dee da citare la fenicia Astarte ed
identificata successivamente con Afrotide. Era la dea dei naviganti e collegata
alla Stella che guida le rotte delle navi.
Astarte
VII secolo a.C.
Museo Archeologico di
Siviglia
Trai Fenici ed i Cartaginesi il culto di Astarte era
molto diffuso ancora nel III e IV secolo
d.C.
San Agostino ed Eusebio di Cesarea infatti in quel periodo
condannarono la devozione e le relative pratiche che erano rivolte alla divinità.
Secondo la tradizione sarebbe stata Didone (figura
mitologia, fondatrice e prima regina di Cartagine) ad introdurre tra il suo
popolo la prostituzione sacra. Il luogo principale era il tempio di Sicca Veneria “ detto di Afrodite” (vicino
Cartagine) e che fu ricordato da Valerio Massimo (storico romano; I secolo a.C. – I secolo
d.C.)
Un’antica immagine di
Sicca Veneria
(El Kef – Tunisia)
Disegno ed incisione di T.
Allon e E. Challis
Pubblicata nel
“Mediterraneo Illustrato”, Ed. Spirito Battelli
Firenze, 1841
Immagine di Sicca Veneria
durante gli scavi del 1860
In Grecia numerosi
santuari presentavano la prostituzione sacra soprattutto a Corinto dove sorgeva il tempio di Afrotide Pornè,
frequentatissimo e ricchissimo.
Il geografo Strabone lo
citò nei suoi scritti riferendo antiche fonti.
Queste prostitute
godevano una grande stima ed avevano un posto riservato anche nel teatro. Laide
di Hykkara (Sicilia) fu una di queste tanto famosa e bella da posare per il
pittore Apelle.
Altri santuari sono
attestati a Cipro, in Lidia e nella Ionia dove una città, chiamata Abido,
secondo la leggenda sarebbe stata governata da etere.
Le navi reali di Abido
Tomba del re
Djer (3500 a.C.) – Abido
Esistevano diverse forme
di prostituzione sacra che erano legate alle caratteristiche ed alle funzione
delle etere:-
Ierogamia, cioè di matrimonio
o unione sacra, in occasione di un’unione rituale o mitica tra un dio e una dea
o tra un dio e un umano. In Grecia questa pratica identificò l’unione tra un
sovrano e la sacerdotessa di una divinità, quindi unione ideale sovrano-dea per
la propiziazione della fertilità;-
Ierodulìa
(servitù sacra) come un servizio sessuale effettuato da serve sacre consacrate
alla divinità. Le ierodule, quindi, oltre a prostituirsi nel tempio o nel
santuario dovevano effettuare e accompagnare riti con musica e con danze;-
apotropaica
che ha caratteristica essenzialmente di scongiuro e veniva praticata in
precedenza delle nozze di una giovane donna. Questa infatti consacrava la sua
verginità alla dea congiungendosi nel tempio con un estraneo allo scopo di
scacciare i pericoli nascosti nella vita matrimoniale.
Uomini con prostitute raffigurati su vaso
(hydria) attico a figure rosse del V secolo a.C.
Anche in
Italia la prostituzione sacra era presente in alcuni santuari che si trovavano
in centri commerciali greci e fenici in cui i commercianti potevano ritrovare
le proprie divinità tutelari.
Il culto di
Afrotide era molto presente nella Magna Grecia così come la fenicia Astarte in
Sardegna ed in Sicilia. (questi culti si ritrovano anche tra gli Etruschi).
Le
caratteristiche dei santuari con prostituzione sacre rimangono le stesse di
quelle conosciute in Grecia ed anche loro dotati di una grande ricchezza.
L’etrusca Pyrgi (Santa Marinella – Roma) venne
saccheggiata nel 384 a.C. da Dioniso I di Siracusa per la ricchezza del suo
santuario, ed Erice fu razziata per lo stesso motivo da Amilcare.
Santa Marinella (Roma) –
Il sito dell’antica Pyrgi
La ricchezza doveva essere tale che in alcune occasioni
furono usate le risorse di questi santuari per riassestare città e territori
dopo le devastazioni di nemici, come avvenne dopo il passaggio di Pirro a Locri
e di Annibale a Rapino.
Uno dei santuari più celebri si trovava a Locri
Epizefiri in Calabria. La città fondata tra VII e VII secolo a.C. da coloni
locresi ospitava il tempio di Afrodite in prossimità del porto. Scavi qui
effettuati hanno portato alla scoperta di una stoà (portico) a forma di U
chiamata di Centocamere per la presenza di numerose stanzette e che è stata
identificata come un lupanare. Vicino a questa struttura è stata ritrovata
l’area del tempio di V secolo a.C. che andò a sostituire una struttura templare
più antica di VII-VI secolo a.C.
Il quartiere di Centocamere
Locri Epizefiri – tempio
di Afrotide
Alcune ricostruzioni fatte da studiosi indicano questo
tempio di Afrodite come sede originaria del famoso Trono Ludovisi (datato al V
secolo a.C.) scoperto a Roma nel 1887 nei terreni della Villa Ludovisi.
I rilievi del Trono Ludovisi, V secolo a.C. Museo Nazionale
Romano di Palazzo Altemps, Roma
Nel 181 a.C. il console Lucio Porcio Licinio aveva
costruito nei pressi della Porta Collina un tempio dedicato a Venere
all’interno del quale fu conservato il “Trono Ludovisi” dopo essere stato preso
dal tempio di Locri Epizefiri (o secondo altri dal tempio di Venere ad Erice).
La sua funzione è ancora discussa, alcuni vogliono identificarlo come la
decorazione del trono sul quale sedeva la statua della dea, altri come
l’ornamento di un altare, o ancora come una sorta di parafuoco per proteggere
chi svolgeva il sacrificio dalle fiamme. Originariamente, secondo una ulteriore
l’ipotesi proposta da alcuni studiosi, questo elemento scultoreo doveva essere
incastonato al centro del pavimento del tempio della dea a Locri, dove è stato
trovato un taglio quadrato le cui misure sembrano corrispondere a quelle del
trono.
Tempio – Cella e Bothros
Tempio – Bothros
Locri – il Tempio
Rilievo dell’apertura
quadrata al centro del pavimento del tempio
con la supposta
collocazione originaria del “trono Ludovisi”
Ricostruzione dello
storico, D. Mertens
Frammenti di Skyphoi a vernice nera
con iscrizioni dal Bothros
Iscrizione su vaso fittile
da Locri
La particolarità di questo manufatto è dovuta alla
presenza di tre rilievi scultorei, quello centrale, più grande, che raffigura
tre figure femminili, due laterali che aiutano una terza donna ad uscire dalla
terra o dal mare. Nei due pannelli laterali compaiono invece due figure
femminili. Sulla destra una donna seduta, velata, che sta svolgendo un
sacrificio, mentre un’altra donna sul pannello sinistro, è nuda, seduta e sta
suonando gli auloi. Questi rilievi presenti sul trono sono stati interpretati
come tipici del culto di Venere-Afrodite. Nel pannello centrale infatti si è
soliti vedere la nascita della dea, mentre nei pannelli laterali si riconosce
una sacerdotessa che sta bruciando incenso (elemento caratteristico dei
sacrifici a questa divinità) e una prostituta (la figura nuda) che suona gli
strumenti a fiato. La funzione originaria del trono quindi potrebbe essere
stata quella di pannello scenografico, al centro del tempio, dietro al quale
una sacerdotessa, in particolari occasioni, rappresentava ritualmente la
nascita della dea, accompagnata dal suono degli auloi delle prostitute sacre e
con sacrifici d’incenso. La presenza della prostituzione sacra a Locri è
inoltre testimoniata dal ritrovamento di numerose statuette ex-voto
rappresentanti donne nude e dalle “Tabelle Locresi”, su alcune delle quali
compare l’espressione che indica il prezzo delle prostitute.
Notizie di altri santuari con prostitute sacre le abbiamo
poi nell’antica Cossyra (Pantelleria) dove sorgeva il tempio di Astarte.
Pantelleria
La popolazione originaria di Pantelleria furono i
Sesioti, un popolo di origine ibero-ligure che s’insediò nell’isola a scopo
commerciale. Pantelleria aveva una grande quantità di ossidiana che veniva
ricercata in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo per fare arnesi da
taglio.
Furono poi i Fenici a fondarci una colonia, Cossyra, i
cui resti archeologici si trovano sulle colline di San Mauro e Santa Teresa. Successivamente
i Romani diedero un forte impulso nell’economia dell’isola come dimostrano i
numerosi insediamenti sparsi nel territorio.
Il grande santuario, risalente al periodo romano, si
trova nel sito archeologico del Lago di Venere, nella parte Nord dell’isola.
Pantelleria - Lago di
Venere
Resti del
Santuariodi Astarte/Venere
Il
tempio è costituito da una struttura porticata di notevole consistenza e da una
gradinata d’accesso al santuario rupestre ancora da scavare. Esso sorge sulle
fondamenta di una precedente costruzione punica utilizzando di questa alcuni
elementi architettonici. La struttura originaria era sicuramente dedicata alla
dea punica Tanit.Nella
caldera vulcanica del lago di Venere le ricerche archeologiche eseguite anche
da Paolo Orsi, rilevarono la presenza di resti risalenti anche all’età
preistorica. La contrada “Kattibuale” presenta un alta concentrazione di
materiale ceramico (a vernice nera, sigillata africana ed italica) e quella di
frammenti di cocciopesto, d’intonaco dipinto, di fusti di colonne e basi di
pilastri. Tutti elementi che lasciavano presagire alla presenza di un antica
struttura a carattere religioso e che era stata parzialmente ricoperta: sul
lato Nord dalla frana della strada sovrastante, sul lato Orientale da un
dammuso ottocentesco e sul lato occidentale da un muro di contenimento di un
terrazzo artificiale.Lo
scavo permise d’identificare l’effettiva estensione del tempio e nello stesso
tempio di rilevare come l’antico lago era ben più ampio e le modificazioni
geo-morfologiche che si sono succedute nel tempo. Fu inoltre possibile
determinare l’arco cronologico di frequentazione del sito a partire dall’età
del rame alla fase d’insediamento d’età punica e romana.Come
detto fu riportato alla luce parte del colonnato disposto ai piedi del margine
di frana in direzione Est-Ovest e che si sviluppava lungo il lato lungo dell’edificio
di culto.L’ingresso
era rivolto ad Est e presenta una scenografica scalinata costituita da nove
gradini a blocchi perfettamente regolari.Presenta
una pianta rettangolare (10 x 6,00) m, con un orientamento Est-Ovest e con uno
spessore delle strutture murarie variabile (2,20/1,50)m.È
probabile come la struttura primitiva presentasse un doppio colonnato con un
alternanza di pilastri e colonne lungo il lato meridionale.L’edificio
in antico era d’ordine ionico e costituito da due ambienti contigui accessibili
da Nord e separati da un tratto murario, la parte occidentale presenta un
sacello di piccole dimensioni che, privo d’ingresso, doveva contenere la statua
di culto (Astarte o Tanit o forse anche Venere) che era visibile dall’esterno e
non accessibile.Gli
imponenti blocchi di pietra all’interno dell’ambiente e sottostanti il
pavimento, di cui fu rinvenuto il piano di preparazione, avevano la funzione di
sostenere il peso della statua di culto che doveva essere di notevoli
dimensioni. Nell’area antistante il sacello il tempio presentava delle
strutture, che potremo definire accessorie, e sempre pertinenti al culto.Infatti
è presente un altare a base cilindrica che era affiancato da due vasche di raccolta
di ceneri e di resti ossei animali da sacrificio ed era presente anche una
vasca di dimensioni maggiori.Dai
dati di scavo, quale il rinvenimento di una moneta in bronzo dell’imperatore
romano Caligola, datata 378 d.C., la struttura potrebbe essere identificata
come il tempio d’età tardo - romana costruito sui resti dell’edificio punico.
Anche se nessuno ne parla, gli archeologi rimasero meravigliati dall’imponenza
della struttura che superava di gran lunga ogni possibile aspettativa. Il
santuario posto sulle rive del lago rappresenta infatti un dei più importanti
monumenti cultuali del Mediterraneo.
Le mura
Penso che sia importante fare una distinzione tra Fenici e
Punici.“Poeni” era il nome che i Romani davano ai Cartaginesi e deriva
dal greco “Phoenikes” che i Greci usavano per chiamare i Fenici del Libano e
quelli in Tunisia, Sicilia e Sardegna.In sintesi la differenza che passa tra i termini fenicio e
punico è la seguente:fenicio è tutto ciò che proviene dalla Fenicia cioè dal Libanopunico, ha la stessa origine culturale fenicia ma proviene da
Cartagine.Tanit era la dea della
fertilità, dell’amore e del piacere ed era associata alla buona fortuna, alla
Luna e ai raccolti.Nelle stele votive di Cartagine è raffigurata con il disco e la
falce lunare oltre al cosiddetto “simbolo di Tanit” molto complesso e sul cui
significato non tutti gli storici sono concordi.Si tratta di un triangolo equilatero, una linea orizzontale ed
un disco, in modo da rendere una rozza
figura umana.
Pantelleria –
Iscrizione Tanir (Miderna)
Monte Gibele
La
Grande Madre Tanit era anche chiamata “Mirionima” cioè “dai 10.000 nomi”.
Anche
a Roma le venne consacrato un tempio chiamata “Iuno Caelestis”.
Termine
“Caelestis” che era associato ad altre divinità come a Giunone, Venere, Diana e
Fortuna
Il
tempio di Tanir a Pantelleria fu dai Romani dedicato a Venere.
Una
dea associata all’amore, alla bellezza ed alla fertilità e quindi equivalente
alla dea greca Afrotide.
L’isola
di Pantelleria sarà oggetto di una mia prossima ricerca ed è forte la tentazione di pubblicare alcune
foto su degli aspetti naturalistici unici anche per dare una prima visione della bellissima isola del
Mediterraneo.
Lo
zibibbo è un vitigno molti diffuso nel paesaggio agricolo di Pantelleria. Il
particolare sistema di coltivazione e di potatura sono tramandati da secoli. Il sistema di allevamento del vitigno è ad alberello ma s’incontra anche un sistema
che è denominato “canestro” ed è simile a quello praticato nell’isola di
Santorini (Thera) in Grecia.
Pantelleria
– Vite ad alberello
Pantelleria
– Viti ad alberello (Patrimonio dell’UNESCO)
Pantelleria – Vite
“a canestro”,
Santorini (Grecia)
I
contadini panteschi da secoli s’adeguano al clima ventoso dell’isola con vari
accorgimenti. In questa foto sono utilizzate deli cladodi di fichidindia
(“pale”) tagliate in modo da fare un cuneo
e posizionate a protezione delle piantine di pomodoro o di altri ortaggi. In
questo modo si crea non solo una zona d’ombra per la piantina ma anche una
buona protezione dal vento necessaria soprattutto nelle prime fasi di crescita
della stessa piantina. L’umore della
“pala” spezzata, che fuoriesce dalla ferita, crea anche una piccola umidità che
è favorevole allo sviluppo delle piccole radici e alla nutrizione della
piantina.
Nei vigneti la protezione del vento s’ottiene con la
piantagione dell’orzo tra i filari di zibibbo. L’orzo oltre che come alimento,
un tempo il biscotto d’orzo era molto diffuso nell’isola, protegge i germogli
delle viti dal vento impetuoso primaverile (scirocco) che nel mese di maggio è
molto intenso.
La varie piante da frutto nell’isola vengono potate in un
modo particolare e cioè con i rami bassi verso il suolo. Un sistema per esporre
la minore superficie fogliare ai forti venti. Questa tecnica di potatura è
applicata anche agli alberi d’olivo con il risultato che si possono vedere
piante centenarie alte poco più di un metro con tronchi enormi e con rami che
sfiorano il suolo. Non sembra che esista al mondo una potatura simile per
l’olivo.
Ma Pantelleria non
finirà mai di stupire il visitatore alla ricerca di aspetti sconosciuti e in
grado di suscitare emazioni forse insesparte.
Penso che il
raggiumento di un offerta di valore nel capo turistico sia quella di offrire al
turistia .. qualcosa in più che non s’aspetta.
Nel bellissimo lago di Venere, un vero specchio della Natura,
sono presenti le Stromatoliti cioè delle strutture
sedimentarie di orgine organica e che sono prodotte da comunità di
microorganismi in ambiente marino o lacustre.
Le
stromatoliti silicee - spiega dice Marianna Cangemi -, sono molto rare in
natura e per la maggior parte all'interno di ambienti idrotermali a temperature
molto più elevate di quelle ambientali. Per questo motivo il ritrovamento di
tali strutture nel lago Specchio di Venere assume un carattere di eccezionalità,
se non di unicità, in quanto a Pantelleria tali rocce si sono formate e sono
attualmente in fase di accrescimento, in un ambiente di bassa temperatura,
costituendo un prezioso e attuale laboratorio geo-biologico".
"Questi
materiali - continua Paolo Madonia, ricercatore Ingv - rivestono da sempre
particolare interesse per microbiologi, paleontologi, sedimentologi,
biogeochimici e astrobiologi, in quanto contenenti, nella loro matrice minerale
la registrazione della storia chimica e morfologica della vita, e rappresentano
inoltre un fondamentale punto di riferimento per il riconoscimento di forme di
vita primordiali in altri pianeti, ad esempio su Marte."
Si
tratta di organismi viventi che risalirebbero a ben 3,5 miliardi d’anni fa.
L’impronta
di questi organismi sarebbe stata trovata in alcune rocce australiane.
Si
tratta di rocce sedimentarie della formazione di Dresser appartenenti proprio
alle stromatoliti, cioè le prime forme di vita terrestre (Raphael Baumgaetner,
della University of New Spoyth Wales (Australia) (studio pubblicato sulla
rivista “Geology”).).
“le
stromatoliti sono strutture sedimentarie che si osservano in rocce calcaree e
che sono il risultato dell’azione di microorganismi fotosintetici, in
particolare cianobatteri”.
Poi
hanno sottoposto i campioni alle più sofisticate e avanzate tecniche di
analisi: dalla microscopia elettronica a scansione, alla spettroscopia a raggi
X, fino alla spettroscopia Raman e
alla spettrometria di massa ionica
secondaria... una impressionante batteria di metodi e strumenti che
hanno infine condotto i ricercatori a una conclusione univoca.
SONO
STROMATOLITI, senza ombra di dubbio: le analisi hanno rilevato che
le strutture sono prevalentemente costituite da pirite (minerale composto da
ferro e zolfo) piena di pori nanoscopici, ossia estremamente piccoli; nella
pirite sono state evidenziate inclusioni di materiale organico contenente
azoto che somigliano a resti di biofilm (una complessa
aggregazione di microrganismi che si depositano su una superficie dando origine
a una sottilissima pellicola).
Fossile di Stromatolite
della formazione di Dresser
Sezione di un
frammento di roccia di 3,48 miliardi di anni fa, rinvenuto nella Dresser
Formation (Pilbara, Australia occidentale): le aree biancastre sarebbero la
prova della più antica forma di vita, che si è sviluppata in prossimità di
antiche sorgenti calde.
Australia – Baia degli squali – Stromatoliti
Pantelleria
– Stromalotiti
Pantelleria
Non
ho riferimenti su quando si sia formato il Lago o Specchio di Venere.
Il
monte più alto di Pantelleria è Montagna Grande con i suoi 836 m s.l.m.
Il
tipo di vulcano: caldera con centro monogenici
Tipo
di eruzioni: effusive, stromboliane, freatomagmatiche, pliniane
Fenomeno
prevalenti: emissioni idrotermali, sismicità
Inizio
attività eruttiva: < 330 – 325.000 anni
Ultima
eruzione: 1891
Stato
di attività: quiescente
Cratere di Gelfiser a Pantelleria
L’isola è costituita in gran parte
da un mosaico di centri eruttivi che si
sovrappongono e che si sono
sviluppati al centro di una caldera di circa 28 kmq,
detta “Caldera dei Cinque Denti”
che a sua volta si era formata all’interno di
una più grande antica caldera che era ampia ben 42 kmq e detta “La Vecchia”
L’attività eruttiva si concluse tra
4000 e 5000 anni fa.
C’è da dire che due piccole eruzioni
sottomarine basaltiche a Nord-Ovest di
Pantelleria si verificarono nel
1831 e nel 1891 che furono accompagnate da
attività sismica e fumarolica
sull’isola.
Si verificarono
inoltre due episodi di sollevamento: fino a 0.8 m lungo la costa Nord-orientale
dell’isola (Maggio-Giugno 1890) e fino a 0.55 m (nell’ottobre 1891). L’ultima
eruzione ebbe inizio il 17 ottobre 1891 con lancio di brandelli di lava incandescenti,
visibili sia dall’isola sia dalle coste tunisine, e durò fino al 25 ottobre.
Questo episodio eruttivo, e in generale la geologia dell’isola, suggeriscono
che il vulcanismo si sia progressivamente spostato verso NW.
I tassi della
deformazione del suolo, delle temperature e le emissioni di gas (H2O
vap., CO2 e H2S) registrate negli ultimi 15 anni
sono in accordo con la presenza di un sistema idrotermale attivo e di una
camera magmatica superficiale (a circa 4 km di profondità) che sarebbe in via
di raffreddamento e in uno stato di deflazione.
Il Lago di Venere
dovrebbe essere uno dei centri eruttivi
dell’isola e diventato lago vulcanico (alimentato da ben tre sorgenti termali).
Un altro tempio importante si trovava ad Erice dove la tradizione indicava in Enea
il fondatore della città e del tempio di Venere, sua divina madre.
Nel tempio di Erice. che gli scrittori antichi indicavano
come il tempio più bello di tutta la Sicilia. fu praticata la prostituzione
sacra. Il sontuoso santuario di Venere Ericina si trovava sul Monte Erice, ma
oggi ne rimangono poche tracce consistenti nella piattaforma di base, in parte
del recinto sacro e nel “Pozzo di Venere”, una fossa votiva.
Tra le montagne di Sicilia. il Monte Erice (San Giuliano,
alto 751 m s.l.m.) è stato sempre uno dei siti più importanti dell’isola, non
solo per la presenza del santuario dedicato alla dea Ericina ma anche perché
posto a presidio delle importanti rotte commerciali marittime percorse da Fenici,
Greci. Ciprioti, Etruschi, Romani.
Sul monte era presente l’acropoli protesa sul mare e
Polibio lo definì
altus, magnus, Zephyro
semper apertus, ....selvaggio e ricco di vegetazione
Le prime citazioni indicarono il santuario come
extraurbano, comprendente il temenos o recinto sacro della dea ed un grande
altare. Polibio collocò l’edificio sulla cima del monte che era piana e secondo
Diodoro Siculo sorgeva su una terrazza che fu realizzata da Dedalo che mise in
opera un grande muro di contenimento poggiato sulla parete rocciosa. L’edificio
secondo Diodoro era costruito proprio
“sopra la parte
scoscesa della roccia”.
L’abitato invece si estendeva sulle pendici più in basso
e presentava un accesso molto difficile.
Oltre alle fonti letterarie, di grande importanza sono i
reperti numismatici che indicano la posizione del tempio sul monte.
Il denario romano di Marcus Considius Nonia nus, del 57
a.C., riporta un tempio posto su un rilievo, una cinta muraria, le torri e la
scritta
ERVC
Lo storico Biagio Pace, basandosi sulla raffigurazione
della moneta, avanzò l’ipotesi che il tempio fosse in origine a pianta
circolare. Tuttavia non si potrebbe escludere l’ipotesi che il tempio fosse in
realtà un “naòs tetrastilo con la cella interna del tempio destinata ad
accogliere la statua della divinità (Afrodite)”. (cioè la cella del tempio
con quattro colonne sul fronte).
La documentazione sul tempio risalirebbe al V secolo a.C.
ma l’edificio di culto era già preesistente dato che era il più importante
santuario dell’area Elima.
Si trovava anche in una posizione privilegiata rispetto
alla vicina città di Segesta che vi esercitava una sorta di egemonia.
I Segestani, come riferì Tucidide, si comportavano come
se il tempio fosse posto sotto la loro giurisdizione e lo convolsero nei
rapporti diplomatici con il mondo greco.
Nel 416, quando richiesero gli aiuti ad Atene per la
guerra contro i Selinuntini, i segestani
portarono in visita ad Erice gli ambasciatori ateniesi per dare loro un saggio
della forte ricchezza (alla fine si rilevò che era tutto un inganno) della
città.
Dimensione, ricchezza sempre decantata, continuità nel
tempo, peculiare collocazione geografica, sono tutti fattori che attestano
l’importanza, potremo definire “internazionale” del tempio che è confermata dai
notevoli reperti archeologici rinvenuti (purtroppo) in un contesto archeologico
molto rimaneggiato e che nel tempo ha subito delle manomissioni.
Furono rinvenute :
-
ceramiche tardocorinzie e attiche a figure nere e a
figure rosse, datate tra la seconda metà del VI e la fine del V secolo a.C.);-
amuleti e scarabei magico-sacrali di provenienza
orientale (micrasiatica, insulare, egizia, sirio-palestinese); nonché -
oggetti arcaici di fattura o ispirazione cipriota che
concorrono nel ribadire come proprio greche e fenicie siano le componenti più
leggibili dell’esperienza cultuale ericina.
A questo orizzonte si può ascrivere anche la nota statuetta in bronzo
conservata a Trapani. Si tratta di una
statuetta femminile ignuda che regge in mano una brocchetta , riconducibile
alla piccola plastica peloponnesiaca del periodo arcaico.
Bronzetto femminile con
brocchetta
Trapani – Museo “A.
Pepoli”.
In una rigorosa analisi
dei bronzetti, lo storico R. Fondacaro avanzò
l’ipotesi di riconoscere
nei due bronzetti, provenienti dall’area del santuario,
la raffigurazione
iconografica di una delle
ipotetiche “prostitute sacre” ericine.
-
Gruppo di amuleti e scarabei di tipi diffusi nel mondo
fenicio-punico e riferibili ad iconografie egiziane, esso costituisce
un’ulteriore importante testimonianza sulla presenza fenicio-punica ad Erice.
-
Una celebre testina in marmo alabastrino (IV sec. a.C.)
in cui è stata vista l’immagine stessa della dea ericina
Testa femminile in marmo
alabastrino in
cui è stata identificata
la dea ericina
(IV secolo a.C.)
Erice – Museo Civico “A.
Cordici”.
-
Una seconda testina
in pietra arenaria (databile alla metà del V sec. a.C.) raffigurante una
probabile divinità femminile (la dea ericina?). La dea indossa un copricapo di
forma troncoconica rovesciata, il cui margine presenta una inedita corona di
frutti, probabilmente ghiande. I frutti erano in origine costituiti in parte dalla
stessa pietra lavorata e in parte da elementi aggiunti in altro materiale
(bronzo?) che si inserivano nella cavità inferiore di ciascuno di essi. Le
dimensioni ridotte (alt. 16,5) suggeriscono la pertinenza a un gruppo scultoreo
relativo a decorazioni architettoniche per altari, acroteri o frontoni.
Testa Femminile con
copricapo tronco conico
Trapani – Museo “A.
Pepoli”
Statuetta femminile, forse
una danzatrice,
avvolta nell’”himation” e
velata
IV/ III secolo a.C.
Purtroppo dei resti archeologici è rimasto ben poco:
un’antica necropoli fuori Porta Trapani; gli imponenti
resti della cinta muraria e alcuni resti nel cortile del castello normanno
detto di “Venere” e riconducibili all’antico santuario o tempio.
L’acrocoro di Sud-Est, con le sue pareti tagliate
verticalmente, coincide perfettamente con la descrizione di Diodoro Siculo, e
presenta alcuni resti dell’area sacra che erano visibili ancora prima
dell’inizio degli scavi.
I resti del famoso santuario sono legati alla piattaforma
di base.
Resti
del santuario nel cortile del castello
Sono presenti alcuni tratti di un robusto muro di
sostruzione in grossi blocchi squadrati che richiama alla mente la descrizione
di Diodoro in merito al “muro di Dedalo”.
Vista sul “Ponte di
Dedalo” e sul “Muro di Dedalo”
Le Torri del Balio sullo
sfondo
Muro di Dedalo
“A Erice, dove si trova
una roccia tagliata a picco fino ad un altezza insolita, poiché
la ristrettezza dello
spazio occupato dal santuario di Afrotide rendeva necessario edificare le
strutture sullo strapiombo della roccia, costruì un muro proprio
sul precipizio,
ampliando il modo straordinario il piano sovrastante il precipizio”.
Si notano anche tre fosse circolari, adibite a cisterne.
I primi scavi su quest’area sommitale, dove insiste il
castello normanno, risalgono agli anni 1930 -31 per merito degli archeologi P.
Marconi e G. Cultrera.
Dagli studi condotti dagli archeologici emerse come i tre
settori riconosciuti come precedenti all’edificazione del castello normanno
erano contraddistinti dai seguenti vani:
-
I vani (1 -4), disposti ad L, e destinati ad aree
funzionali per edificio sacro. I loro muri esterni sono più visibili perché
sostituiti dalle strutture murarie del castello;
-
Il “pozzo di Venere”;
Si tratta di un’ampia
cisterna interamente scavata nel banco roccioso
ed usata per contenere
l’acqua della spianata che doveva ospitare il tempio.
Sullo sfondo, sopra il
muro, si nota una struttura forata,
la “Colombaia” che
richiama alla colomba volatile caro ad Afrotide.
-
La piattaforma al centro del cortile, con il muro in corrispondenza del suo ingresso;
-
Una serie di rocchi di colonne ed elementi della
decorazione architettonica.
Della piattaforma facevano parte i vani (5 – 6) che
fungevano da fronte settentrionale di una probabile terrazza più ampia dove
sorgeva il tempio.
Il muro (6) presenta delle tecniche edilizie diverse
indicanti altrettanti fasi costruttive che si sono succedute nel tempo. Le
lastre pavimentali, poste lungo il muro (6) con un orientamento differente.
È probabile come questo muro in origine abbia avuto la
funzione di separare due settori:
a Sud una terrazza posta ad una quota più elevata e a
Nord un’area lastricata scoperta che fu rovinata dal successivo edificio a
carattere termale.
L’area sacra doveva occupare anche la zona dove oggi sono
presenti le Torri del Balio dove nel 1885 furono rinvenuti frammenti di anfore
con bolli rodii ed italici databili al III secolo a.C.
Erice – Stampa del 1892
Parlare del santuario significherebbe citare la nascita
della città di Erice, uno dei principali centri degli Elimi insieme a Segesta
ed Entella.
Secondo la leggenda sarebbe stata fondata da Eryx, figlio
di Afrotide e del re locale Bures. Proprio in onore della madre il giovane Eryx
fondò il celebre santuario che sorgeva sulla rocca della città. All’arrivo di
Eracle con i buoi di Gerlone, Eryx lo avrebbe sfidato ad una gara di pugilato,
restando ucciso nello scontro.
Una leggenda molto antica che forse riflette antiche
frequentazioni micenee. Leggenda che era conosciuta da Erodoto che la citò in
merito alla spedizione dello spartano Dorieo che, intorno al 510 a.C., fondò
una colonia ad Erice, chiamandola Eraclea.
L’oracolo di Delfi, infatti, affermò che il territorio di
Erice apparteneva agli Eraclidi, in quanto era stato conquistato da Eracle.
La colonia ebbe una vita breve, e fu distrutta dai
Cartaginesi che erano alleati con i Segestani.
Tra i fondatori sopravvisse solo Eurileonte, che con
pochi compagni andò ad occupare Eraclea Minoa. Tutta la vicenda testimonia
l’interesse strategico ed economico di questa zona, contesa tra Greci e Cartaginesi già alla fine del VI
secolo a.C.
La città ed il suo porto di Drepanon, l’attuale Trapani,
rimasero da allora soggette al dominio cartaginese, fino alla prima guerra
punica.
Nel 260 a.C. i Cartaginesi rasero al suo Erice, tranne
il tempio, e ne trasferirono gli abitanti a Trapani, che fu allora fondata
come città, diventando una delle più importanti basi navali.
Nel 248 a.C. i Romani, con un colpo di mano, riuscirono
ad impadronirsi di Erice, ma nel 244 Amilcare Barca, provenendo da Palermo,
riconquistò la città, tranne la cittadella con il tempio, che rimase in
mano romana.
Gli aspri combattimenti che si svolsero sulla sommità del
monte non modificarono la situazione, finchè la fine della guerra, nel 241
a.C., assegnò tutta la Sicilia Occidentale, compresa Erice, ai Romani.
Da allora il santuario di Venere Ericina diventerà uno
dei più venerati, in base alla comune origine troiana che avrebbe legato i Romani
agli Elimi. Una tarda leggenda, ripresa da Virgilio, ne attribuiva la
fondazione allo stesso Enea.
Il Santuario di Venere Ericina sorgeva su una spianta in
parte sostenuta da mura megalitiche.
Un tratto, sul lato Nord – Ovest. È detto “Muro di Dedalo”
secondo una tradizione mitica che, come abbiamo visto, fu riportata da Diodoro
Siculo, secondo cui:
presso Erice esisteva
una roccia a picco così alta, che le costruzioni
circostanti il tempio
di Venere minacciavano di finire nel precipizio.
Dedalo consolidò queste
costruzioni, circondò la roccia con un muro e ne
allargò la sommità in
modo mirabile.
Successivamente
consacrò ad Afrotide Ericina un’arnia d’oro,
lavoro straordinario
che imitava in modo perfetto una vera arnia”.
Secondo Diodoro, il santuario fiorì soprattutto dopo la
conquista romana;
quando i consoli, i
generali, e tutti coloro che rivestono una grande carica
arrivano in Sicilia,
passano da Erice, onorano il tempio di Venere con
sacrifici ed offerte,
spogliandosi delle insegne della loro dignità, si danno ad allegri godimenti
con le donne, ritenendo di rendersi così gradi alla dea”.
Accenna quindi alla prostituzione sacra, tipica delle
divinità di origine orientale e diffusa anche in ambiente fenicio.
Il culto della dea, come quello in origine di Astarte a
cui era dedicato il tempio con i cartaginesi, si svolgeva su un altare
all’aperto, senza sacrifici cruenti.
Le colombe sacre alla dea e rappresentate insieme alla
stessa dea nelle monete di Erice datate V secolo a.C., sarebbero scomparse una
volta all’anno per 9 nove giorni,
era le festività degli “Anagogia e Katagogia” e
l’intervallo di tempo che separava le due festività, era ritenuto come il
viaggio di Afrotide verso il santuario gemello di Astarte, che sorgeva a Sicca
Veneria, in Africa Settentrionale.
Un fenomeno che ribadiva l’antica protezione verso il
mondo fenicio e cartaginese.
litra di Eryx
Bellissima Anfora del IV
secolo a.C.
Opera del “Pittore di Afrotide”
Collocazione: Museo
Archeologico di Paestum.

La figura rappresentata è Afrodite,
dea della fertilità, e richiama il suo arrivo
sull'isola di Cipro: al suo
passaggio la vegetazione esplode rigogliosa.
La dea è circondata da due eroti con
ali di colomba.
Il senato romano impose
a 17 città siciliane di versare un’offerta di corone d’oro al santuario e creò
anche un corpo di guardie speciali costituito da 200 schiavi armati che si
chiamavano “venerii”.La venerazione
particolare dei Romani, testimoniata tra l’altro da iscrizioni con dedich3e
d’età repubblicana, non impedì la decadenza del santuario.In età augustea era
ormai abbandonato, come ricorda Strabone e con Tiberio fu iniziato un restauro
che fu completato solo da Claudio secondo le fonti di Tacito e di Svetonio.Questa fu l’ultima
citazione mentre la data della sua completa distruzione è sconosciuta.
Probabilmente i materiali furono impiegati nella costruzione del castello.
......................
Ritornando alla
prostituzione sacra c’è da dite che fu
presente anche nel territorio abruzzese e nella popolazione dei Peligni (un
piccolo popolo italico di lingua osco-umbra, storicamente stanziato nel I
millennio a.C. nella valle Peligna in Abruzzo).
Un’iscrizione del II – I
secolo a.C. trovata su una tomba nel 1877 riportava la presenza di “un incaricata
delle prostitute “ (“pristafalacirix” in lingua peligna) con una carica
religiosa simile a quella esistente
nella città di Corinto.
Popolazioni dell’Abruzzo
Presso il popolo dei
Marrucini (sempre di lingua osca-umbra, ma rispetto ai Peligni erano stanziati
lungo una parte della costa adriatica dell’Abruzzo) era presente la
prostituzione sacra come testimonia la “Tabula Rapinensis” relativa alla città
di Rapino (Chieti).“Tabula” che fu scoperta
nel 1841 e databile al III secolo a.C. e che riportava, secondo alcune interpretazioni,
una legge che istituiva e regolamentava la stessa prostituzione sacra.
Tabula rapinensis (Tavola di
Rapino), una legge sacra incisa su una lamina bronzea del
prostituzione
sacra.
Il culto
di Giove è attestato anche dalla raffigurazione sulla preziosa gemma
in diaspro esposta vicino alla Dea di Rapino e rinvenuta nella stessa grotta.La Tavola di
Rapino, di cui si ha notizia sin dal 1841, fu pubblicata per la prima volta
da Mommsen nel 1846, che ne propose l’acquisto al Museo di Napoli. Fu
poi invece acquistata per l’Antikensammlungen di Berlino, da cui scomparve per
le vicende della II Guerra Mondiale. Si troverebbe, secondo alcune notizie non
confermate, presso il Museo Puskin a Mosca.
La cosiddetta “Dea
di Rapino” è una piccola statuina in bronzo raffigurante una divinità
femminile databile, secondo alcuni, all’Età arcaica (VI sec. a.C.) o, più
probabilmente, come sostenuto più recentemente da altri studiosi, all’età
ellenistica (III-I sec. a.C.). Indossa una lunga veste coperta da un mantello ed
ha i capelli raccolti in una lunga treccia. È forse una riproduzione
miniaturistica di una più grande statua di culto che rappresentava la Dea
Madre, divinità legata ai cicli naturali della terra, come indica anche la
focaccia con spiga che regge con la mano sinistra, oppure riproduce
semplicemente una figura di offerente.
la Dea di Rapino
A Gravisca, che fu porto di Tarquinia (Viterbo) già dal
VI secolo a.C., originato come emporio greco, si sviluppò il culto di Afrodite,
conosciuta presso gli Etruschi con il nome di Turan. Qui erano presenti anche
altri templi tra cui quello di Era e Demetra (in etrusco Uni e Vei) ed un
importante culto di Adone. Dagli scavi dell’area di Gravisca provengono alcuni
elementi come tavolette con raffigurazioni di donne nude e iscrizioni con
epiteti riconducibili alle ierodule, che consentono di indicare la presenza di
prostitute sacre.
Santuario di Gravisca
Ex voto dal santuario di
Gravisca
A Pyrgi, attuale Santa Severa (Roma), porto di Caere
(Cerveteri), la ricchezza del santuario emporico era tale che portò Dioniso I
di Siracusa a depredarlo nel 384 a.C. Qui nel V secolo a.C. venne ampliata
l’originaria area sacra con la costruzione di un nuovo tempio, dedicato,
secondo quanto indicato da Strabone, ad Ilizia-Leucotea (identificabili con
Era-Mater Matuta) accanto al tempio più antico (del VI secolo a.C.) consacrato
ad Uni-Astarte. Scavi in un sacello posto tra le due strutture templari hanno
portato al ritrovamento nel 1964 delle famose lamine di Pyrgi, in oro, sulle
quali compare un testo bilingue in fenicio ed etrusco. La prima lamina, scritta
in fenicio, riporta una dedica ad Astarte, mentre sulle altre, in etrusco,
viene riportata la fondazione di un culto e lo svolgimento di un rituale. Alcuni autori antichi citarono le “scorte
Pyrgiensia” (prostitute di Pyrgi) e una prova archeologica di
questa indicazione può essere legata alla presenza nell’area sacra di un edificio
con circa 20 camere con altari per i sacrifici nell’area antistante, molto
simile alla stoà di Centocamere trovata a Locri Epizefiri, che poteva essere
usato dalle ierodule per accogliere i fedeli.
Pyrgi – Area Archeologica
Pyrgi
Santuario
Antefissa a testa di
acheloo
(divinità fluviale con la raffigurazione di un toro)
530/520 a.C.
Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia (Roma)
Acroterio configurato a guerriero
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek.
Le tre lamine d’oro del VI secolo
a.C.,
con la stessa iscrizione in etrusco
e punico, rinvenute a Pyrgi
Furono trovate nel 1964 e
la loro scoperta destò molto entusiasmo nel mondo
scientifico. Si trovavano
tra il materiale di scarico proveniente
da un recinto posto tra
i due templi dell’area
archeologica. Tre lamine d’oro, accuratamente arrotolate,
due delle quali
incise con scritte i lingua etrusca e
l’altra in lingua fenicia arcaica.
Attorno alle lamine vi
sono una serie di piccoli fori che
permettevano di
collocarle alle porte di uno dei due templi (erano più
vicine al tempio B) con dei
chiodini, in parte
ritrovati, in bronzo e con la testa d’oro.
I due testi più lunghi, una lamina con iscrizione in
etrusco di 16 righe e 36 o 37 parole e l’altra di 10 righe in fenicio, sono
quelle con le maggiori somiglianze. La terza lamina, in etrusco e in 9 righe,
riassume brevemente le dedica.
Si tratta di un’iscrizione sacra che testimonia la
consacrazione di un piccolo tempio alla dea etrusca Uni (Giunone), assimilata
alla fenicia Astarte, da parte di Thefarie Velianas, supremo magistrato
(lucomone) della città di Caere.
Il testo in fenicio fornisce le motivazione della
consacrazione (Thefarie Velianas, principe/tiranno di Cere, rende omaggio alla
dea per la sua posizione di vertice nel governo cittadino), mentre quello
etrusco sembra dare un maggiore risalto al cerimoniale del culto. La terza
lamina, quella più breve, riassume brevemente la dedica.
Secondo gli studiosi i due testi corrispondono tra loro
ma non sono l’esatta traduzione l’uno dell’altro e i contenuti della lamina in
lingua punica presenta alcuni punti oscuri che ne limitano la perfetta
conoscenza.
Anche
tra i Sabini, nella città di Curi, si consacrava al dio Quirino la più bella e
nobile delle fanciulle della città che diventava danzatrice e prostituta del
dio. É probabile che queste pratiche religiose venissero assorbite dai popoli
indigeni attraverso l’influenza etrusca e greca.
Cures Sabina
In ambito romano abbiamo alcune testimonianze che
sembrano provare la presenza della prostituzione sacra a Roma. Attraverso
l’analisi di alcune festività del calendario romano si è visto come precisi
elementi cultuali possano identificarsi come riflesso di una antica pratica
della prostituzione sacra. È il caso ad esempio della festa delle Nonae
Caprotine che si celebrava il 7 luglio. Il nome di Nonae Caprotinae deriva dal
fatto che le donne in quel giorno eseguissero un sacrificio a Iuno Caprotina sotto
un caprifico (fico selvatico). Il Racconto leggendario all’origine della festa
narrava che dopo la ritirata dei Galli, che avevano invaso la città, Roma non
si era ancora ripresa e rimaneva indifesa contro l’aggressione dei popoli
vicini. Questi minacciavano guerra se i Romani non avessero consegnato tutte le
loro donne. In questa situazione di pericolo una schiava, ricordata con il nome
di Filotide o Tutula, escogitò un piano per salvare la città, e propose che con
altre schiave la lasciassero andare dal nemico vestite come donne libere. Una
volta nel campo nemico avrebbero fatto festeggiare i guerrieri fino a stordirli
e solo a quel punto avrebbero lanciato un segnale ai soldati romani che
sarebbero dovuti intervenire per distruggere i nemici. Il piano riuscì in pieno
e le schiave furono liberate e ricompensate con una dote che permise loro di
sposarsi, e inoltre da quel momento Roma istituì questa festa dedicata alle
schiave chiamata anche ancillarum feriae (festa
delle serve). Infatti in quel particolare giorno le schiave potevano vestirsi
come donne libere e, insieme alle loro padrone, facevano un sacrificio alla dea
sotto un albero di caprifico, albero sul quale, secondo la leggenda, Filotide
si sarebbe arrampicata per dare il segnale ai soldati romani.
Nonae Caprotinae era Giunone, patrona di numerose feste,
che come questa la cui origine risalirebbe al 390 a.C., erano in rapporto con
la fecondità delle donne.
Era (Giunone) Barberini
(Barberini dal nome della
famiglia che possedeva la statua)
Copia romana del II secolo
d.C. di un’originale del V secolo a.C.
attribuito a Agorakritos
Collocazione: Musei
Vaticani – Città del Vaticano
Il termine “Caprotinae” sarebbe legato all’agricoltura
romana in quanto coincide con la “caprificatio”, periodo dell’anno in cui si
fissavano rami di fichi selvatici a quelli coltivati per favorirne
l’impollinazione.Il termine sarebbe anche collegato al capro (becco)
(“caper”), comunque sia il fico selvatico che il capro erano considerati
simboli di fecondità.Il sacrificio che le donne libere compivano sotto il
fico selvatico consisteva nell’offrire a Giunone Caprotina il succo che
gocciava dai rami e dai frutti dell’albero stesso.Le
schiave invece, per tutto il resto della giornata, si vestivano da matrone e si
divertivano a correre e a simulare combattimenti tra di loro sia a mani nude
che lanciandosi delle pietre.Alcuni storici hanno voluto vedere in questa festività
romana elementi caratteristici della prostituzione prenuziale nella quale la
prostituzione appunto, oltre alla vittoria di Roma, portò queste serve al
raggiungimento di una dote ed al successivo matrimonio. Ulteriori tracce di
ierodulìa nella tradizione romana emergono inoltre dai racconti mitici che
narrano di incontri sessuali tra donne e membri virili apparsi dal nulla, come
nel caso della nascita del re Servio Tullio, frutto dell’unione della madre
Ocrisia, schiava del re Tarquinio Prisco, con un fallo comparso tra le ceneri
del focolare.
Altre prove sarebbero legate alla festa di Anna Perenna
che si svolgeva sulle rive del Tevere ed era caratterizzata da rituali
orgiastici, nei Floralia in cui le prostitute si spogliavano ritualmente su
richiesta dei partecipanti ed eseguivano sfrenate danze, e ancora nei Vinalia
dedicati a Venere e svolti nel tempio di Porta Collina nel quale si portavano
doni a Venere Ericina, e dove le donne, non quelle sposate o libere, venivano
scelte dagli uomini.
Bona Dea
Durante la festa della Bona Dea si svolgevano invece vere
e proprie orge rituali, che rappresentavano dei matrimoni sacri nei quali si
prostituivano donne di nobili natali ed erano tenute in grande
considerazione.
Bona Dea
Statua in marmo con
epigrafe
Bona
Dea-II-III sec., iscrizione
Ex visu iussu Bonae
Deae Sacr (um) Callistus Rufinae N(ostrae) Act(or)
“Callistus schiavo alle
dipendenze di Rufina in veste di actor (avvocato o tesoriere),
ha dedicato questa
statua alla Bona Dea, in seguito ad una richiesta della dea stessa,
che gli è comparsa in
sogno”
Collocazione: Collezione
privata
Il termine Bona Dea aveva il significato generale di
Grande Madre e si venerava un’antica divinità laziale, il cui nome non poteva
essere pronunciato.
In origine fu un appellativo della dea romana Fauna che
formò insieme a Faunus (suo marito e fratello) una delle più antiche coppie di
dei indigeni del Lazio.
Bona Dea Fauna era stata, come Fauno, una divinità della
pastorizia e dei boschi e venne anche indicata con il nome di “Fatua”, dea che
predice l’avvenire.
Dal suo culto erano esclusi gli uomini così come a quello
rivolto a Fauno erano escluse le donne.
Ben presto sull’epiteto di Bona Dea venne ad innestarsi
il culto di una divinità greca che fu introdotta in Roma dalla Magna Grecia e
così la nuova figura fece dimenticare l’antica dea.
La dea greca che assunse a Roma il nome di Bona Dea fu
Damia, una divinità venerata specialmente nell’Argolide, a Egina, a Sparta, a
Thera, e in Italia in particolare a Taranto.
Secondo alcuni storici sarebbe la Giunone venerata a
Cartagine.
Anche per il culto di Damia potevano partecipare solo le
donne e le cerimonie venivano eseguite con gli occhi chiusi ed al buio
(duravano nove giorni e nove notti).
Ritornando al culto della Bona Dea, secondo la versione
di Lattanzio (scrittore, apologeta romano di fede cristiana; Africa 250 circa /Gallie,
dopo il 317) era la moglie di Fauno. Una donna molto abile in tutte le arti
domestiche e molto pudica, al punto di non uscire dalla propria casa e di non
vedere altro uomo che suo marito.
Un giorno trovò una brocca di vino. Cominciò a bere la
bevanda fino al punto di ubriacarsi.
Sua marito la castigò con verghe di mirto ma con tanta
inaudita violenza da procurargli la morte. Infatti l’uso del mirto era vietato
nei templi a lei dedicati.
Fauno si pentì del misfatto e deplorando la morte della
sua sposa, la pose nel numero degli Dei.
Un’altra versione del mito recita come la donna cercò di
sfuggire alle pretese sessuali di Fauno (che in questo caso era il padre) e lui
la colpì con i rami di mirto. La costrinse a bere del vino e riuscì alla fine a
possederla dopo essersi trasformato in serpente.
Sulla figura della Dea Bona tante leggende, qualcuna
immortalata nella pittura di famosi artisti, ed anche violenze e vendette
maturate sulle sponde del Tevere.
Ancora prima della nascita di Roma, sui colli erano
presenti delle divinità tra cui Ercole al tempo del mitico re Evandro.
Ercole sui Colli si sarebbe scontrato con il gigante Caco che era dedito alla rapina e
che viveva in una grotta dell’Aventino.
Dopo aver ucciso il gigante, Ercole stanco ed assetato,
si mise alla ricerca di una fonte. Giunse in un bosco in cui si trovava il
santuario della Dea Bona da dove giungevano delle risate di fanciulle.
S’avvicinò al santuario e chiese dell’acqua ma la vecchia sacerdotessa lo
allontanò in modo scortese dichiarando che la sacra fonte era riservata alle
donne.
Ercole non reagì alla scortesia e si vendicò
dell’affronto subito quando eresse l’Ara massima nel Foro Boario dove il suo
culto era interdetto alle donne:
“affinché in eterno la sete di Ercole non resti invendicata”,
(elegia di Properzio)
La dolce e sfortunata Fauna,, una volta divinizzata, diventò
il simbolo del chiuso mondo muliebre, tutto legato alle eterne vicende della
vita femminile, dalla castità prenuziale all’iniziazione sessuale ed alla
maternità.
Il suo santuario si trovava in un bosco sacro sulle pendici
dell’Aventino Piccolo ed Ovidio lo citò nei suoi “Fasti”: “È un nativo dirupo il suo luogo; la realtà ne suggerì il
nome: / lo chiamano infatti Sasso, ed è parte cospicua del monte”. Per
questo motivo venne anche chiamata “Subsaxana” dal termine “saxum” (sasso).Nel
santuario, come detto precluso agli uomini, erano allevati dei serpenti
domestici, come avveniva anche in altri templi di dee che erano legate alla
fecondità ed alla salute.Il
tempio sorgeva nei pressi del luogo dove oggi si trova la chiesa di santa
Balbina. Vi veniva celebrata una festa il primo maggio e in quell’occasione si
sacrificava una scrofa gravida.La
data aveva una sua funzione perché doveva ricordare l’anniversario della
fondazione del tempio che, secondo Ovidio,
le era stato dedicato da una vestale.La
vestale sarebbe stata Claudia Quinta, la stessa che aveva accolto a Roma
la Magna Mater.Nata
nel III secolo a.C. di lei non si conoscono le date di nascita e di morte. Una
delle poche citazioni fa riferimento ad Ovidio che la descrisse come donna
virtuosa e di bell’aspetto. La sua reputazione era ingiustamente colpita per il
suo abbigliamento e portamento. La donna era stata falsamente accusata di essere
una pettegola.La
sua virtù fu riscattata da un evento miracoloso avvenuto nel 204 a.C. quando il
simulacro della Magna Mater (Cibele) fu trasportato in nave da Pessinunte a
Roma-La
nave giunta nell’alveo del Tevere s’incagliò e la donna con le sole sue forze
riuscì a disincagliarla grazie all’aiuto della stessa dea.In
questo modo fornì al popolo romano il grande segno della sua purezza. Un
episodio che rimase impresso nei ricordi dei romani tanto che venne più volte
rappresentato in teatro come racconta lo stesso Ovidio.Come
mai il simulacro si stava trasportando a Roma?Nel
205 a.C. la repubblica romana decise d’incorporare il culto della Grade Madre o
Culto di Cibele e decise di spostare il simulacro da Pessinunte, una città
tempio posta nella regione più orientale dell’Asia minore sotto il dominio
romano.Funo
spostati dalla città sia il simulacro e la grande pietra nera, che si diceva fatta
cadere dalla stessa Cibele. Questo spostamento era legato allo scopo di
garantirsi i favori della popolazione locale durante la seconda guerra punica
dato che Annibale ed i suoi cartaginesi si lasciavano andare a spietate razzie.
Claudia Quinta riesce
da solo a disincagliare l’imbarcazione
(Artista: Lambert
Lombard
Liegi, 1505 –
Liegi, 1566
Pittura: olio su
tela- Datazione: ?
Dimensioni: (1,39
x 1,69) m – Collocazione: Chiesa di St. Armand a Stokrooie
Claudia Quinta
Artista: Neroccio
di Bartolomeo de’ Landi
(Siena, giugno
1447 – Siena, 1500)
Dipinto: Olio su
tela ? – Datazione: 1490 circa
Misure: (1,05 x
0,46) m
Collezione: Andrew W. Mellon collection
National Gallery
of Art – Washington
Nel Museo della
centrale Montemartini c’è un altare in rilievo marmoreo di
età claudia (14
a.C. – 68 d.C.) dedicato alla Dea Madre e alla “navis salvia” e
raffigurante l’arrivo
della dea Cibele a Roma in nave.
La dedica presente
sull’altare allude alla leggenda legata
alla donna della
onorata famiglia
Claudia. Si tratta di un altare in rilievo in marmo che
fu scoperto sulla
riva del Tevere, sotto l’Aventino e durante il pontificato di
Clemente XI, in un
periodo compreso tra il 1700 ed il 1721.
La facciata
dell’atare reca un iscrizione dedicatoria e un’allusione all’arrivo
in nave a Roma
della dea Cibele.
Sulla faccia
posteriore dell’altare ci sono due flauti, mentre il lato destro haun “pedum” e un
piatto mentre il sinistro un berretto frigio.Tutti simboli
riferiti alle origini di Cibele e al suo collegamento con il culto associato
di Attis.
L’immagine
centrale è una piccola nave con un pennacchio di poppa
ricurvo e una prua
a voluta. La dea in trono al centro dovrebbe essere
immaginata
all’interno dell’edicola che si trova alle sue spalle.
È completamente
avvolta in un velo, chitone e himation con una mano
appoggiata sul
ginocchio e un’altra sollevato sul timpano.
Attorno all’argano
a prua, è avvolto una breve fune la cui estremità cade
leggermente dalla
mano di una donna posizionata obliquamente alla
parte anteriore
della barca. La donna è posizionata su una piattaforma
sporgente. Ha in
testa un velo e indossa un chitone avvolto strettamente
sul petto e
allacciato allo stesso modo di quello indossato dalla dea, ma il suo
mantello è avvolto
in modo sciolto sul braccio libero.
L’iscrizione
dedicatoria nomina la dea e dà anche un nome alla nave
matri.deum.et navi salviae
salviae voto suscepto
claudia synthyche
d. d.
Alla
madre degli dei e alla nave salvia
Come in un voto fatto a Salvia
Claudia Syntyche
dedica questo dono
La dea Cibele
rinvenuta ad Osta
Museo di Napoli
La dea siede in
trono con alta spalliera, bassi braccioli e gambe quadrate,
e poggia i piedi
su un suppedaneo con sostegni a zampe di leone.
Veste una lunga
tunica altocinta e calza sandali; un himation le copre
le spalle, scende
sulle braccia e sulle gambe, dove si distende in ampie pieghe orizzontali. Ai
lati del trono, due leoni accovacciati poggiano l'uno la gamba destra, l'altro
la gamba sinistra sul poggiapiedi della dea. La mano sinistra della dea con il
tympanum appoggiato al bracciolo del trono e la testa, dai cappelli raccolti
dietro la nuca con scrimitura centrale e con corona turrita, sono frutto di un
restauro operato probabilmente tra il XVII ed il XVIII secolo, certamente prima
del trasferimento della scultura dalla guardaroba del Palazzo Farnese alla
Villa della Farnesina; la mano destra Ë stata invece integrata a Napoli, dopo
il 1805.
l'iscrizione:
Virius Marcarianus v(ir) c(larissimus) deam Cybelen p(ecunia) s(ua).
Alta: 98 cm
Marmo banco
/scalpellatura e levigatura
Dara di creazione:
140 d.C. – 160 d.C.
Il
tempio della Dea Bona venne poi restaurato da Livia, la moglie di Augusto, come
riportò Ovidio: “Lo dedicò la erede dell’antico nome dei Clausi, / che mai
aveva sopportato uomo con il virgineo corpo. / Livia lo restaurò affinché non
restasse non imitato / lo sposo, ed ella lo seguisse in ogni sua iniziativaAi
primi di dicembre si celebrava un culto misterico privato, riservato alle donne
più influenti della città e che si svolgeva in casa di un alto magistrato della
città (console o pretore), sulla quale ricadeva la benedizione della dea.La
cerimonia si svolgeva di notte ed era prevista
l’assistenza di vestali. La casa prescelta veniva addobbata di tralci
d’uva, altre piante e fiori, escluso il mirto. Si faceva venire il vino, che era chiamato “lac”
(latte) e il recipiente che lo conteneva “mellarium” (vaso di miele).Tutti gli uomini presenti nella casa la dovevano
abbandonare e in, poche parole, anche i bambini ed i neonati. Gli uomini aspettavano la fine del rito presso
le case di amici e parenti consapevoli che quel rito era sacro e quindi non si
doveva infrangere la regola.Eppure
avvenne un fatto strano perchè un uomo osò infrangere la regola: Publio Clodio
Pulcro.La
notte tra i 4 ed il 5 dicembre del 62 a.C., il rito doveva svolgersi nella casa
di Giulio Cesare, pontefice massimo e neoeletto pretore. La dimora era quella
“Regia”, in origine dimora dei re e poi dei pontefici massimi, i cui resti si
notano lungo la via Sacra del Foro Romano, vicino alla Casa delle Vestali.
sulla destra la Regia
Clodio
aveva trentun’anni ed era all’inizio della sua carriera politica. Il suo
obiettivo era diventare tribuno della plebe e per questo motivo aveva
modificato anche il suo nome aristocratico “Claudius” nella variante plebea
“Clodius”.Era
fratello della bellissima e spregiudicata Clodia che fu più volte citata da
Cicerone e da identificare probabilmente con la Lesbia cantata da Catullo.
Publio Clodio Pulcro
Clodia , sorella di Clodio e amante di CatulloPer quale motivo Clodio s’introdusse nella casa di Cesare
in modo furtivo ?I rapporti con lo stesso Cesare erano ottimi oppure c’era una relazione clandestina con la
padrona di casa Pompea ?Accettata quest’ultima versione il momento per un azione
simile non era molto opportuno.
Pompea Silla, seconda moglie di
Giulio CesarePompea ritratta
nel "Promptuarii Iconum Insigniorum" del 1553
Clodio
riuscì ad entrare nella casa di Cesare, trasvestito da suonatrice d’arpa e
grazie alla complicità d’una schiava. La luce tenue delle lucerne favorì il suo
piano.
Durante
il il lectisternium, cioè il
solenne banchetto così chiamato perché le immagini sacre della dea erano
adagiate sui letti rivestiti di preziosi tessuti, l’austerità del rito lasciava
il posto a un po’ di conversazione tra le presenti, che potevano scambiarsi le
loro confidenze.
Qualcuna
di loro rivolse probabilmente la parola
al travestito, che, rispondendo, si sarebbe tradito con la voce. Subito Aurelia, madre di
Cesare e suocera di Pompea, lanciò l’allarme e le presenti, troppo sopraffatte
dall’orrore del sacrilegio, non riuscirono a impedire la fuga della falsa
suonatrice.
La voce si sparse subito per la città. Nella dea Bona era
stato colpito qualcosa di assai profondo, un sentimento
sacro, antico come la città stessa. La dea Bona era
stata per un seguito ininterrotto di generazioni il nume tutelare delle donne
romane e delle loro virtù più tradizionali, come la castità, la maternità e
l’operosità, e quindi veniva con quel gesto offesa la pietas femminile.
Cesare ripudia
Pompea e sposa Calpurnia
Incisione del 1780
di Claude Nicolas Malapeau,
da un dipinto di
Pietro da Cortona
Si narra che Cesare
abbia ripudiato la moglie Pompea con la celebre frase:“la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni
sospetto”Lo
scandalo con conseguente processo colpì la città.Un
processo lungo con numerosi avvenimenti procedurali e pressioni politiche che
iniziò nel mese di maggioClodio
presentò un alibi dichiarando che quella notte non si trovava a Roma ma a
Terni.Cicerone
diede un forte colpo a questo alibi dichiarando che quella sera Clodio gli
aveva fatto visita a Roma poco prima dell’introduzione di Clodio nella casa di
Cesare.Cicerone
forse non voleva intromettersi in questa
vicenda giudiziaria e dichiarò la verità.Clodio
capì subito che il suo alibi era in discussione , preso dall’ira, apostrofò con
derisione l’oratore romano comeColui che sapeva
tutto(una frase che
aveva tratto da un orazione di Cicerone contro Catilina)Naturalmente
Cicerone fu chiamato a deporre contro Clodio.Il
processo finì con l’assoluzione di Clodio e in realtà dietro a questa sentenza
ci furono delle ripetute minacce di violenza e ricatti vari nei confronti dei
giurati.Giurati
che, impauriti, preferirono scegliere la via della non colpevolezza passando
per 31 voti contro 25.Clodio
quando divenne tribuno della plebe, si vendicò dell’affronto subito da Cicerone
ritorcendogli contro proprio quello che era stato il suo maggior titolo di merito,
cioè la repressione della congiura di Catilina, che
aveva comportato l’esecuzione sommaria di cittadini romani con una procedura al
limite della legalità.Cicerone
del 58 a.C. fu costretto all’esilio. La sua casa sul Palatino fu rasa al suolo
e al suo posto Clodio ebbe la forza di far erigere un tempio dedicato alla
Libertà.La
Bona Dea compì la sua vendetta perché la sera del 20 gennaio del 52 a.C. il
cadavere di Clodio venne portato a Roma dal senatore Sesto Fulvio. Il senatore
trovò il corpo di Clodio, ferito a morte, sulla via Appia vicino a “Bovillae”.Per
uno strano gioco del destino, Clodio fu ucciso dagli uomini del suo avversario
politico Annio Milone (secondo quando riferì Cicerone), proprio sui gradini di
un piccolo tempio dedicato alla dea Bona. L’onore delle donne romane aveva
trovato la sua definitiva giustizia.
La Via Appia
Antica
Apoteosi di Omero
Opera di Archelao
di Priene su richiesta di un poeta
Αρχέλαος, Archelaos
(Priene, II secolo a.C. - ?, II secolo a.C.)
Originariamente
era posto sulla Via Appia..... ora al British Museum ?????????
Primo Livello:
Omero seduto su un
trono; dietro di lui, Oikoumene (Arsinoe III?) e Cronos (Tolomeo
IV?); accovacciati accanto al trono, l'Iliade e l'Odissea;
a sinistra
dell'altare, il Mito (da bambino);
a destra
dell'altare, da sinistra a destra, Storia, Poesia, Tragedia e Commedia, poi
Natura (Physis), Virtù (Arete), Memoria (Mneme), Buona Fede (Pistis), Saggezza
(Sophia).
Livello superiore:
Zeus;
livelli intermedi:
Muse.
Davanti ad Omero,
Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati
benevolmente dai
geni produttori della poesia. Sopra di loro si erge il
Monte delle Muse.
Nella grotta risiede Apollo con la lita ed è avvicinato
da una Musa che
gli porge un papiro contenente l’opera del poeta che ha
commissionato il
bassorilievo. Poeta che è rappresentato da una
statua posta a
destra della grotta. Sulla statua ci sono dei segni.
Chi è questo
committente ?
Si tratta di un
poeta che con molta probabilità fu il vincitore dell’agone
(competizione)
poetica e offerente l’ex voto.
Infatti alle sue
spalle è posto il tripode della vittoria.
Le restanti Muse
si pongono a sinistra della grotta, con
un atteggiamento
calmo che,
risalendo verso la vetta del monte, si trasforma in una danza in
onore di Zeus
collocato sulla cima del monte. Zeus ha il volto rivolto verso
Mnemosyne, la
madre delle Muse.
Materiale: marmo –
Datazione: 225/205 a.C.
Misure: 1,18 m
Collezione:
British Museum
Un opera
stupenda che dal 1805 ha lasciato
l’Italia...
Una delle grandi
opere perdute.... vergogna
È
da un terreno posto nel territorio di Albano Laziale, vicino ai resti
dell’antica “Bovillae” che fu trovata un antichissima statuetta marmorea della
dea. Una statuetta di cui si erano perse le tracce e raffigurata in un disegno,
risalente all’Ottocento, riprodotto nell’antico “Bollettino Archeologico
Comunale”.
È
ricomparsa qualche anno fa nel mercato
dell’antiquariato e si trovava nella collezione di Ettore Roesler Franz, morto
nel 1907, e dei suoi eredi
Bona Dea disegno del 1879 del Bollettino Archeologico
Comunale
Statuetta di Dea Bona con cornucopia e serpente,
I-II sec. Museo Barracco
È
una piccola scultura votiva, alta 45,6 cm, con l’iscrizione dedicante. La dea è
raffigurata seduta in trono, con la gamba sinistra più avanti rispetto
all’altra, e con la cornucopia appoggiata al braccio sinistro.Il
braccio destro è mancante e doveva recare probabilmente un attributo e cioè una
patera nella quale si abbeverava un serpente avvolto attorno all’avambraccio.Il
serpente fu citato da Macrobio nella sua descrizione iconografica della dea.Indossa
un chitone, allacciato sotto il seno da una cintura, e un mantello panneggiato.
La testa è separata dal collo da una linea di frattura
presente alla base del collo ed è di marmo più compatto. La pettinatura è a
larghe bande ondulate che si ritrova in iconografie femminili nel III secolo d.
C. mentre il corpo sembra databile alla seconda metà del II secolo d.C. L’iscrizione,
disposta su tre righe (sulla base e sulla pedana),:Ex visu iussu Bonae Deae /
sacr(um) / Callistus Rufinae n(ostrae) actor“In sogno, per suo
ordine, Callisto, amministratore della nostra Rufina, ha consacrato (questa immagine)
alla Bona Dea”. La
dea era apparsa in sogno a Callisto chiedendogli un simulacro.Apparire
in sogno è una manifestazione tipica delle divinità oracolari che, attraverso
di esso, manifestano i loro desideri e volontà, come pure la diagnosi in caso di
malattie. Per questo motivo la dea era anche chiamata “fatua”, cioè “parlare”
alludendo alle sue capacità divinatorie.Questa
statuetta era probabilmente collocata in un sacello che fu citato da Cicerone
nell’omicidio di Clodio e riproduceva la statua originale di culto che si
trovava nel santuario posto sul Piccolo Aventino. Per il resto non ci sono
altri riferimenti se non che il santuario si trovava in un luogo ricco di grotte
e sorgenti.Nonostante
la ricchezza delle fonti letterarie (in gran parte legate allo scandalo del 62
a.C.) ed epigrafiche relative al culto, la documentazione archeologica sulla
Bona Dea è scarsa, a eccezione di due santuari rinvenuti a Ostia antica, uno
presso Porta Marina e uno in via degli Augustali, che dovevano però essere luoghi
di culto privato.
Ostia,
Santuario di Bona Dea in via degli Augustali
Acca LarentiaUn altra tradizione sembra ricollegarsi all’antico
costume della prostituzione sacra a Roma e si tratta del racconto leggendario
di Acca Larentia. Nella tradizione letteraria questa figura mitica non ha
un’unica storia ma due diverse versioni riferite da Plutarco (Plut. Rom. 4):“Secondo
altri fu un equivoco sul nome della nutrice [di Romolo e Remo] ad avviare il
racconto verso la favola, e precisamente il fatto che i Latini chiamavano lupa
tanto le femmine dei lupi, quanto le donne prodighe delle loro grazie, quale la
moglie di Faustolo, che allattò i due gemelli. Il vero nome di costei era Acca
Larenzia, e i Romani fanno dei sacrifici in suo onore; ad aprile il sacerdote
di Ares versa per lei delle libagioni durante una festa chiamata Larenzia.” L’altra versione (Rom. 5), più articolata:“Un’altra
Larenzia si onora a Roma, per il seguente motivo. Pare che un giorno il
sacrestano del tempio di Eracle, non sapendo cosa fare per passare il tempo,
proponesse al dio una partita a dadi col patto che, se vinceva, gli avrebbe
fatto una grossa grazia, se perdeva, egli gli avrebbe procurato un lauto pranzo
e una bella donna con cui passare la notte. Con questa posta gettò i dadi,
prima per Eracle e poi per sé. Beh, rimase battuto; ma aveva dato la parola e
ritenne doveroso attenersi ai patti. Apparecchiò un pranzo per il dio e assoldò
Larenzia, che, sebbene non fosse ancora famosa, era pure un fior di donna, la
fece cenare nel tempio e dopo mangiato ve la rinchiuse, non senza aver
apprestato il giaciglio, come se Eracle dovesse venire a goderla. Dice la
storia che il dio venne davvero, abbracciò la donna e alla fine le comandò di
recarsi la mattina per tempo al mercato e di salutare il primo uomo che
incontrava, stringendo amicizia con lui. Così fece Larenzia. L’uomo incontrato
al mercato era un cittadino anziano, che aveva messo da parte una discreta
sostanza, senza figli come pure senza moglie, di nome Tarruzio. Egli si prese
nel letto Larenzia e ne rimase tanto soddisfatto, da lasciarla alla sua morte
erede di molti e grandi beni, che ella in gran parte donò poi per testamento al
popolo, quando, famosa ormai e assai venerata per esser stata amata da un dio,
disparve nel medesimo luogo dov’era sepolta la prima Larenzia.”
Acca Larenzia
Artista: Jacopo di Pietro
d’Agnolo di Guarnieri
detto Jacopo della Quercia
(Siena, 1374 circa –
Siena, 1435)
Datazione: 1414 – 1418
Materiale: Marmo della
Montagnola Senese - Altezza: 1,65 m
Collocazione: Complesso
Museale di Santa Maria della Scala – Siena
Romolo e Remo trovati da
Faustolo
Artista: Pietro Berrettini
detto Pietro da Cortona
Cortona, 1 novembre 1596 –
Roma, 16 maggio 1669
Pittura: olio su tela –
Datazione 1643 circa
Misure: (2,51 x 2,66) m – Collocazione: Museo di Louvre, Parigi
La seconda tradizione riportata da Plutarco lascia
ipotizzare, attraverso il racconto mitico, la presenza a Roma della
prostituzione sacra, connessa al culto di Ercole identificato con il fenicio
Melqart.
Il santuario
emporico, sorto probabilmente già prima della fondazione di Roma, si trovava in
prossimità del guado del Tevere, dove passavano le via commerciali che dalle
saline alla foce del fiume proseguivano verso l’entroterra, e dove sorgeranno
l’Ara Massima di Ercole e il Foro Boario. Nel racconto compaiono altri elementi
importanti che consentono di decodificare la verità inserita nella leggenda,
come il gioco dei dadi con la divinità che è riconducibile ad antiche pratiche
divinatorie praticate in Oriente, oppure la cena preparata per il dio che trova
riscontro nei rituali per l’Ercole italico venerato dai commercianti, e infine,
l’unione sessuale tra dio e prostituta che è chiara prova della prostituzione
sacra. Da altri autori antichi come Macrobio e Aulo Gellio Larenzia era
indicata come nobilissimum scortum, cioè
nobilissima prostituta che divenne ricchissima con il suo esercizio. È
probabile che il titolo di nobilissima attribuito a Larenzia possa derivare
dall’aspetto sacrale della sua funzione. Anche il matrimonio rispettabile alla
fine del suo servizio sacro rientra nelle caratteristiche tipiche della
prostituzione sacra già evidenziate in precedenza per altre aree geografiche, e
sembra inoltre rimandare a quella prostituzione prenuziale diffusa in altri
popoli antichi. Elementi chiave appaiono poi il contesto del santuario emporico
con frequentazioni greche-orientali e l’influsso etrusco indicato dalla figura
di Tarutius, componenti che contestualizzano ancora più chiaramente le influenze
culturali che portarono anche in ambiente romano allo sviluppo della pratica
della prostituzione sacra. (Professore, Gabriele Romano)
Romolo e Remo
Artista: Sebastiano Ricci
(Belluno, luglio 1659 –
Venezia, 15 maggio 1734)
Pittura: olio su tela – Datazione:
1708 circa
Misure: (1,85 x 1,70) m –
Collocazione: Museo
Hermitage . St. Petersburg. Russia)
Acca Larentia sarebbe una figura semidivina che fu
ereditata ai Romani dagli Etruschi come prostituta protettrice del popolo
umile. Secondo una delle tante leggende, al tempo dei re, il custode del tempio
di Eracle sfidò il dio al gioco dei dadi.La posta in palio sarebbe stata una cena e l’etera più
bella. Vinse il dio e il custode rinchiuse, per tutta la notte, Acca Larentia
nel tempio. Il dio Eracle fu grato alla giovane donna per le sue preghiere e le
promise cheIl primo uomo che
incontrerai ti ricompenserà.Fu così che Acca Larentia incontrò l’etrusco, Tarutius,
che colpito dalla bellezza della fanciulla la sposò.Alla morte del marito la donna ereditò una grande fortuna
che donò al popolo romano che per gratitudine istituirono in suo onore una
festa.Feste che furono dette “Accalia o Larentalia” e che si
svolgevano il 23 dicembre nei pressi della sua tomba posta, come dicono le
fonti, dietro il Velabro.
Roma – il Velabro in una
stampa del 1800
Secondo alcuni storici la
tomba di Acca Larentia si doveva
trovare sul sito
dell’edicola di Giuturna
Secondo un ulteriore versione di Lattanzio Acca Larentia
sarebbe la moglie del pastore Faustolo che soccorse i gemelli Romolo e Remo,
fondatori di Roma.
In questa versione la donna assunse anche i nomi di “
Faula o Fabula” e venne detta “lupa”, un termine con il quale i Romani
indicavano le prostitute e dal quale viene il termine “lupanare”.
La donna era madre di dodici figli, e alla morte di uno
di loro, Romolo ne prese il posto dando vita alla “Fratres Arvales” (Arvali,
collegio sacerdotale istituito da Romolo e composto da dodici membri).
Acca Larentia si curò di allattare anche Romolo e Remo che, una volta venuti a conoscenza
della loro origine (figli della vestale rea Silva, discendente dell’eroe
troiano Enea, e di Marte dio della
guerra), decisero di vendicarsi uccidendo lo zio usurpatore Amulio e rimettendo sul trono il nonno
Numitore, legittimo re di Alba Longa.
La lupa che allattò Romolo e Remo sarebbe quindi secondo
alcuni storici identificabile con Acca Larentia per il suo passato di “lupa”
cioè di prostituta.
...........................
Afrotide, dea della bellezza e dell’amore.
Da Inanna..Istar...Astarte ..ad Afrotite...un eroina ?
I romani la identificarono con Venere ed era secondo
Omero la figlia di Zeus e della ninfa Dione.Secondo Esiodo la dea sarebbe nata in primavera dalla
spuma del mare fecondata dai genitali di Urano che Cronos aveva scagliato in
mare dopo la ribellione con il padre.La parola Afrotide deriverebbe dal greco “Afros” cioè
spuma.Nella sua Teogonia Esiodo riportò:i genitali vennero trascinati dal mare per un
lungo periodo e spuma bianca sorse dalla carne immortale; dentro ad essa crebbe
una ragazza che divenne Afrodite”.Quando il sangue di Urano cadde sul mare, l’acqua cominciò a
ribollire e su di una conchiglia, sospinta da Zefiro, emerse Afrotide in tutto
il suo splendore.Zefito l’aveva spinta sulla riva dell’isola di Cipro e da qui
anche gli appellativi dati alla dea di “Anadiomene” (l’emersa) e di “Ciprigna”
da Cipro. Sulla spiaggia giocavano le Ore, figlie di Teti, e quando
videro la dea emergere corsero verso di lei per ricoprirla con dei veli ed
intrecciarle i biondi capelli con corone di fiori.Zeus fu subito colpito dalla bellezza della donna ed
inviò un carro di gemme, tirato da due colombe, per prelevarla ed accoglierla
nell’Olimpo come figlia adottiva, suscitando l’ira e l’invidia delle altre dee.Per ironia della sorte, Zeus le diede come marito
Hefesto, uno degli dei più brutti e non fu un matrimonio felice.Ebbe altre relazioni con la nascita di figli: dal troiano
Anchise ebbe Enea; dal dio Dionisio ebbe Imene, il dio delle feste nuziali; dal
rapporto con Ares nacquero due figli terribili, Eros (amore) e Anteros.I poeti greci raccontarono che quando Afrotide ebbe Erts,
si lamentò con la dea Temi perché il figlio non cresceva.Temi le rispose che il bambino non sarebbe cresciuto fino
a quando non avesse avuto un fratello. Afrotide diede quindi vita ad Anteros che significa
“colui che ricambia l’amore”.Con queste leggenda i poeti misero in evidenza il concetto che l’amore per poter
crescere deve essere ricambiato.La dea portava sul vestito una cintura magica dove erano
raccolti tutti le grazie, il sorriso che promette ogni gioia, i teneri dialoghi
degli innamorati, i sospiri che persuadono e il silenzio espressivo.
La Nascita di Venere
Artista: Sandro Botticelli
(Alessandro di Mariano di
Vanni Filipepi)
(Firenze, 1 marzo 1445 –
Firenze, 17 maggio 1510)
Data: 1485
Tecnica: Tempera su tela –
Misure : (172,5 x 278,5) cm
Collocazione: Galleria
degli Uffizi, Firenze
Gli erano sacri: tra le piante, il mirto, la rosa, il
melo, il papavero mentre tra gli animali, il passero, la lepre, il cigno, il
riccio, il delfino, la seppia, e soprattutto la colomba e la tortora.
Cavalcando una conchiglia Afrotide giunse nell’isola di
Citera.
L’isola era un importante centro di scambi e questo
favorì la diffusione del suo culto in
tutta la Grecia. L’isola era però troppo piccola per contenere la sua bellezza
e quindi attraversò il Peloponneso e finì per stabilire la sua residenza a
Pafo, nell’isola di Cipro.
Un sito che fu la sede principale del suo culto.
Ogni primavera le sue sacerdotesse si bagnavano nel mare
e ne riemergevano vergini.
Su una gemma ritrovata nella grotta Idea si vede incisa
la dea cretese mentre soffia in una conchiglia con un pesce vicino all’altare
(forse un delfino).
Un’altra leggenda narra che al suo passaggio sulla terra
sboccino i papaveri.
Un giorno la dea, volendosi rendere utile, si mise a
tessere ad un telaio.
Fu sorpresa da Atena, dea delle arti, che non capendo il
suo umile gesto, corse subito a lamentarsi con Zeus.
L’arte del tessere era una sua virtù e nessun’altra
poteva prenderle il posto.
Afrotide si scusò con Atena e decise di non lavorare più
al telaio e di dedicarsi solamente a fare innamorare tutti di lei.
Afrotide Cnidia di
Prassitele
Spesso la letteratura storica ha dato un origine
orientale alla figura di Afrotide collegandola alle figure di Inanna, di Istar
e soprattutto di Atagartis (siriaca) e di Astarte (fenicia).
La figura di Astarte è sostanzialmente simile ed
assimilabile a quella di Atargatis anche se con qualche differenza legata alla
provenienza e alla formazione del culto.
Atargatis, nata dall’Eufrate come ci tramanda Igino,
giunse in Siria non dall’area mesopotamica-babilonese ma dall’Anatolia grazie
agli Hittiti.
Poiché il territorio siriano subì l’influenza hittita e quella
babilonese, le due figure finirono per fondersi quasi ovunque mantenendo delle
differenze solo in alcuni luoghi come ad esempio in Ascalona in Palestina.
Qui infatti, come riferisce Luciano di Samosata, si
trovavano templi di entrambe le
divinità.
Astarte – Museo
Archeologico di Siviglia
Bellissima placca votiva
in argilla cotta.
Una donna nuda in
bassorilievo, probabilmente la dea
Astarte.
Parrucca egiziana dipinta
di nero; le mani posizionate sui seni mentre
il foro in alto era per la
sospensione della placca.
Reperto Fenicio della
tarda Età del bronzo (VI secolo a.C.)
Rinvenuto a Tharros
(Sardegna) in una tomba.
Collezione: British Museum
, Londra
Astarte era venerata come la Grande madre da tutte le
popolazioni fenicie ed ebbe tra i suoi maggiori centri di culto Sidone, Tiros,
Ascalona, Byblos e in altri centri fenici del Mediterraneo fra cui Malta,
Tharros in Sardegna ed Erice in Sicilia.
Ad Erice diventò una figura di prima piano nella
religiosità degli Elimi e già intorno al XIII secolo a.C. era esistente un
celebre tempio che diventò famoso in seguito con l’appellativo di “Venere
Ericina” (Sotto il dominio romano).
Nella Sicilia Occidentale Astarte venne rapidamente
assimilata ad Afrotide ed alla Venere Romana.
Diodoro Siculo riportò che Erice, figlio di Bute e di
Afrotide, abbia eretto un tempio dedicato alla divinità sua madre e fondato la
città che da lui prese il nome, e dell’arrivo di Liparo, figlio di Ausonio,
dalle isole Eolie.
Aggiunse che anche i Sicani
Abitavano le alte vette
dei monti e adoravano Venere Ericina
Sulle rovine del tempio venne edificato dai Normanni un
castello che fu chiamato “di Venere” e sempre in Sicilia, sul versante opposto
e cioè sui Monti Nebrodi, a dimostrazione del culto radicato nell’isola di
Astarte, si trova Mistretta.
Mistretta un nome, che a detta dei filologi, deriva
dal fenicio “Am-Ashtart” (“Città di Astarte”).
Mistretta (Me)
Ma dove ha avuto origine il culto di Astarte e di
Atargatis ?
Le loro origini andrebbero ricercate in Mesopotamia ed
esattamente nella figura della dea Inanna sumera e della Istar babilonese. Si
tratta di due dee che hanno delle prerogative e degli attributi che si
troveranno successivamente, nel mondo greco e in quello romano, sia in Afrotide
che in Venere.
Antico sigillo (a
cilindro) accadico che rappresenta la
dea Inanna (Ishtar) con il
suo “sukkal” (ministro)
Ninshubur.
Datazione: periodo di
Akkad , 2334 -2335 a.C.
La dea poggia il piede su
un leone mentre Ninshubur le offre obbedienza.
Istituto orientale
dell’Università di Chicago
Il vaso votivo Warna è
decorato con tre registri orizzontali ed
evidenzia dei chiari segni
di riparazioni risalenti all’antichità.
È raffigurata una scena in
cui un uomo nudo offre una ciotola di frutta e
cereali ad una divinità
femminile, Inanna (Ishtar).
Dietro ci sono due fasci
di canne per indicare che è il tempio della dea.
In vaso fu trovato in
frammenti da una squadra di archeologi tedeschi in
un complesso di templi
dedicati alla dea Inanna nella città di Uruk
(nel sud dell’Irag) nel
1933.
Altezza: 1 metro – Trovato
a Warka (antica Uruk)
Periodo: Jemdet Nasr –
3000- 2900 a.C.
Collocazione: Sumeriam
Gallery, Museum di Baghdad (Iraq)
Inanna
(Inana) ( cuneiforme sumerico
IN.AN.NA, forse con il significato di “Signora del Cielo”
o “Splendente”. Era la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell’amore.
Un amore inteso come relazione erotica piuttosto che coniugale.
Rappresentava la più importante divinità femminile
mesopotamica e successivamente fu assimilata alla dea babilonese ed assira Ishtar.
La più antica attestazione del nome della divinità si
trova nelle tavole d’argilla rinvenute nell’antico complesso templare di
Uruk risalenti al 3400/3000 a.C.
La tradizione sumerica la vuole figlia del dio del Cielo
An oppure, secondo un altra tesi, figlia
del dio Luna (Nanna) e sorella gemella del Sole (Utu).
Donò alla città di Uruk, di cui era protettrice, i Me
sottratti ad Enki con un inganno ( lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la
sua bellezza).
(I “Me” nella mitologia sumerica erano quelle forze impersonali che insieme con gli Dei
garantivano l’ordine nell’universo).
Con questa donazione garantiva all’umanità una vita nella
prosperità e nel benessere. Dopo la morte del suo innamorato Damuzi, diventò
una seduttrice di uomini e di dei. Nella saga di Gilgamesh (mitico re di Uruk
risalente al 4500 a.C.) questi rifiuta le offerte di sesso di Inanna
accusandola che
“nessun uomo è rimasto vivo fino all’indomani mattina, dopo
aver giaciuto con lei una notte”.
Dea dell’amore, volubile e perennemente innamorata,
vogliosa, disinibita (in alcuni suoi inni chiede al compagno Dumuzi degli atti
osceni), è una regina che pretende ciò
che desidera.Dea della fertilità della terra, rappresentata con in
mano dei giunchi ripiegati a formare degli anelli, che pretende sacrifici e
grandi feste in suo onore. È anche dea della guerra e non in contrapposizione all’amore perché
protegge il suo popolo che ama distruggendo i nemici in battaglia con i suoi artigli. La sua femminilità è spesso chiamata nei suoi inni con
il termine “hyeròdula” cioè prostituzione sacra facendo riferimento ad una atteggiamento senza limiti e ricco
d’orgoglio.La dea appare in molti antichi miti mesopotamici:-
Inanna e l’albero di Huluppu (un mito della creazione
dell’Inizio);
-
Inanna e il dio della Sapienza (un mito che narra dei doni della conoscenza
e della cultura alla città di Uruk. Già citato in merito ai “Me”)
-
Il corteggiamento di Inanna e Dumuzi (la storia del
matrimonio di Inanna con il dio-vegetale o della vegetazione);
-
La Discesa di Inanna negli Inferi dimora della sorella
Ereskigal (un mito risalente al 1900-1600 a.C.
ed il più famoso)
Nel racconto “Inanna e l’albero di Huluppu” si narra come la dea trovò un albero chiamato
“Huluppu” sulle sponde del fiume Eufrate e che era stato sradicato
dall’erosione dell’acque del fiume in piena. Lo prese per piantarlo nel suo
giardino con l’obiettivo di utilizzarne la legna per creare il suo trono e il suo letto. Passarono dieci anni e l’albero
era cresciuto ma non potò utilizzarlo per gli scopi che si era prefissata.“Quindi
un serpente, che non può essere incantatofece il suo nido tra le radici dell’albero Huluppu.L’uccello Anzu mise i suoi piccoli tra i rami dell’alberoe la vergine oscura Lilith costruì la sua casa nel tronco”.La dea, che sorrideva sempre, fu conquistata da un
pianto senza fine e chiamò in suo aiuto il fratello Utu/Shamash che però si
rifiutò di aiutarla. Si rivolse al grande eroe semi-divino Gilgames che, dato
di una grande forza, colpì il serpente tra le radici; l’uccello Anzù fuggì,
assieme ai suoi piccoli, sulle montagne e lo stesso fece anche Lilith in fuga
verso luoghi selvatici.L’albero Huluppu fu quindi consegnato dalla dea che
iniziò a lavorarlo: trasformò le radici dell’albero in tamburo (pukku) e dai
suoi rami creò delle bacchette (mekku) per suonarlo.Con la creazione di questo strumento costrinse i
giovani di Uruk a danzare al suo ritorno fino allo sfinimento.Al sopraggiungere della sera, posò lo strumento che
precipitò negli inferi.Nel racconto appare la figura di “Lilith” che è molto
nota nella cultura mesopotamica. Una figura che nelle leggende ebraiche sarebbe
diventata la prima moglie di Adamo, precedendo “Eva”, considerata dall’esegesi
cristiano-cattolica la “prima donna” ovvero la capostipite del genere
femminile. È probabile che la religione ebraica assorbì quindi la figura di
Lilith direttamente dalla cultura babilonese durante la prigionia degli Ebrei
in Babilonia.
“La Discesa di Inanna negli Inferi” è il poema
più famoso, scritto in origine in cuneiforme ed inciso su tavolette d’argilla
rinvenute nei pressi dei siti archeologici di Assur e Ninive composte da 145
righe.
Racconta del viaggio della dea nel mondo sotterraneo
per sfidare la sorella di nome Ereshkigal.
Scritto probabilmente tra il 3500 ed il 1900 a.C.
anche se alcuni storici siano propensi a dare una data ancora più antica.
Con il passare del tempo la narrazione ha subito delle
variazioni sia nello stile che nella caratterizzazione dei personaggi.
Variazioni legati alla maggiore importanza
del ruolo delle divinità femminili durante il secondo millennio a.C.
Dal grande paradiso ella si immerse nel mondo di sotto. Dal grande paradiso
la dea mise la sua mente nel grande abisso. Dal grande paradiso Inanna mise la
sua mente nel grande abisso. La mia padrona abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo. Inana abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo”.
Inanna sperava d’estendere la sua sfera d’influenza
anche nel regno degli inferi, la cui regina era la sorella Ereshkigal.
Inanna si mise d’accordo con il suo primo ministro,
una donna di nome Ninshuba, dicendole
cheSe non fosse tornata entro massimo tre giorni e tre notti dal
sottosuolo, avrebbe dovuto organizzare grandi cerimonie funebri e
avrebbe dovuto chiamare gli Anunnaki perché corressero in suo soccorso.
Presi questi accordi Inanna cominciò a scendere nel
mondo sotterraneo. Al primo dei sette cancelli degli inferi, la dea venne fermata
dal custode Neti che le chiese il motivo della sua visita.Inanna rispose che era venuta fare visita alla sorella
Ereshkigal, signora dell’oltretomba, e per portarle le condoglianze per la
morte di Gugalanna, suo marito, il “toro del cielo” ucciso da Gilgamesh e da Enkidu.
Ereshkigal,
sorella di Inanna e regina del mondo sotterraneo (gli inferi)
La regina Ereshkigal fu informata
della visita della sorella e si dimostrò tanto
non felice della visita tanto che diede ordine al custode di bloccare le
sette porte.
Il guardiano obbedì al comando e
chiuse le porte.
Ad Inanna fu permesso di
attraversare un cancello alla volta e ad ogni ingresso doveva abbandonare un
pezzo del suo abito regale e dei suoi
gioielli.
Passaggio dopo passaggio alla fine
dopo l’ultimo ingresso, si ritrovò completamente nuda ed inerme (priva dei suoi
simboli sacri tra cui una collana di lapislazzuli) di fronte alla sorella Ereshkigal.
La regina degli inferi volse i suoi
occhi di pietra sulla sorella venuta dal mondo di sopra e la trasformò
In un
istante in un cadavere inanimato lasciandola poi appesa
ad un gancio per tre giorni e tre notti.
Al suo sguardo Inanna perse la sua
vitalità e rimase per tre giorni e per tre notti come un cadavere, giacendo
inerme nel mondo sotterraneo (il cadavere ormai in putrefazione).
Passati i tre giorni la ministra
Ninshuba fece ciò che le era stata ordinato dalla dea e si mise quindi alla
ricerca di Enki ( dio dell’acqua e della saggezza) che, venuto a conoscenza
della grave situazione, prese subito dei provvedimenti.
Enki, con lo sporco che aveva sotto
le unghie, diede vita a due strane creature asessuate, “Kurgarra” e “Galatur”,
che furono subito inviate nel mondo sotterraneo con cibo ed acqua per riportare
in vita Inanna che vi giaceva inerte.
Quando giunsero negli inferi
trovarono Ereshkigal in travaglio, in preda ad un parto dolorosissimo. La
regina dell’oltretomba offrì loro qualunque cosa in cambio di un pò di sollievo
e i due richiesero la liberazione di Inanna
Inanna fu riportata in vita grazie
all’intervento delle due creature ma c’era un grosso problema da superare visto
che
Nessuno
poteva lasciare il mondo sotterraneo se non fosse stato trovatoun sostituto
che rimanesse per sempre al suo posto
nella“Terra del
Giudizio (Inferi)”.
Inanna tornò felice nella sua città
sacra ma trovò il suo compagno ed amante
Dumuzi non vestito a lutto e, in sua assenza, s’era anche impadronito del suo
posto di comando.
Infuriata per tanta presunzione
ordinò che Dumuzi fosse portato, come suo sostituto, nel regno degli inferi.
Tentò una disperata fuga ma venne raggiunto e trascinato nell’ade.
L’affezionata sorella Gestinanna lo
seguì nel mondo degli inferi e riuscì ad ottenere da Ereshkugal la vita del
fratello per la metà d’ogni anno. La metà dell’ano in cui le piante del deserto
fioriscono, perché Dumuzi era il dio della vegetazione.
Fu la tristezza di Geshtinanna a
commuovere Ereshkigal al tal punto da permette a Dumuzi di tornare sulla terra
durante l’estate e la primavera venendo sostituito nell’ade dalla sorella,
Come per Persefone e Demetra, questo
evento fu preso ad esempio per il cambiamento delle stagioni.
Nel mito Inanna, dopo aver condanno a morte Dumuzi,
pianse la morte dell’amato.
Tavoletta che
descrive la discesa di Inanna negli Inferi
Istituto orientale
presso l’Università di Chicago
Ereshkigal (?) regina degli inferi e
sorella di Inanna
Un rilevo detto di Burney dal nome del suo scopritore
Altorilievo di terracotta, alto 50
cm. risalente al II millennio a.C. e di
probabile fattura paleobabilonese
British Museum, Londra
La dea Inanna aveva sposato(?) Dumuzi con l’obiettivo di
espandere i propri domini sempre in
sinergia con il suo carattere vivace e battagliero.
Dumuzi morì, come abbiamo visto, per aver usurpato il
trono della moglie durante la sua discesa nell’ade o, secondo un ‘altra
versione, per una caduta in un fiume e conseguente morte per soffocamento
(probabilmente durante la fuga).
Restò quindi da sola e per nulla rassegnata al suo
antico e mai domo obiettivo di espansione di potere.
Accusò il dio Marduk/Ra di essere responsabile della
morte del marito e dunque del fallimento (temporaneo) del suo progetto
d’espansione.
Decise quindi d’intraprendere una guerra contro il
dio.
In impresa difficile tanto che suo padre Anu cercò di
scoraggiarla dal compiere un gesto così pericoloso.
Il mito narra come la donna s’equipaggiò di ogni
genere d’armi e decise d’affrontare l’impossibile. Le tavolette sumeriche
narrano come la dea assaltò il monte Ebih e riuscì alla fine anche a demolirlo.
Naturalmente non si tratta di una montagna ma di
qualcosa in ogni caso importante e sontuoso tanto da demolirlo con rabbia.
Le versioni secondo gli studiosi sul muto monte “Ebih”
sarebbero tre:
1)
Il nome potrebbe indicare qualcosa che ha attinenza
con un “gruppo di cime”;2)
In un graffito
è raffigurata Inanna che fronteggia un nemico armato e si vede sullo sfondo un
chiaro profilo di tre cime che sarebbero le tre piramidi principali della Piana
di Giza;3)
C’è il ricordo che, nella Piana di Giza, si trovasse
una quarta piramide andata “perduta” in circostanze non chiare o di cui non
c’era memoria. La de Inanna potrebbe aver distrutto quindi la quarta piramide
(nera) che era presente nella Piana di Giza ?
Inanna era anche la dea del cielo, la stella del mattino
e della sera, dea di luce abbagliante. Per integrare il suo lato oscuro
intraprese quindi il suo viaggio nelle tenebre durante il quale incontrò il suo
lato ombra rappresentato dalla sorella Ereshkigal che per gelosia, con un
inganno, costringe Inamna a morire e a restare per sempre con lei nel buio.
In questa lunga storia
fatta anche di morte e di resurrezione, si presenta sempre con una veste
regale, coraggiosa, orgogliosa ed anche vendicativa.
Inanna
insegna la fierezza, la disinibizione, l’orgoglio di una femminilità piena, mai
sottomessa. Una femminilità che li porta ad essere regine del cielo, signore
dal cuore immenso in cui c’è spazio per tutto, anche per il dolore – per ogni
cosa, tranne che per la paura.
Nella mitologia fenicia e nella tradizione ebraica appare
come la divinità Astarte, a cui viene attribuito il ruolo di “Elohim”.
Nel mito greco “Il Giudizio di Paride” – ma anche in
altri racconti degli antichi Greci – Inanna viene identificata con la dea
Afrodite, tradizionalmente associata a Inanna per via della sua
incantevole bellezza ed estrema sensualità. Inanna viene sempre descritta come una giovane donna,
mai come madre o come una moglie fedele, pienamente consapevole del suo potere
femminile e che fa fronte alla vita con coraggio senza timore di come sarà
percepita dagli altri, specialmente dagli uomini.
Inanna appare come Ištar (babilonese), una dea dalla
sessualità promiscua, gelosa e vendicativa.
I suoi appellativi sono “Argentea” e “Donatrice di
Semi” e, come la sua controparte sumera, governava la fertilità e il raccolto.In epoche successive divenne anche protettrice delle
prostitute e dell’amore sessuale. Era la dea delle tempeste, dei sogni e dei
presagi e distribuiva agli uomini potere e conoscenza tramite i “ME” sottratti
al dio Ea/Enki.
Uno dei suoi simboli era il bastone con i serpenti
intrecciati.
Uno dei monumenti più importanti dedicati alla dea
Inanna è la “Porta di Istar”, l’ottava porta della città di Babilonia. Fu
costruita intorno al 575 a.C. sotto il regno di Nabucodonosor II, nella parte
Nord della città.
Dal 1930 la porta si trova la “Pergamonmuseum” di
Berlino e fu ricostruita con i materiali recuperati dagli scavi condotti dal
noto archeologo tedesco Robert Koldewey, insieme ad una parte della “Via
Processionale” che passava sotto di essa.
La struttura era in realtà una doppia porta di cui ciò
che è in mostra nel Pergamonmuseum è solo la più piccola parte frontale.
L’ingresso posteriore, più ampio, è custodito nei magazzini del museo, mentre
altre parti della porta, e due leoni della Via Processionale si trovano in
altri musei sparsi nel mondo.
I decori principali della porta sono: leoni, tori,
draghi e fiori. Le maioliche sono costruite con lapislazzuli e rivestite con
finissima ceramica invetriata. Una più piccola riproduzione della porta è stata
costruita in Iraq sotto Saddam Hussein come entrata ad un museo che però non fu
completato.
Danni alla riproduzione avvennero durante la guerra in Iraq per colpa degli
eserciti statunitensi che, come si venne a sapere in seguito, avevano l’ordine
di distruggere gli antichi monumenti conservati nei musei iracheni.
Enheduana, scrisse degli inni per Innana
La prima testimonianza scritta di un’autrice
Enheduana, figlia del
grande re accadico (popolazione proveniente dal deserti siro – arabico e che
coabitarono con i Sumeri) Sargon, il
primo che sottomise l’intera Mesopotamia al suo potere, e prima sacerdotessa di
Nanna, dio della Luna, scrisse numerosi inni, tra cui alcuni di grande fascino,
dedicati alla dea Inanna.
Per la prima volta nella
storia qualcuno usa la scrittura non
per tenere dei registi commerciali o
altro, ma per fare poesia e per esprimere sentimenti e stati psicologici.
Ricordiamoci che siamo nel 2300 circa
a.C......
Il Disco di calcite che riporta il nome di Enheduanna”
Museo de la Università di Pensilvania
Nel disco Enheduanna è rappresentata nell’atto di celebrare una cerimonia
religiosa
in onore di Inanna. La sacerdotessa offre libagioni rituali alla dea
ed è vestita con il tradizionale abbigliamento di Soma Sacerdotessa.
Accanto a lei due servitori.
Nel retro del disco è raffigurato il simbolo di Nanna, il dio della luna,
al quale era consacrata la vita di Enheduanna. È riportata una breve
traccia biografica della sacerdotessa
“Enheduanna, sacerdotessa zirru, sposa del dio Nanna, figlia di Sargon, re
del mondo, nel tempio della dea Inanna”.
Il disco fu trovato dall’archeologo britannico Sir Leonard Wooley nel 1928.
Il disco presenta una sola testa che tocca il margine superiore del fregio
per
simboleggiare il dominio della
figura.
Venne trovato nel Giparu (residenza della sacerdotessa o tempio) di Ur,
forse
Il luogo dove Enheduanna viveva. È datato 200 – 1600 a.C. e si trovava
vicino alla
statua di una sacerdotessa, la stessa Enduhanna (?).
anche il ritrovamento di una piccola figura femminile, seduta con un abito
a balze,
lascia suggerire che si tratti proprio della sacerdotessa.
Ma " come per tanti artefatti
del mondo antico, le teste sono rotte,
proprio come nel mondo antico.”
Le tavolette con
gli inni di Enheduanna
Nei suoi inni si rivolge alla dea Inanna chiamandola
“Signora dal cuore immenso” descrivendola come una donna piena d’amore, di luce
ed anche come una belva assetata di sangue che fa scempio dei corpi dei suoi
nemici sul campo di battaglia.Uno degli inni scritti da Enedhuanna:
“Regina di tutti i Me
Donna vestita di luce
Il cielo e la terra sono i tuoi indumenti
Tu sei l’eletta, la santificata.
Oh tu grandiosa per le tue doti
Coronata dalla tua immensa bontà
Somma sacerdotessa, sei giusta
La tua mano si afferra ai sette poteri
Mia sovrana, tu dalla forza fondamentale
custode delle origini cosmiche essenziali
Tu esalti gli elementi
Legali alle tue mani
Riunisci in te i poteri
Imprigionali nel tuo cuore
Come un drago lanci veleno sulla terra dei nemici
Ruggisci come il dio della tormenta
Come il seme che imputridisce nella terra
Sei il fiume in piena che precipita già dalle montagne
Sei Inanna
Suprema in cielo e in terra”
...................
Esilio da Ur
Tu mi hai chiesto di entrare nel santo chiostro, il giparu,
e io vi sono entrata, io, l’alta sacerdotessa, Enheduanna!
Ho recato con me la cesta rituale
e ho levato il mio canto di lode per te.
Ora, però, sono relegata in mezzo ai lebbrosi
e non posso più vivere con te.
Le tenebre si approssimano alla luce del giorno,
intorno a me si fa buio.
Le tenebre si approssimano alla luce del giorno
e lo ricoprono con tempesta di sabbia.
La mia tenera bocca di miele d’improvviso si confonde.
Polvere è il mio bel volto.
Da Inno a Inanna, IX
.......................
Accusa a Inanna
Di me, mio Nanna, non ti curi più:
mi trascini alla rovina per sentieri di morte.
[…]
Eccomi, sono Enheduanna:
gloriosa e trionfante, un tempo;
ma il dio mi ha tratto fuori dal mio santuario,
come una rondine dalla finestra ha lasciato che io volassi.
La mia vita è in fiamme.
Egli mi ha costretto a camminare tra i rovi sulla montagna,
ha spogliato il mio capo della corona di prima sacerdotessa,
mi ha dato un pugnale e una spada e mi ha detto:
“Sono per te: rivolgili contro il tuo corpo”.
Da Inno a Inanna, XIII
Facciata del tempio di Inanna a kara (Uruk)
.....................
La figura di Inanna la troveremo nella Istar babilonese.
I Babilonesi erano dei grandi conoscitori dell’astronomia
e già associavano la loro dea Istar al pianete Venere perché aveva due aspetti:
“il vespertino e il mattutino”
Anche Istar aveva un duplice aspetto
Io sono Istar Dea del
mattino, io sono Istar Dea della sera
Come dea della sera era “La Benevola”, la Dea dell’amore
nei cui templi si svolgevano dei riti licenziosi; come Dea del mattino era
invece la prode sorella del Dio solare Samas, la “Regina delle Battaglie”- per
quest’ultimo motivo era raffigurata sui rilievi di Susa in forma maschile e con
barba, una caratteristica che si ritrova
anche nell’Afrotide di Cipro secondo la descrizione di Macrobio nei
“Saturnalia”.
Anche Istar era una Dea collegata con gli Inferi e
l’Oltretomba secondo un racconto mitologico mesopotamico di Inanna. Il mito
babilonese assunse nel tempo delle modifiche rispetto a quella della dea
Inanna.
Secondo il racconto la dea Istar giunse alle porte
dell’Oltretomba e chiamò a gran voce i guardiani. Li minacciò dicendo che se
non fosse stato aperto, avrebbe distrutto la porta e fatto uscire i morti che
avrebbero divorato i vivi, cambiando così l’ordine naturale del mondo.
I preoccupati guardiani corsero ad avvertire del pericolo
la Signora dell’Oltretomba, Ereskigal. Sorella di istar, che colse l’occasione
propizia per attirarla in una trappola.
Istar fu fatta entrare attraverso le sette porte
dell’Irkalia, ed ad ogni passaggio venne spogliata gradualmente delle sue vesti
e dei suoi gioielli, che erano dei simboli importanti del suo potere.
Alla fine si trovò completamente nuda e venne accolta
nella sala del trono da Ereskigal.
Ereskigal rilevò ad istar le sue reali intenzioni ed
ordinò al suo ministro Namtar, dio del destino, di scagliare contro la sorella
sessanta malattie, che colpivano ogni parte del suo corpo.
Istar venne presa prigioniera e questa sua prigionia aveva come effetto l’interruzione di ogni
attività di generazione nel mondo dei viventi.
Questi eventi preoccuparono il Consiglio degli Dei e fu
Enki a trovare una soluzione. Creò un giovane di straordinaria bellezza,
Tammuz, da mandare a Ereskigal per sedurla e indurla al perdono nei confronti
della sorella.
Il piano sembra che sia fallito (il testo è privo in
alcune parti) perchè la signora dell’Irkalia, anche se inizialmente affascinata
dal bel giovane, iniziò a maledire Tammuz.
Alla fine però
concesse la grazia alla sorella
Istar ed ordinò al fedele Namtar di innaffiarla con l’acqua della vita.
La dea potè così ritornare nel mondo dei viventi,
rivestita dei suoi abiti e dei suoi gioielli.
In cambio della propria, e forse insperata salvezza, dovette
lasciare nell’Oltretomba Tammuz che era diventato nel frattempo suo amante.
Tammuz sarà destinato a fare ritorno sulla terra ogni
anno per un solo giorno, quello dei riti a lui consacrati.
Lo scrittore Paul Dhome
in un suo brano della “Discesa di Istar agli Inferi”...
Da quando la Signora
Istar era discesa nel Paese senza Ritorno,
il toro non si
appressava più alla giovenca, né l’asino all’asina,
l’uomo non si
accoppiava più alla donna incontrata sulla via,
questi si addormentava
nelle sue camere e la donna sul proprio giaciglio
Nell’epopea di Gilgames, sovrano di Kulabe e quinto re di
Uruk (intorno all’anno 2500 a.C.), venne menzionato Tammuz come amante di Istar.
Si tratta di un passo in cui Tammuz rimprovera la dea di avergli fatto delle
proposte amorose, che il giovane rifiutò, denunciandone gli aspetti lascivi e
devastanti come di “Grande Prostituta”..
Chi è il tuo amante che
Tu ami per sempre ?
Chi è il tuo eroe che
nell’avvenire ti sarà grato ?
Io rileverò le tue prostituzioni !
A Tammuz, l’amante
della tua giovinezza, anno per anno Tu hai
fissato la lamentazione
! Tu hai amato l’uccello Allalu e poi lo hai
colpito e gli hai
spezzato l’ala (...)
Tu hai amato il leone,
perfetto in vigore, e gli hai scavato
sette e sette fosse !
Tu hai amato il cavallo, fiero nella battaglia,
e gli hai destinato le
redini, il pungolo e la sferza.
Tu lo hai destinato a
galoppare per sette doppie ore !
Tu hai amato il
pastore, quel pastore che ogni giorno faceva salire a Te
il fumo del sacrificio,
che ogni giorno t’immolava capretti.
Tu l’hai colpito e
l’hai trasformato in leopardo !
E ora i suoi compagni
lo perseguitano e i suoi cani gli mordono la pelle !
Tu hai amato Isullani,
il giardiniere di tuo padre, che ogni giorno
faceva brillare la tua mensa. Tu levasti gli occhi
su di lui, andasti da lui
e gli dicesti: “Oh mio
Isullanu, oh pieno di forza, mangiamo, stendi la tua mano
e tocca le mie carni!”.
Ma Isullanu ti disse:
“Che vuoi da me ? Mia
Madre non ha cotto e io non ho mangiato.
Quello che io mangio
sono alimenti di vergogna e maledizione !”
E Tu, a sentire queste
parole, lo colpisti e lo trasformasti nell’animale tallalu"
La figura di Damuzi – Tammuz sarebbe nella cultura
fenicia quella di Adone dove “Adon” nelle lingue semitiche ha in significato di
“Signore”.
Inanna nella cultura fenicia diventerà Astarte.
Le solenni cerimonie rivolte ad Adone e Astarte, con i
relativi Misteri, trovarono un ampia diffusione nei territori dell’Impero
Romano e anche nella stessa città di
Roma. Quin la presenza di forti comunità orientali favorì la diffusione dei
culti nei confronti dei due dei ed anche per la diffusa pratica dell’Evocatio,
praticata dalle autorità imperiali, che favoriva la diffusione dei culti
stranieri sotto la protezione dello Stato.
Gli scavi archeologici hanno infatti confermato
l’esistenza di un importante Santuario di Astarte sul versante Nord del
Gianicolo presso il Lucus Furrinae. Un edificio costruito in età neroniana e
oggetto di vari rifacimenti sino al V secolo. Il santuario comprendeva anche
una piscina per l’allevamento di pesci che erano sacri alla dea.
Teocrito
(in greco antico: Θεόκριτος,
Theókritos; Siracusa, 315 a.C. – 260 a.C. circa) è stato un poeta siceliota,
inventore della poesia bucolica.
Il poeta siracusano Teocrito visità l’Egitto nel 273 a.C.
e in un suo idillio “Le siracusane o le donne alla festa di Adone” fornì una
chiara visione sullo svolgimento della festa in onore di Adone e di Astarte.
Una festa organizzata da Alessandria dalla regina del tempo, Arsinoe, moglie di
Tolomeo II.
Sotto un padiglione ad
alcova, su un tappeto di porpora, veniva collocato
un letto per i due
sposi divini. Tutto intorno venivano disposti in bell’ordine
preziosi doni della
natura, frutta matura, focacce, unguenti di Siria conservati
in vasetti di alabastro
e all’interno di canestri d’argento, zolle di terra fiorite,
i cosiddetti “Giardini
di Adone” in genere vasetti di terracotta contenenti
della terra che veniva
seminata con pianticelle di rapida crescita e
di breve durata, che si
disponevano attorno al simulacro di
Adone e che poi venivano gettati nelle acque del mare o del fiume
più vicino al termine
della festa.
Questo avveniva nel corso
della prima giornata della festa, chiamato il
“Giorno della Gioia” in
cui si celebrava l’imeneo della coppia.
La seconda giornata era
invece una giornata all’insegna del lutto.
All’alba, quando ancora
la rugiada bagnava il suolo, una processione di
fedeli e di iniziati
muoveva verso il mare, mentre le donne, con le chiome
sciolte e le vesti
discinte, si disperavano e piangevano la dipartita
di Adone, rivolgendogli
preghiere affinchè egli ritornasse propizio con
il
nuovo anno, riportando
la gioia”.
Qui finisce il racconto di Teocrito che non accenna al
rito di gettare le zolle fiorite in mare e citato in altre fonti. Non descrive
nemmeno il terzo giorno della festa che
era basato sulla rappresentazione della resurrezione di Adone che una figura
sacerdotale, detta Adoniaste, bagnata di acqua lustrale e coronato, si recava
ad incontrare il dio in un apposito edificio.
Molti testi greci e latini, molte commedie come la
“Lisistrata” di Aristofane, misero in evidenza la diffusione del culto di
Astarte che aveva in sé le simbologia di Atargatis, dell’antica e sumerica
Inanna.
Una diffusione del culto in tutto il bacino del
Mediterraneo quasi in contemporanea con l’ellenica Afrotide.
Erodoto sosteneva che il culto di Afrotide fosse
originario di Ascalona, una città posta sulla costa meridionale della Palestina
e da questa città i Ciprioti lo avevano importato.
Secondo Pausania sarebbero stati i Fenici, che adoravano
la divinità, a trasferire il suo culto a Citera.
Afrotite, in ogni caso, era già una figura attestata
nella sua forma “ellenica” già al tempo di Omero.
Infatti il poeta indicò l’origine del culto dal santuario
che fu dedicato alla dea a Pafos, sulla costa Sud-Ovest di Cipro.
Pafos, Cipro, Tempio di Afrotide
La fondazione del santuario fu attestata dagli
archeologi nel XII secolo a.C. in
stretto legame co la dominazione micenea dell’isola circa un secolo dopo la
fondazione del tempio di Erice.
A pochi chilometri da Pafos, lungo la costa in direzione
di Limqassol, è ancora oggi visibile la “Roccia di Afrotide”, che fu chiamata
dai Ciprioti anche “Roccia dei Romani”.
Si dice che in determinate
condizioni atmosferiche, le onde si alzano, si infrangono e formano una colonna
d'acqua che si dissolve in una colonna di schiuma. Con l'immaginazione, questa
sembra momentaneamente una forma umana effimera ed evanescente. Altri miti
popolari raccontano che nuotare tre volte intorno alla roccia porterà varie
benedizioni, tra cui l'eterna giovinezza e bellezza, buona fortuna, fertilità e
vero amore.
È chiamata Roccia dei
Romani perché legata alle gesta di un eroe locale Basilio. Un eroe per metà
arabo e per metà bizantino che scagliò una grande roccia dal monte Trodos
contro i Saraceni che stavano per invadere l’isola.
Afrotide emerse dalle
acque e fu subito accolta, come abbiamo visto, dalle Horai, dalle Cariti, da Peitho (la persuasione), da
Photos (il desiderio) e da Himeros (la bramosia d’amore).
Ma se l’Afrotide greca e
anche la Venere latina, non furono, come
invece sostengono gli storici delle religioni, che trasposizioni e adattamenti
occidentali delle figure di Astarte, Atagartis e Inanna e delle loro relative
prerogative, come mai in età ellenistica e durante l’età imperiale le figure di
Astarte e Atagartis non furono messe in disparte e continuarono ad essere venerate nei loro luoghi di culto
da una gran moltitudine di gente ?
Le divinità continuarono
ad esistere anche con templi vicini sia di Afrotide/venere che di Astarte o
della De Syria ?
Un probabile
attaccamento all’antica tradizione religiosa degli antenati o un riflesso della
componente culturale orientale dei fedeli ?
È anche vero che in
epoca tardo-imperiale a Roma erano ancora presenti i Misteri di Adone ed
Astarte e prendevano parte alle relative cerimonie tutti i cittadini di
qualsiasi estrazione sociale o delle diverse etnie.
Il culto di Astarte e
della Dea Syria nel III secolo d.C. erano dei culti pienamente romanizzati e
quindi dei culti universali accessibili a chiunque si avvicinasse a prescindere
dalla propria origine etnica.
Le antiche classi sacerdotali di Astarte o di Atargatis mantennero sempre ben distinto
il culto di queste due divinità, evitando qualsiasi contaminazione, con
Afrotide/Venere.
Probabilmente conoscevano la vera storia di Afrotide e
sulla nascita della sua figura e del suo relativo culto.
In merito è veramente interessante la narrazione storica
dello storico Nicola Bizzi che affrontò il problema con grande senso critico.
Nella tradizione Misterica non è Afrotide ad essere nata dalla spuma
marina ma Dione.
Una dea titana che fu venerata dalla civiltà Minoica come
Akakal e per secoli come somma Dea Madre e Signora del Cielo, della Terra e del
Mare dai popoli pelasgici.
Tra il XV ed il XII secolo a.C. nel mondo mediterraneo e
nell’area dell’Egeo ci fu uno scontro religioso fra gli antichi popoli
pre-greci, con i testa gli eredi della civiltà Minoica che erano fedeli al
culto dei Titani e agli schemi sociali del matriarcato, e gli invasori che
progressivamente occuparono l’intera Grecia dei quali i Dori furono soltanto
gli ultimi arrivati. Popolo diversi tra loro ma avevano nella loro cultura uno
schema sociale patriarcale e il culto di Zeus e di quelle divinità conosciute
come “Olimpiche”. Divinità che finirono con lo spodestare i Titani ponendo fine
al loro Regno di Giustizia.
Questo scontro religioso diventò ben presto politico e
militare vedendo nella famosa guerra di Troia il suo apice.
Questi popoli invasori man mano che consolidarono il loro
potere e la loro presenza nel territorio, con la fondazione dei primi regni “Micenei”, le classi sacerdotali,
vere personaggi di potere, iniziarono
una serie di riforme religiose che avevano l’obiettivo di affermare il primato
del loro dio principale (Zeus) demolendo
la presenza del culto Titanico sul territorio.
Furono condotte delle abili azioni di sostituzione che
nel giro di un paio di secoli riuscirono a trovare una accettazione del nuovo credo nella mentalità popolare.
Quasi ovunque l’ingombrante figure del dio Titano
primario (Knos o Kreios) venne sostituita da quella di Zeus.
Anche buona parte delle dee Titane furono sostituite
dalla creazioni di miti ben studiati che facevano delle nuove dee “amanti,
mogli, figlie” dello stesso Zeus o di suoi compagni della cerchia degli
Olimpici.
La sostituzione fu anche architettonica. Il tempio o santuario di un Dio Titano o di
una Titanide se non era abbattuto veniva nella sua gerarchia sacerdotale
sostituito con nuove sacerdoti che naturalmente vi inserivano le nuove divinità
Uno degli esempi
fu relativo al tempio di Delfi con il nuovo dio Apollo.
A Dodona dove si trovava il più antico santuario
Oracolare della Grecia, la figura di Zeus venne inizialmente imposta al fianco
di quella della dea Titana primaria Dona
che diventò sua moglie. Alla fine in epoca classica la figura di Zeus nel
santuario diventò primaria tanto che lo stesso tempio era chiamato come
“Santuario dello Zeus di Dodona”.
Ma la sostituzione della figura di Dione non fu semplice
sia per il suo grande significato di “Grande Madre” e di “Madre Terra” che per
il suo culto che era molto diffuso nel mondo popolare che era contrario al
nuovo ordine zeutico.
Si rese necessaria la creazione di una nuova figura che
riuscisse a sostituire Dione.
Venne cos’ stabilito, dopo la guerra di Troia, di darle
una figlia che fino a quel momento era inesistente nei miti della divinità.
Una nuova divinità che doveva assumere la natura
,compresa la sua origine dalla spuma del mare), le caratteristiche e gli emblemi fondamentali anche se in
maniera meno forte per essere la figura
più facilmente gestibile.
Una figura quindi che con il tempo doveva sostituire
totalmente la figura di Dione facendola sparire dal culto popolare.
I sacerdoti non riuscirono a trovare tra gli dei olimpici
una figura femminile all’altezza del ruolo e le classi sacerdotali avrebbero
fatto ricorso ad una figura mortale, una certa Afrotide.
Alcune fonti misteriche riferirono di Afrotide come
sacerdotessa di Dione, originaria della regione anatolica della Frigia
-
I Frigi presero parte
alla guerra di Troia come alleati dei Troiani e la giovane sacerdotessa
rimase uccisa per mano degli Achei proprio durante il conflitto.
La giovane donna divenne, a livello locale, oggetto di
una forte divinizzazione secondo un antica tradizione che riguardava gli Eroi e
le Eroine soprattutto se in possesso di un incarico sacerdotale che cadevano in
battaglia.
Omero, tanto nell’Iliade come nell’Odissea, lanciò in
modo quasi celato il messaggio su questa sacerdotessa senza però mai svelare la
verità.
Nell’Iliade di Omero
Nell’Inno Omerico di Afrotide la Dea emerge nuda alle
acque del mare e viene accolta dalle Horai che l’abbigliano con sontuose vesti.
Ai tempi di Omero la nuova azione politica-religiosa aveva già radicato con i
primi effetti.
Nell’Iliade Afrotide appare già come figlia di Zeus e di
Dione ma c’è una piccola contraddizione.
Afrotide difende i Troiani ed è madre dell’eroe Enea
avuto dal marito troiano Anchise.
Sempre nell’Iliade, nel terzo libro, salva Paride quando
sta per essere ucciso da Menelao.
In questa vicenda la dea è apertamente schierata con i
Troiani e rifiuta , con questa posizione, la paternità di Zeus. Il motivo ?
Gli dei Titani furono per eccellenza i sostenitori dei
Troiani rappresentando Taura dei Teucri
uno degli ultimi baluardi del loro antico ordine (il popolo Tropiano secondo
un’antica versione sarebbe indicato come discendente dal mitico Teucro)..
Nell’Iliade interviene per salvare suo figlio Enea che,
ferito, rischia di restare ucciso nello scontro e cerca di coprirlo con il suo
peplo sgargiante.
Viene vista da Diomede che le scaglia contro una lancia
ferendola gravemente al polso. Un avvenimento che potrebbe alludere ad un
origine umana piuttosto che divina.
Per questo motivo venne richiamata all’ordine da Zeus che
la rimprovera di occuparsi di fatti guerreschi anziché di situazioni riguardanti
Amabili questioni
d’amore
che sarebbero di sua competenza.
La disperata Afrotide, sempre secondo la narrazione
omerica, lascia Enea alle cure di Apollo e si reca sull’Olimpo dove si getta
piangente ai piedi della madre Dione.
Al vederla in quello stato, la madre domanda la causa del
suo dolore, dando per scontato che solo un immortale avrebbe potuto procurarle
quella ferita al polso.
Afrotide le svela in contrario, confermando la sua
possibile origine non divina.
Nell’Odissea
Anche nell’Odissea Afrotide apparenelle vesti di Dea
dell’amore ma qui Omero la rappresenta come moglie del dio Efesto e nello
stesso momento anche amante di Ares (un dio in origine tracio della vegetazione
e successivamente collocato nella religione degli dei d’Olimpo, come figlio di
Zeus e di Hera, nella nuova simbologia legata agli aspetti più violenti della
guerra e della lotta intesa come sete di sangue. Omero infatti riferì che fu
proprio in Tracia che Ares decise di ritirarsi dopo essere stato sorpreso
mentre si univa ad Afrotide.
.. così dormì il molto paziente Ulisse
lì, nel letto traforato sotto il portico risonante.
E Alcinoo si mise a letto nel vano più interno
dell’alta casa
e accanto la moglie regina che gli preparò il letto e
le coltri.
La regina Arete, moglie del re Alcinoo, ordina alle
ancelle di preparare il letto per l’ospite Ulisse. Un ordine dato alle
ancelle in termini comparabili con un
analogo comando dato da Elena.
Le ancelle avvisano lo straniero che il letto è pronto ed
Omero evidenzia il piacere che in Ulisse
provoca l’idea di andare subito a dormire. A questo proposito usa un
espressione che poi viene usata per Afrotide, quando disse di “sì” al suo amante Ares e s’avviò anche lei sul
letto, per dormire, ma non immediatamente.
La scelta venne pianificata nel XII secolo a.C.
nell’isola di Cipro dove nello stesso secolo sorse il tempio di Pafos e si
consolidò il mito della nascita della dea.
Nell’isola di Cipro, per la sua vicinanza geografica alle
coste dell’Anatolia e con quelle dell’area siro – cananea , erano conosciute le
figure di Astarte e di Atargatis.
Si decise cos’ la nascita di Afrotide attribuendogli la
genealogia, le caratteristiche e gli epiteti di Dione oltre a quelli della
“Grande Prostituta” Akagartis/Astarte/Istar/Inanna.
La scelta di una divinità orientale estranea al mondo
ellenico e pre-ellenico, estranea alla cultura greca, si rilevò vincente.
Venne quindi creata una nuova divinità sfruttando il
ricordo di un eroina umana, sacerdotessa morta nella causa troiana
Afrotide presente
quindi le caratteristiche di dea Titana primaria e di Divinità orientale le cui
radici vanno ricercate nell’antica Mesopotamia.
Esiodo nella sua teogonia narrò la nascita di Afrotide
secondo un modello culturale affermato e consolidato da tempo nella memoria popolare.
Un Afrotide anche con attributi funerari e con l’epiteto
di “Pasifaessa” cioè di “colei che splende ovunque”, che ha in comune con la
Regina degli Inferi, e convolta in un mondo religioso di incantesimi, di malie,
di filtri amorosi, tutte espressioni tipici di una certa religiosità popolare-
Questi aspetti rendono Afrotide una divinità ambigua,
imprevedibile, capace di infondere la sua benevolenza ma anche di arrecare
disgrazie e sventure. Infatti un altro suo epiteto era quello di Doloplokos (“tessitrice d’inganni”) e di
Epitymbidia (“colei che sta sulle tombe”).
Assimilata dai Latini a Venere (Venus), la dea italica
della bellezza, dell’amore e della fecondità.
Ila cui origine e il significato del nome è ancora incerto, assume nella
tradizione religiosa romana una grandissima importanza anche “politica”.
E’ infatti madre dell’eroe troiano Enea e di conseguenza
della Gens Julia.
Virgilio, nell’Eneide, si accorda alla tradizione omerica
chiamandola con l’appellativo di “dionea” allo stesso modo di Ovidio.
Igino nelle sue “Fabulae” narra della nascita di Afrotide non secondo l’antica versione
ellenica ma in una interessante versione orientale frutto di una contaminazione
del mito greco della nascita di Afrotide con quello della dea Atargatis, nata
da un uovo caduto dal cielo nel fiume Eufrate.
Si racconta che nel
fiume Eufrate cadde dal cielo un uovo di straordinaria grandezza.
Si narra che i pesci si
riversarono sulle sponde, mentre delle colombe si posarono
sull’uovo e,
scaldatolo, si aprì portando alla luce Venere, in seguito chiamata
Dea Syria. A quella
Dea, poiché superò gli altri Numi in giustizia e probità, da
Giove fu data la
facoltà che i pesci fossero trasformati in astri. Per questo
motivo i Siri
considerano i pesci e le colombe nel novero degli Dei e non se ne cibano
Atargatis, come rilevò Marciano, era una divinità dell’umidità
fertilizzante, corrispondente alla Inanna sumerica e alla istar babilonese, non
si consce il nome originaria di questa dea ma i filologi citarono come il nome
originario fosse quello di “Ata Divina” collegata alle grandi Istar e Astarte. Nel
“Dizionario delle Dee e delle Eroine” di Patricia Monaghan:
“Ella
discese dal cielo sotto forma di un uovo da cui emerse la Dea-sirena, bella e
sapiente, suscitò la gelosia di un rivale che la maledisse, augurandole di
consumarsi d’amore per un bellissimo giovane. Ella restò incinta del ragazzo e
partorì Semiramide.
Poi
si assicurò l’eterna fedeltà del giovane rendendolo invisibile. Dopo aver
portato la figlia nelle foreste dove fu nutrita ed accudita da colombe, Atagartis
si gettò in un lago e divenne un pesce... in onore suo e di sua figlia, i
Siriani non vollero più mangiare colombi e pescare. Questa la forma base della sua leggenda, ma
ve ne erano delle varianti: quello di Dea della vegetazione, quella di Dea del
cielo, con la testa cinta di un velo di nubi e circondata da aquile, quella
infine di Dea del mare, coronata da delfini.
I
suoi Santuari contenevano tranquilli laghetti pieni di pesci, circondati da
alberi sacri su cui i colombi si
appollaiavano. Durante l’epoca romana, Akagartis era venerata con danze
estatiche da sacerdoti eunuchi.
Atagartis è una figura paragonabile ad Ishtar e a Cibele”.
(Le colombe, simbolo di fecondità, era sacre sia alla
Afrotide ellenica che alla Venere latina). Afrotide assunse
nel culto e nella tradizione letteraria l’aspetto di divinità dell’amore inteso “come attrazione delle varie parti dell’universo tra di loro, simboleggiando
nello stesso tempo l’istinto naturale di fecondazione e di generazione”.Anche sotto questi aspetti fu da molti assimilata alla
Istar babilonese , all’Astarte fenicia e alla Inanna sumerica.Il filosofo romano del I secolo d.C. Lucio Anneo Cornuto,
nel suo “Compendio di Teologia Greca”, scriveva in merito di Afrotide:
è verosimile che anche
di Afrotide si tramandi che sia nata nel mare
per nessun altro motivo
se non per questo: affinchè tutto venga all’essere, c’è
bisogno di movimento e
di umidità. Entrambi presenti nel mare in abbondanza....
Afrotide, per altro, è
la potenza che conduce insieme il maschile e il femminile:
forse ha assunto tale
denominazione in virtù del fatto che i semi generatori
degli animali sono
spumosi (aphrode)........
E’ presentata come
bellissima, poiché agli uomini risulta gradito in
massima misura il piacere relativo al congiungimento
come eccellente
al di sopra di tutti
gli altri, ed è chiamata per questo anche amante del
sorriso
(philomeides),,,,,, La fascia ricamata,
poi, è come adorna,
trapunta e variegata, e ha il potere di legare e
serrare insieme. È
chiamata inoltre sia celeste (Ourania), sia terrena
(Pàndemos), sia marina
(Pontia), poiché la sua potenza si osserva
sia in cielo sia in
terra sia in mare”.
I tre epiteti “Ourania,
Pandemos e Pontia” erano riferiti anche a Dione che dagli antichi popoli
pelagici era considerata la Signora del Cielo, della Terra e del Mare.
Era difficile
cancellare una simile figura con queste prerogative dalla cultura
popolare ed è per questo che gli attributi furono trasferiti in blocco alla
figlia Afrotide.
..............................
Enciclopedia delle Donne; altri file
Enciclopedia delle Donne – Seconda parte
Le Allieve della Scuola Pitagorica di Kroton (Crotone)
…………………………………………..
Enciclopedia della Donne – Terza Parte
1. Asclepio, il dio della medicina – Le sue figlie tutelari della salute;
5. Il Primo Ospedale di Roma; Santa Fabiola di Roma;
Adelasia Cocco; La Prima Medica di Condotta in Italia
………………………….
Enciclopedia delle Donne – Quarta parte
1. Il primo marito: Emerico d’Ungheria – Costanza fu la prima Regina d’Ungheria - Il Figlio Ladislao – La fuga verso l’Austria – Ritorno in Aragona dalla madre Sancha nel Monastero di Sigena (Sijna);
----------------------------
Enciclopedia delle Donne – Quinta Parte
OLANDA (ISABELLA) DI BRIENNE - SECONDA MOGLIE DELL'IMPERATORE
FEDERICO II DI SVEVIA
Sposò Federico II a 14 anni e morì di parto quando aveva 16 anni...un matrimonio voluto dalla Chiesa .....il suo Triste "Diario"
…………………………
Enciclopedia delle Donne – Sesta Parte
Indice:
……………………………………….
8 Marzo
……………………….
Il Movimenti Femminista - Il Diritto al Voto in Italia
Storia emancipazione femminile – Riviste femminili – La donna delle guerre –
Video
............................................
Eleonor de Moura - Prima ed unica donna Vicerè di Spagna in Sicilia - In 27 giorni di reggenza tante leggi anche a favore delle donne in difficoltà - Enciclopedia delle Donne (Settima Parte)
Indice:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/4152513673917210757/361050465589987803
.................................
Uomini con prostitute raffigurati su vaso
(hydria) attico a figure rosse del V secolo a.C.
Anche in
Italia la prostituzione sacra era presente in alcuni santuari che si trovavano
in centri commerciali greci e fenici in cui i commercianti potevano ritrovare
le proprie divinità tutelari.
Il culto di
Afrotide era molto presente nella Magna Grecia così come la fenicia Astarte in
Sardegna ed in Sicilia. (questi culti si ritrovano anche tra gli Etruschi).
Le
caratteristiche dei santuari con prostituzione sacre rimangono le stesse di
quelle conosciute in Grecia ed anche loro dotati di una grande ricchezza.
L’etrusca Pyrgi (Santa Marinella – Roma) venne
saccheggiata nel 384 a.C. da Dioniso I di Siracusa per la ricchezza del suo
santuario, ed Erice fu razziata per lo stesso motivo da Amilcare.
Santa Marinella (Roma) –
Il sito dell’antica Pyrgi
La ricchezza doveva essere tale che in alcune occasioni
furono usate le risorse di questi santuari per riassestare città e territori
dopo le devastazioni di nemici, come avvenne dopo il passaggio di Pirro a Locri
e di Annibale a Rapino.
Uno dei santuari più celebri si trovava a Locri
Epizefiri in Calabria. La città fondata tra VII e VII secolo a.C. da coloni
locresi ospitava il tempio di Afrodite in prossimità del porto. Scavi qui
effettuati hanno portato alla scoperta di una stoà (portico) a forma di U
chiamata di Centocamere per la presenza di numerose stanzette e che è stata
identificata come un lupanare. Vicino a questa struttura è stata ritrovata
l’area del tempio di V secolo a.C. che andò a sostituire una struttura templare
più antica di VII-VI secolo a.C.
Il quartiere di Centocamere
Locri Epizefiri – tempio
di Afrotide
Alcune ricostruzioni fatte da studiosi indicano questo
tempio di Afrodite come sede originaria del famoso Trono Ludovisi (datato al V
secolo a.C.) scoperto a Roma nel 1887 nei terreni della Villa Ludovisi.
Nel 181 a.C. il console Lucio Porcio Licinio aveva
costruito nei pressi della Porta Collina un tempio dedicato a Venere
all’interno del quale fu conservato il “Trono Ludovisi” dopo essere stato preso
dal tempio di Locri Epizefiri (o secondo altri dal tempio di Venere ad Erice).
La sua funzione è ancora discussa, alcuni vogliono identificarlo come la
decorazione del trono sul quale sedeva la statua della dea, altri come
l’ornamento di un altare, o ancora come una sorta di parafuoco per proteggere
chi svolgeva il sacrificio dalle fiamme. Originariamente, secondo una ulteriore
l’ipotesi proposta da alcuni studiosi, questo elemento scultoreo doveva essere
incastonato al centro del pavimento del tempio della dea a Locri, dove è stato
trovato un taglio quadrato le cui misure sembrano corrispondere a quelle del
trono.
Tempio – Cella e Bothros
Tempio – Bothros
Locri – il Tempio
Rilievo dell’apertura
quadrata al centro del pavimento del tempio
con la supposta
collocazione originaria del “trono Ludovisi”
Ricostruzione dello
storico, D. Mertens
Frammenti di Skyphoi a vernice nera
con iscrizioni dal Bothros
Iscrizione su vaso fittile
da Locri
La particolarità di questo manufatto è dovuta alla presenza di tre rilievi scultorei, quello centrale, più grande, che raffigura tre figure femminili, due laterali che aiutano una terza donna ad uscire dalla terra o dal mare. Nei due pannelli laterali compaiono invece due figure femminili. Sulla destra una donna seduta, velata, che sta svolgendo un sacrificio, mentre un’altra donna sul pannello sinistro, è nuda, seduta e sta suonando gli auloi. Questi rilievi presenti sul trono sono stati interpretati come tipici del culto di Venere-Afrodite. Nel pannello centrale infatti si è soliti vedere la nascita della dea, mentre nei pannelli laterali si riconosce una sacerdotessa che sta bruciando incenso (elemento caratteristico dei sacrifici a questa divinità) e una prostituta (la figura nuda) che suona gli strumenti a fiato. La funzione originaria del trono quindi potrebbe essere stata quella di pannello scenografico, al centro del tempio, dietro al quale una sacerdotessa, in particolari occasioni, rappresentava ritualmente la nascita della dea, accompagnata dal suono degli auloi delle prostitute sacre e con sacrifici d’incenso. La presenza della prostituzione sacra a Locri è inoltre testimoniata dal ritrovamento di numerose statuette ex-voto rappresentanti donne nude e dalle “Tabelle Locresi”, su alcune delle quali compare l’espressione che indica il prezzo delle prostitute.
Notizie di altri santuari con prostitute sacre le abbiamo
poi nell’antica Cossyra (Pantelleria) dove sorgeva il tempio di Astarte.
Pantelleria
La popolazione originaria di Pantelleria furono i
Sesioti, un popolo di origine ibero-ligure che s’insediò nell’isola a scopo
commerciale. Pantelleria aveva una grande quantità di ossidiana che veniva
ricercata in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo per fare arnesi da
taglio.
Furono poi i Fenici a fondarci una colonia, Cossyra, i
cui resti archeologici si trovano sulle colline di San Mauro e Santa Teresa. Successivamente
i Romani diedero un forte impulso nell’economia dell’isola come dimostrano i
numerosi insediamenti sparsi nel territorio.
Il grande santuario, risalente al periodo romano, si
trova nel sito archeologico del Lago di Venere, nella parte Nord dell’isola.
Pantelleria - Lago di
Venere
Resti del
Santuariodi Astarte/Venere
Le mura
Pantelleria –
Iscrizione Tanir (Miderna)
Monte Gibele
La
Grande Madre Tanit era anche chiamata “Mirionima” cioè “dai 10.000 nomi”.
Anche
a Roma le venne consacrato un tempio chiamata “Iuno Caelestis”.
Termine
“Caelestis” che era associato ad altre divinità come a Giunone, Venere, Diana e
Fortuna
Il
tempio di Tanir a Pantelleria fu dai Romani dedicato a Venere.
Una
dea associata all’amore, alla bellezza ed alla fertilità e quindi equivalente
alla dea greca Afrotide.
L’isola
di Pantelleria sarà oggetto di una mia prossima ricerca ed è forte la tentazione di pubblicare alcune
foto su degli aspetti naturalistici unici anche per dare una prima visione della bellissima isola del
Mediterraneo.
Lo zibibbo è un vitigno molti diffuso nel paesaggio agricolo di Pantelleria. Il particolare sistema di coltivazione e di potatura sono tramandati da secoli. Il sistema di allevamento del vitigno è ad alberello ma s’incontra anche un sistema che è denominato “canestro” ed è simile a quello praticato nell’isola di Santorini (Thera) in Grecia.
Pantelleria
– Vite ad alberello
Pantelleria
– Viti ad alberello (Patrimonio dell’UNESCO)
Pantelleria – Vite
“a canestro”,
Santorini (Grecia)
I
contadini panteschi da secoli s’adeguano al clima ventoso dell’isola con vari
accorgimenti. In questa foto sono utilizzate deli cladodi di fichidindia
(“pale”) tagliate in modo da fare un cuneo
e posizionate a protezione delle piantine di pomodoro o di altri ortaggi. In
questo modo si crea non solo una zona d’ombra per la piantina ma anche una
buona protezione dal vento necessaria soprattutto nelle prime fasi di crescita
della stessa piantina. L’umore della
“pala” spezzata, che fuoriesce dalla ferita, crea anche una piccola umidità che
è favorevole allo sviluppo delle piccole radici e alla nutrizione della
piantina.
Nei vigneti la protezione del vento s’ottiene con la
piantagione dell’orzo tra i filari di zibibbo. L’orzo oltre che come alimento,
un tempo il biscotto d’orzo era molto diffuso nell’isola, protegge i germogli
delle viti dal vento impetuoso primaverile (scirocco) che nel mese di maggio è
molto intenso.
La varie piante da frutto nell’isola vengono potate in un
modo particolare e cioè con i rami bassi verso il suolo. Un sistema per esporre
la minore superficie fogliare ai forti venti. Questa tecnica di potatura è
applicata anche agli alberi d’olivo con il risultato che si possono vedere
piante centenarie alte poco più di un metro con tronchi enormi e con rami che
sfiorano il suolo. Non sembra che esista al mondo una potatura simile per
l’olivo.
Ma Pantelleria non
finirà mai di stupire il visitatore alla ricerca di aspetti sconosciuti e in
grado di suscitare emazioni forse insesparte.
Penso che il
raggiumento di un offerta di valore nel capo turistico sia quella di offrire al
turistia .. qualcosa in più che non s’aspetta.
Nel bellissimo lago di Venere, un vero specchio della Natura,
sono presenti le Stromatoliti cioè delle strutture
sedimentarie di orgine organica e che sono prodotte da comunità di
microorganismi in ambiente marino o lacustre.
Le
stromatoliti silicee - spiega dice Marianna Cangemi -, sono molto rare in
natura e per la maggior parte all'interno di ambienti idrotermali a temperature
molto più elevate di quelle ambientali. Per questo motivo il ritrovamento di
tali strutture nel lago Specchio di Venere assume un carattere di eccezionalità,
se non di unicità, in quanto a Pantelleria tali rocce si sono formate e sono
attualmente in fase di accrescimento, in un ambiente di bassa temperatura,
costituendo un prezioso e attuale laboratorio geo-biologico".
"Questi
materiali - continua Paolo Madonia, ricercatore Ingv - rivestono da sempre
particolare interesse per microbiologi, paleontologi, sedimentologi,
biogeochimici e astrobiologi, in quanto contenenti, nella loro matrice minerale
la registrazione della storia chimica e morfologica della vita, e rappresentano
inoltre un fondamentale punto di riferimento per il riconoscimento di forme di
vita primordiali in altri pianeti, ad esempio su Marte."
Si
tratta di organismi viventi che risalirebbero a ben 3,5 miliardi d’anni fa.
L’impronta
di questi organismi sarebbe stata trovata in alcune rocce australiane.
Si
tratta di rocce sedimentarie della formazione di Dresser appartenenti proprio
alle stromatoliti, cioè le prime forme di vita terrestre (Raphael Baumgaetner,
della University of New Spoyth Wales (Australia) (studio pubblicato sulla
rivista “Geology”).).
“le
stromatoliti sono strutture sedimentarie che si osservano in rocce calcaree e
che sono il risultato dell’azione di microorganismi fotosintetici, in
particolare cianobatteri”.
Poi
hanno sottoposto i campioni alle più sofisticate e avanzate tecniche di
analisi: dalla microscopia elettronica a scansione, alla spettroscopia a raggi
X, fino alla spettroscopia Raman e
alla spettrometria di massa ionica
secondaria... una impressionante batteria di metodi e strumenti che
hanno infine condotto i ricercatori a una conclusione univoca.
SONO
STROMATOLITI, senza ombra di dubbio: le analisi hanno rilevato che
le strutture sono prevalentemente costituite da pirite (minerale composto da
ferro e zolfo) piena di pori nanoscopici, ossia estremamente piccoli; nella
pirite sono state evidenziate inclusioni di materiale organico contenente
azoto che somigliano a resti di biofilm (una complessa
aggregazione di microrganismi che si depositano su una superficie dando origine
a una sottilissima pellicola).
Fossile di Stromatolite
della formazione di Dresser
Sezione di un
frammento di roccia di 3,48 miliardi di anni fa, rinvenuto nella Dresser
Formation (Pilbara, Australia occidentale): le aree biancastre sarebbero la
prova della più antica forma di vita, che si è sviluppata in prossimità di
antiche sorgenti calde.
Pantelleria
– Stromalotiti
Pantelleria
Non
ho riferimenti su quando si sia formato il Lago o Specchio di Venere.
Il
monte più alto di Pantelleria è Montagna Grande con i suoi 836 m s.l.m.
Il
tipo di vulcano: caldera con centro monogenici
Tipo
di eruzioni: effusive, stromboliane, freatomagmatiche, pliniane
Fenomeno
prevalenti: emissioni idrotermali, sismicità
Inizio
attività eruttiva: < 330 – 325.000 anni
Ultima
eruzione: 1891
Stato
di attività: quiescente
L’isola è costituita in gran parte
da un mosaico di centri eruttivi che si
sovrappongono e che si sono
sviluppati al centro di una caldera di circa 28 kmq,
detta “Caldera dei Cinque Denti”
che a sua volta si era formata all’interno di
una più grande antica caldera che era ampia ben 42 kmq e detta “La Vecchia”
L’attività eruttiva si concluse tra
4000 e 5000 anni fa.
C’è da dire che due piccole eruzioni
sottomarine basaltiche a Nord-Ovest di
Pantelleria si verificarono nel
1831 e nel 1891 che furono accompagnate da
attività sismica e fumarolica
sull’isola.
Si verificarono
inoltre due episodi di sollevamento: fino a 0.8 m lungo la costa Nord-orientale
dell’isola (Maggio-Giugno 1890) e fino a 0.55 m (nell’ottobre 1891). L’ultima
eruzione ebbe inizio il 17 ottobre 1891 con lancio di brandelli di lava incandescenti,
visibili sia dall’isola sia dalle coste tunisine, e durò fino al 25 ottobre.
Questo episodio eruttivo, e in generale la geologia dell’isola, suggeriscono
che il vulcanismo si sia progressivamente spostato verso NW.
I tassi della
deformazione del suolo, delle temperature e le emissioni di gas (H2O
vap., CO2 e H2S) registrate negli ultimi 15 anni
sono in accordo con la presenza di un sistema idrotermale attivo e di una
camera magmatica superficiale (a circa 4 km di profondità) che sarebbe in via
di raffreddamento e in uno stato di deflazione.
Il Lago di Venere
dovrebbe essere uno dei centri eruttivi
dell’isola e diventato lago vulcanico (alimentato da ben tre sorgenti termali).
Un altro tempio importante si trovava ad Erice dove la tradizione indicava in Enea
il fondatore della città e del tempio di Venere, sua divina madre.
Nel tempio di Erice. che gli scrittori antichi indicavano
come il tempio più bello di tutta la Sicilia. fu praticata la prostituzione
sacra. Il sontuoso santuario di Venere Ericina si trovava sul Monte Erice, ma
oggi ne rimangono poche tracce consistenti nella piattaforma di base, in parte
del recinto sacro e nel “Pozzo di Venere”, una fossa votiva.
Tra le montagne di Sicilia. il Monte Erice (San Giuliano,
alto 751 m s.l.m.) è stato sempre uno dei siti più importanti dell’isola, non
solo per la presenza del santuario dedicato alla dea Ericina ma anche perché
posto a presidio delle importanti rotte commerciali marittime percorse da Fenici,
Greci. Ciprioti, Etruschi, Romani.
Sul monte era presente l’acropoli protesa sul mare e
Polibio lo definì
altus, magnus, Zephyro
semper apertus, ....selvaggio e ricco di vegetazione
Le prime citazioni indicarono il santuario come
extraurbano, comprendente il temenos o recinto sacro della dea ed un grande
altare. Polibio collocò l’edificio sulla cima del monte che era piana e secondo
Diodoro Siculo sorgeva su una terrazza che fu realizzata da Dedalo che mise in
opera un grande muro di contenimento poggiato sulla parete rocciosa. L’edificio
secondo Diodoro era costruito proprio
“sopra la parte
scoscesa della roccia”.
L’abitato invece si estendeva sulle pendici più in basso
e presentava un accesso molto difficile.
Oltre alle fonti letterarie, di grande importanza sono i
reperti numismatici che indicano la posizione del tempio sul monte.
Il denario romano di Marcus Considius Nonia nus, del 57
a.C., riporta un tempio posto su un rilievo, una cinta muraria, le torri e la
scritta
ERVC
Lo storico Biagio Pace, basandosi sulla raffigurazione
della moneta, avanzò l’ipotesi che il tempio fosse in origine a pianta
circolare. Tuttavia non si potrebbe escludere l’ipotesi che il tempio fosse in
realtà un “naòs tetrastilo con la cella interna del tempio destinata ad
accogliere la statua della divinità (Afrodite)”. (cioè la cella del tempio
con quattro colonne sul fronte).
La documentazione sul tempio risalirebbe al V secolo a.C.
ma l’edificio di culto era già preesistente dato che era il più importante
santuario dell’area Elima.
Si trovava anche in una posizione privilegiata rispetto
alla vicina città di Segesta che vi esercitava una sorta di egemonia.
I Segestani, come riferì Tucidide, si comportavano come
se il tempio fosse posto sotto la loro giurisdizione e lo convolsero nei
rapporti diplomatici con il mondo greco.
Nel 416, quando richiesero gli aiuti ad Atene per la
guerra contro i Selinuntini, i segestani
portarono in visita ad Erice gli ambasciatori ateniesi per dare loro un saggio
della forte ricchezza (alla fine si rilevò che era tutto un inganno) della
città.
Dimensione, ricchezza sempre decantata, continuità nel
tempo, peculiare collocazione geografica, sono tutti fattori che attestano
l’importanza, potremo definire “internazionale” del tempio che è confermata dai
notevoli reperti archeologici rinvenuti (purtroppo) in un contesto archeologico
molto rimaneggiato e che nel tempo ha subito delle manomissioni.
Furono rinvenute :
-
ceramiche tardocorinzie e attiche a figure nere e a
figure rosse, datate tra la seconda metà del VI e la fine del V secolo a.C.);-
amuleti e scarabei magico-sacrali di provenienza
orientale (micrasiatica, insulare, egizia, sirio-palestinese); nonché -
oggetti arcaici di fattura o ispirazione cipriota che
concorrono nel ribadire come proprio greche e fenicie siano le componenti più
leggibili dell’esperienza cultuale ericina.
A questo orizzonte si può ascrivere anche la nota statuetta in bronzo
conservata a Trapani. Si tratta di una
statuetta femminile ignuda che regge in mano una brocchetta , riconducibile
alla piccola plastica peloponnesiaca del periodo arcaico.
Bronzetto femminile con
brocchetta
Trapani – Museo “A.
Pepoli”.
In una rigorosa analisi
dei bronzetti, lo storico R. Fondacaro avanzò
l’ipotesi di riconoscere
nei due bronzetti, provenienti dall’area del santuario,
la raffigurazione
iconografica di una delle
ipotetiche “prostitute sacre” ericine.
-
Gruppo di amuleti e scarabei di tipi diffusi nel mondo
fenicio-punico e riferibili ad iconografie egiziane, esso costituisce
un’ulteriore importante testimonianza sulla presenza fenicio-punica ad Erice.
-
Una celebre testina in marmo alabastrino (IV sec. a.C.)
in cui è stata vista l’immagine stessa della dea ericina
Testa femminile in marmo
alabastrino in
cui è stata identificata
la dea ericina
(IV secolo a.C.)
Erice – Museo Civico “A.
Cordici”.
-
Una seconda testina
in pietra arenaria (databile alla metà del V sec. a.C.) raffigurante una
probabile divinità femminile (la dea ericina?). La dea indossa un copricapo di
forma troncoconica rovesciata, il cui margine presenta una inedita corona di
frutti, probabilmente ghiande. I frutti erano in origine costituiti in parte dalla
stessa pietra lavorata e in parte da elementi aggiunti in altro materiale
(bronzo?) che si inserivano nella cavità inferiore di ciascuno di essi. Le
dimensioni ridotte (alt. 16,5) suggeriscono la pertinenza a un gruppo scultoreo
relativo a decorazioni architettoniche per altari, acroteri o frontoni.
Testa Femminile con
copricapo tronco conico
Trapani – Museo “A.
Pepoli”
Statuetta femminile, forse
una danzatrice,
avvolta nell’”himation” e
velata
IV/ III secolo a.C.
Purtroppo dei resti archeologici è rimasto ben poco:
un’antica necropoli fuori Porta Trapani; gli imponenti
resti della cinta muraria e alcuni resti nel cortile del castello normanno
detto di “Venere” e riconducibili all’antico santuario o tempio.
L’acrocoro di Sud-Est, con le sue pareti tagliate
verticalmente, coincide perfettamente con la descrizione di Diodoro Siculo, e
presenta alcuni resti dell’area sacra che erano visibili ancora prima
dell’inizio degli scavi.
I resti del famoso santuario sono legati alla piattaforma
di base.
Sono presenti alcuni tratti di un robusto muro di
sostruzione in grossi blocchi squadrati che richiama alla mente la descrizione
di Diodoro in merito al “muro di Dedalo”.
Vista sul “Ponte di
Dedalo” e sul “Muro di Dedalo”
Le Torri del Balio sullo
sfondo
“A Erice, dove si trova
una roccia tagliata a picco fino ad un altezza insolita, poiché
la ristrettezza dello
spazio occupato dal santuario di Afrotide rendeva necessario edificare le
strutture sullo strapiombo della roccia, costruì un muro proprio
sul precipizio,
ampliando il modo straordinario il piano sovrastante il precipizio”.
Si notano anche tre fosse circolari, adibite a cisterne.
I primi scavi su quest’area sommitale, dove insiste il
castello normanno, risalgono agli anni 1930 -31 per merito degli archeologi P.
Marconi e G. Cultrera.
Dagli studi condotti dagli archeologici emerse come i tre
settori riconosciuti come precedenti all’edificazione del castello normanno
erano contraddistinti dai seguenti vani:
-
I vani (1 -4), disposti ad L, e destinati ad aree
funzionali per edificio sacro. I loro muri esterni sono più visibili perché
sostituiti dalle strutture murarie del castello;
-
Il “pozzo di Venere”;
Si tratta di un’ampia
cisterna interamente scavata nel banco roccioso
ed usata per contenere
l’acqua della spianata che doveva ospitare il tempio.
Sullo sfondo, sopra il
muro, si nota una struttura forata,
la “Colombaia” che
richiama alla colomba volatile caro ad Afrotide.
-
La piattaforma al centro del cortile, con il muro in corrispondenza del suo ingresso;
-
Una serie di rocchi di colonne ed elementi della
decorazione architettonica.
Della piattaforma facevano parte i vani (5 – 6) che
fungevano da fronte settentrionale di una probabile terrazza più ampia dove
sorgeva il tempio.
Il muro (6) presenta delle tecniche edilizie diverse
indicanti altrettanti fasi costruttive che si sono succedute nel tempo. Le
lastre pavimentali, poste lungo il muro (6) con un orientamento differente.
È probabile come questo muro in origine abbia avuto la
funzione di separare due settori:
a Sud una terrazza posta ad una quota più elevata e a
Nord un’area lastricata scoperta che fu rovinata dal successivo edificio a
carattere termale.
L’area sacra doveva occupare anche la zona dove oggi sono
presenti le Torri del Balio dove nel 1885 furono rinvenuti frammenti di anfore
con bolli rodii ed italici databili al III secolo a.C.
Erice – Stampa del 1892
Parlare del santuario significherebbe citare la nascita
della città di Erice, uno dei principali centri degli Elimi insieme a Segesta
ed Entella.
Secondo la leggenda sarebbe stata fondata da Eryx, figlio
di Afrotide e del re locale Bures. Proprio in onore della madre il giovane Eryx
fondò il celebre santuario che sorgeva sulla rocca della città. All’arrivo di
Eracle con i buoi di Gerlone, Eryx lo avrebbe sfidato ad una gara di pugilato,
restando ucciso nello scontro.
Una leggenda molto antica che forse riflette antiche
frequentazioni micenee. Leggenda che era conosciuta da Erodoto che la citò in
merito alla spedizione dello spartano Dorieo che, intorno al 510 a.C., fondò
una colonia ad Erice, chiamandola Eraclea.
L’oracolo di Delfi, infatti, affermò che il territorio di
Erice apparteneva agli Eraclidi, in quanto era stato conquistato da Eracle.
La colonia ebbe una vita breve, e fu distrutta dai
Cartaginesi che erano alleati con i Segestani.
Tra i fondatori sopravvisse solo Eurileonte, che con
pochi compagni andò ad occupare Eraclea Minoa. Tutta la vicenda testimonia
l’interesse strategico ed economico di questa zona, contesa tra Greci e Cartaginesi già alla fine del VI
secolo a.C.
La città ed il suo porto di Drepanon, l’attuale Trapani,
rimasero da allora soggette al dominio cartaginese, fino alla prima guerra
punica.
Nel 260 a.C. i Cartaginesi rasero al suo Erice, tranne
il tempio, e ne trasferirono gli abitanti a Trapani, che fu allora fondata
come città, diventando una delle più importanti basi navali.
Nel 248 a.C. i Romani, con un colpo di mano, riuscirono
ad impadronirsi di Erice, ma nel 244 Amilcare Barca, provenendo da Palermo,
riconquistò la città, tranne la cittadella con il tempio, che rimase in
mano romana.
Gli aspri combattimenti che si svolsero sulla sommità del
monte non modificarono la situazione, finchè la fine della guerra, nel 241
a.C., assegnò tutta la Sicilia Occidentale, compresa Erice, ai Romani.
Da allora il santuario di Venere Ericina diventerà uno
dei più venerati, in base alla comune origine troiana che avrebbe legato i Romani
agli Elimi. Una tarda leggenda, ripresa da Virgilio, ne attribuiva la
fondazione allo stesso Enea.
Il Santuario di Venere Ericina sorgeva su una spianta in
parte sostenuta da mura megalitiche.
Un tratto, sul lato Nord – Ovest. È detto “Muro di Dedalo”
secondo una tradizione mitica che, come abbiamo visto, fu riportata da Diodoro
Siculo, secondo cui:
presso Erice esisteva
una roccia a picco così alta, che le costruzioni
circostanti il tempio
di Venere minacciavano di finire nel precipizio.
Dedalo consolidò queste
costruzioni, circondò la roccia con un muro e ne
allargò la sommità in
modo mirabile.
Successivamente
consacrò ad Afrotide Ericina un’arnia d’oro,
lavoro straordinario
che imitava in modo perfetto una vera arnia”.
Secondo Diodoro, il santuario fiorì soprattutto dopo la
conquista romana;
quando i consoli, i
generali, e tutti coloro che rivestono una grande carica
arrivano in Sicilia,
passano da Erice, onorano il tempio di Venere con
sacrifici ed offerte,
spogliandosi delle insegne della loro dignità, si danno ad allegri godimenti
con le donne, ritenendo di rendersi così gradi alla dea”.
Accenna quindi alla prostituzione sacra, tipica delle
divinità di origine orientale e diffusa anche in ambiente fenicio.
Il culto della dea, come quello in origine di Astarte a
cui era dedicato il tempio con i cartaginesi, si svolgeva su un altare
all’aperto, senza sacrifici cruenti.
Le colombe sacre alla dea e rappresentate insieme alla
stessa dea nelle monete di Erice datate V secolo a.C., sarebbero scomparse una
volta all’anno per 9 nove giorni,
era le festività degli “Anagogia e Katagogia” e
l’intervallo di tempo che separava le due festività, era ritenuto come il
viaggio di Afrotide verso il santuario gemello di Astarte, che sorgeva a Sicca
Veneria, in Africa Settentrionale.
Un fenomeno che ribadiva l’antica protezione verso il
mondo fenicio e cartaginese.
Bellissima Anfora del IV
secolo a.C.
Opera del “Pittore di Afrotide”
Collocazione: Museo
Archeologico di Paestum.

La figura rappresentata è Afrodite,
dea della fertilità, e richiama il suo arrivo
sull'isola di Cipro: al suo
passaggio la vegetazione esplode rigogliosa.
La dea è circondata da due eroti con
ali di colomba.
Il senato romano impose
a 17 città siciliane di versare un’offerta di corone d’oro al santuario e creò
anche un corpo di guardie speciali costituito da 200 schiavi armati che si
chiamavano “venerii”.La venerazione
particolare dei Romani, testimoniata tra l’altro da iscrizioni con dedich3e
d’età repubblicana, non impedì la decadenza del santuario.In età augustea era
ormai abbandonato, come ricorda Strabone e con Tiberio fu iniziato un restauro
che fu completato solo da Claudio secondo le fonti di Tacito e di Svetonio.Questa fu l’ultima
citazione mentre la data della sua completa distruzione è sconosciuta.
Probabilmente i materiali furono impiegati nella costruzione del castello.
......................Ritornando alla
prostituzione sacra c’è da dite che fu
presente anche nel territorio abruzzese e nella popolazione dei Peligni (un
piccolo popolo italico di lingua osco-umbra, storicamente stanziato nel I
millennio a.C. nella valle Peligna in Abruzzo).
Un’iscrizione del II – I
secolo a.C. trovata su una tomba nel 1877 riportava la presenza di “un incaricata
delle prostitute “ (“pristafalacirix” in lingua peligna) con una carica
religiosa simile a quella esistente
nella città di Corinto.
Presso il popolo dei
Marrucini (sempre di lingua osca-umbra, ma rispetto ai Peligni erano stanziati
lungo una parte della costa adriatica dell’Abruzzo) era presente la
prostituzione sacra come testimonia la “Tabula Rapinensis” relativa alla città
di Rapino (Chieti).“Tabula” che fu scoperta
nel 1841 e databile al III secolo a.C. e che riportava, secondo alcune interpretazioni,
una legge che istituiva e regolamentava la stessa prostituzione sacra.
Tabula rapinensis (Tavola di
Rapino), una legge sacra incisa su una lamina bronzea del
prostituzione
sacra.
Il culto
di Giove è attestato anche dalla raffigurazione sulla preziosa gemma
in diaspro esposta vicino alla Dea di Rapino e rinvenuta nella stessa grotta.La Tavola di
Rapino, di cui si ha notizia sin dal 1841, fu pubblicata per la prima volta
da Mommsen nel 1846, che ne propose l’acquisto al Museo di Napoli. Fu
poi invece acquistata per l’Antikensammlungen di Berlino, da cui scomparve per
le vicende della II Guerra Mondiale. Si troverebbe, secondo alcune notizie non
confermate, presso il Museo Puskin a Mosca.
La cosiddetta “Dea di Rapino” è una piccola statuina in bronzo raffigurante una divinità femminile databile, secondo alcuni, all’Età arcaica (VI sec. a.C.) o, più probabilmente, come sostenuto più recentemente da altri studiosi, all’età ellenistica (III-I sec. a.C.). Indossa una lunga veste coperta da un mantello ed ha i capelli raccolti in una lunga treccia. È forse una riproduzione miniaturistica di una più grande statua di culto che rappresentava la Dea Madre, divinità legata ai cicli naturali della terra, come indica anche la focaccia con spiga che regge con la mano sinistra, oppure riproduce semplicemente una figura di offerente.
A Gravisca, che fu porto di Tarquinia (Viterbo) già dal
VI secolo a.C., originato come emporio greco, si sviluppò il culto di Afrodite,
conosciuta presso gli Etruschi con il nome di Turan. Qui erano presenti anche
altri templi tra cui quello di Era e Demetra (in etrusco Uni e Vei) ed un
importante culto di Adone. Dagli scavi dell’area di Gravisca provengono alcuni
elementi come tavolette con raffigurazioni di donne nude e iscrizioni con
epiteti riconducibili alle ierodule, che consentono di indicare la presenza di
prostitute sacre.
Santuario di Gravisca
Ex voto dal santuario di
Gravisca
A Pyrgi, attuale Santa Severa (Roma), porto di Caere
(Cerveteri), la ricchezza del santuario emporico era tale che portò Dioniso I
di Siracusa a depredarlo nel 384 a.C. Qui nel V secolo a.C. venne ampliata
l’originaria area sacra con la costruzione di un nuovo tempio, dedicato,
secondo quanto indicato da Strabone, ad Ilizia-Leucotea (identificabili con
Era-Mater Matuta) accanto al tempio più antico (del VI secolo a.C.) consacrato
ad Uni-Astarte. Scavi in un sacello posto tra le due strutture templari hanno
portato al ritrovamento nel 1964 delle famose lamine di Pyrgi, in oro, sulle
quali compare un testo bilingue in fenicio ed etrusco. La prima lamina, scritta
in fenicio, riporta una dedica ad Astarte, mentre sulle altre, in etrusco,
viene riportata la fondazione di un culto e lo svolgimento di un rituale. Alcuni autori antichi citarono le “scorte
Pyrgiensia” (prostitute di Pyrgi) e una prova archeologica di
questa indicazione può essere legata alla presenza nell’area sacra di un edificio
con circa 20 camere con altari per i sacrifici nell’area antistante, molto
simile alla stoà di Centocamere trovata a Locri Epizefiri, che poteva essere
usato dalle ierodule per accogliere i fedeli.
Pyrgi – Area Archeologica
Pyrgi
Santuario
Antefissa a testa di
acheloo
(divinità fluviale con la raffigurazione di un toro)
530/520 a.C.
Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia (Roma)
Acroterio configurato a guerriero
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek.
Le tre lamine d’oro del VI secolo
a.C.,
con la stessa iscrizione in etrusco
e punico, rinvenute a Pyrgi
Furono trovate nel 1964 e
la loro scoperta destò molto entusiasmo nel mondo
scientifico. Si trovavano
tra il materiale di scarico proveniente
da un recinto posto tra
i due templi dell’area
archeologica. Tre lamine d’oro, accuratamente arrotolate,
due delle quali
incise con scritte i lingua etrusca e
l’altra in lingua fenicia arcaica.
Attorno alle lamine vi
sono una serie di piccoli fori che
permettevano di
collocarle alle porte di uno dei due templi (erano più
vicine al tempio B) con dei
chiodini, in parte
ritrovati, in bronzo e con la testa d’oro.
I due testi più lunghi, una lamina con iscrizione in
etrusco di 16 righe e 36 o 37 parole e l’altra di 10 righe in fenicio, sono
quelle con le maggiori somiglianze. La terza lamina, in etrusco e in 9 righe,
riassume brevemente le dedica.
Si tratta di un’iscrizione sacra che testimonia la
consacrazione di un piccolo tempio alla dea etrusca Uni (Giunone), assimilata
alla fenicia Astarte, da parte di Thefarie Velianas, supremo magistrato
(lucomone) della città di Caere.
Il testo in fenicio fornisce le motivazione della
consacrazione (Thefarie Velianas, principe/tiranno di Cere, rende omaggio alla
dea per la sua posizione di vertice nel governo cittadino), mentre quello
etrusco sembra dare un maggiore risalto al cerimoniale del culto. La terza
lamina, quella più breve, riassume brevemente la dedica.
Secondo gli studiosi i due testi corrispondono tra loro ma non sono l’esatta traduzione l’uno dell’altro e i contenuti della lamina in lingua punica presenta alcuni punti oscuri che ne limitano la perfetta conoscenza.
Anche
tra i Sabini, nella città di Curi, si consacrava al dio Quirino la più bella e
nobile delle fanciulle della città che diventava danzatrice e prostituta del
dio. É probabile che queste pratiche religiose venissero assorbite dai popoli
indigeni attraverso l’influenza etrusca e greca.
In ambito romano abbiamo alcune testimonianze che
sembrano provare la presenza della prostituzione sacra a Roma. Attraverso
l’analisi di alcune festività del calendario romano si è visto come precisi
elementi cultuali possano identificarsi come riflesso di una antica pratica
della prostituzione sacra. È il caso ad esempio della festa delle Nonae
Caprotine che si celebrava il 7 luglio. Il nome di Nonae Caprotinae deriva dal
fatto che le donne in quel giorno eseguissero un sacrificio a Iuno Caprotina sotto
un caprifico (fico selvatico). Il Racconto leggendario all’origine della festa
narrava che dopo la ritirata dei Galli, che avevano invaso la città, Roma non
si era ancora ripresa e rimaneva indifesa contro l’aggressione dei popoli
vicini. Questi minacciavano guerra se i Romani non avessero consegnato tutte le
loro donne. In questa situazione di pericolo una schiava, ricordata con il nome
di Filotide o Tutula, escogitò un piano per salvare la città, e propose che con
altre schiave la lasciassero andare dal nemico vestite come donne libere. Una
volta nel campo nemico avrebbero fatto festeggiare i guerrieri fino a stordirli
e solo a quel punto avrebbero lanciato un segnale ai soldati romani che
sarebbero dovuti intervenire per distruggere i nemici. Il piano riuscì in pieno
e le schiave furono liberate e ricompensate con una dote che permise loro di
sposarsi, e inoltre da quel momento Roma istituì questa festa dedicata alle
schiave chiamata anche ancillarum feriae (festa
delle serve). Infatti in quel particolare giorno le schiave potevano vestirsi
come donne libere e, insieme alle loro padrone, facevano un sacrificio alla dea
sotto un albero di caprifico, albero sul quale, secondo la leggenda, Filotide
si sarebbe arrampicata per dare il segnale ai soldati romani.
Nonae Caprotinae era Giunone, patrona di numerose feste,
che come questa la cui origine risalirebbe al 390 a.C., erano in rapporto con
la fecondità delle donne.
Era (Giunone) Barberini
(Barberini dal nome della
famiglia che possedeva la statua)
Copia romana del II secolo
d.C. di un’originale del V secolo a.C.
attribuito a Agorakritos
Collocazione: Musei
Vaticani – Città del Vaticano
Il termine “Caprotinae” sarebbe legato all’agricoltura
romana in quanto coincide con la “caprificatio”, periodo dell’anno in cui si
fissavano rami di fichi selvatici a quelli coltivati per favorirne
l’impollinazione.Il termine sarebbe anche collegato al capro (becco)
(“caper”), comunque sia il fico selvatico che il capro erano considerati
simboli di fecondità.Il sacrificio che le donne libere compivano sotto il
fico selvatico consisteva nell’offrire a Giunone Caprotina il succo che
gocciava dai rami e dai frutti dell’albero stesso.Le
schiave invece, per tutto il resto della giornata, si vestivano da matrone e si
divertivano a correre e a simulare combattimenti tra di loro sia a mani nude
che lanciandosi delle pietre.Alcuni storici hanno voluto vedere in questa festività
romana elementi caratteristici della prostituzione prenuziale nella quale la
prostituzione appunto, oltre alla vittoria di Roma, portò queste serve al
raggiungimento di una dote ed al successivo matrimonio. Ulteriori tracce di
ierodulìa nella tradizione romana emergono inoltre dai racconti mitici che
narrano di incontri sessuali tra donne e membri virili apparsi dal nulla, come
nel caso della nascita del re Servio Tullio, frutto dell’unione della madre
Ocrisia, schiava del re Tarquinio Prisco, con un fallo comparso tra le ceneri
del focolare.
Altre prove sarebbero legate alla festa di Anna Perenna
che si svolgeva sulle rive del Tevere ed era caratterizzata da rituali
orgiastici, nei Floralia in cui le prostitute si spogliavano ritualmente su
richiesta dei partecipanti ed eseguivano sfrenate danze, e ancora nei Vinalia
dedicati a Venere e svolti nel tempio di Porta Collina nel quale si portavano
doni a Venere Ericina, e dove le donne, non quelle sposate o libere, venivano
scelte dagli uomini.
Bona Dea
Durante la festa della Bona Dea si svolgevano invece vere
e proprie orge rituali, che rappresentavano dei matrimoni sacri nei quali si
prostituivano donne di nobili natali ed erano tenute in grande
considerazione.
Bona Dea
Statua in marmo con
epigrafe
Bona
Dea-II-III sec., iscrizione
Ex visu iussu Bonae
Deae Sacr (um) Callistus Rufinae N(ostrae) Act(or)
“Callistus schiavo alle
dipendenze di Rufina in veste di actor (avvocato o tesoriere),
ha dedicato questa
statua alla Bona Dea, in seguito ad una richiesta della dea stessa,
che gli è comparsa in
sogno”
Collocazione: Collezione
privata
Il termine Bona Dea aveva il significato generale di
Grande Madre e si venerava un’antica divinità laziale, il cui nome non poteva
essere pronunciato.
In origine fu un appellativo della dea romana Fauna che
formò insieme a Faunus (suo marito e fratello) una delle più antiche coppie di
dei indigeni del Lazio.
Bona Dea Fauna era stata, come Fauno, una divinità della
pastorizia e dei boschi e venne anche indicata con il nome di “Fatua”, dea che
predice l’avvenire.
Dal suo culto erano esclusi gli uomini così come a quello
rivolto a Fauno erano escluse le donne.
Ben presto sull’epiteto di Bona Dea venne ad innestarsi
il culto di una divinità greca che fu introdotta in Roma dalla Magna Grecia e
così la nuova figura fece dimenticare l’antica dea.
La dea greca che assunse a Roma il nome di Bona Dea fu
Damia, una divinità venerata specialmente nell’Argolide, a Egina, a Sparta, a
Thera, e in Italia in particolare a Taranto.
Secondo alcuni storici sarebbe la Giunone venerata a
Cartagine.
Anche per il culto di Damia potevano partecipare solo le
donne e le cerimonie venivano eseguite con gli occhi chiusi ed al buio
(duravano nove giorni e nove notti).
Ritornando al culto della Bona Dea, secondo la versione
di Lattanzio (scrittore, apologeta romano di fede cristiana; Africa 250 circa /Gallie,
dopo il 317) era la moglie di Fauno. Una donna molto abile in tutte le arti
domestiche e molto pudica, al punto di non uscire dalla propria casa e di non
vedere altro uomo che suo marito.
Un giorno trovò una brocca di vino. Cominciò a bere la
bevanda fino al punto di ubriacarsi.
Sua marito la castigò con verghe di mirto ma con tanta
inaudita violenza da procurargli la morte. Infatti l’uso del mirto era vietato
nei templi a lei dedicati.
Fauno si pentì del misfatto e deplorando la morte della
sua sposa, la pose nel numero degli Dei.
Un’altra versione del mito recita come la donna cercò di
sfuggire alle pretese sessuali di Fauno (che in questo caso era il padre) e lui
la colpì con i rami di mirto. La costrinse a bere del vino e riuscì alla fine a
possederla dopo essersi trasformato in serpente.
Sulla figura della Dea Bona tante leggende, qualcuna
immortalata nella pittura di famosi artisti, ed anche violenze e vendette
maturate sulle sponde del Tevere.
Ancora prima della nascita di Roma, sui colli erano
presenti delle divinità tra cui Ercole al tempo del mitico re Evandro.
Ercole sui Colli si sarebbe scontrato con il gigante Caco che era dedito alla rapina e
che viveva in una grotta dell’Aventino.
Dopo aver ucciso il gigante, Ercole stanco ed assetato,
si mise alla ricerca di una fonte. Giunse in un bosco in cui si trovava il
santuario della Dea Bona da dove giungevano delle risate di fanciulle.
S’avvicinò al santuario e chiese dell’acqua ma la vecchia sacerdotessa lo
allontanò in modo scortese dichiarando che la sacra fonte era riservata alle
donne.
Ercole non reagì alla scortesia e si vendicò
dell’affronto subito quando eresse l’Ara massima nel Foro Boario dove il suo
culto era interdetto alle donne:
“affinché in eterno la sete di Ercole non resti invendicata”,
(elegia di Properzio)
La dolce e sfortunata Fauna,, una volta divinizzata, diventò
il simbolo del chiuso mondo muliebre, tutto legato alle eterne vicende della
vita femminile, dalla castità prenuziale all’iniziazione sessuale ed alla
maternità.
Il suo santuario si trovava in un bosco sacro sulle pendici
dell’Aventino Piccolo ed Ovidio lo citò nei suoi “Fasti”: “È un nativo dirupo il suo luogo; la realtà ne suggerì il
nome: / lo chiamano infatti Sasso, ed è parte cospicua del monte”. Per
questo motivo venne anche chiamata “Subsaxana” dal termine “saxum” (sasso).Nel
santuario, come detto precluso agli uomini, erano allevati dei serpenti
domestici, come avveniva anche in altri templi di dee che erano legate alla
fecondità ed alla salute.Il
tempio sorgeva nei pressi del luogo dove oggi si trova la chiesa di santa
Balbina. Vi veniva celebrata una festa il primo maggio e in quell’occasione si
sacrificava una scrofa gravida.La
data aveva una sua funzione perché doveva ricordare l’anniversario della
fondazione del tempio che, secondo Ovidio,
le era stato dedicato da una vestale.La
vestale sarebbe stata Claudia Quinta, la stessa che aveva accolto a Roma
la Magna Mater.Nata
nel III secolo a.C. di lei non si conoscono le date di nascita e di morte. Una
delle poche citazioni fa riferimento ad Ovidio che la descrisse come donna
virtuosa e di bell’aspetto. La sua reputazione era ingiustamente colpita per il
suo abbigliamento e portamento. La donna era stata falsamente accusata di essere
una pettegola.La
sua virtù fu riscattata da un evento miracoloso avvenuto nel 204 a.C. quando il
simulacro della Magna Mater (Cibele) fu trasportato in nave da Pessinunte a
Roma-La
nave giunta nell’alveo del Tevere s’incagliò e la donna con le sole sue forze
riuscì a disincagliarla grazie all’aiuto della stessa dea.In
questo modo fornì al popolo romano il grande segno della sua purezza. Un
episodio che rimase impresso nei ricordi dei romani tanto che venne più volte
rappresentato in teatro come racconta lo stesso Ovidio.Come
mai il simulacro si stava trasportando a Roma?Nel
205 a.C. la repubblica romana decise d’incorporare il culto della Grade Madre o
Culto di Cibele e decise di spostare il simulacro da Pessinunte, una città
tempio posta nella regione più orientale dell’Asia minore sotto il dominio
romano.Funo
spostati dalla città sia il simulacro e la grande pietra nera, che si diceva fatta
cadere dalla stessa Cibele. Questo spostamento era legato allo scopo di
garantirsi i favori della popolazione locale durante la seconda guerra punica
dato che Annibale ed i suoi cartaginesi si lasciavano andare a spietate razzie.
Claudia Quinta riesce
da solo a disincagliare l’imbarcazione
(Artista: Lambert
Lombard
Liegi, 1505 –
Liegi, 1566
Pittura: olio su
tela- Datazione: ?
Dimensioni: (1,39
x 1,69) m – Collocazione: Chiesa di St. Armand a Stokrooie
Claudia Quinta
Artista: Neroccio
di Bartolomeo de’ Landi
(Siena, giugno
1447 – Siena, 1500)
Dipinto: Olio su
tela ? – Datazione: 1490 circa
Misure: (1,05 x
0,46) m
Collezione: Andrew W. Mellon collection
National Gallery
of Art – Washington
Nel Museo della
centrale Montemartini c’è un altare in rilievo marmoreo di
età claudia (14
a.C. – 68 d.C.) dedicato alla Dea Madre e alla “navis salvia” e
raffigurante l’arrivo
della dea Cibele a Roma in nave.
La dedica presente
sull’altare allude alla leggenda legata
alla donna della
onorata famiglia
Claudia. Si tratta di un altare in rilievo in marmo che
fu scoperto sulla
riva del Tevere, sotto l’Aventino e durante il pontificato di
Clemente XI, in un
periodo compreso tra il 1700 ed il 1721.
La facciata
dell’atare reca un iscrizione dedicatoria e un’allusione all’arrivo
in nave a Roma
della dea Cibele.
Sulla faccia
posteriore dell’altare ci sono due flauti, mentre il lato destro haun “pedum” e un
piatto mentre il sinistro un berretto frigio.Tutti simboli
riferiti alle origini di Cibele e al suo collegamento con il culto associato
di Attis.
L’immagine
centrale è una piccola nave con un pennacchio di poppa
ricurvo e una prua
a voluta. La dea in trono al centro dovrebbe essere
immaginata
all’interno dell’edicola che si trova alle sue spalle.
È completamente
avvolta in un velo, chitone e himation con una mano
appoggiata sul
ginocchio e un’altra sollevato sul timpano.
Attorno all’argano
a prua, è avvolto una breve fune la cui estremità cade
leggermente dalla
mano di una donna posizionata obliquamente alla
parte anteriore
della barca. La donna è posizionata su una piattaforma
sporgente. Ha in
testa un velo e indossa un chitone avvolto strettamente
sul petto e
allacciato allo stesso modo di quello indossato dalla dea, ma il suo
mantello è avvolto
in modo sciolto sul braccio libero.
L’iscrizione
dedicatoria nomina la dea e dà anche un nome alla nave
matri.deum.et navi salviae
salviae voto suscepto
claudia synthyche
d. d.
Alla
madre degli dei e alla nave salvia
Come in un voto fatto a Salvia
Claudia Syntyche
dedica questo dono
La dea Cibele
rinvenuta ad Osta
Museo di Napoli
La dea siede in
trono con alta spalliera, bassi braccioli e gambe quadrate,
e poggia i piedi
su un suppedaneo con sostegni a zampe di leone.
Veste una lunga
tunica altocinta e calza sandali; un himation le copre
le spalle, scende
sulle braccia e sulle gambe, dove si distende in ampie pieghe orizzontali. Ai
lati del trono, due leoni accovacciati poggiano l'uno la gamba destra, l'altro
la gamba sinistra sul poggiapiedi della dea. La mano sinistra della dea con il
tympanum appoggiato al bracciolo del trono e la testa, dai cappelli raccolti
dietro la nuca con scrimitura centrale e con corona turrita, sono frutto di un
restauro operato probabilmente tra il XVII ed il XVIII secolo, certamente prima
del trasferimento della scultura dalla guardaroba del Palazzo Farnese alla
Villa della Farnesina; la mano destra Ë stata invece integrata a Napoli, dopo
il 1805.
l'iscrizione:
Virius Marcarianus v(ir) c(larissimus) deam Cybelen p(ecunia) s(ua).
Alta: 98 cm
Marmo banco
/scalpellatura e levigatura
Dara di creazione:
140 d.C. – 160 d.C.
Il
tempio della Dea Bona venne poi restaurato da Livia, la moglie di Augusto, come
riportò Ovidio: “Lo dedicò la erede dell’antico nome dei Clausi, / che mai
aveva sopportato uomo con il virgineo corpo. / Livia lo restaurò affinché non
restasse non imitato / lo sposo, ed ella lo seguisse in ogni sua iniziativaAi
primi di dicembre si celebrava un culto misterico privato, riservato alle donne
più influenti della città e che si svolgeva in casa di un alto magistrato della
città (console o pretore), sulla quale ricadeva la benedizione della dea.La
cerimonia si svolgeva di notte ed era prevista
l’assistenza di vestali. La casa prescelta veniva addobbata di tralci
d’uva, altre piante e fiori, escluso il mirto. Si faceva venire il vino, che era chiamato “lac”
(latte) e il recipiente che lo conteneva “mellarium” (vaso di miele).Tutti gli uomini presenti nella casa la dovevano
abbandonare e in, poche parole, anche i bambini ed i neonati. Gli uomini aspettavano la fine del rito presso
le case di amici e parenti consapevoli che quel rito era sacro e quindi non si
doveva infrangere la regola.Eppure
avvenne un fatto strano perchè un uomo osò infrangere la regola: Publio Clodio
Pulcro.La
notte tra i 4 ed il 5 dicembre del 62 a.C., il rito doveva svolgersi nella casa
di Giulio Cesare, pontefice massimo e neoeletto pretore. La dimora era quella
“Regia”, in origine dimora dei re e poi dei pontefici massimi, i cui resti si
notano lungo la via Sacra del Foro Romano, vicino alla Casa delle Vestali.
sulla destra la Regia
Clodio
aveva trentun’anni ed era all’inizio della sua carriera politica. Il suo
obiettivo era diventare tribuno della plebe e per questo motivo aveva
modificato anche il suo nome aristocratico “Claudius” nella variante plebea
“Clodius”.Era
fratello della bellissima e spregiudicata Clodia che fu più volte citata da
Cicerone e da identificare probabilmente con la Lesbia cantata da Catullo.
Publio Clodio Pulcro
Clodia , sorella di Clodio e amante di CatulloPer quale motivo Clodio s’introdusse nella casa di Cesare
in modo furtivo ?I rapporti con lo stesso Cesare erano ottimi oppure c’era una relazione clandestina con la
padrona di casa Pompea ?Accettata quest’ultima versione il momento per un azione
simile non era molto opportuno.
Pompea Silla, seconda moglie di
Giulio CesarePompea ritratta
nel "Promptuarii Iconum Insigniorum" del 1553
Clodio
riuscì ad entrare nella casa di Cesare, trasvestito da suonatrice d’arpa e
grazie alla complicità d’una schiava. La luce tenue delle lucerne favorì il suo
piano.
Durante
il il lectisternium, cioè il
solenne banchetto così chiamato perché le immagini sacre della dea erano
adagiate sui letti rivestiti di preziosi tessuti, l’austerità del rito lasciava
il posto a un po’ di conversazione tra le presenti, che potevano scambiarsi le
loro confidenze.
Qualcuna
di loro rivolse probabilmente la parola
al travestito, che, rispondendo, si sarebbe tradito con la voce. Subito Aurelia, madre di
Cesare e suocera di Pompea, lanciò l’allarme e le presenti, troppo sopraffatte
dall’orrore del sacrilegio, non riuscirono a impedire la fuga della falsa
suonatrice.
La voce si sparse subito per la città. Nella dea Bona era
stato colpito qualcosa di assai profondo, un sentimento
sacro, antico come la città stessa. La dea Bona era
stata per un seguito ininterrotto di generazioni il nume tutelare delle donne
romane e delle loro virtù più tradizionali, come la castità, la maternità e
l’operosità, e quindi veniva con quel gesto offesa la pietas femminile.
Cesare ripudia
Pompea e sposa Calpurnia
Incisione del 1780
di Claude Nicolas Malapeau,
da un dipinto di
Pietro da Cortona
Si narra che Cesare
abbia ripudiato la moglie Pompea con la celebre frase:“la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni
sospetto”Lo
scandalo con conseguente processo colpì la città.Un
processo lungo con numerosi avvenimenti procedurali e pressioni politiche che
iniziò nel mese di maggioClodio
presentò un alibi dichiarando che quella notte non si trovava a Roma ma a
Terni.Cicerone
diede un forte colpo a questo alibi dichiarando che quella sera Clodio gli
aveva fatto visita a Roma poco prima dell’introduzione di Clodio nella casa di
Cesare.Cicerone
forse non voleva intromettersi in questa
vicenda giudiziaria e dichiarò la verità.Clodio
capì subito che il suo alibi era in discussione , preso dall’ira, apostrofò con
derisione l’oratore romano comeColui che sapeva
tutto(una frase che
aveva tratto da un orazione di Cicerone contro Catilina)Naturalmente
Cicerone fu chiamato a deporre contro Clodio.Il
processo finì con l’assoluzione di Clodio e in realtà dietro a questa sentenza
ci furono delle ripetute minacce di violenza e ricatti vari nei confronti dei
giurati.Giurati
che, impauriti, preferirono scegliere la via della non colpevolezza passando
per 31 voti contro 25.Clodio
quando divenne tribuno della plebe, si vendicò dell’affronto subito da Cicerone
ritorcendogli contro proprio quello che era stato il suo maggior titolo di merito,
cioè la repressione della congiura di Catilina, che
aveva comportato l’esecuzione sommaria di cittadini romani con una procedura al
limite della legalità.Cicerone
del 58 a.C. fu costretto all’esilio. La sua casa sul Palatino fu rasa al suolo
e al suo posto Clodio ebbe la forza di far erigere un tempio dedicato alla
Libertà.La
Bona Dea compì la sua vendetta perché la sera del 20 gennaio del 52 a.C. il
cadavere di Clodio venne portato a Roma dal senatore Sesto Fulvio. Il senatore
trovò il corpo di Clodio, ferito a morte, sulla via Appia vicino a “Bovillae”.Per
uno strano gioco del destino, Clodio fu ucciso dagli uomini del suo avversario
politico Annio Milone (secondo quando riferì Cicerone), proprio sui gradini di
un piccolo tempio dedicato alla dea Bona. L’onore delle donne romane aveva
trovato la sua definitiva giustizia.
La Via Appia
Antica
Apoteosi di Omero
Opera di Archelao
di Priene su richiesta di un poeta
Αρχέλαος, Archelaos
(Priene, II secolo a.C. - ?, II secolo a.C.)
Originariamente
era posto sulla Via Appia..... ora al British Museum ?????????
Primo Livello:
Omero seduto su un
trono; dietro di lui, Oikoumene (Arsinoe III?) e Cronos (Tolomeo
IV?); accovacciati accanto al trono, l'Iliade e l'Odissea;
a sinistra
dell'altare, il Mito (da bambino);
a destra
dell'altare, da sinistra a destra, Storia, Poesia, Tragedia e Commedia, poi
Natura (Physis), Virtù (Arete), Memoria (Mneme), Buona Fede (Pistis), Saggezza
(Sophia).
Livello superiore:
Zeus;
livelli intermedi:
Muse.
Davanti ad Omero,
Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati
benevolmente dai
geni produttori della poesia. Sopra di loro si erge il
Monte delle Muse.
Nella grotta risiede Apollo con la lita ed è avvicinato
da una Musa che
gli porge un papiro contenente l’opera del poeta che ha
commissionato il
bassorilievo. Poeta che è rappresentato da una
statua posta a
destra della grotta. Sulla statua ci sono dei segni.
Chi è questo
committente ?
Si tratta di un
poeta che con molta probabilità fu il vincitore dell’agone
(competizione)
poetica e offerente l’ex voto.
Infatti alle sue
spalle è posto il tripode della vittoria.
Le restanti Muse
si pongono a sinistra della grotta, con
un atteggiamento
calmo che,
risalendo verso la vetta del monte, si trasforma in una danza in
onore di Zeus
collocato sulla cima del monte. Zeus ha il volto rivolto verso
Mnemosyne, la
madre delle Muse.
Materiale: marmo –
Datazione: 225/205 a.C.
Misure: 1,18 m
Collezione:
British Museum
Un opera
stupenda che dal 1805 ha lasciato
l’Italia...
Una delle grandi
opere perdute.... vergogna
È
da un terreno posto nel territorio di Albano Laziale, vicino ai resti
dell’antica “Bovillae” che fu trovata un antichissima statuetta marmorea della
dea. Una statuetta di cui si erano perse le tracce e raffigurata in un disegno,
risalente all’Ottocento, riprodotto nell’antico “Bollettino Archeologico
Comunale”.
È
ricomparsa qualche anno fa nel mercato
dell’antiquariato e si trovava nella collezione di Ettore Roesler Franz, morto
nel 1907, e dei suoi eredi
Bona Dea disegno del 1879 del Bollettino Archeologico
Comunale
Statuetta di Dea Bona con cornucopia e serpente,
I-II sec. Museo Barracco
È
una piccola scultura votiva, alta 45,6 cm, con l’iscrizione dedicante. La dea è
raffigurata seduta in trono, con la gamba sinistra più avanti rispetto
all’altra, e con la cornucopia appoggiata al braccio sinistro.Il
braccio destro è mancante e doveva recare probabilmente un attributo e cioè una
patera nella quale si abbeverava un serpente avvolto attorno all’avambraccio.Il
serpente fu citato da Macrobio nella sua descrizione iconografica della dea.Indossa
un chitone, allacciato sotto il seno da una cintura, e un mantello panneggiato.
La testa è separata dal collo da una linea di frattura
presente alla base del collo ed è di marmo più compatto. La pettinatura è a
larghe bande ondulate che si ritrova in iconografie femminili nel III secolo d.
C. mentre il corpo sembra databile alla seconda metà del II secolo d.C. L’iscrizione,
disposta su tre righe (sulla base e sulla pedana),:Ex visu iussu Bonae Deae /
sacr(um) / Callistus Rufinae n(ostrae) actor“In sogno, per suo
ordine, Callisto, amministratore della nostra Rufina, ha consacrato (questa immagine)
alla Bona Dea”. La
dea era apparsa in sogno a Callisto chiedendogli un simulacro.Apparire
in sogno è una manifestazione tipica delle divinità oracolari che, attraverso
di esso, manifestano i loro desideri e volontà, come pure la diagnosi in caso di
malattie. Per questo motivo la dea era anche chiamata “fatua”, cioè “parlare”
alludendo alle sue capacità divinatorie.Questa
statuetta era probabilmente collocata in un sacello che fu citato da Cicerone
nell’omicidio di Clodio e riproduceva la statua originale di culto che si
trovava nel santuario posto sul Piccolo Aventino. Per il resto non ci sono
altri riferimenti se non che il santuario si trovava in un luogo ricco di grotte
e sorgenti.Nonostante
la ricchezza delle fonti letterarie (in gran parte legate allo scandalo del 62
a.C.) ed epigrafiche relative al culto, la documentazione archeologica sulla
Bona Dea è scarsa, a eccezione di due santuari rinvenuti a Ostia antica, uno
presso Porta Marina e uno in via degli Augustali, che dovevano però essere luoghi
di culto privato.
Ostia,
Santuario di Bona Dea in via degli Augustali
Acca LarentiaUn altra tradizione sembra ricollegarsi all’antico
costume della prostituzione sacra a Roma e si tratta del racconto leggendario
di Acca Larentia. Nella tradizione letteraria questa figura mitica non ha
un’unica storia ma due diverse versioni riferite da Plutarco (Plut. Rom. 4):“Secondo
altri fu un equivoco sul nome della nutrice [di Romolo e Remo] ad avviare il
racconto verso la favola, e precisamente il fatto che i Latini chiamavano lupa
tanto le femmine dei lupi, quanto le donne prodighe delle loro grazie, quale la
moglie di Faustolo, che allattò i due gemelli. Il vero nome di costei era Acca
Larenzia, e i Romani fanno dei sacrifici in suo onore; ad aprile il sacerdote
di Ares versa per lei delle libagioni durante una festa chiamata Larenzia.” L’altra versione (Rom. 5), più articolata:“Un’altra
Larenzia si onora a Roma, per il seguente motivo. Pare che un giorno il
sacrestano del tempio di Eracle, non sapendo cosa fare per passare il tempo,
proponesse al dio una partita a dadi col patto che, se vinceva, gli avrebbe
fatto una grossa grazia, se perdeva, egli gli avrebbe procurato un lauto pranzo
e una bella donna con cui passare la notte. Con questa posta gettò i dadi,
prima per Eracle e poi per sé. Beh, rimase battuto; ma aveva dato la parola e
ritenne doveroso attenersi ai patti. Apparecchiò un pranzo per il dio e assoldò
Larenzia, che, sebbene non fosse ancora famosa, era pure un fior di donna, la
fece cenare nel tempio e dopo mangiato ve la rinchiuse, non senza aver
apprestato il giaciglio, come se Eracle dovesse venire a goderla. Dice la
storia che il dio venne davvero, abbracciò la donna e alla fine le comandò di
recarsi la mattina per tempo al mercato e di salutare il primo uomo che
incontrava, stringendo amicizia con lui. Così fece Larenzia. L’uomo incontrato
al mercato era un cittadino anziano, che aveva messo da parte una discreta
sostanza, senza figli come pure senza moglie, di nome Tarruzio. Egli si prese
nel letto Larenzia e ne rimase tanto soddisfatto, da lasciarla alla sua morte
erede di molti e grandi beni, che ella in gran parte donò poi per testamento al
popolo, quando, famosa ormai e assai venerata per esser stata amata da un dio,
disparve nel medesimo luogo dov’era sepolta la prima Larenzia.”
Acca Larenzia
Artista: Jacopo di Pietro
d’Agnolo di Guarnieri
detto Jacopo della Quercia
(Siena, 1374 circa –
Siena, 1435)
Datazione: 1414 – 1418
Materiale: Marmo della
Montagnola Senese - Altezza: 1,65 m
Collocazione: Complesso
Museale di Santa Maria della Scala – Siena
Romolo e Remo trovati da
Faustolo
Artista: Pietro Berrettini
detto Pietro da Cortona
Cortona, 1 novembre 1596 –
Roma, 16 maggio 1669
Pittura: olio su tela –
Datazione 1643 circa
Misure: (2,51 x 2,66) m – Collocazione: Museo di Louvre, Parigi
La seconda tradizione riportata da Plutarco lascia
ipotizzare, attraverso il racconto mitico, la presenza a Roma della
prostituzione sacra, connessa al culto di Ercole identificato con il fenicio
Melqart.
Il santuario
emporico, sorto probabilmente già prima della fondazione di Roma, si trovava in
prossimità del guado del Tevere, dove passavano le via commerciali che dalle
saline alla foce del fiume proseguivano verso l’entroterra, e dove sorgeranno
l’Ara Massima di Ercole e il Foro Boario. Nel racconto compaiono altri elementi
importanti che consentono di decodificare la verità inserita nella leggenda,
come il gioco dei dadi con la divinità che è riconducibile ad antiche pratiche
divinatorie praticate in Oriente, oppure la cena preparata per il dio che trova
riscontro nei rituali per l’Ercole italico venerato dai commercianti, e infine,
l’unione sessuale tra dio e prostituta che è chiara prova della prostituzione
sacra. Da altri autori antichi come Macrobio e Aulo Gellio Larenzia era
indicata come nobilissimum scortum, cioè
nobilissima prostituta che divenne ricchissima con il suo esercizio. È
probabile che il titolo di nobilissima attribuito a Larenzia possa derivare
dall’aspetto sacrale della sua funzione. Anche il matrimonio rispettabile alla
fine del suo servizio sacro rientra nelle caratteristiche tipiche della
prostituzione sacra già evidenziate in precedenza per altre aree geografiche, e
sembra inoltre rimandare a quella prostituzione prenuziale diffusa in altri
popoli antichi. Elementi chiave appaiono poi il contesto del santuario emporico
con frequentazioni greche-orientali e l’influsso etrusco indicato dalla figura
di Tarutius, componenti che contestualizzano ancora più chiaramente le influenze
culturali che portarono anche in ambiente romano allo sviluppo della pratica
della prostituzione sacra. (Professore, Gabriele Romano)
Romolo e Remo
Artista: Sebastiano Ricci
(Belluno, luglio 1659 –
Venezia, 15 maggio 1734)
Pittura: olio su tela – Datazione:
1708 circa
Misure: (1,85 x 1,70) m –
Collocazione: Museo
Hermitage . St. Petersburg. Russia)
Acca Larentia sarebbe una figura semidivina che fu
ereditata ai Romani dagli Etruschi come prostituta protettrice del popolo
umile. Secondo una delle tante leggende, al tempo dei re, il custode del tempio
di Eracle sfidò il dio al gioco dei dadi.La posta in palio sarebbe stata una cena e l’etera più
bella. Vinse il dio e il custode rinchiuse, per tutta la notte, Acca Larentia
nel tempio. Il dio Eracle fu grato alla giovane donna per le sue preghiere e le
promise cheIl primo uomo che
incontrerai ti ricompenserà.Fu così che Acca Larentia incontrò l’etrusco, Tarutius,
che colpito dalla bellezza della fanciulla la sposò.Alla morte del marito la donna ereditò una grande fortuna
che donò al popolo romano che per gratitudine istituirono in suo onore una
festa.Feste che furono dette “Accalia o Larentalia” e che si
svolgevano il 23 dicembre nei pressi della sua tomba posta, come dicono le
fonti, dietro il Velabro.
Roma – il Velabro in una
stampa del 1800
Secondo alcuni storici la
tomba di Acca Larentia si doveva
trovare sul sito
dell’edicola di Giuturna
Secondo un ulteriore versione di Lattanzio Acca Larentia
sarebbe la moglie del pastore Faustolo che soccorse i gemelli Romolo e Remo,
fondatori di Roma.
In questa versione la donna assunse anche i nomi di “
Faula o Fabula” e venne detta “lupa”, un termine con il quale i Romani
indicavano le prostitute e dal quale viene il termine “lupanare”.
La donna era madre di dodici figli, e alla morte di uno
di loro, Romolo ne prese il posto dando vita alla “Fratres Arvales” (Arvali,
collegio sacerdotale istituito da Romolo e composto da dodici membri).
Acca Larentia si curò di allattare anche Romolo e Remo che, una volta venuti a conoscenza
della loro origine (figli della vestale rea Silva, discendente dell’eroe
troiano Enea, e di Marte dio della
guerra), decisero di vendicarsi uccidendo lo zio usurpatore Amulio e rimettendo sul trono il nonno
Numitore, legittimo re di Alba Longa.
La lupa che allattò Romolo e Remo sarebbe quindi secondo
alcuni storici identificabile con Acca Larentia per il suo passato di “lupa”
cioè di prostituta.
...........................
Afrotide, dea della bellezza e dell’amore.
Da Inanna..Istar...Astarte ..ad Afrotite...un eroina ?
I romani la identificarono con Venere ed era secondo
Omero la figlia di Zeus e della ninfa Dione.Secondo Esiodo la dea sarebbe nata in primavera dalla
spuma del mare fecondata dai genitali di Urano che Cronos aveva scagliato in
mare dopo la ribellione con il padre.La parola Afrotide deriverebbe dal greco “Afros” cioè
spuma.Nella sua Teogonia Esiodo riportò:i genitali vennero trascinati dal mare per un
lungo periodo e spuma bianca sorse dalla carne immortale; dentro ad essa crebbe
una ragazza che divenne Afrodite”.Quando il sangue di Urano cadde sul mare, l’acqua cominciò a
ribollire e su di una conchiglia, sospinta da Zefiro, emerse Afrotide in tutto
il suo splendore.Zefito l’aveva spinta sulla riva dell’isola di Cipro e da qui
anche gli appellativi dati alla dea di “Anadiomene” (l’emersa) e di “Ciprigna”
da Cipro. Sulla spiaggia giocavano le Ore, figlie di Teti, e quando
videro la dea emergere corsero verso di lei per ricoprirla con dei veli ed
intrecciarle i biondi capelli con corone di fiori.Zeus fu subito colpito dalla bellezza della donna ed
inviò un carro di gemme, tirato da due colombe, per prelevarla ed accoglierla
nell’Olimpo come figlia adottiva, suscitando l’ira e l’invidia delle altre dee.Per ironia della sorte, Zeus le diede come marito
Hefesto, uno degli dei più brutti e non fu un matrimonio felice.Ebbe altre relazioni con la nascita di figli: dal troiano
Anchise ebbe Enea; dal dio Dionisio ebbe Imene, il dio delle feste nuziali; dal
rapporto con Ares nacquero due figli terribili, Eros (amore) e Anteros.I poeti greci raccontarono che quando Afrotide ebbe Erts,
si lamentò con la dea Temi perché il figlio non cresceva.Temi le rispose che il bambino non sarebbe cresciuto fino
a quando non avesse avuto un fratello. Afrotide diede quindi vita ad Anteros che significa
“colui che ricambia l’amore”.Con queste leggenda i poeti misero in evidenza il concetto che l’amore per poter
crescere deve essere ricambiato.La dea portava sul vestito una cintura magica dove erano
raccolti tutti le grazie, il sorriso che promette ogni gioia, i teneri dialoghi
degli innamorati, i sospiri che persuadono e il silenzio espressivo.
La Nascita di Venere
Artista: Sandro Botticelli
(Alessandro di Mariano di
Vanni Filipepi)
(Firenze, 1 marzo 1445 –
Firenze, 17 maggio 1510)
Data: 1485
Tecnica: Tempera su tela –
Misure : (172,5 x 278,5) cm
Collocazione: Galleria
degli Uffizi, Firenze
Gli erano sacri: tra le piante, il mirto, la rosa, il
melo, il papavero mentre tra gli animali, il passero, la lepre, il cigno, il
riccio, il delfino, la seppia, e soprattutto la colomba e la tortora.
Cavalcando una conchiglia Afrotide giunse nell’isola di
Citera.
L’isola era un importante centro di scambi e questo
favorì la diffusione del suo culto in
tutta la Grecia. L’isola era però troppo piccola per contenere la sua bellezza
e quindi attraversò il Peloponneso e finì per stabilire la sua residenza a
Pafo, nell’isola di Cipro.
Un sito che fu la sede principale del suo culto.
Ogni primavera le sue sacerdotesse si bagnavano nel mare
e ne riemergevano vergini.
Su una gemma ritrovata nella grotta Idea si vede incisa
la dea cretese mentre soffia in una conchiglia con un pesce vicino all’altare
(forse un delfino).
Un’altra leggenda narra che al suo passaggio sulla terra
sboccino i papaveri.
Un giorno la dea, volendosi rendere utile, si mise a
tessere ad un telaio.
Fu sorpresa da Atena, dea delle arti, che non capendo il
suo umile gesto, corse subito a lamentarsi con Zeus.
L’arte del tessere era una sua virtù e nessun’altra
poteva prenderle il posto.
Afrotide si scusò con Atena e decise di non lavorare più
al telaio e di dedicarsi solamente a fare innamorare tutti di lei.
Afrotide Cnidia di
Prassitele
Spesso la letteratura storica ha dato un origine
orientale alla figura di Afrotide collegandola alle figure di Inanna, di Istar
e soprattutto di Atagartis (siriaca) e di Astarte (fenicia).
La figura di Astarte è sostanzialmente simile ed
assimilabile a quella di Atargatis anche se con qualche differenza legata alla
provenienza e alla formazione del culto.
Atargatis, nata dall’Eufrate come ci tramanda Igino,
giunse in Siria non dall’area mesopotamica-babilonese ma dall’Anatolia grazie
agli Hittiti.
Poiché il territorio siriano subì l’influenza hittita e quella
babilonese, le due figure finirono per fondersi quasi ovunque mantenendo delle
differenze solo in alcuni luoghi come ad esempio in Ascalona in Palestina.
Qui infatti, come riferisce Luciano di Samosata, si
trovavano templi di entrambe le
divinità.
Astarte – Museo
Archeologico di Siviglia
Bellissima placca votiva
in argilla cotta.
Una donna nuda in
bassorilievo, probabilmente la dea
Astarte.
Parrucca egiziana dipinta
di nero; le mani posizionate sui seni mentre
il foro in alto era per la
sospensione della placca.
Reperto Fenicio della
tarda Età del bronzo (VI secolo a.C.)
Rinvenuto a Tharros
(Sardegna) in una tomba.
Collezione: British Museum
, Londra
Astarte era venerata come la Grande madre da tutte le
popolazioni fenicie ed ebbe tra i suoi maggiori centri di culto Sidone, Tiros,
Ascalona, Byblos e in altri centri fenici del Mediterraneo fra cui Malta,
Tharros in Sardegna ed Erice in Sicilia.
Ad Erice diventò una figura di prima piano nella
religiosità degli Elimi e già intorno al XIII secolo a.C. era esistente un
celebre tempio che diventò famoso in seguito con l’appellativo di “Venere
Ericina” (Sotto il dominio romano).
Nella Sicilia Occidentale Astarte venne rapidamente
assimilata ad Afrotide ed alla Venere Romana.
Diodoro Siculo riportò che Erice, figlio di Bute e di
Afrotide, abbia eretto un tempio dedicato alla divinità sua madre e fondato la
città che da lui prese il nome, e dell’arrivo di Liparo, figlio di Ausonio,
dalle isole Eolie.
Aggiunse che anche i Sicani
Abitavano le alte vette
dei monti e adoravano Venere Ericina
Sulle rovine del tempio venne edificato dai Normanni un
castello che fu chiamato “di Venere” e sempre in Sicilia, sul versante opposto
e cioè sui Monti Nebrodi, a dimostrazione del culto radicato nell’isola di
Astarte, si trova Mistretta.
Mistretta un nome, che a detta dei filologi, deriva
dal fenicio “Am-Ashtart” (“Città di Astarte”).
Mistretta (Me)
Ma dove ha avuto origine il culto di Astarte e di
Atargatis ?
Le loro origini andrebbero ricercate in Mesopotamia ed
esattamente nella figura della dea Inanna sumera e della Istar babilonese. Si
tratta di due dee che hanno delle prerogative e degli attributi che si
troveranno successivamente, nel mondo greco e in quello romano, sia in Afrotide
che in Venere.
Antico sigillo (a
cilindro) accadico che rappresenta la
dea Inanna (Ishtar) con il
suo “sukkal” (ministro)
Ninshubur.
Datazione: periodo di
Akkad , 2334 -2335 a.C.
La dea poggia il piede su
un leone mentre Ninshubur le offre obbedienza.
Istituto orientale
dell’Università di Chicago
Il vaso votivo Warna è
decorato con tre registri orizzontali ed
evidenzia dei chiari segni
di riparazioni risalenti all’antichità.
È raffigurata una scena in
cui un uomo nudo offre una ciotola di frutta e
cereali ad una divinità
femminile, Inanna (Ishtar).
Dietro ci sono due fasci
di canne per indicare che è il tempio della dea.
In vaso fu trovato in
frammenti da una squadra di archeologi tedeschi in
un complesso di templi
dedicati alla dea Inanna nella città di Uruk
(nel sud dell’Irag) nel
1933.
Altezza: 1 metro – Trovato
a Warka (antica Uruk)
Periodo: Jemdet Nasr –
3000- 2900 a.C.
Collocazione: Sumeriam
Gallery, Museum di Baghdad (Iraq)
Inanna
(Inana) ( cuneiforme sumerico
IN.AN.NA, forse con il significato di “Signora del Cielo”
o “Splendente”. Era la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell’amore.
Un amore inteso come relazione erotica piuttosto che coniugale.
Rappresentava la più importante divinità femminile
mesopotamica e successivamente fu assimilata alla dea babilonese ed assira Ishtar.
La più antica attestazione del nome della divinità si
trova nelle tavole d’argilla rinvenute nell’antico complesso templare di
Uruk risalenti al 3400/3000 a.C.
La tradizione sumerica la vuole figlia del dio del Cielo
An oppure, secondo un altra tesi, figlia
del dio Luna (Nanna) e sorella gemella del Sole (Utu).
Donò alla città di Uruk, di cui era protettrice, i Me
sottratti ad Enki con un inganno ( lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la
sua bellezza).
(I “Me” nella mitologia sumerica erano quelle forze impersonali che insieme con gli Dei
garantivano l’ordine nell’universo).
Con questa donazione garantiva all’umanità una vita nella
prosperità e nel benessere. Dopo la morte del suo innamorato Damuzi, diventò
una seduttrice di uomini e di dei. Nella saga di Gilgamesh (mitico re di Uruk
risalente al 4500 a.C.) questi rifiuta le offerte di sesso di Inanna
accusandola che
“nessun uomo è rimasto vivo fino all’indomani mattina, dopo
aver giaciuto con lei una notte”.
Dea dell’amore, volubile e perennemente innamorata,
vogliosa, disinibita (in alcuni suoi inni chiede al compagno Dumuzi degli atti
osceni), è una regina che pretende ciò
che desidera.Dea della fertilità della terra, rappresentata con in
mano dei giunchi ripiegati a formare degli anelli, che pretende sacrifici e
grandi feste in suo onore. È anche dea della guerra e non in contrapposizione all’amore perché
protegge il suo popolo che ama distruggendo i nemici in battaglia con i suoi artigli. La sua femminilità è spesso chiamata nei suoi inni con
il termine “hyeròdula” cioè prostituzione sacra facendo riferimento ad una atteggiamento senza limiti e ricco
d’orgoglio.La dea appare in molti antichi miti mesopotamici:-
Inanna e l’albero di Huluppu (un mito della creazione
dell’Inizio);
-
Inanna e il dio della Sapienza (un mito che narra dei doni della conoscenza
e della cultura alla città di Uruk. Già citato in merito ai “Me”)
-
Il corteggiamento di Inanna e Dumuzi (la storia del
matrimonio di Inanna con il dio-vegetale o della vegetazione);
-
La Discesa di Inanna negli Inferi dimora della sorella
Ereskigal (un mito risalente al 1900-1600 a.C.
ed il più famoso)
Nel racconto “Inanna e l’albero di Huluppu” si narra come la dea trovò un albero chiamato
“Huluppu” sulle sponde del fiume Eufrate e che era stato sradicato
dall’erosione dell’acque del fiume in piena. Lo prese per piantarlo nel suo
giardino con l’obiettivo di utilizzarne la legna per creare il suo trono e il suo letto. Passarono dieci anni e l’albero
era cresciuto ma non potò utilizzarlo per gli scopi che si era prefissata.“Quindi
un serpente, che non può essere incantatofece il suo nido tra le radici dell’albero Huluppu.L’uccello Anzu mise i suoi piccoli tra i rami dell’alberoe la vergine oscura Lilith costruì la sua casa nel tronco”.La dea, che sorrideva sempre, fu conquistata da un
pianto senza fine e chiamò in suo aiuto il fratello Utu/Shamash che però si
rifiutò di aiutarla. Si rivolse al grande eroe semi-divino Gilgames che, dato
di una grande forza, colpì il serpente tra le radici; l’uccello Anzù fuggì,
assieme ai suoi piccoli, sulle montagne e lo stesso fece anche Lilith in fuga
verso luoghi selvatici.L’albero Huluppu fu quindi consegnato dalla dea che
iniziò a lavorarlo: trasformò le radici dell’albero in tamburo (pukku) e dai
suoi rami creò delle bacchette (mekku) per suonarlo.Con la creazione di questo strumento costrinse i
giovani di Uruk a danzare al suo ritorno fino allo sfinimento.Al sopraggiungere della sera, posò lo strumento che
precipitò negli inferi.Nel racconto appare la figura di “Lilith” che è molto
nota nella cultura mesopotamica. Una figura che nelle leggende ebraiche sarebbe
diventata la prima moglie di Adamo, precedendo “Eva”, considerata dall’esegesi
cristiano-cattolica la “prima donna” ovvero la capostipite del genere
femminile. È probabile che la religione ebraica assorbì quindi la figura di
Lilith direttamente dalla cultura babilonese durante la prigionia degli Ebrei
in Babilonia.
“La Discesa di Inanna negli Inferi” è il poema
più famoso, scritto in origine in cuneiforme ed inciso su tavolette d’argilla
rinvenute nei pressi dei siti archeologici di Assur e Ninive composte da 145
righe.
Racconta del viaggio della dea nel mondo sotterraneo
per sfidare la sorella di nome Ereshkigal.
Scritto probabilmente tra il 3500 ed il 1900 a.C.
anche se alcuni storici siano propensi a dare una data ancora più antica.
Con il passare del tempo la narrazione ha subito delle
variazioni sia nello stile che nella caratterizzazione dei personaggi.
Variazioni legati alla maggiore importanza
del ruolo delle divinità femminili durante il secondo millennio a.C.
Dal grande paradiso ella si immerse nel mondo di sotto. Dal grande paradiso
la dea mise la sua mente nel grande abisso. Dal grande paradiso Inanna mise la
sua mente nel grande abisso. La mia padrona abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo. Inana abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo”.
Inanna sperava d’estendere la sua sfera d’influenza
anche nel regno degli inferi, la cui regina era la sorella Ereshkigal.
Inanna si mise d’accordo con il suo primo ministro,
una donna di nome Ninshuba, dicendole
cheSe non fosse tornata entro massimo tre giorni e tre notti dal
sottosuolo, avrebbe dovuto organizzare grandi cerimonie funebri e
avrebbe dovuto chiamare gli Anunnaki perché corressero in suo soccorso.
Alcuni storici hanno voluto vedere in questa festività
romana elementi caratteristici della prostituzione prenuziale nella quale la
prostituzione appunto, oltre alla vittoria di Roma, portò queste serve al
raggiungimento di una dote ed al successivo matrimonio. Ulteriori tracce di
ierodulìa nella tradizione romana emergono inoltre dai racconti mitici che
narrano di incontri sessuali tra donne e membri virili apparsi dal nulla, come
nel caso della nascita del re Servio Tullio, frutto dell’unione della madre
Ocrisia, schiava del re Tarquinio Prisco, con un fallo comparso tra le ceneri
del focolare.
Altre prove sarebbero legate alla festa di Anna Perenna che si svolgeva sulle rive del Tevere ed era caratterizzata da rituali orgiastici, nei Floralia in cui le prostitute si spogliavano ritualmente su richiesta dei partecipanti ed eseguivano sfrenate danze, e ancora nei Vinalia dedicati a Venere e svolti nel tempio di Porta Collina nel quale si portavano doni a Venere Ericina, e dove le donne, non quelle sposate o libere, venivano scelte dagli uomini.
Bona Dea
Durante la festa della Bona Dea si svolgevano invece vere
e proprie orge rituali, che rappresentavano dei matrimoni sacri nei quali si
prostituivano donne di nobili natali ed erano tenute in grande
considerazione.
Bona Dea
Statua in marmo con
epigrafe
Bona Dea-II-III sec., iscrizione
Ex visu iussu Bonae
Deae Sacr (um) Callistus Rufinae N(ostrae) Act(or)
“Callistus schiavo alle
dipendenze di Rufina in veste di actor (avvocato o tesoriere),
ha dedicato questa
statua alla Bona Dea, in seguito ad una richiesta della dea stessa,
che gli è comparsa in
sogno”
Collocazione: Collezione
privata
Il termine Bona Dea aveva il significato generale di
Grande Madre e si venerava un’antica divinità laziale, il cui nome non poteva
essere pronunciato.
In origine fu un appellativo della dea romana Fauna che
formò insieme a Faunus (suo marito e fratello) una delle più antiche coppie di
dei indigeni del Lazio.
Bona Dea Fauna era stata, come Fauno, una divinità della
pastorizia e dei boschi e venne anche indicata con il nome di “Fatua”, dea che
predice l’avvenire.
Dal suo culto erano esclusi gli uomini così come a quello
rivolto a Fauno erano escluse le donne.
Ben presto sull’epiteto di Bona Dea venne ad innestarsi
il culto di una divinità greca che fu introdotta in Roma dalla Magna Grecia e
così la nuova figura fece dimenticare l’antica dea.
La dea greca che assunse a Roma il nome di Bona Dea fu
Damia, una divinità venerata specialmente nell’Argolide, a Egina, a Sparta, a
Thera, e in Italia in particolare a Taranto.
Secondo alcuni storici sarebbe la Giunone venerata a
Cartagine.
Anche per il culto di Damia potevano partecipare solo le
donne e le cerimonie venivano eseguite con gli occhi chiusi ed al buio
(duravano nove giorni e nove notti).
Ritornando al culto della Bona Dea, secondo la versione
di Lattanzio (scrittore, apologeta romano di fede cristiana; Africa 250 circa /Gallie,
dopo il 317) era la moglie di Fauno. Una donna molto abile in tutte le arti
domestiche e molto pudica, al punto di non uscire dalla propria casa e di non
vedere altro uomo che suo marito.
Un giorno trovò una brocca di vino. Cominciò a bere la
bevanda fino al punto di ubriacarsi.
Sua marito la castigò con verghe di mirto ma con tanta
inaudita violenza da procurargli la morte. Infatti l’uso del mirto era vietato
nei templi a lei dedicati.
Fauno si pentì del misfatto e deplorando la morte della
sua sposa, la pose nel numero degli Dei.
Un’altra versione del mito recita come la donna cercò di
sfuggire alle pretese sessuali di Fauno (che in questo caso era il padre) e lui
la colpì con i rami di mirto. La costrinse a bere del vino e riuscì alla fine a
possederla dopo essersi trasformato in serpente.
Sulla figura della Dea Bona tante leggende, qualcuna
immortalata nella pittura di famosi artisti, ed anche violenze e vendette
maturate sulle sponde del Tevere.
Ancora prima della nascita di Roma, sui colli erano
presenti delle divinità tra cui Ercole al tempo del mitico re Evandro.
Ercole sui Colli si sarebbe scontrato con il gigante Caco che era dedito alla rapina e
che viveva in una grotta dell’Aventino.
Dopo aver ucciso il gigante, Ercole stanco ed assetato,
si mise alla ricerca di una fonte. Giunse in un bosco in cui si trovava il
santuario della Dea Bona da dove giungevano delle risate di fanciulle.
S’avvicinò al santuario e chiese dell’acqua ma la vecchia sacerdotessa lo
allontanò in modo scortese dichiarando che la sacra fonte era riservata alle
donne.
Ercole non reagì alla scortesia e si vendicò
dell’affronto subito quando eresse l’Ara massima nel Foro Boario dove il suo
culto era interdetto alle donne:
(elegia di Properzio)
La dolce e sfortunata Fauna,, una volta divinizzata, diventò il simbolo del chiuso mondo muliebre, tutto legato alle eterne vicende della vita femminile, dalla castità prenuziale all’iniziazione sessuale ed alla maternità.
Il suo santuario si trovava in un bosco sacro sulle pendici
dell’Aventino Piccolo ed Ovidio lo citò nei suoi “Fasti”: “È un nativo dirupo il suo luogo; la realtà ne suggerì il
nome: / lo chiamano infatti Sasso, ed è parte cospicua del monte”. Per
questo motivo venne anche chiamata “Subsaxana” dal termine “saxum” (sasso).Nel
santuario, come detto precluso agli uomini, erano allevati dei serpenti
domestici, come avveniva anche in altri templi di dee che erano legate alla
fecondità ed alla salute.Il
tempio sorgeva nei pressi del luogo dove oggi si trova la chiesa di santa
Balbina. Vi veniva celebrata una festa il primo maggio e in quell’occasione si
sacrificava una scrofa gravida.La
data aveva una sua funzione perché doveva ricordare l’anniversario della
fondazione del tempio che, secondo Ovidio,
le era stato dedicato da una vestale.La
vestale sarebbe stata Claudia Quinta, la stessa che aveva accolto a Roma
la Magna Mater.Nata
nel III secolo a.C. di lei non si conoscono le date di nascita e di morte. Una
delle poche citazioni fa riferimento ad Ovidio che la descrisse come donna
virtuosa e di bell’aspetto. La sua reputazione era ingiustamente colpita per il
suo abbigliamento e portamento. La donna era stata falsamente accusata di essere
una pettegola.La
sua virtù fu riscattata da un evento miracoloso avvenuto nel 204 a.C. quando il
simulacro della Magna Mater (Cibele) fu trasportato in nave da Pessinunte a
Roma-La
nave giunta nell’alveo del Tevere s’incagliò e la donna con le sole sue forze
riuscì a disincagliarla grazie all’aiuto della stessa dea.In
questo modo fornì al popolo romano il grande segno della sua purezza. Un
episodio che rimase impresso nei ricordi dei romani tanto che venne più volte
rappresentato in teatro come racconta lo stesso Ovidio.Come
mai il simulacro si stava trasportando a Roma?Nel
205 a.C. la repubblica romana decise d’incorporare il culto della Grade Madre o
Culto di Cibele e decise di spostare il simulacro da Pessinunte, una città
tempio posta nella regione più orientale dell’Asia minore sotto il dominio
romano.Funo
spostati dalla città sia il simulacro e la grande pietra nera, che si diceva fatta
cadere dalla stessa Cibele. Questo spostamento era legato allo scopo di
garantirsi i favori della popolazione locale durante la seconda guerra punica
dato che Annibale ed i suoi cartaginesi si lasciavano andare a spietate razzie.
Claudia Quinta riesce
da solo a disincagliare l’imbarcazione
(Artista: Lambert
Lombard
Liegi, 1505 –
Liegi, 1566
Pittura: olio su
tela- Datazione: ?
Dimensioni: (1,39
x 1,69) m – Collocazione: Chiesa di St. Armand a Stokrooie
Claudia Quinta
Artista: Neroccio
di Bartolomeo de’ Landi
(Siena, giugno
1447 – Siena, 1500)
Dipinto: Olio su
tela ? – Datazione: 1490 circa
Misure: (1,05 x
0,46) m
Collezione: Andrew W. Mellon collection
National Gallery
of Art – Washington
Nel Museo della
centrale Montemartini c’è un altare in rilievo marmoreo di
età claudia (14
a.C. – 68 d.C.) dedicato alla Dea Madre e alla “navis salvia” e
raffigurante l’arrivo
della dea Cibele a Roma in nave.
La dedica presente
sull’altare allude alla leggenda legata
alla donna della
onorata famiglia
Claudia. Si tratta di un altare in rilievo in marmo che
fu scoperto sulla
riva del Tevere, sotto l’Aventino e durante il pontificato di
Clemente XI, in un
periodo compreso tra il 1700 ed il 1721.
La facciata
dell’atare reca un iscrizione dedicatoria e un’allusione all’arrivo
in nave a Roma
della dea Cibele.
Sulla faccia posteriore dell’altare ci sono due flauti, mentre il lato destro haun “pedum” e un piatto mentre il sinistro un berretto frigio.Tutti simboli riferiti alle origini di Cibele e al suo collegamento con il culto associato di Attis.
L’immagine
centrale è una piccola nave con un pennacchio di poppa
ricurvo e una prua
a voluta. La dea in trono al centro dovrebbe essere
immaginata
all’interno dell’edicola che si trova alle sue spalle.
È completamente
avvolta in un velo, chitone e himation con una mano
appoggiata sul
ginocchio e un’altra sollevato sul timpano.
Attorno all’argano
a prua, è avvolto una breve fune la cui estremità cade
leggermente dalla
mano di una donna posizionata obliquamente alla
parte anteriore
della barca. La donna è posizionata su una piattaforma
sporgente. Ha in
testa un velo e indossa un chitone avvolto strettamente
sul petto e
allacciato allo stesso modo di quello indossato dalla dea, ma il suo
mantello è avvolto
in modo sciolto sul braccio libero.
L’iscrizione
dedicatoria nomina la dea e dà anche un nome alla nave
matri.deum.et navi salviae
salviae voto suscepto
claudia synthyche
d. d.
Alla
madre degli dei e alla nave salvia
Come in un voto fatto a Salvia
Claudia Syntyche
dedica questo dono
La dea Cibele
rinvenuta ad Osta
Museo di Napoli
La dea siede in
trono con alta spalliera, bassi braccioli e gambe quadrate,
e poggia i piedi
su un suppedaneo con sostegni a zampe di leone.
Veste una lunga
tunica altocinta e calza sandali; un himation le copre
le spalle, scende
sulle braccia e sulle gambe, dove si distende in ampie pieghe orizzontali. Ai
lati del trono, due leoni accovacciati poggiano l'uno la gamba destra, l'altro
la gamba sinistra sul poggiapiedi della dea. La mano sinistra della dea con il
tympanum appoggiato al bracciolo del trono e la testa, dai cappelli raccolti
dietro la nuca con scrimitura centrale e con corona turrita, sono frutto di un
restauro operato probabilmente tra il XVII ed il XVIII secolo, certamente prima
del trasferimento della scultura dalla guardaroba del Palazzo Farnese alla
Villa della Farnesina; la mano destra Ë stata invece integrata a Napoli, dopo
il 1805.
l'iscrizione:
Virius Marcarianus v(ir) c(larissimus) deam Cybelen p(ecunia) s(ua).
Alta: 98 cm
Marmo banco
/scalpellatura e levigatura
Dara di creazione:
140 d.C. – 160 d.C.
Il
tempio della Dea Bona venne poi restaurato da Livia, la moglie di Augusto, come
riportò Ovidio: “Lo dedicò la erede dell’antico nome dei Clausi, / che mai
aveva sopportato uomo con il virgineo corpo. / Livia lo restaurò affinché non
restasse non imitato / lo sposo, ed ella lo seguisse in ogni sua iniziativaAi
primi di dicembre si celebrava un culto misterico privato, riservato alle donne
più influenti della città e che si svolgeva in casa di un alto magistrato della
città (console o pretore), sulla quale ricadeva la benedizione della dea.La
cerimonia si svolgeva di notte ed era prevista
l’assistenza di vestali. La casa prescelta veniva addobbata di tralci
d’uva, altre piante e fiori, escluso il mirto. Si faceva venire il vino, che era chiamato “lac”
(latte) e il recipiente che lo conteneva “mellarium” (vaso di miele).Tutti gli uomini presenti nella casa la dovevano
abbandonare e in, poche parole, anche i bambini ed i neonati. Gli uomini aspettavano la fine del rito presso
le case di amici e parenti consapevoli che quel rito era sacro e quindi non si
doveva infrangere la regola.Eppure
avvenne un fatto strano perchè un uomo osò infrangere la regola: Publio Clodio
Pulcro.La
notte tra i 4 ed il 5 dicembre del 62 a.C., il rito doveva svolgersi nella casa
di Giulio Cesare, pontefice massimo e neoeletto pretore. La dimora era quella
“Regia”, in origine dimora dei re e poi dei pontefici massimi, i cui resti si
notano lungo la via Sacra del Foro Romano, vicino alla Casa delle Vestali.
Clodio
aveva trentun’anni ed era all’inizio della sua carriera politica. Il suo
obiettivo era diventare tribuno della plebe e per questo motivo aveva
modificato anche il suo nome aristocratico “Claudius” nella variante plebea
“Clodius”.Era
fratello della bellissima e spregiudicata Clodia che fu più volte citata da
Cicerone e da identificare probabilmente con la Lesbia cantata da Catullo.
Publio Clodio Pulcro
Clodia , sorella di Clodio e amante di CatulloPer quale motivo Clodio s’introdusse nella casa di Cesare
in modo furtivo ?I rapporti con lo stesso Cesare erano ottimi oppure c’era una relazione clandestina con la
padrona di casa Pompea ?Accettata quest’ultima versione il momento per un azione
simile non era molto opportuno.
Pompea Silla, seconda moglie di
Giulio CesarePompea ritratta
nel "Promptuarii Iconum Insigniorum" del 1553
Clodio
riuscì ad entrare nella casa di Cesare, trasvestito da suonatrice d’arpa e
grazie alla complicità d’una schiava. La luce tenue delle lucerne favorì il suo
piano.
Durante
il il lectisternium, cioè il
solenne banchetto così chiamato perché le immagini sacre della dea erano
adagiate sui letti rivestiti di preziosi tessuti, l’austerità del rito lasciava
il posto a un po’ di conversazione tra le presenti, che potevano scambiarsi le
loro confidenze.
Qualcuna
di loro rivolse probabilmente la parola
al travestito, che, rispondendo, si sarebbe tradito con la voce. Subito Aurelia, madre di
Cesare e suocera di Pompea, lanciò l’allarme e le presenti, troppo sopraffatte
dall’orrore del sacrilegio, non riuscirono a impedire la fuga della falsa
suonatrice.
La voce si sparse subito per la città. Nella dea Bona era
stato colpito qualcosa di assai profondo, un sentimento
sacro, antico come la città stessa. La dea Bona era
stata per un seguito ininterrotto di generazioni il nume tutelare delle donne
romane e delle loro virtù più tradizionali, come la castità, la maternità e
l’operosità, e quindi veniva con quel gesto offesa la pietas femminile.
Cesare ripudia
Pompea e sposa Calpurnia
Incisione del 1780
di Claude Nicolas Malapeau,
da un dipinto di
Pietro da Cortona
Si narra che Cesare
abbia ripudiato la moglie Pompea con la celebre frase:“la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni
sospetto”Lo
scandalo con conseguente processo colpì la città.Un
processo lungo con numerosi avvenimenti procedurali e pressioni politiche che
iniziò nel mese di maggioClodio
presentò un alibi dichiarando che quella notte non si trovava a Roma ma a
Terni.Cicerone
diede un forte colpo a questo alibi dichiarando che quella sera Clodio gli
aveva fatto visita a Roma poco prima dell’introduzione di Clodio nella casa di
Cesare.Cicerone
forse non voleva intromettersi in questa
vicenda giudiziaria e dichiarò la verità.Clodio
capì subito che il suo alibi era in discussione , preso dall’ira, apostrofò con
derisione l’oratore romano comeColui che sapeva
tutto(una frase che
aveva tratto da un orazione di Cicerone contro Catilina)Naturalmente
Cicerone fu chiamato a deporre contro Clodio.Il
processo finì con l’assoluzione di Clodio e in realtà dietro a questa sentenza
ci furono delle ripetute minacce di violenza e ricatti vari nei confronti dei
giurati.Giurati
che, impauriti, preferirono scegliere la via della non colpevolezza passando
per 31 voti contro 25.Clodio
quando divenne tribuno della plebe, si vendicò dell’affronto subito da Cicerone
ritorcendogli contro proprio quello che era stato il suo maggior titolo di merito,
cioè la repressione della congiura di Catilina, che
aveva comportato l’esecuzione sommaria di cittadini romani con una procedura al
limite della legalità.Cicerone
del 58 a.C. fu costretto all’esilio. La sua casa sul Palatino fu rasa al suolo
e al suo posto Clodio ebbe la forza di far erigere un tempio dedicato alla
Libertà.La
Bona Dea compì la sua vendetta perché la sera del 20 gennaio del 52 a.C. il
cadavere di Clodio venne portato a Roma dal senatore Sesto Fulvio. Il senatore
trovò il corpo di Clodio, ferito a morte, sulla via Appia vicino a “Bovillae”.Per
uno strano gioco del destino, Clodio fu ucciso dagli uomini del suo avversario
politico Annio Milone (secondo quando riferì Cicerone), proprio sui gradini di
un piccolo tempio dedicato alla dea Bona. L’onore delle donne romane aveva
trovato la sua definitiva giustizia.
La Via Appia
Antica
Apoteosi di Omero
Opera di Archelao
di Priene su richiesta di un poeta
Αρχέλαος, Archelaos
(Priene, II secolo a.C. - ?, II secolo a.C.)
Originariamente
era posto sulla Via Appia..... ora al British Museum ?????????
Primo Livello:
Omero seduto su un
trono; dietro di lui, Oikoumene (Arsinoe III?) e Cronos (Tolomeo
IV?); accovacciati accanto al trono, l'Iliade e l'Odissea;
a sinistra
dell'altare, il Mito (da bambino);
a destra
dell'altare, da sinistra a destra, Storia, Poesia, Tragedia e Commedia, poi
Natura (Physis), Virtù (Arete), Memoria (Mneme), Buona Fede (Pistis), Saggezza
(Sophia).
Livello superiore:
Zeus;
livelli intermedi:
Muse.
Davanti ad Omero,
Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati
benevolmente dai
geni produttori della poesia. Sopra di loro si erge il
Monte delle Muse.
Nella grotta risiede Apollo con la lita ed è avvicinato
da una Musa che
gli porge un papiro contenente l’opera del poeta che ha
commissionato il
bassorilievo. Poeta che è rappresentato da una
statua posta a
destra della grotta. Sulla statua ci sono dei segni.
Chi è questo
committente ?
Si tratta di un
poeta che con molta probabilità fu il vincitore dell’agone
(competizione)
poetica e offerente l’ex voto.
Infatti alle sue
spalle è posto il tripode della vittoria.
Le restanti Muse
si pongono a sinistra della grotta, con
un atteggiamento
calmo che,
risalendo verso la vetta del monte, si trasforma in una danza in
onore di Zeus
collocato sulla cima del monte. Zeus ha il volto rivolto verso
Mnemosyne, la
madre delle Muse.
Materiale: marmo –
Datazione: 225/205 a.C.
Misure: 1,18 m
Collezione:
British Museum
Un opera
stupenda che dal 1805 ha lasciato
l’Italia...
Una delle grandi
opere perdute.... vergogna
È
da un terreno posto nel territorio di Albano Laziale, vicino ai resti
dell’antica “Bovillae” che fu trovata un antichissima statuetta marmorea della
dea. Una statuetta di cui si erano perse le tracce e raffigurata in un disegno,
risalente all’Ottocento, riprodotto nell’antico “Bollettino Archeologico
Comunale”.
È
ricomparsa qualche anno fa nel mercato
dell’antiquariato e si trovava nella collezione di Ettore Roesler Franz, morto
nel 1907, e dei suoi eredi
Bona Dea disegno del 1879 del Bollettino Archeologico
Comunale
Statuetta di Dea Bona con cornucopia e serpente,
I-II sec. Museo Barracco
È
una piccola scultura votiva, alta 45,6 cm, con l’iscrizione dedicante. La dea è
raffigurata seduta in trono, con la gamba sinistra più avanti rispetto
all’altra, e con la cornucopia appoggiata al braccio sinistro.Il
braccio destro è mancante e doveva recare probabilmente un attributo e cioè una
patera nella quale si abbeverava un serpente avvolto attorno all’avambraccio.Il
serpente fu citato da Macrobio nella sua descrizione iconografica della dea.Indossa
un chitone, allacciato sotto il seno da una cintura, e un mantello panneggiato.
La testa è separata dal collo da una linea di frattura
presente alla base del collo ed è di marmo più compatto. La pettinatura è a
larghe bande ondulate che si ritrova in iconografie femminili nel III secolo d.
C. mentre il corpo sembra databile alla seconda metà del II secolo d.C. L’iscrizione,
disposta su tre righe (sulla base e sulla pedana),:Ex visu iussu Bonae Deae /
sacr(um) / Callistus Rufinae n(ostrae) actor“In sogno, per suo
ordine, Callisto, amministratore della nostra Rufina, ha consacrato (questa immagine)
alla Bona Dea”. La
dea era apparsa in sogno a Callisto chiedendogli un simulacro.Apparire
in sogno è una manifestazione tipica delle divinità oracolari che, attraverso
di esso, manifestano i loro desideri e volontà, come pure la diagnosi in caso di
malattie. Per questo motivo la dea era anche chiamata “fatua”, cioè “parlare”
alludendo alle sue capacità divinatorie.Questa
statuetta era probabilmente collocata in un sacello che fu citato da Cicerone
nell’omicidio di Clodio e riproduceva la statua originale di culto che si
trovava nel santuario posto sul Piccolo Aventino. Per il resto non ci sono
altri riferimenti se non che il santuario si trovava in un luogo ricco di grotte
e sorgenti.Nonostante
la ricchezza delle fonti letterarie (in gran parte legate allo scandalo del 62
a.C.) ed epigrafiche relative al culto, la documentazione archeologica sulla
Bona Dea è scarsa, a eccezione di due santuari rinvenuti a Ostia antica, uno
presso Porta Marina e uno in via degli Augustali, che dovevano però essere luoghi
di culto privato.
Ostia,
Santuario di Bona Dea in via degli Augustali
Acca LarentiaUn altra tradizione sembra ricollegarsi all’antico
costume della prostituzione sacra a Roma e si tratta del racconto leggendario
di Acca Larentia. Nella tradizione letteraria questa figura mitica non ha
un’unica storia ma due diverse versioni riferite da Plutarco (Plut. Rom. 4):“Secondo
altri fu un equivoco sul nome della nutrice [di Romolo e Remo] ad avviare il
racconto verso la favola, e precisamente il fatto che i Latini chiamavano lupa
tanto le femmine dei lupi, quanto le donne prodighe delle loro grazie, quale la
moglie di Faustolo, che allattò i due gemelli. Il vero nome di costei era Acca
Larenzia, e i Romani fanno dei sacrifici in suo onore; ad aprile il sacerdote
di Ares versa per lei delle libagioni durante una festa chiamata Larenzia.” L’altra versione (Rom. 5), più articolata:“Un’altra
Larenzia si onora a Roma, per il seguente motivo. Pare che un giorno il
sacrestano del tempio di Eracle, non sapendo cosa fare per passare il tempo,
proponesse al dio una partita a dadi col patto che, se vinceva, gli avrebbe
fatto una grossa grazia, se perdeva, egli gli avrebbe procurato un lauto pranzo
e una bella donna con cui passare la notte. Con questa posta gettò i dadi,
prima per Eracle e poi per sé. Beh, rimase battuto; ma aveva dato la parola e
ritenne doveroso attenersi ai patti. Apparecchiò un pranzo per il dio e assoldò
Larenzia, che, sebbene non fosse ancora famosa, era pure un fior di donna, la
fece cenare nel tempio e dopo mangiato ve la rinchiuse, non senza aver
apprestato il giaciglio, come se Eracle dovesse venire a goderla. Dice la
storia che il dio venne davvero, abbracciò la donna e alla fine le comandò di
recarsi la mattina per tempo al mercato e di salutare il primo uomo che
incontrava, stringendo amicizia con lui. Così fece Larenzia. L’uomo incontrato
al mercato era un cittadino anziano, che aveva messo da parte una discreta
sostanza, senza figli come pure senza moglie, di nome Tarruzio. Egli si prese
nel letto Larenzia e ne rimase tanto soddisfatto, da lasciarla alla sua morte
erede di molti e grandi beni, che ella in gran parte donò poi per testamento al
popolo, quando, famosa ormai e assai venerata per esser stata amata da un dio,
disparve nel medesimo luogo dov’era sepolta la prima Larenzia.”
Per quale motivo Clodio s’introdusse nella casa di Cesare
in modo furtivo ?I rapporti con lo stesso Cesare erano ottimi oppure c’era una relazione clandestina con la
padrona di casa Pompea ?Accettata quest’ultima versione il momento per un azione
simile non era molto opportuno.
Pompea Silla, seconda moglie di
Giulio CesarePompea ritratta
nel "Promptuarii Iconum Insigniorum" del 1553
Clodio
riuscì ad entrare nella casa di Cesare, trasvestito da suonatrice d’arpa e
grazie alla complicità d’una schiava. La luce tenue delle lucerne favorì il suo
piano.
Durante
il il lectisternium, cioè il
solenne banchetto così chiamato perché le immagini sacre della dea erano
adagiate sui letti rivestiti di preziosi tessuti, l’austerità del rito lasciava
il posto a un po’ di conversazione tra le presenti, che potevano scambiarsi le
loro confidenze.
Qualcuna
di loro rivolse probabilmente la parola
al travestito, che, rispondendo, si sarebbe tradito con la voce. Subito Aurelia, madre di
Cesare e suocera di Pompea, lanciò l’allarme e le presenti, troppo sopraffatte
dall’orrore del sacrilegio, non riuscirono a impedire la fuga della falsa
suonatrice.
La voce si sparse subito per la città. Nella dea Bona era
stato colpito qualcosa di assai profondo, un sentimento
sacro, antico come la città stessa. La dea Bona era
stata per un seguito ininterrotto di generazioni il nume tutelare delle donne
romane e delle loro virtù più tradizionali, come la castità, la maternità e
l’operosità, e quindi veniva con quel gesto offesa la pietas femminile.
Cesare ripudia
Pompea e sposa Calpurnia
Incisione del 1780
di Claude Nicolas Malapeau,
da un dipinto di
Pietro da Cortona
Si narra che Cesare
abbia ripudiato la moglie Pompea con la celebre frase:“la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni
sospetto”Lo
scandalo con conseguente processo colpì la città.Un
processo lungo con numerosi avvenimenti procedurali e pressioni politiche che
iniziò nel mese di maggioClodio
presentò un alibi dichiarando che quella notte non si trovava a Roma ma a
Terni.Cicerone
diede un forte colpo a questo alibi dichiarando che quella sera Clodio gli
aveva fatto visita a Roma poco prima dell’introduzione di Clodio nella casa di
Cesare.Cicerone
forse non voleva intromettersi in questa
vicenda giudiziaria e dichiarò la verità.Clodio
capì subito che il suo alibi era in discussione , preso dall’ira, apostrofò con
derisione l’oratore romano comeColui che sapeva
tutto(una frase che
aveva tratto da un orazione di Cicerone contro Catilina)Naturalmente
Cicerone fu chiamato a deporre contro Clodio.Il
processo finì con l’assoluzione di Clodio e in realtà dietro a questa sentenza
ci furono delle ripetute minacce di violenza e ricatti vari nei confronti dei
giurati.Giurati
che, impauriti, preferirono scegliere la via della non colpevolezza passando
per 31 voti contro 25.Clodio
quando divenne tribuno della plebe, si vendicò dell’affronto subito da Cicerone
ritorcendogli contro proprio quello che era stato il suo maggior titolo di merito,
cioè la repressione della congiura di Catilina, che
aveva comportato l’esecuzione sommaria di cittadini romani con una procedura al
limite della legalità.Cicerone
del 58 a.C. fu costretto all’esilio. La sua casa sul Palatino fu rasa al suolo
e al suo posto Clodio ebbe la forza di far erigere un tempio dedicato alla
Libertà.La
Bona Dea compì la sua vendetta perché la sera del 20 gennaio del 52 a.C. il
cadavere di Clodio venne portato a Roma dal senatore Sesto Fulvio. Il senatore
trovò il corpo di Clodio, ferito a morte, sulla via Appia vicino a “Bovillae”.Per
uno strano gioco del destino, Clodio fu ucciso dagli uomini del suo avversario
politico Annio Milone (secondo quando riferì Cicerone), proprio sui gradini di
un piccolo tempio dedicato alla dea Bona. L’onore delle donne romane aveva
trovato la sua definitiva giustizia.
La Via Appia
Antica
Apoteosi di Omero
Opera di Archelao
di Priene su richiesta di un poeta
Αρχέλαος, Archelaos
(Priene, II secolo a.C. - ?, II secolo a.C.)
Originariamente
era posto sulla Via Appia..... ora al British Museum ?????????
Primo Livello:
Omero seduto su un
trono; dietro di lui, Oikoumene (Arsinoe III?) e Cronos (Tolomeo
IV?); accovacciati accanto al trono, l'Iliade e l'Odissea;
a sinistra
dell'altare, il Mito (da bambino);
a destra
dell'altare, da sinistra a destra, Storia, Poesia, Tragedia e Commedia, poi
Natura (Physis), Virtù (Arete), Memoria (Mneme), Buona Fede (Pistis), Saggezza
(Sophia).
Livello superiore:
Zeus;
livelli intermedi:
Muse.
Davanti ad Omero,
Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati
benevolmente dai
geni produttori della poesia. Sopra di loro si erge il
Monte delle Muse.
Nella grotta risiede Apollo con la lita ed è avvicinato
da una Musa che
gli porge un papiro contenente l’opera del poeta che ha
commissionato il
bassorilievo. Poeta che è rappresentato da una
statua posta a
destra della grotta. Sulla statua ci sono dei segni.
Chi è questo
committente ?
Si tratta di un
poeta che con molta probabilità fu il vincitore dell’agone
(competizione)
poetica e offerente l’ex voto.
Infatti alle sue
spalle è posto il tripode della vittoria.
Le restanti Muse
si pongono a sinistra della grotta, con
un atteggiamento
calmo che,
risalendo verso la vetta del monte, si trasforma in una danza in
onore di Zeus
collocato sulla cima del monte. Zeus ha il volto rivolto verso
Mnemosyne, la
madre delle Muse.
Materiale: marmo –
Datazione: 225/205 a.C.
Misure: 1,18 m
Collezione:
British Museum
Un opera
stupenda che dal 1805 ha lasciato
l’Italia...
Una delle grandi
opere perdute.... vergogna
È
da un terreno posto nel territorio di Albano Laziale, vicino ai resti
dell’antica “Bovillae” che fu trovata un antichissima statuetta marmorea della
dea. Una statuetta di cui si erano perse le tracce e raffigurata in un disegno,
risalente all’Ottocento, riprodotto nell’antico “Bollettino Archeologico
Comunale”.
È
ricomparsa qualche anno fa nel mercato
dell’antiquariato e si trovava nella collezione di Ettore Roesler Franz, morto
nel 1907, e dei suoi eredi
Pompea Silla, seconda moglie di
Giulio CesarePompea ritratta
nel "Promptuarii Iconum Insigniorum" del 1553
Clodio
riuscì ad entrare nella casa di Cesare, trasvestito da suonatrice d’arpa e
grazie alla complicità d’una schiava. La luce tenue delle lucerne favorì il suo
piano.
Durante
il il lectisternium, cioè il
solenne banchetto così chiamato perché le immagini sacre della dea erano
adagiate sui letti rivestiti di preziosi tessuti, l’austerità del rito lasciava
il posto a un po’ di conversazione tra le presenti, che potevano scambiarsi le
loro confidenze.
Qualcuna
di loro rivolse probabilmente la parola
al travestito, che, rispondendo, si sarebbe tradito con la voce. Subito Aurelia, madre di
Cesare e suocera di Pompea, lanciò l’allarme e le presenti, troppo sopraffatte
dall’orrore del sacrilegio, non riuscirono a impedire la fuga della falsa
suonatrice.
La voce si sparse subito per la città. Nella dea Bona era
stato colpito qualcosa di assai profondo, un sentimento
sacro, antico come la città stessa. La dea Bona era
stata per un seguito ininterrotto di generazioni il nume tutelare delle donne
romane e delle loro virtù più tradizionali, come la castità, la maternità e
l’operosità, e quindi veniva con quel gesto offesa la pietas femminile.
Cesare ripudia
Pompea e sposa Calpurnia
Incisione del 1780
di Claude Nicolas Malapeau,
da un dipinto di
Pietro da Cortona
Si narra che Cesare
abbia ripudiato la moglie Pompea con la celebre frase:“la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni
sospetto”Lo
scandalo con conseguente processo colpì la città.Un
processo lungo con numerosi avvenimenti procedurali e pressioni politiche che
iniziò nel mese di maggioClodio
presentò un alibi dichiarando che quella notte non si trovava a Roma ma a
Terni.Cicerone
diede un forte colpo a questo alibi dichiarando che quella sera Clodio gli
aveva fatto visita a Roma poco prima dell’introduzione di Clodio nella casa di
Cesare.Cicerone
forse non voleva intromettersi in questa
vicenda giudiziaria e dichiarò la verità.Clodio
capì subito che il suo alibi era in discussione , preso dall’ira, apostrofò con
derisione l’oratore romano comeColui che sapeva
tutto(una frase che
aveva tratto da un orazione di Cicerone contro Catilina)Naturalmente
Cicerone fu chiamato a deporre contro Clodio.Il
processo finì con l’assoluzione di Clodio e in realtà dietro a questa sentenza
ci furono delle ripetute minacce di violenza e ricatti vari nei confronti dei
giurati.Giurati
che, impauriti, preferirono scegliere la via della non colpevolezza passando
per 31 voti contro 25.Clodio
quando divenne tribuno della plebe, si vendicò dell’affronto subito da Cicerone
ritorcendogli contro proprio quello che era stato il suo maggior titolo di merito,
cioè la repressione della congiura di Catilina, che
aveva comportato l’esecuzione sommaria di cittadini romani con una procedura al
limite della legalità.Cicerone
del 58 a.C. fu costretto all’esilio. La sua casa sul Palatino fu rasa al suolo
e al suo posto Clodio ebbe la forza di far erigere un tempio dedicato alla
Libertà.La
Bona Dea compì la sua vendetta perché la sera del 20 gennaio del 52 a.C. il
cadavere di Clodio venne portato a Roma dal senatore Sesto Fulvio. Il senatore
trovò il corpo di Clodio, ferito a morte, sulla via Appia vicino a “Bovillae”.Per
uno strano gioco del destino, Clodio fu ucciso dagli uomini del suo avversario
politico Annio Milone (secondo quando riferì Cicerone), proprio sui gradini di
un piccolo tempio dedicato alla dea Bona. L’onore delle donne romane aveva
trovato la sua definitiva giustizia.
La Via Appia
Antica
Apoteosi di Omero
Opera di Archelao
di Priene su richiesta di un poeta
Αρχέλαος, Archelaos
(Priene, II secolo a.C. - ?, II secolo a.C.)
Originariamente
era posto sulla Via Appia..... ora al British Museum ?????????
Primo Livello:
Omero seduto su un
trono; dietro di lui, Oikoumene (Arsinoe III?) e Cronos (Tolomeo
IV?); accovacciati accanto al trono, l'Iliade e l'Odissea;
a sinistra
dell'altare, il Mito (da bambino);
a destra
dell'altare, da sinistra a destra, Storia, Poesia, Tragedia e Commedia, poi
Natura (Physis), Virtù (Arete), Memoria (Mneme), Buona Fede (Pistis), Saggezza
(Sophia).
Livello superiore:
Zeus;
livelli intermedi:
Muse.
Davanti ad Omero,
Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati
benevolmente dai
geni produttori della poesia. Sopra di loro si erge il
Monte delle Muse.
Nella grotta risiede Apollo con la lita ed è avvicinato
da una Musa che
gli porge un papiro contenente l’opera del poeta che ha
commissionato il
bassorilievo. Poeta che è rappresentato da una
statua posta a
destra della grotta. Sulla statua ci sono dei segni.
Chi è questo
committente ?
Si tratta di un
poeta che con molta probabilità fu il vincitore dell’agone
(competizione)
poetica e offerente l’ex voto.
Infatti alle sue
spalle è posto il tripode della vittoria.
Le restanti Muse
si pongono a sinistra della grotta, con
un atteggiamento
calmo che,
risalendo verso la vetta del monte, si trasforma in una danza in
onore di Zeus
collocato sulla cima del monte. Zeus ha il volto rivolto verso
Mnemosyne, la
madre delle Muse.
Materiale: marmo –
Datazione: 225/205 a.C.
Misure: 1,18 m
Collezione:
British Museum
Un opera
stupenda che dal 1805 ha lasciato
l’Italia...
Una delle grandi
opere perdute.... vergogna
È
da un terreno posto nel territorio di Albano Laziale, vicino ai resti
dell’antica “Bovillae” che fu trovata un antichissima statuetta marmorea della
dea. Una statuetta di cui si erano perse le tracce e raffigurata in un disegno,
risalente all’Ottocento, riprodotto nell’antico “Bollettino Archeologico
Comunale”.
È
ricomparsa qualche anno fa nel mercato
dell’antiquariato e si trovava nella collezione di Ettore Roesler Franz, morto
nel 1907, e dei suoi eredi
Bona Dea disegno del 1879 del Bollettino Archeologico
Comunale
Statuetta di Dea Bona con cornucopia e serpente,
I-II sec. Museo Barracco
È
una piccola scultura votiva, alta 45,6 cm, con l’iscrizione dedicante. La dea è
raffigurata seduta in trono, con la gamba sinistra più avanti rispetto
all’altra, e con la cornucopia appoggiata al braccio sinistro.Il
braccio destro è mancante e doveva recare probabilmente un attributo e cioè una
patera nella quale si abbeverava un serpente avvolto attorno all’avambraccio.Il
serpente fu citato da Macrobio nella sua descrizione iconografica della dea.Indossa
un chitone, allacciato sotto il seno da una cintura, e un mantello panneggiato.
La testa è separata dal collo da una linea di frattura
presente alla base del collo ed è di marmo più compatto. La pettinatura è a
larghe bande ondulate che si ritrova in iconografie femminili nel III secolo d.
C. mentre il corpo sembra databile alla seconda metà del II secolo d.C. L’iscrizione,
disposta su tre righe (sulla base e sulla pedana),:Ex visu iussu Bonae Deae /
sacr(um) / Callistus Rufinae n(ostrae) actor“In sogno, per suo
ordine, Callisto, amministratore della nostra Rufina, ha consacrato (questa immagine)
alla Bona Dea”. La
dea era apparsa in sogno a Callisto chiedendogli un simulacro.Apparire
in sogno è una manifestazione tipica delle divinità oracolari che, attraverso
di esso, manifestano i loro desideri e volontà, come pure la diagnosi in caso di
malattie. Per questo motivo la dea era anche chiamata “fatua”, cioè “parlare”
alludendo alle sue capacità divinatorie.Questa
statuetta era probabilmente collocata in un sacello che fu citato da Cicerone
nell’omicidio di Clodio e riproduceva la statua originale di culto che si
trovava nel santuario posto sul Piccolo Aventino. Per il resto non ci sono
altri riferimenti se non che il santuario si trovava in un luogo ricco di grotte
e sorgenti.Nonostante
la ricchezza delle fonti letterarie (in gran parte legate allo scandalo del 62
a.C.) ed epigrafiche relative al culto, la documentazione archeologica sulla
Bona Dea è scarsa, a eccezione di due santuari rinvenuti a Ostia antica, uno
presso Porta Marina e uno in via degli Augustali, che dovevano però essere luoghi
di culto privato.
Ostia, Santuario di Bona Dea in via degli Augustali
Acca LarentiaUn altra tradizione sembra ricollegarsi all’antico
costume della prostituzione sacra a Roma e si tratta del racconto leggendario
di Acca Larentia. Nella tradizione letteraria questa figura mitica non ha
un’unica storia ma due diverse versioni riferite da Plutarco (Plut. Rom. 4):“Secondo
altri fu un equivoco sul nome della nutrice [di Romolo e Remo] ad avviare il
racconto verso la favola, e precisamente il fatto che i Latini chiamavano lupa
tanto le femmine dei lupi, quanto le donne prodighe delle loro grazie, quale la
moglie di Faustolo, che allattò i due gemelli. Il vero nome di costei era Acca
Larenzia, e i Romani fanno dei sacrifici in suo onore; ad aprile il sacerdote
di Ares versa per lei delle libagioni durante una festa chiamata Larenzia.” L’altra versione (Rom. 5), più articolata:“Un’altra
Larenzia si onora a Roma, per il seguente motivo. Pare che un giorno il
sacrestano del tempio di Eracle, non sapendo cosa fare per passare il tempo,
proponesse al dio una partita a dadi col patto che, se vinceva, gli avrebbe
fatto una grossa grazia, se perdeva, egli gli avrebbe procurato un lauto pranzo
e una bella donna con cui passare la notte. Con questa posta gettò i dadi,
prima per Eracle e poi per sé. Beh, rimase battuto; ma aveva dato la parola e
ritenne doveroso attenersi ai patti. Apparecchiò un pranzo per il dio e assoldò
Larenzia, che, sebbene non fosse ancora famosa, era pure un fior di donna, la
fece cenare nel tempio e dopo mangiato ve la rinchiuse, non senza aver
apprestato il giaciglio, come se Eracle dovesse venire a goderla. Dice la
storia che il dio venne davvero, abbracciò la donna e alla fine le comandò di
recarsi la mattina per tempo al mercato e di salutare il primo uomo che
incontrava, stringendo amicizia con lui. Così fece Larenzia. L’uomo incontrato
al mercato era un cittadino anziano, che aveva messo da parte una discreta
sostanza, senza figli come pure senza moglie, di nome Tarruzio. Egli si prese
nel letto Larenzia e ne rimase tanto soddisfatto, da lasciarla alla sua morte
erede di molti e grandi beni, che ella in gran parte donò poi per testamento al
popolo, quando, famosa ormai e assai venerata per esser stata amata da un dio,
disparve nel medesimo luogo dov’era sepolta la prima Larenzia.”
Acca Larenzia
Artista: Jacopo di Pietro
d’Agnolo di Guarnieri
detto Jacopo della Quercia
(Siena, 1374 circa –
Siena, 1435)
Datazione: 1414 – 1418
Materiale: Marmo della
Montagnola Senese - Altezza: 1,65 m
Collocazione: Complesso
Museale di Santa Maria della Scala – Siena
Romolo e Remo trovati da
Faustolo
Artista: Pietro Berrettini
detto Pietro da Cortona
Cortona, 1 novembre 1596 –
Roma, 16 maggio 1669
Pittura: olio su tela –
Datazione 1643 circa
Misure: (2,51 x 2,66) m – Collocazione: Museo di Louvre, Parigi
La seconda tradizione riportata da Plutarco lascia
ipotizzare, attraverso il racconto mitico, la presenza a Roma della
prostituzione sacra, connessa al culto di Ercole identificato con il fenicio
Melqart.
Il santuario
emporico, sorto probabilmente già prima della fondazione di Roma, si trovava in
prossimità del guado del Tevere, dove passavano le via commerciali che dalle
saline alla foce del fiume proseguivano verso l’entroterra, e dove sorgeranno
l’Ara Massima di Ercole e il Foro Boario. Nel racconto compaiono altri elementi
importanti che consentono di decodificare la verità inserita nella leggenda,
come il gioco dei dadi con la divinità che è riconducibile ad antiche pratiche
divinatorie praticate in Oriente, oppure la cena preparata per il dio che trova
riscontro nei rituali per l’Ercole italico venerato dai commercianti, e infine,
l’unione sessuale tra dio e prostituta che è chiara prova della prostituzione
sacra. Da altri autori antichi come Macrobio e Aulo Gellio Larenzia era
indicata come nobilissimum scortum, cioè
nobilissima prostituta che divenne ricchissima con il suo esercizio. È
probabile che il titolo di nobilissima attribuito a Larenzia possa derivare
dall’aspetto sacrale della sua funzione. Anche il matrimonio rispettabile alla
fine del suo servizio sacro rientra nelle caratteristiche tipiche della
prostituzione sacra già evidenziate in precedenza per altre aree geografiche, e
sembra inoltre rimandare a quella prostituzione prenuziale diffusa in altri
popoli antichi. Elementi chiave appaiono poi il contesto del santuario emporico
con frequentazioni greche-orientali e l’influsso etrusco indicato dalla figura
di Tarutius, componenti che contestualizzano ancora più chiaramente le influenze
culturali che portarono anche in ambiente romano allo sviluppo della pratica
della prostituzione sacra. (Professore, Gabriele Romano)
Romolo e Remo
Artista: Sebastiano Ricci
(Belluno, luglio 1659 –
Venezia, 15 maggio 1734)
Pittura: olio su tela – Datazione:
1708 circa
Misure: (1,85 x 1,70) m –
Collocazione: Museo
Hermitage . St. Petersburg. Russia)
Acca Larentia sarebbe una figura semidivina che fu
ereditata ai Romani dagli Etruschi come prostituta protettrice del popolo
umile. Secondo una delle tante leggende, al tempo dei re, il custode del tempio
di Eracle sfidò il dio al gioco dei dadi.La posta in palio sarebbe stata una cena e l’etera più
bella. Vinse il dio e il custode rinchiuse, per tutta la notte, Acca Larentia
nel tempio. Il dio Eracle fu grato alla giovane donna per le sue preghiere e le
promise cheIl primo uomo che
incontrerai ti ricompenserà.Fu così che Acca Larentia incontrò l’etrusco, Tarutius,
che colpito dalla bellezza della fanciulla la sposò.Alla morte del marito la donna ereditò una grande fortuna
che donò al popolo romano che per gratitudine istituirono in suo onore una
festa.Feste che furono dette “Accalia o Larentalia” e che si
svolgevano il 23 dicembre nei pressi della sua tomba posta, come dicono le
fonti, dietro il Velabro.
Roma – il Velabro in una
stampa del 1800
Secondo alcuni storici la
tomba di Acca Larentia si doveva
trovare sul sito
dell’edicola di Giuturna
Secondo un ulteriore versione di Lattanzio Acca Larentia
sarebbe la moglie del pastore Faustolo che soccorse i gemelli Romolo e Remo,
fondatori di Roma.
In questa versione la donna assunse anche i nomi di “
Faula o Fabula” e venne detta “lupa”, un termine con il quale i Romani
indicavano le prostitute e dal quale viene il termine “lupanare”.
La donna era madre di dodici figli, e alla morte di uno
di loro, Romolo ne prese il posto dando vita alla “Fratres Arvales” (Arvali,
collegio sacerdotale istituito da Romolo e composto da dodici membri).
Acca Larentia si curò di allattare anche Romolo e Remo che, una volta venuti a conoscenza
della loro origine (figli della vestale rea Silva, discendente dell’eroe
troiano Enea, e di Marte dio della
guerra), decisero di vendicarsi uccidendo lo zio usurpatore Amulio e rimettendo sul trono il nonno
Numitore, legittimo re di Alba Longa.
La lupa che allattò Romolo e Remo sarebbe quindi secondo
alcuni storici identificabile con Acca Larentia per il suo passato di “lupa”
cioè di prostituta.
...........................
Afrotide, dea della bellezza e dell’amore.
Da Inanna..Istar...Astarte ..ad Afrotite...un eroina ?
I romani la identificarono con Venere ed era secondo
Omero la figlia di Zeus e della ninfa Dione.Secondo Esiodo la dea sarebbe nata in primavera dalla
spuma del mare fecondata dai genitali di Urano che Cronos aveva scagliato in
mare dopo la ribellione con il padre.La parola Afrotide deriverebbe dal greco “Afros” cioè
spuma.Nella sua Teogonia Esiodo riportò:i genitali vennero trascinati dal mare per un
lungo periodo e spuma bianca sorse dalla carne immortale; dentro ad essa crebbe
una ragazza che divenne Afrodite”.Quando il sangue di Urano cadde sul mare, l’acqua cominciò a
ribollire e su di una conchiglia, sospinta da Zefiro, emerse Afrotide in tutto
il suo splendore.Zefito l’aveva spinta sulla riva dell’isola di Cipro e da qui
anche gli appellativi dati alla dea di “Anadiomene” (l’emersa) e di “Ciprigna”
da Cipro. Sulla spiaggia giocavano le Ore, figlie di Teti, e quando
videro la dea emergere corsero verso di lei per ricoprirla con dei veli ed
intrecciarle i biondi capelli con corone di fiori.Zeus fu subito colpito dalla bellezza della donna ed
inviò un carro di gemme, tirato da due colombe, per prelevarla ed accoglierla
nell’Olimpo come figlia adottiva, suscitando l’ira e l’invidia delle altre dee.Per ironia della sorte, Zeus le diede come marito
Hefesto, uno degli dei più brutti e non fu un matrimonio felice.Ebbe altre relazioni con la nascita di figli: dal troiano
Anchise ebbe Enea; dal dio Dionisio ebbe Imene, il dio delle feste nuziali; dal
rapporto con Ares nacquero due figli terribili, Eros (amore) e Anteros.I poeti greci raccontarono che quando Afrotide ebbe Erts,
si lamentò con la dea Temi perché il figlio non cresceva.Temi le rispose che il bambino non sarebbe cresciuto fino
a quando non avesse avuto un fratello. Afrotide diede quindi vita ad Anteros che significa
“colui che ricambia l’amore”.Con queste leggenda i poeti misero in evidenza il concetto che l’amore per poter
crescere deve essere ricambiato.La dea portava sul vestito una cintura magica dove erano
raccolti tutti le grazie, il sorriso che promette ogni gioia, i teneri dialoghi
degli innamorati, i sospiri che persuadono e il silenzio espressivo.
La Nascita di Venere
Artista: Sandro Botticelli
(Alessandro di Mariano di
Vanni Filipepi)
(Firenze, 1 marzo 1445 –
Firenze, 17 maggio 1510)
Data: 1485
Tecnica: Tempera su tela –
Misure : (172,5 x 278,5) cm
Collocazione: Galleria
degli Uffizi, Firenze
Gli erano sacri: tra le piante, il mirto, la rosa, il
melo, il papavero mentre tra gli animali, il passero, la lepre, il cigno, il
riccio, il delfino, la seppia, e soprattutto la colomba e la tortora.
Cavalcando una conchiglia Afrotide giunse nell’isola di
Citera.
L’isola era un importante centro di scambi e questo
favorì la diffusione del suo culto in
tutta la Grecia. L’isola era però troppo piccola per contenere la sua bellezza
e quindi attraversò il Peloponneso e finì per stabilire la sua residenza a
Pafo, nell’isola di Cipro.
Un sito che fu la sede principale del suo culto.
Ogni primavera le sue sacerdotesse si bagnavano nel mare
e ne riemergevano vergini.
Su una gemma ritrovata nella grotta Idea si vede incisa
la dea cretese mentre soffia in una conchiglia con un pesce vicino all’altare
(forse un delfino).
Un’altra leggenda narra che al suo passaggio sulla terra
sboccino i papaveri.
Un giorno la dea, volendosi rendere utile, si mise a
tessere ad un telaio.
Fu sorpresa da Atena, dea delle arti, che non capendo il
suo umile gesto, corse subito a lamentarsi con Zeus.
L’arte del tessere era una sua virtù e nessun’altra
poteva prenderle il posto.
Afrotide si scusò con Atena e decise di non lavorare più
al telaio e di dedicarsi solamente a fare innamorare tutti di lei.
Afrotide Cnidia di
Prassitele
Spesso la letteratura storica ha dato un origine
orientale alla figura di Afrotide collegandola alle figure di Inanna, di Istar
e soprattutto di Atagartis (siriaca) e di Astarte (fenicia).
La figura di Astarte è sostanzialmente simile ed
assimilabile a quella di Atargatis anche se con qualche differenza legata alla
provenienza e alla formazione del culto.
Atargatis, nata dall’Eufrate come ci tramanda Igino,
giunse in Siria non dall’area mesopotamica-babilonese ma dall’Anatolia grazie
agli Hittiti.
Poiché il territorio siriano subì l’influenza hittita e quella
babilonese, le due figure finirono per fondersi quasi ovunque mantenendo delle
differenze solo in alcuni luoghi come ad esempio in Ascalona in Palestina.
Qui infatti, come riferisce Luciano di Samosata, si
trovavano templi di entrambe le
divinità.
Astarte – Museo
Archeologico di Siviglia
Bellissima placca votiva
in argilla cotta.
Una donna nuda in
bassorilievo, probabilmente la dea
Astarte.
Parrucca egiziana dipinta
di nero; le mani posizionate sui seni mentre
il foro in alto era per la
sospensione della placca.
Reperto Fenicio della
tarda Età del bronzo (VI secolo a.C.)
Rinvenuto a Tharros
(Sardegna) in una tomba.
Collezione: British Museum
, Londra
Astarte era venerata come la Grande madre da tutte le
popolazioni fenicie ed ebbe tra i suoi maggiori centri di culto Sidone, Tiros,
Ascalona, Byblos e in altri centri fenici del Mediterraneo fra cui Malta,
Tharros in Sardegna ed Erice in Sicilia.
Ad Erice diventò una figura di prima piano nella
religiosità degli Elimi e già intorno al XIII secolo a.C. era esistente un
celebre tempio che diventò famoso in seguito con l’appellativo di “Venere
Ericina” (Sotto il dominio romano).
Nella Sicilia Occidentale Astarte venne rapidamente
assimilata ad Afrotide ed alla Venere Romana.
Diodoro Siculo riportò che Erice, figlio di Bute e di
Afrotide, abbia eretto un tempio dedicato alla divinità sua madre e fondato la
città che da lui prese il nome, e dell’arrivo di Liparo, figlio di Ausonio,
dalle isole Eolie.
Aggiunse che anche i Sicani
Abitavano le alte vette
dei monti e adoravano Venere Ericina
Sulle rovine del tempio venne edificato dai Normanni un
castello che fu chiamato “di Venere” e sempre in Sicilia, sul versante opposto
e cioè sui Monti Nebrodi, a dimostrazione del culto radicato nell’isola di
Astarte, si trova Mistretta.
Mistretta un nome, che a detta dei filologi, deriva
dal fenicio “Am-Ashtart” (“Città di Astarte”).
Mistretta (Me)
Ma dove ha avuto origine il culto di Astarte e di
Atargatis ?
Le loro origini andrebbero ricercate in Mesopotamia ed
esattamente nella figura della dea Inanna sumera e della Istar babilonese. Si
tratta di due dee che hanno delle prerogative e degli attributi che si
troveranno successivamente, nel mondo greco e in quello romano, sia in Afrotide
che in Venere.
Antico sigillo (a
cilindro) accadico che rappresenta la
dea Inanna (Ishtar) con il
suo “sukkal” (ministro)
Ninshubur.
Datazione: periodo di
Akkad , 2334 -2335 a.C.
La dea poggia il piede su
un leone mentre Ninshubur le offre obbedienza.
Istituto orientale
dell’Università di Chicago
Il vaso votivo Warna è
decorato con tre registri orizzontali ed
evidenzia dei chiari segni
di riparazioni risalenti all’antichità.
È raffigurata una scena in
cui un uomo nudo offre una ciotola di frutta e
cereali ad una divinità
femminile, Inanna (Ishtar).
Dietro ci sono due fasci
di canne per indicare che è il tempio della dea.
In vaso fu trovato in
frammenti da una squadra di archeologi tedeschi in
un complesso di templi
dedicati alla dea Inanna nella città di Uruk
(nel sud dell’Irag) nel
1933.
Altezza: 1 metro – Trovato
a Warka (antica Uruk)
Periodo: Jemdet Nasr –
3000- 2900 a.C.
Collocazione: Sumeriam
Gallery, Museum di Baghdad (Iraq)
Inanna (Inana) ( cuneiforme sumerico
IN.AN.NA, forse con il significato di “Signora del Cielo”
o “Splendente”. Era la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell’amore.
Un amore inteso come relazione erotica piuttosto che coniugale.
Rappresentava la più importante divinità femminile
mesopotamica e successivamente fu assimilata alla dea babilonese ed assira Ishtar.
La più antica attestazione del nome della divinità si
trova nelle tavole d’argilla rinvenute nell’antico complesso templare di
Uruk risalenti al 3400/3000 a.C.
La tradizione sumerica la vuole figlia del dio del Cielo
An oppure, secondo un altra tesi, figlia
del dio Luna (Nanna) e sorella gemella del Sole (Utu).
Donò alla città di Uruk, di cui era protettrice, i Me
sottratti ad Enki con un inganno ( lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la
sua bellezza).
(I “Me” nella mitologia sumerica erano quelle forze impersonali che insieme con gli Dei
garantivano l’ordine nell’universo).
Con questa donazione garantiva all’umanità una vita nella prosperità e nel benessere. Dopo la morte del suo innamorato Damuzi, diventò una seduttrice di uomini e di dei. Nella saga di Gilgamesh (mitico re di Uruk risalente al 4500 a.C.) questi rifiuta le offerte di sesso di Inanna accusandola che
“nessun uomo è rimasto vivo fino all’indomani mattina, dopo
aver giaciuto con lei una notte”.
Dea dell’amore, volubile e perennemente innamorata,
vogliosa, disinibita (in alcuni suoi inni chiede al compagno Dumuzi degli atti
osceni), è una regina che pretende ciò
che desidera.Dea della fertilità della terra, rappresentata con in
mano dei giunchi ripiegati a formare degli anelli, che pretende sacrifici e
grandi feste in suo onore. È anche dea della guerra e non in contrapposizione all’amore perché
protegge il suo popolo che ama distruggendo i nemici in battaglia con i suoi artigli. La sua femminilità è spesso chiamata nei suoi inni con
il termine “hyeròdula” cioè prostituzione sacra facendo riferimento ad una atteggiamento senza limiti e ricco
d’orgoglio.La dea appare in molti antichi miti mesopotamici:-
Inanna e l’albero di Huluppu (un mito della creazione
dell’Inizio);
-
Inanna e il dio della Sapienza (un mito che narra dei doni della conoscenza
e della cultura alla città di Uruk. Già citato in merito ai “Me”)
-
Il corteggiamento di Inanna e Dumuzi (la storia del
matrimonio di Inanna con il dio-vegetale o della vegetazione);
-
La Discesa di Inanna negli Inferi dimora della sorella
Ereskigal (un mito risalente al 1900-1600 a.C.
ed il più famoso)
Nel racconto “Inanna e l’albero di Huluppu” si narra come la dea trovò un albero chiamato
“Huluppu” sulle sponde del fiume Eufrate e che era stato sradicato
dall’erosione dell’acque del fiume in piena. Lo prese per piantarlo nel suo
giardino con l’obiettivo di utilizzarne la legna per creare il suo trono e il suo letto. Passarono dieci anni e l’albero
era cresciuto ma non potò utilizzarlo per gli scopi che si era prefissata.“Quindi
un serpente, che non può essere incantatofece il suo nido tra le radici dell’albero Huluppu.L’uccello Anzu mise i suoi piccoli tra i rami dell’alberoe la vergine oscura Lilith costruì la sua casa nel tronco”.La dea, che sorrideva sempre, fu conquistata da un
pianto senza fine e chiamò in suo aiuto il fratello Utu/Shamash che però si
rifiutò di aiutarla. Si rivolse al grande eroe semi-divino Gilgames che, dato
di una grande forza, colpì il serpente tra le radici; l’uccello Anzù fuggì,
assieme ai suoi piccoli, sulle montagne e lo stesso fece anche Lilith in fuga
verso luoghi selvatici.L’albero Huluppu fu quindi consegnato dalla dea che
iniziò a lavorarlo: trasformò le radici dell’albero in tamburo (pukku) e dai
suoi rami creò delle bacchette (mekku) per suonarlo.Con la creazione di questo strumento costrinse i
giovani di Uruk a danzare al suo ritorno fino allo sfinimento.Al sopraggiungere della sera, posò lo strumento che
precipitò negli inferi.Nel racconto appare la figura di “Lilith” che è molto
nota nella cultura mesopotamica. Una figura che nelle leggende ebraiche sarebbe
diventata la prima moglie di Adamo, precedendo “Eva”, considerata dall’esegesi
cristiano-cattolica la “prima donna” ovvero la capostipite del genere
femminile. È probabile che la religione ebraica assorbì quindi la figura di
Lilith direttamente dalla cultura babilonese durante la prigionia degli Ebrei
in Babilonia.
“La Discesa di Inanna negli Inferi” è il poema
più famoso, scritto in origine in cuneiforme ed inciso su tavolette d’argilla
rinvenute nei pressi dei siti archeologici di Assur e Ninive composte da 145
righe.
Racconta del viaggio della dea nel mondo sotterraneo
per sfidare la sorella di nome Ereshkigal.
Scritto probabilmente tra il 3500 ed il 1900 a.C.
anche se alcuni storici siano propensi a dare una data ancora più antica.
Con il passare del tempo la narrazione ha subito delle
variazioni sia nello stile che nella caratterizzazione dei personaggi.
Variazioni legati alla maggiore importanza
del ruolo delle divinità femminili durante il secondo millennio a.C.
Dal grande paradiso ella si immerse nel mondo di sotto. Dal grande paradiso
la dea mise la sua mente nel grande abisso. Dal grande paradiso Inanna mise la
sua mente nel grande abisso. La mia padrona abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo. Inana abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo”.
Inanna sperava d’estendere la sua sfera d’influenza
anche nel regno degli inferi, la cui regina era la sorella Ereshkigal.
Inanna si mise d’accordo con il suo primo ministro,
una donna di nome Ninshuba, dicendole
cheSe non fosse tornata entro massimo tre giorni e tre notti dal
sottosuolo, avrebbe dovuto organizzare grandi cerimonie funebri e
avrebbe dovuto chiamare gli Anunnaki perché corressero in suo soccorso.
-
Inanna e l’albero di Huluppu (un mito della creazione
dell’Inizio);
-
Inanna e il dio della Sapienza (un mito che narra dei doni della conoscenza
e della cultura alla città di Uruk. Già citato in merito ai “Me”)
-
Il corteggiamento di Inanna e Dumuzi (la storia del
matrimonio di Inanna con il dio-vegetale o della vegetazione);
-
La Discesa di Inanna negli Inferi dimora della sorella
Ereskigal (un mito risalente al 1900-1600 a.C.
ed il più famoso)
Nel racconto “Inanna e l’albero di Huluppu” si narra come la dea trovò un albero chiamato
“Huluppu” sulle sponde del fiume Eufrate e che era stato sradicato
dall’erosione dell’acque del fiume in piena. Lo prese per piantarlo nel suo
giardino con l’obiettivo di utilizzarne la legna per creare il suo trono e il suo letto. Passarono dieci anni e l’albero
era cresciuto ma non potò utilizzarlo per gli scopi che si era prefissata.“Quindi
un serpente, che non può essere incantatofece il suo nido tra le radici dell’albero Huluppu.L’uccello Anzu mise i suoi piccoli tra i rami dell’alberoe la vergine oscura Lilith costruì la sua casa nel tronco”.La dea, che sorrideva sempre, fu conquistata da un
pianto senza fine e chiamò in suo aiuto il fratello Utu/Shamash che però si
rifiutò di aiutarla. Si rivolse al grande eroe semi-divino Gilgames che, dato
di una grande forza, colpì il serpente tra le radici; l’uccello Anzù fuggì,
assieme ai suoi piccoli, sulle montagne e lo stesso fece anche Lilith in fuga
verso luoghi selvatici.L’albero Huluppu fu quindi consegnato dalla dea che
iniziò a lavorarlo: trasformò le radici dell’albero in tamburo (pukku) e dai
suoi rami creò delle bacchette (mekku) per suonarlo.Con la creazione di questo strumento costrinse i
giovani di Uruk a danzare al suo ritorno fino allo sfinimento.Al sopraggiungere della sera, posò lo strumento che
precipitò negli inferi.Nel racconto appare la figura di “Lilith” che è molto
nota nella cultura mesopotamica. Una figura che nelle leggende ebraiche sarebbe
diventata la prima moglie di Adamo, precedendo “Eva”, considerata dall’esegesi
cristiano-cattolica la “prima donna” ovvero la capostipite del genere
femminile. È probabile che la religione ebraica assorbì quindi la figura di
Lilith direttamente dalla cultura babilonese durante la prigionia degli Ebrei
in Babilonia.
Racconta del viaggio della dea nel mondo sotterraneo per sfidare la sorella di nome Ereshkigal.
Scritto probabilmente tra il 3500 ed il 1900 a.C. anche se alcuni storici siano propensi a dare una data ancora più antica.
Con il passare del tempo la narrazione ha subito delle variazioni sia nello stile che nella caratterizzazione dei personaggi. Variazioni legati alla maggiore importanza del ruolo delle divinità femminili durante il secondo millennio a.C.
Dal grande paradiso ella si immerse nel mondo di sotto. Dal grande paradiso
la dea mise la sua mente nel grande abisso. Dal grande paradiso Inanna mise la
sua mente nel grande abisso. La mia padrona abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo. Inana abbandonò il cielo, abbandonò la
Terra e scese nel mondo sotterraneo”.
Inanna si mise d’accordo con il suo primo ministro, una donna di nome Ninshuba, dicendole che
Se non fosse tornata entro massimo tre giorni e tre notti dal
sottosuolo, avrebbe dovuto organizzare grandi cerimonie funebri e
avrebbe dovuto chiamare gli Anunnaki perché corressero in suo soccorso.
Ereshkigal,
sorella di Inanna e regina del mondo sotterraneo (gli inferi)
Il guardiano obbedì al comando e chiuse le porte.
Ad Inanna fu permesso di attraversare un cancello alla volta e ad ogni ingresso doveva abbandonare un pezzo del suo abito regale e dei suoi gioielli.
Passaggio dopo passaggio alla fine dopo l’ultimo ingresso, si ritrovò completamente nuda ed inerme (priva dei suoi simboli sacri tra cui una collana di lapislazzuli) di fronte alla sorella Ereshkigal.
La regina degli inferi volse i suoi occhi di pietra sulla sorella venuta dal mondo di sopra e la trasformò
Al suo sguardo Inanna perse la sua vitalità e rimase per tre giorni e per tre notti come un cadavere, giacendo inerme nel mondo sotterraneo (il cadavere ormai in putrefazione).
Passati i tre giorni la ministra Ninshuba fece ciò che le era stata ordinato dalla dea e si mise quindi alla ricerca di Enki ( dio dell’acqua e della saggezza) che, venuto a conoscenza della grave situazione, prese subito dei provvedimenti.
Enki, con lo sporco che aveva sotto le unghie, diede vita a due strane creature asessuate, “Kurgarra” e “Galatur”, che furono subito inviate nel mondo sotterraneo con cibo ed acqua per riportare in vita Inanna che vi giaceva inerte.
Quando giunsero negli inferi trovarono Ereshkigal in travaglio, in preda ad un parto dolorosissimo. La regina dell’oltretomba offrì loro qualunque cosa in cambio di un pò di sollievo e i due richiesero la liberazione di Inanna
Inanna fu riportata in vita grazie all’intervento delle due creature ma c’era un grosso problema da superare visto che
Inanna tornò felice nella sua città sacra ma trovò il suo compagno ed amante Dumuzi non vestito a lutto e, in sua assenza, s’era anche impadronito del suo posto di comando.
Infuriata per tanta presunzione ordinò che Dumuzi fosse portato, come suo sostituto, nel regno degli inferi. Tentò una disperata fuga ma venne raggiunto e trascinato nell’ade.
L’affezionata sorella Gestinanna lo seguì nel mondo degli inferi e riuscì ad ottenere da Ereshkugal la vita del fratello per la metà d’ogni anno. La metà dell’ano in cui le piante del deserto fioriscono, perché Dumuzi era il dio della vegetazione.
Fu la tristezza di Geshtinanna a commuovere Ereshkigal al tal punto da permette a Dumuzi di tornare sulla terra durante l’estate e la primavera venendo sostituito nell’ade dalla sorella,
Come per Persefone e Demetra, questo evento fu preso ad esempio per il cambiamento delle stagioni.
Nel mito Inanna, dopo aver condanno a morte Dumuzi, pianse la morte dell’amato.
Tavoletta che
descrive la discesa di Inanna negli Inferi
Istituto orientale
presso l’Università di Chicago
Ereshkigal (?) regina degli inferi e
sorella di Inanna
Un rilevo detto di Burney dal nome del suo scopritore
Altorilievo di terracotta, alto 50
cm. risalente al II millennio a.C. e di
probabile fattura paleobabilonese
British Museum, Londra
La dea Inanna aveva sposato(?) Dumuzi con l’obiettivo di
espandere i propri domini sempre in
sinergia con il suo carattere vivace e battagliero.
Dumuzi morì, come abbiamo visto, per aver usurpato il
trono della moglie durante la sua discesa nell’ade o, secondo un ‘altra
versione, per una caduta in un fiume e conseguente morte per soffocamento
(probabilmente durante la fuga).
Restò quindi da sola e per nulla rassegnata al suo
antico e mai domo obiettivo di espansione di potere.
Accusò il dio Marduk/Ra di essere responsabile della
morte del marito e dunque del fallimento (temporaneo) del suo progetto
d’espansione.
Decise quindi d’intraprendere una guerra contro il
dio.
In impresa difficile tanto che suo padre Anu cercò di
scoraggiarla dal compiere un gesto così pericoloso.
Il mito narra come la donna s’equipaggiò di ogni
genere d’armi e decise d’affrontare l’impossibile. Le tavolette sumeriche
narrano come la dea assaltò il monte Ebih e riuscì alla fine anche a demolirlo.
Naturalmente non si tratta di una montagna ma di
qualcosa in ogni caso importante e sontuoso tanto da demolirlo con rabbia.
Le versioni secondo gli studiosi sul muto monte “Ebih”
sarebbero tre:
In questa lunga storia fatta anche di morte e di resurrezione, si presenta sempre con una veste regale, coraggiosa, orgogliosa ed anche vendicativa.
Inanna insegna la fierezza, la disinibizione, l’orgoglio di una femminilità piena, mai sottomessa. Una femminilità che li porta ad essere regine del cielo, signore dal cuore immenso in cui c’è spazio per tutto, anche per il dolore – per ogni cosa, tranne che per la paura.
Nella mitologia fenicia e nella tradizione ebraica appare come la divinità Astarte, a cui viene attribuito il ruolo di “Elohim”.
Nel mito greco “Il Giudizio di Paride” – ma anche in altri racconti degli antichi Greci – Inanna viene identificata con la dea Afrodite, tradizionalmente associata a Inanna per via della sua incantevole bellezza ed estrema sensualità. Inanna viene sempre descritta come una giovane donna, mai come madre o come una moglie fedele, pienamente consapevole del suo potere femminile e che fa fronte alla vita con coraggio senza timore di come sarà percepita dagli altri, specialmente dagli uomini.
Inanna appare come Ištar (babilonese), una dea dalla sessualità promiscua, gelosa e vendicativa.
I suoi appellativi sono “Argentea” e “Donatrice di Semi” e, come la sua controparte sumera, governava la fertilità e il raccolto.
In epoche successive divenne anche protettrice delle
prostitute e dell’amore sessuale. Era la dea delle tempeste, dei sogni e dei
presagi e distribuiva agli uomini potere e conoscenza tramite i “ME” sottratti
al dio Ea/Enki.
Uno dei suoi simboli era il bastone con i serpenti
intrecciati.
Uno dei monumenti più importanti dedicati alla dea
Inanna è la “Porta di Istar”, l’ottava porta della città di Babilonia. Fu
costruita intorno al 575 a.C. sotto il regno di Nabucodonosor II, nella parte
Nord della città.
La struttura era in realtà una doppia porta di cui ciò che è in mostra nel Pergamonmuseum è solo la più piccola parte frontale. L’ingresso posteriore, più ampio, è custodito nei magazzini del museo, mentre altre parti della porta, e due leoni della Via Processionale si trovano in altri musei sparsi nel mondo.
I decori principali della porta sono: leoni, tori, draghi e fiori. Le maioliche sono costruite con lapislazzuli e rivestite con finissima ceramica invetriata. Una più piccola riproduzione della porta è stata costruita in Iraq sotto Saddam Hussein come entrata ad un museo che però non fu completato.
Danni alla riproduzione avvennero durante la guerra in Iraq per colpa degli eserciti statunitensi che, come si venne a sapere in seguito, avevano l’ordine di distruggere gli antichi monumenti conservati nei musei iracheni.
Enheduana, scrisse degli inni per Innana
La prima testimonianza scritta di un’autrice
Enheduana, figlia del
grande re accadico (popolazione proveniente dal deserti siro – arabico e che
coabitarono con i Sumeri) Sargon, il
primo che sottomise l’intera Mesopotamia al suo potere, e prima sacerdotessa di
Nanna, dio della Luna, scrisse numerosi inni, tra cui alcuni di grande fascino,
dedicati alla dea Inanna.
Per la prima volta nella
storia qualcuno usa la scrittura non
per tenere dei registi commerciali o
altro, ma per fare poesia e per esprimere sentimenti e stati psicologici.
Ricordiamoci che siamo nel 2300 circa
a.C......
Il Disco di calcite che riporta il nome di Enheduanna”
Museo de la Università di Pensilvania
Nel disco Enheduanna è rappresentata nell’atto di celebrare una cerimonia
religiosa
in onore di Inanna. La sacerdotessa offre libagioni rituali alla dea
ed è vestita con il tradizionale abbigliamento di Soma Sacerdotessa.
Accanto a lei due servitori.
Nel retro del disco è raffigurato il simbolo di Nanna, il dio della luna,
al quale era consacrata la vita di Enheduanna. È riportata una breve
traccia biografica della sacerdotessa
“Enheduanna, sacerdotessa zirru, sposa del dio Nanna, figlia di Sargon, re
del mondo, nel tempio della dea Inanna”.
Il disco fu trovato dall’archeologo britannico Sir Leonard Wooley nel 1928.
Il disco presenta una sola testa che tocca il margine superiore del fregio
per
simboleggiare il dominio della
figura.
Venne trovato nel Giparu (residenza della sacerdotessa o tempio) di Ur,
forse
Il luogo dove Enheduanna viveva. È datato 200 – 1600 a.C. e si trovava
vicino alla
statua di una sacerdotessa, la stessa Enduhanna (?).
anche il ritrovamento di una piccola figura femminile, seduta con un abito
a balze,
lascia suggerire che si tratti proprio della sacerdotessa.
Ma " come per tanti artefatti
del mondo antico, le teste sono rotte,
proprio come nel mondo antico.”
Le tavolette con gli inni di Enheduanna
Nei suoi inni si rivolge alla dea Inanna chiamandola
“Signora dal cuore immenso” descrivendola come una donna piena d’amore, di luce
ed anche come una belva assetata di sangue che fa scempio dei corpi dei suoi
nemici sul campo di battaglia.Uno degli inni scritti da Enedhuanna:
“Regina di tutti i Me
Donna vestita di luce
Il cielo e la terra sono i tuoi indumenti
Tu sei l’eletta, la santificata.
Oh tu grandiosa per le tue doti
Coronata dalla tua immensa bontà
Somma sacerdotessa, sei giusta
La tua mano si afferra ai sette poteri
Mia sovrana, tu dalla forza fondamentale
custode delle origini cosmiche essenziali
Tu esalti gli elementi
Legali alle tue mani
Riunisci in te i poteri
Imprigionali nel tuo cuore
Come un drago lanci veleno sulla terra dei nemici
Ruggisci come il dio della tormenta
Come il seme che imputridisce nella terra
Sei il fiume in piena che precipita già dalle montagne
Sei Inanna
Suprema in cielo e in terra”
...................
Esilio da Ur
Tu mi hai chiesto di entrare nel santo chiostro, il giparu,
e io vi sono entrata, io, l’alta sacerdotessa, Enheduanna!
Ho recato con me la cesta rituale
e ho levato il mio canto di lode per te.
Ora, però, sono relegata in mezzo ai lebbrosi
e non posso più vivere con te.
Le tenebre si approssimano alla luce del giorno,
intorno a me si fa buio.
Le tenebre si approssimano alla luce del giorno
e lo ricoprono con tempesta di sabbia.
La mia tenera bocca di miele d’improvviso si confonde.
Polvere è il mio bel volto.
Da Inno a Inanna, IX
.......................
Accusa a Inanna
Di me, mio Nanna, non ti curi più:
mi trascini alla rovina per sentieri di morte.
[…]
Eccomi, sono Enheduanna:
gloriosa e trionfante, un tempo;
ma il dio mi ha tratto fuori dal mio santuario,
come una rondine dalla finestra ha lasciato che io volassi.
La mia vita è in fiamme.
Egli mi ha costretto a camminare tra i rovi sulla montagna,
ha spogliato il mio capo della corona di prima sacerdotessa,
mi ha dato un pugnale e una spada e mi ha detto:
“Sono per te: rivolgili contro il tuo corpo”.
Da Inno a Inanna, XIII
Facciata del tempio di Inanna a kara (Uruk)
.....................
La figura di Inanna la troveremo nella Istar babilonese.
I Babilonesi erano dei grandi conoscitori dell’astronomia
e già associavano la loro dea Istar al pianete Venere perché aveva due aspetti:
“il vespertino e il mattutino”
Anche Istar aveva un duplice aspetto
Io sono Istar Dea del
mattino, io sono Istar Dea della sera
Come dea della sera era “La Benevola”, la Dea dell’amore
nei cui templi si svolgevano dei riti licenziosi; come Dea del mattino era
invece la prode sorella del Dio solare Samas, la “Regina delle Battaglie”- per
quest’ultimo motivo era raffigurata sui rilievi di Susa in forma maschile e con
barba, una caratteristica che si ritrova
anche nell’Afrotide di Cipro secondo la descrizione di Macrobio nei
“Saturnalia”.
Anche Istar era una Dea collegata con gli Inferi e
l’Oltretomba secondo un racconto mitologico mesopotamico di Inanna. Il mito
babilonese assunse nel tempo delle modifiche rispetto a quella della dea
Inanna.
Secondo il racconto la dea Istar giunse alle porte
dell’Oltretomba e chiamò a gran voce i guardiani. Li minacciò dicendo che se
non fosse stato aperto, avrebbe distrutto la porta e fatto uscire i morti che
avrebbero divorato i vivi, cambiando così l’ordine naturale del mondo.
I preoccupati guardiani corsero ad avvertire del pericolo
la Signora dell’Oltretomba, Ereskigal. Sorella di istar, che colse l’occasione
propizia per attirarla in una trappola.
Istar fu fatta entrare attraverso le sette porte
dell’Irkalia, ed ad ogni passaggio venne spogliata gradualmente delle sue vesti
e dei suoi gioielli, che erano dei simboli importanti del suo potere.
Alla fine si trovò completamente nuda e venne accolta
nella sala del trono da Ereskigal.
Ereskigal rilevò ad istar le sue reali intenzioni ed
ordinò al suo ministro Namtar, dio del destino, di scagliare contro la sorella
sessanta malattie, che colpivano ogni parte del suo corpo.
Istar venne presa prigioniera e questa sua prigionia aveva come effetto l’interruzione di ogni
attività di generazione nel mondo dei viventi.
Questi eventi preoccuparono il Consiglio degli Dei e fu
Enki a trovare una soluzione. Creò un giovane di straordinaria bellezza,
Tammuz, da mandare a Ereskigal per sedurla e indurla al perdono nei confronti
della sorella.
Il piano sembra che sia fallito (il testo è privo in
alcune parti) perchè la signora dell’Irkalia, anche se inizialmente affascinata
dal bel giovane, iniziò a maledire Tammuz.
Alla fine però
concesse la grazia alla sorella
Istar ed ordinò al fedele Namtar di innaffiarla con l’acqua della vita.
La dea potè così ritornare nel mondo dei viventi,
rivestita dei suoi abiti e dei suoi gioielli.
In cambio della propria, e forse insperata salvezza, dovette
lasciare nell’Oltretomba Tammuz che era diventato nel frattempo suo amante.
Tammuz sarà destinato a fare ritorno sulla terra ogni
anno per un solo giorno, quello dei riti a lui consacrati.
Lo scrittore Paul Dhome
in un suo brano della “Discesa di Istar agli Inferi”...
Da quando la Signora
Istar era discesa nel Paese senza Ritorno,
il toro non si
appressava più alla giovenca, né l’asino all’asina,
l’uomo non si
accoppiava più alla donna incontrata sulla via,
questi si addormentava
nelle sue camere e la donna sul proprio giaciglio
Nell’epopea di Gilgames, sovrano di Kulabe e quinto re di
Uruk (intorno all’anno 2500 a.C.), venne menzionato Tammuz come amante di Istar.
Si tratta di un passo in cui Tammuz rimprovera la dea di avergli fatto delle
proposte amorose, che il giovane rifiutò, denunciandone gli aspetti lascivi e
devastanti come di “Grande Prostituta”..
Chi è il tuo amante che
Tu ami per sempre ?
Chi è il tuo eroe che
nell’avvenire ti sarà grato ?
Io rileverò le tue prostituzioni !
A Tammuz, l’amante
della tua giovinezza, anno per anno Tu hai
fissato la lamentazione
! Tu hai amato l’uccello Allalu e poi lo hai
colpito e gli hai
spezzato l’ala (...)
Tu hai amato il leone,
perfetto in vigore, e gli hai scavato
sette e sette fosse !
Tu hai amato il cavallo, fiero nella battaglia,
e gli hai destinato le
redini, il pungolo e la sferza.
Tu lo hai destinato a
galoppare per sette doppie ore !
Tu hai amato il
pastore, quel pastore che ogni giorno faceva salire a Te
il fumo del sacrificio,
che ogni giorno t’immolava capretti.
Tu l’hai colpito e
l’hai trasformato in leopardo !
E ora i suoi compagni
lo perseguitano e i suoi cani gli mordono la pelle !
Tu hai amato Isullani,
il giardiniere di tuo padre, che ogni giorno
faceva brillare la tua mensa. Tu levasti gli occhi
su di lui, andasti da lui
e gli dicesti: “Oh mio
Isullanu, oh pieno di forza, mangiamo, stendi la tua mano
e tocca le mie carni!”.
Ma Isullanu ti disse:
“Che vuoi da me ? Mia
Madre non ha cotto e io non ho mangiato.
Quello che io mangio
sono alimenti di vergogna e maledizione !”
E Tu, a sentire queste
parole, lo colpisti e lo trasformasti nell’animale tallalu"
La figura di Damuzi – Tammuz sarebbe nella cultura
fenicia quella di Adone dove “Adon” nelle lingue semitiche ha in significato di
“Signore”.
Inanna nella cultura fenicia diventerà Astarte.
Le solenni cerimonie rivolte ad Adone e Astarte, con i
relativi Misteri, trovarono un ampia diffusione nei territori dell’Impero
Romano e anche nella stessa città di
Roma. Quin la presenza di forti comunità orientali favorì la diffusione dei
culti nei confronti dei due dei ed anche per la diffusa pratica dell’Evocatio,
praticata dalle autorità imperiali, che favoriva la diffusione dei culti
stranieri sotto la protezione dello Stato.
Gli scavi archeologici hanno infatti confermato
l’esistenza di un importante Santuario di Astarte sul versante Nord del
Gianicolo presso il Lucus Furrinae. Un edificio costruito in età neroniana e
oggetto di vari rifacimenti sino al V secolo. Il santuario comprendeva anche
una piscina per l’allevamento di pesci che erano sacri alla dea.
Teocrito
(in greco antico: Θεόκριτος,
Theókritos; Siracusa, 315 a.C. – 260 a.C. circa) è stato un poeta siceliota,
inventore della poesia bucolica.
Il poeta siracusano Teocrito visità l’Egitto nel 273 a.C.
e in un suo idillio “Le siracusane o le donne alla festa di Adone” fornì una
chiara visione sullo svolgimento della festa in onore di Adone e di Astarte.
Una festa organizzata da Alessandria dalla regina del tempo, Arsinoe, moglie di
Tolomeo II.
Sotto un padiglione ad
alcova, su un tappeto di porpora, veniva collocato
un letto per i due
sposi divini. Tutto intorno venivano disposti in bell’ordine
preziosi doni della
natura, frutta matura, focacce, unguenti di Siria conservati
in vasetti di alabastro
e all’interno di canestri d’argento, zolle di terra fiorite,
i cosiddetti “Giardini
di Adone” in genere vasetti di terracotta contenenti
della terra che veniva
seminata con pianticelle di rapida crescita e
di breve durata, che si
disponevano attorno al simulacro di
Adone e che poi venivano gettati nelle acque del mare o del fiume
più vicino al termine
della festa.
Questo avveniva nel corso
della prima giornata della festa, chiamato il
“Giorno della Gioia” in
cui si celebrava l’imeneo della coppia.
La seconda giornata era
invece una giornata all’insegna del lutto.
All’alba, quando ancora
la rugiada bagnava il suolo, una processione di
fedeli e di iniziati
muoveva verso il mare, mentre le donne, con le chiome
sciolte e le vesti
discinte, si disperavano e piangevano la dipartita
di Adone, rivolgendogli
preghiere affinchè egli ritornasse propizio con
il
nuovo anno, riportando
la gioia”.
Qui finisce il racconto di Teocrito che non accenna al
rito di gettare le zolle fiorite in mare e citato in altre fonti. Non descrive
nemmeno il terzo giorno della festa che
era basato sulla rappresentazione della resurrezione di Adone che una figura
sacerdotale, detta Adoniaste, bagnata di acqua lustrale e coronato, si recava
ad incontrare il dio in un apposito edificio.
Molti testi greci e latini, molte commedie come la
“Lisistrata” di Aristofane, misero in evidenza la diffusione del culto di
Astarte che aveva in sé le simbologia di Atargatis, dell’antica e sumerica
Inanna.
Una diffusione del culto in tutto il bacino del
Mediterraneo quasi in contemporanea con l’ellenica Afrotide.
Erodoto sosteneva che il culto di Afrotide fosse
originario di Ascalona, una città posta sulla costa meridionale della Palestina
e da questa città i Ciprioti lo avevano importato.
Secondo Pausania sarebbero stati i Fenici, che adoravano
la divinità, a trasferire il suo culto a Citera.
Afrotite, in ogni caso, era già una figura attestata
nella sua forma “ellenica” già al tempo di Omero.
Infatti il poeta indicò l’origine del culto dal santuario
che fu dedicato alla dea a Pafos, sulla costa Sud-Ovest di Cipro.
La fondazione del santuario fu attestata dagli
archeologi nel XII secolo a.C. in
stretto legame co la dominazione micenea dell’isola circa un secolo dopo la
fondazione del tempio di Erice.
A pochi chilometri da Pafos, lungo la costa in direzione
di Limqassol, è ancora oggi visibile la “Roccia di Afrotide”, che fu chiamata
dai Ciprioti anche “Roccia dei Romani”.
Si dice che in determinate
condizioni atmosferiche, le onde si alzano, si infrangono e formano una colonna
d'acqua che si dissolve in una colonna di schiuma. Con l'immaginazione, questa
sembra momentaneamente una forma umana effimera ed evanescente. Altri miti
popolari raccontano che nuotare tre volte intorno alla roccia porterà varie
benedizioni, tra cui l'eterna giovinezza e bellezza, buona fortuna, fertilità e
vero amore.
È chiamata Roccia dei
Romani perché legata alle gesta di un eroe locale Basilio. Un eroe per metà
arabo e per metà bizantino che scagliò una grande roccia dal monte Trodos
contro i Saraceni che stavano per invadere l’isola.
Afrotide emerse dalle
acque e fu subito accolta, come abbiamo visto, dalle Horai, dalle Cariti, da Peitho (la persuasione), da
Photos (il desiderio) e da Himeros (la bramosia d’amore).
Ma se l’Afrotide greca e
anche la Venere latina, non furono, come
invece sostengono gli storici delle religioni, che trasposizioni e adattamenti
occidentali delle figure di Astarte, Atagartis e Inanna e delle loro relative
prerogative, come mai in età ellenistica e durante l’età imperiale le figure di
Astarte e Atagartis non furono messe in disparte e continuarono ad essere venerate nei loro luoghi di culto
da una gran moltitudine di gente ?
Le divinità continuarono
ad esistere anche con templi vicini sia di Afrotide/venere che di Astarte o
della De Syria ?
Un probabile
attaccamento all’antica tradizione religiosa degli antenati o un riflesso della
componente culturale orientale dei fedeli ?
È anche vero che in
epoca tardo-imperiale a Roma erano ancora presenti i Misteri di Adone ed
Astarte e prendevano parte alle relative cerimonie tutti i cittadini di
qualsiasi estrazione sociale o delle diverse etnie.
Il culto di Astarte e
della Dea Syria nel III secolo d.C. erano dei culti pienamente romanizzati e
quindi dei culti universali accessibili a chiunque si avvicinasse a prescindere
dalla propria origine etnica.
Le antiche classi sacerdotali di Astarte o di Atargatis mantennero sempre ben distinto
il culto di queste due divinità, evitando qualsiasi contaminazione, con
Afrotide/Venere.
Probabilmente conoscevano la vera storia di Afrotide e
sulla nascita della sua figura e del suo relativo culto.
In merito è veramente interessante la narrazione storica
dello storico Nicola Bizzi che affrontò il problema con grande senso critico.
Nella tradizione Misterica non è Afrotide ad essere nata dalla spuma
marina ma Dione.
Una dea titana che fu venerata dalla civiltà Minoica come
Akakal e per secoli come somma Dea Madre e Signora del Cielo, della Terra e del
Mare dai popoli pelasgici.
Tra il XV ed il XII secolo a.C. nel mondo mediterraneo e
nell’area dell’Egeo ci fu uno scontro religioso fra gli antichi popoli
pre-greci, con i testa gli eredi della civiltà Minoica che erano fedeli al
culto dei Titani e agli schemi sociali del matriarcato, e gli invasori che
progressivamente occuparono l’intera Grecia dei quali i Dori furono soltanto
gli ultimi arrivati. Popolo diversi tra loro ma avevano nella loro cultura uno
schema sociale patriarcale e il culto di Zeus e di quelle divinità conosciute
come “Olimpiche”. Divinità che finirono con lo spodestare i Titani ponendo fine
al loro Regno di Giustizia.
Questo scontro religioso diventò ben presto politico e
militare vedendo nella famosa guerra di Troia il suo apice.
Questi popoli invasori man mano che consolidarono il loro
potere e la loro presenza nel territorio, con la fondazione dei primi regni “Micenei”, le classi sacerdotali,
vere personaggi di potere, iniziarono
una serie di riforme religiose che avevano l’obiettivo di affermare il primato
del loro dio principale (Zeus) demolendo
la presenza del culto Titanico sul territorio.
Furono condotte delle abili azioni di sostituzione che
nel giro di un paio di secoli riuscirono a trovare una accettazione del nuovo credo nella mentalità popolare.
Quasi ovunque l’ingombrante figure del dio Titano
primario (Knos o Kreios) venne sostituita da quella di Zeus.
Anche buona parte delle dee Titane furono sostituite
dalla creazioni di miti ben studiati che facevano delle nuove dee “amanti,
mogli, figlie” dello stesso Zeus o di suoi compagni della cerchia degli
Olimpici.
La sostituzione fu anche architettonica. Il tempio o santuario di un Dio Titano o di
una Titanide se non era abbattuto veniva nella sua gerarchia sacerdotale
sostituito con nuove sacerdoti che naturalmente vi inserivano le nuove divinità
Uno degli esempi
fu relativo al tempio di Delfi con il nuovo dio Apollo.
A Dodona dove si trovava il più antico santuario
Oracolare della Grecia, la figura di Zeus venne inizialmente imposta al fianco
di quella della dea Titana primaria Dona
che diventò sua moglie. Alla fine in epoca classica la figura di Zeus nel
santuario diventò primaria tanto che lo stesso tempio era chiamato come
“Santuario dello Zeus di Dodona”.
Ma la sostituzione della figura di Dione non fu semplice
sia per il suo grande significato di “Grande Madre” e di “Madre Terra” che per
il suo culto che era molto diffuso nel mondo popolare che era contrario al
nuovo ordine zeutico.
Si rese necessaria la creazione di una nuova figura che
riuscisse a sostituire Dione.
Venne cos’ stabilito, dopo la guerra di Troia, di darle
una figlia che fino a quel momento era inesistente nei miti della divinità.
Una nuova divinità che doveva assumere la natura
,compresa la sua origine dalla spuma del mare), le caratteristiche e gli emblemi fondamentali anche se in
maniera meno forte per essere la figura
più facilmente gestibile.
Una figura quindi che con il tempo doveva sostituire
totalmente la figura di Dione facendola sparire dal culto popolare.
I sacerdoti non riuscirono a trovare tra gli dei olimpici
una figura femminile all’altezza del ruolo e le classi sacerdotali avrebbero
fatto ricorso ad una figura mortale, una certa Afrotide.
Alcune fonti misteriche riferirono di Afrotide come
sacerdotessa di Dione, originaria della regione anatolica della Frigia
-
I Frigi presero parte
alla guerra di Troia come alleati dei Troiani e la giovane sacerdotessa
rimase uccisa per mano degli Achei proprio durante il conflitto.
La giovane donna divenne, a livello locale, oggetto di
una forte divinizzazione secondo un antica tradizione che riguardava gli Eroi e
le Eroine soprattutto se in possesso di un incarico sacerdotale che cadevano in
battaglia.
Omero, tanto nell’Iliade come nell’Odissea, lanciò in
modo quasi celato il messaggio su questa sacerdotessa senza però mai svelare la
verità.
Nell’Iliade di Omero
Nell’Inno Omerico di Afrotide la Dea emerge nuda alle
acque del mare e viene accolta dalle Horai che l’abbigliano con sontuose vesti.
Ai tempi di Omero la nuova azione politica-religiosa aveva già radicato con i
primi effetti.
Nell’Iliade Afrotide appare già come figlia di Zeus e di
Dione ma c’è una piccola contraddizione.
Afrotide difende i Troiani ed è madre dell’eroe Enea
avuto dal marito troiano Anchise.
Sempre nell’Iliade, nel terzo libro, salva Paride quando
sta per essere ucciso da Menelao.
In questa vicenda la dea è apertamente schierata con i
Troiani e rifiuta , con questa posizione, la paternità di Zeus. Il motivo ?
Gli dei Titani furono per eccellenza i sostenitori dei
Troiani rappresentando Taura dei Teucri
uno degli ultimi baluardi del loro antico ordine (il popolo Tropiano secondo
un’antica versione sarebbe indicato come discendente dal mitico Teucro)..
Nell’Iliade interviene per salvare suo figlio Enea che,
ferito, rischia di restare ucciso nello scontro e cerca di coprirlo con il suo
peplo sgargiante.
Viene vista da Diomede che le scaglia contro una lancia
ferendola gravemente al polso. Un avvenimento che potrebbe alludere ad un
origine umana piuttosto che divina.
Per questo motivo venne richiamata all’ordine da Zeus che
la rimprovera di occuparsi di fatti guerreschi anziché di situazioni riguardanti
Amabili questioni
d’amore
che sarebbero di sua competenza.
La disperata Afrotide, sempre secondo la narrazione
omerica, lascia Enea alle cure di Apollo e si reca sull’Olimpo dove si getta
piangente ai piedi della madre Dione.
Al vederla in quello stato, la madre domanda la causa del
suo dolore, dando per scontato che solo un immortale avrebbe potuto procurarle
quella ferita al polso.
Afrotide le svela in contrario, confermando la sua
possibile origine non divina.
Nell’Odissea
Anche nell’Odissea Afrotide apparenelle vesti di Dea
dell’amore ma qui Omero la rappresenta come moglie del dio Efesto e nello
stesso momento anche amante di Ares (un dio in origine tracio della vegetazione
e successivamente collocato nella religione degli dei d’Olimpo, come figlio di
Zeus e di Hera, nella nuova simbologia legata agli aspetti più violenti della
guerra e della lotta intesa come sete di sangue. Omero infatti riferì che fu
proprio in Tracia che Ares decise di ritirarsi dopo essere stato sorpreso
mentre si univa ad Afrotide.
.. così dormì il molto paziente Ulisse
lì, nel letto traforato sotto il portico risonante.
E Alcinoo si mise a letto nel vano più interno
dell’alta casa
e accanto la moglie regina che gli preparò il letto e
le coltri.
La regina Arete, moglie del re Alcinoo, ordina alle
ancelle di preparare il letto per l’ospite Ulisse. Un ordine dato alle
ancelle in termini comparabili con un
analogo comando dato da Elena.
Le ancelle avvisano lo straniero che il letto è pronto ed
Omero evidenzia il piacere che in Ulisse
provoca l’idea di andare subito a dormire. A questo proposito usa un
espressione che poi viene usata per Afrotide, quando disse di “sì” al suo amante Ares e s’avviò anche lei sul
letto, per dormire, ma non immediatamente.
La scelta venne pianificata nel XII secolo a.C.
nell’isola di Cipro dove nello stesso secolo sorse il tempio di Pafos e si
consolidò il mito della nascita della dea.
Nell’isola di Cipro, per la sua vicinanza geografica alle
coste dell’Anatolia e con quelle dell’area siro – cananea , erano conosciute le
figure di Astarte e di Atargatis.
Si decise cos’ la nascita di Afrotide attribuendogli la
genealogia, le caratteristiche e gli epiteti di Dione oltre a quelli della
“Grande Prostituta” Akagartis/Astarte/Istar/Inanna.
La scelta di una divinità orientale estranea al mondo
ellenico e pre-ellenico, estranea alla cultura greca, si rilevò vincente.
Venne quindi creata una nuova divinità sfruttando il
ricordo di un eroina umana, sacerdotessa morta nella causa troiana
Afrotide presente
quindi le caratteristiche di dea Titana primaria e di Divinità orientale le cui
radici vanno ricercate nell’antica Mesopotamia.
Esiodo nella sua teogonia narrò la nascita di Afrotide
secondo un modello culturale affermato e consolidato da tempo nella memoria popolare.
Un Afrotide anche con attributi funerari e con l’epiteto
di “Pasifaessa” cioè di “colei che splende ovunque”, che ha in comune con la
Regina degli Inferi, e convolta in un mondo religioso di incantesimi, di malie,
di filtri amorosi, tutte espressioni tipici di una certa religiosità popolare-
Questi aspetti rendono Afrotide una divinità ambigua,
imprevedibile, capace di infondere la sua benevolenza ma anche di arrecare
disgrazie e sventure. Infatti un altro suo epiteto era quello di Doloplokos (“tessitrice d’inganni”) e di
Epitymbidia (“colei che sta sulle tombe”).
Assimilata dai Latini a Venere (Venus), la dea italica
della bellezza, dell’amore e della fecondità.
Ila cui origine e il significato del nome è ancora incerto, assume nella
tradizione religiosa romana una grandissima importanza anche “politica”.
E’ infatti madre dell’eroe troiano Enea e di conseguenza
della Gens Julia.
Virgilio, nell’Eneide, si accorda alla tradizione omerica
chiamandola con l’appellativo di “dionea” allo stesso modo di Ovidio.
Igino nelle sue “Fabulae” narra della nascita di Afrotide non secondo l’antica versione
ellenica ma in una interessante versione orientale frutto di una contaminazione
del mito greco della nascita di Afrotide con quello della dea Atargatis, nata
da un uovo caduto dal cielo nel fiume Eufrate.
Si narra che i pesci si
riversarono sulle sponde, mentre delle colombe si posarono
sull’uovo e,
scaldatolo, si aprì portando alla luce Venere, in seguito chiamata
Dea Syria. A quella
Dea, poiché superò gli altri Numi in giustizia e probità, da
Giove fu data la
facoltà che i pesci fossero trasformati in astri. Per questo
motivo i Siri
considerano i pesci e le colombe nel novero degli Dei e non se ne cibano
Atargatis, come rilevò Marciano, era una divinità dell’umidità
fertilizzante, corrispondente alla Inanna sumerica e alla istar babilonese, non
si consce il nome originaria di questa dea ma i filologi citarono come il nome
originario fosse quello di “Ata Divina” collegata alle grandi Istar e Astarte. Nel
“Dizionario delle Dee e delle Eroine” di Patricia Monaghan:
Poi si assicurò l’eterna fedeltà del giovane rendendolo invisibile. Dopo aver portato la figlia nelle foreste dove fu nutrita ed accudita da colombe, Atagartis si gettò in un lago e divenne un pesce... in onore suo e di sua figlia, i Siriani non vollero più mangiare colombi e pescare. Questa la forma base della sua leggenda, ma ve ne erano delle varianti: quello di Dea della vegetazione, quella di Dea del cielo, con la testa cinta di un velo di nubi e circondata da aquile, quella infine di Dea del mare, coronata da delfini.
I suoi Santuari contenevano tranquilli laghetti pieni di pesci, circondati da alberi sacri su cui i colombi si appollaiavano. Durante l’epoca romana, Akagartis era venerata con danze estatiche da sacerdoti eunuchi. Atagartis è una figura paragonabile ad Ishtar e a Cibele”.
(Le colombe, simbolo di fecondità, era sacre sia alla
Afrotide ellenica che alla Venere latina). Afrotide assunse
nel culto e nella tradizione letteraria l’aspetto di divinità dell’amore inteso “come attrazione delle varie parti dell’universo tra di loro, simboleggiando
nello stesso tempo l’istinto naturale di fecondazione e di generazione”.Anche sotto questi aspetti fu da molti assimilata alla
Istar babilonese , all’Astarte fenicia e alla Inanna sumerica.Il filosofo romano del I secolo d.C. Lucio Anneo Cornuto,
nel suo “Compendio di Teologia Greca”, scriveva in merito di Afrotide:
è verosimile che anche
di Afrotide si tramandi che sia nata nel mare
per nessun altro motivo
se non per questo: affinchè tutto venga all’essere, c’è
bisogno di movimento e
di umidità. Entrambi presenti nel mare in abbondanza....
Afrotide, per altro, è
la potenza che conduce insieme il maschile e il femminile:
forse ha assunto tale
denominazione in virtù del fatto che i semi generatori
degli animali sono
spumosi (aphrode)........
E’ presentata come
bellissima, poiché agli uomini risulta gradito in
massima misura il piacere relativo al congiungimento
come eccellente
al di sopra di tutti
gli altri, ed è chiamata per questo anche amante del
sorriso
(philomeides),,,,,, La fascia ricamata,
poi, è come adorna,
trapunta e variegata, e ha il potere di legare e
serrare insieme. È
chiamata inoltre sia celeste (Ourania), sia terrena
(Pàndemos), sia marina
(Pontia), poiché la sua potenza si osserva
sia in cielo sia in
terra sia in mare”.
I tre epiteti “Ourania,
Pandemos e Pontia” erano riferiti anche a Dione che dagli antichi popoli
pelagici era considerata la Signora del Cielo, della Terra e del Mare.
Era difficile
cancellare una simile figura con queste prerogative dalla cultura
popolare ed è per questo che gli attributi furono trasferiti in blocco alla
figlia Afrotide.
..............................
1. Asclepio, il dio della medicina – Le sue figlie tutelari della salute;
FEDERICO II DI SVEVIA
Eleonora Alvarez de Toledo e i suoi tempi
Un periodo ricco di manifestazioni di altissima cultura ma anche di gravi atti nei confronti delle donne ..La morte di Maria de' Medici, Isabella de' Medici, Leonor Alvarez de Toledo, ecc. - Enciclopedia Delle Donne - VIII Parte
Indice:
1. Eleonora di Toledo;
8. Francesco I de’ Medici;
21. L’uxoricidio di Leonora;
22. Isabella dopo la morte di Leonora – La morte di Isabella ? – Fu uccisa dal marito ? – Le ricerche - Due dei tanti delitti “d’onore” del tempo ?
.............................
Damarete di Agrigento (VI secolo a.C.) - La prima donna della storia a protezione dell'Infanzia - Enciclopedia delle Donne (IX parte).
----------------------
1. Eleonora di Toledo;
8. Francesco I de’ Medici;
21. L’uxoricidio di Leonora;
22. Isabella dopo la morte di Leonora – La morte di Isabella ? – Fu uccisa dal marito ? – Le ricerche - Due dei tanti delitti “d’onore” del tempo ?





















































































































































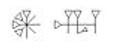







































Commenti
Posta un commento