L'impronta di quella che si crede essere la mano della sfortunata
baronessa di Carini (Foto: tuttomisteri.it)Se la sepoltura della baronessa di Carini si trovasse nelle cripte della Chiesa Madre ?
24 Luglio 2017 di Giuseppe ScavoDal diario di viaggio dei due compari alla scoperta
storico-archeologica del territorio di Carini. Alla costante ricerca della
sepoltura di Laura Lanza, baronessa di Carini. di Ciccio Randazzo Correva l'anno 1997, tempo in cui un nutrito numero di
giovani e meno giovani carinesi, cultori delle bellezze naturali,
architettoniche, artistiche e soprattutto archeologiche del loro territorio, si
erano uniti sotto le insegne della nota Associazione archeologica nazionale
denominata Archeoclub d'Italia. Le loro iniziative di ricerca e conoscenza, di
salvaguardia e custodia, di valorizzazione e comunicazione sviluppate
attraverso mostre, convegni mensili e riunioni settimanali venivano molto
seguite ed apprezzate dalla comunità locale e non solo. Tanti gli obiettivi
prefissati e raggiunti come la riscoperta delle Catacombe paleocristiane di
Villagrazia di Carini; i saggi archeologici al Castello ed in contrada Santo
Nicola; la mostra fotografica del territorio denominata 'Sui sentieri dei
nostri avi"; il progetto 'Salva la Tela' ideato e realizzato per la
salvaguardia di diverse opere pittoriche antiche della Chiesa del Carmelo di
Carini; il recupero delle maioliche del campanile del Castello; il supporto alla
proposta di acquisto di un terreno nella stessa contrada Santo Nicola. ora in
fase di esplorazione archeologica come da progetto. Sono alcune delle tante
iniziative che il club aveva attuato in quegli anni 1997/2000. Questa breve
premessa, per ribadire il fermento culturale e sociale positivo di quei tempi,
quando nessuno poteva immaginare come sarebbe finita nella precarietà la
situazione sociale ed economica locale, nazionale e internazionale. E non solo,
ma anche per fare memoria, dal momento che il "dimenticare' é diventata
una moda voluta, utile soltanto a vanagloriare il 'nuovo che avanza. Sarebbe
auspicabile, invece, che nascesse quel senso di continuità con le esperienze
del passato, utile a migliorare il presente per proiettarsi nel futuro e poter
diventare un tassello da aggiungere a quel mosaico ormai indispensabile per
comporre la rinascita della nostra collettività. Tra le iniziative perseguite dal club c'era e rimane
quella dell'approfondimento storico dell'amaru casu della Baronessa di Carini.
Ci si interessava e ancora continua l'interesse alla storiografia e al
riscontro scientifico che uno studio di ricerca materiale delle sepolture del
casato La Grua, possa dare. Infatti, non è spiegabile che una nobile e
importante dinastia come quella dei La Grua-Talamanca. signoria a Carini dal
1397 non abbia visibile un mausoleo dentro qualche chiesa tra le tante e belle
che Carini possiede. Gli atti di morte descrivono seppellimenti del periodo
rinascimentale effettuati in Chiesa Madre, ma in verità la Chiesa Madre attuale
in quel periodo era ancora in costruzione. Da qui i dubbi nell'individuazione
della Matrice del tempo, nel senso che la chiesa di Santo Vito e la chiesa di
San Giuliano, dentro le mura, possono essere prese in debita considerazione in
quanto sono state anch'esse matrici dei tempi precedenti. Senza per questo
abbandonare le ricerche nell'attuale Chiesa Madre, come stanno continuando un
ristretto numero di studiosi locali ex-soci di Archeoclub. Occorre precisare
che. anche la chiesa del Carmine è interessata a questa ricerca, in quanto
sappiamo che la cripta è stata utilizzata come mausoleo della famiglia La Grua,
prevalentemente dal 1622, periodo del principato. La scoperta delle tombe La
Grua, avrebbero una grande valenza storico-monumentale, per un ritorno
turistico importante come queste realtà sanno promuovere. Pensate a quanta
gente verrebbe a visitare la tomba della Baronessa. Tomba. purtroppo non ancora
trovata come sappiamo e che gli studi. i documenti di seppellimento e il poemetto
che è cronaca in rime, confermano essere a Carini e non altrove, come qualche
notizia infondata vuole collocarla a Palermo. E proprio per questa necessità di trovare la sepoltura di
Laura Lanza che nel 1998 alcuni soci di Archeoclub venendo a conoscenza che dal
mese di aprile sarebbero cominciati i lavori per la sostituzione del vecchio
pavimento della Chiesa Madre attuale, (opera voluta dall'indimenticabile
arciprete Mons. Vincenzo Badalamenti), si adoperarono per saperne di più.
Migliore occasione non poteva presentarsi dunque, affinché si potessero
esplorare le cripte sottostanti della Matrice. Si chiese permesso al sempre disponibile Arciprete
ottenendolo sotto accordo tra le parti, che non si dovevano fermare i lavori. “Mi raccomando!» ribadi il caro sacerdote con il suo fare
deciso e personalissimo. «Un facemu nca nni 'mpirugghiamu i pedi? La Chiesa si deve
pavimentare senza perdere tempo!». e rimase sempre a nostro fianco spinto
com'era dal suo essere appassionato conoscitore e scrittore delle storie della
sua amata Carini. Purtroppo, in verità, non si potè fare uno studio approfondito
in quanto tolti i mattoni vecchi niente era visibile come speravano, tranne
alcune feritoie dove insisteva qualche lacerazione piccola del pavimento.
Comunque, i soci di Archeoclub documentarono fotograficamente quello che fu
possibile scoprendo una fossa comune, un colatoio e poco altro. Niente a vista
di sarcofagi marmorei monumentali, come speravano. E pensare che in quel
periodo a Carini. Antonello Gagini, il più noto scultore di Sicilia, possedeva
proprietà e che comunque aveva lasciato segni della sua immensa arte. Un
ritrovamento interessante e particolare, pero, si scopri nella cripta della
Vergine, posta a sinistra dell'altare maggiore, nella quale due scheletri di
dimensioni diverse, presumibilmente appartenenti ad un uomo e ad una donna, si
mostrarono ai loro occhi increduli. Situazione che ricondusse il pensiero
ad una variante della storia di Laura e Ludovico, che vuole i due amanti
seppelliti assieme, pensiero supportato in parte dalle rime del poemetto che
recita: «...e si nun cridi a
mia, bella figura. vattinni a la Matrici a la Biata, spinci la ciappa di la
sipultura, ddà la trovi di vermi arrusicata...». Per questo sarebbe auspicabile un approfondimento con uno
studio del DNA degli scheletri per verificarne appartenenze ed età, magari chiedendo
aiuto economico ad uno o più sponsor. Il non trovare le tombe La Grua fino
ad oggi, rimane certamente una stranezza, ma resta lo stimolo per cercare
ancora sia nelle cripte della Matrice attuale, sia altrove. E c'è chi ancora
ricerca.
Sepoltura ed atto di morte di Laura La Grua,
Baronessa di Carini 8 settembre 2020 Ricerca condotta da: Ciccio Randazzo, Vito Badalamenti, Vincenzo
Carcioppolo, Filomena Alimento, Cenzi Funaro, Gabriele Arezzo di Trafiletti,
Susanna Sportaro, Maria Scalisi e Sandy Di Natale. A di 4 di vij
indizione 1563 fu morta la spettabili signura Laira La Grua Sepellosi alla Matri
Ecclesia Eodem fu mortu
Ludovico Vernagalli Questo
e il documento ufficiale, estrapolato dai registri di morte, nei quali venivano
appunto annotati i nomi dei defunti di Carini e la collocazione delle loro
sepolture, un vero tesoro di dettagli e informazioni che ci ha condotto su una
strada mai esplorata prima. I registri ci dicono con chiarezza che 'la signura
Laura La Grua* fu sepolta a Carini, presumibilmente insieme allo sfortunato
amante: 'Eodem fu morto
Ludovico Vernagalli' L'Eodem
sta appunto per 'lo stesso' ossia, stesso giorno, stesso luogo che e, senza
ombra di dubbio, la città di Carini. Un atto di morte va considerato a tutti
gli effetti un documento ufficiale, pertanto, il semplice fatto che sia stato
redatto da mano umana e non frutto di ipotesi fantastiche, sfata il mito che
vedrebbe la baronessa Laura La Grua sepolta nella chiesa di Santa Cita a
Palermo, cosa che in molti continuano ad affermare. Chiarito il fatto che fu
sepolta nella città di Carini, come gruppo di ricerca, ci siamo interrogati su
dove potessero essere stati inumati i suoi resti. La prima cosa da stabilire
era appunto quale fosse la “Matri Ecclesia” all'epoca dei fatti. L'accurato
esame degli atti di morte, dal 1535 al 1640 circa, e di alcune visite
pastorali, in particolare quelle del 1573 e 1578 redatte ad opera del Vescovo
Antonio Lombardo, ci ha infine condotto a una incontrovertibile verità: la
Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, ex Santa Maria De Careni,
presumibilmente ex San Giuliano, (l'analisi architettonica della chiesa é
ancora in corso) fu la prima chiesa entro le mura della terra vecchia e Matri
ecclesia col sub titolo di 'Santa Maria L'Assunzione Di Madre Donna' almeno fino
al 1638. Fu
sostituita nella sua funzione di Matrice, dalla costruenda chiesa Maggiore che
riporterà il sub titolo della prima Matti ecclesia, trasformandolo in 'Assunzione
della Gloriosa e Sempre Vergine Maria” oggi, “Maria Santissima Assunta
". Lo studio di approfondimento è partito da Vito Badalamenti,
coadiuvato dall'intero gruppo di ricerca, per avvalorare quella che
inizialmente era un'ipotesi del responsabile della ricerca, Ciccio Randazzo e
che ad oggi può invece definirsi tesi. Ulteriormente avvalorata da un proseguo
di questa ricerca sempre più appassionante che vede Laura La Grua sepolta a
Carini, nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la tesi si arricchisce
di nuovi dettagli. Nel diario del 1590 di
Valerio Rosso, 'filosofo et dottore in medicina'(rif pag.192/89) vengono
riportati alcuni epitaffi del convento di Santa Cita. Tra questi, uno rapisce
la nostra attenzione e ve lo mostriamo sinteticamente:
Epitafia
lllorum
qui sepulti suit in conventu Sancta Cita.
(di
coloro che furono sepolti nel convento di Sancta Cita.).
Epitafium
Lucrezia Lancea
Stemmata
ea ci tara (o ea cifra) micans Lucrezia saxo Lancea unitum gloria rara iacet.
09 Marzo1546'
(Lucrezia,
risplendente di quella cifra (O quella figura) con la sua lancia di pietra,
giace unita in rara gloria. 09 marzo 1546')
L'iscrizione
ci dice con chiarezza che Lucrezia Lanza Gaetani, è sepolta in Santa Cita. Con
l'aiuto di Filomena Alimento, dottoranda in Scienze e Tecniche Psicologiche,
abbiamo tentato una libera traduzione, tenendo conto di alcuni tratti quasi
illeggibili: 'Lucrezia giace al
di sotto dello splendido sepolcro dei Lanza unita a loro nella rara gloria' Dunque
nella tomba anonima, erroneamente attribuita a Laura La Grua, potrebbe in
realtà giacere la madre di Laura. Se cosi tosse, dovè oggi l'epitaffio che lo
proverebbe? Bene, ora provate a seguirci..Riguardo ai Lanza di Trabia, Dott.
Valerio Rosso riportò solo gli epitaffi di Lucrezia Lanza Gaetani e Blasco
Lanza, il cui sepolcro è posto oggi sulla tomba anonima. Il barone Blasco Lanza
aveva commissionato al Gagini la cripta di famiglia nel 1524. Dopo il restauro
di Santa Cita, tuttavia, della prima cripta dei Lanza si salvò ben poco, se si
esclude il sepolcro di Blasco che oggi nasconde, presumibilmente, l’epitaffio
della misteriosa donna scolpita sul simulacro. A
rafforzare questa ipotesi c'è un diario del diciassettesimo secolo (iscrizioni
Sepolcrali"rif pag 115) di Manganante Onofrio, che annovera tra i defunti
della nuova cripta Lanza: Cesare Lanza, Castellana Centelles, Blasco Lanza,
Ottavio Lanza, la moglie, Donna Giovanna Ortega di Gioeni e il sepolcro anonimo.
Ma non fa parola né di Laura La Grua, né Di Lucrezia Lanza Gaetani che però
figura nel diario dì Valerio Rosso. Un ragionamento fatto sulla base di questi
indizi potrebbe dunque svelare, in via ipotetica, l'anonimato della tomba
attribuita alla Baronessa Laura La Grua. ll Valerio Rosso potrebbe aver
visitato la vecchia cripta prima del 1574 e aver trovato solo gli epitaffi di
Blasco e Lucrezia poiché i defunti, che il Manganante aveva annoverato nella
nuova cripta, edificata nel 1614 per commissione di Ottavio Lanza, all'epoca
dei fatti erano ancora in vita. Mentre
Laura La Grua, essendo morta e sepolta a Carini già da molti anni, non poteva
in alcun modo trovarsi nella cripta dei Lanza, tenendo anche conto di una
mentalità androcentrica che vedeva nel suo presunto tradimento, non un atto
d'amore bensì il disonore di un illustre casato. Potremmo ipotizzare
all'infinito. Resta il fatto che sia nel primo che nel secondo diario, il nome
di Laura La Grua non viene mai menzionato nell'elenco dei defunti mentre quello
della madre Lucrezia compare tra gli epitaffi in Santa Cita. Se non bastasse,
in un terzo diario del diciottesimo secolo di Emanuele Francesco Maria Gaetani,
('Notizie di Sicilia" rif pag 162) il Marchese di Villabianca scrive
testualmente: 'Sotto al suddetto cui altro tumulo con una figura di donna steva
adi sopra a sua iscrizione che non si può leggere per esserci un gran sipolcro
che l'occupa". Questa potrebbe essere la prova definitiva di quanto detto
sopra. L'epitaffio di Lucrezia Lanza Gaetani, madre di Laura, é oggi coperto
dal sepolcro di Blasco Lanza: 'Lucrezia giace al
di sotto dello splendido sepolcro dei Lanza' . Essendo
un rampollo dei Gaetani il Marchese di Villabianca poteva presumibilmente
essere a conoscenza della presenza di un suo avo nella cripta Lanza e di
conseguenza avere l'interesse a riportare questa notizia. Le ipotesi devono
essere supportate comunque da fatti oggettivi, che solo i documenti ufficiali
possono attestare con certezza. Per questa ragione siamo ancora in fase di
approfondimento riguardo alla simbologia araldica, che con l'ausilio di Aurelio
Grasso, potrebbe svelare l'arcano definitivamente. Rintracciamo infatti nella
parte destra dello stemma, inciso nell'anonimo sepolcro, la presenza di un
leone e una palma, probabile implicazione di Lanza e Tagliavia.
Nella
lettura araldica, la parte alta é riservata al suocero della defunta, in questo
caso Lanza, in basso a destra, tradizionalmente è collocata invece la suocera,
Tagliavia o Tornambene, comunque imparentati. Blasco Lanza e Laurea Tornambene
potrebbero dunque essere i suoceri dell'anonima defunta, cosa che rafforzerebbe
l'ipotesi che dentro al simulacro ci siano le spoglie di Lucrezia Lanza
Gaetani. Fino a quando non avremo concluso il nostro percorso di
approfondimento, non ci sentiamo di escludere altre strade, compresa quella che
porta a Laurea Tornambene, moglie di Blasco Lanza. Chiunque può formulare
ipotesi, fondendo l'empirico testabile all'immaginario suggestivo, non per
questo ha il diritto di venderle come verità storiche. Storici, appassionati
ricercatori e cantastorie, da sempre narrano di questo efferato delitto e
dell'implicazione romantica che vide Donna Laura adultera pertanto indegna
della sepoltura che le spettava per rango. Vilipesa anche nella morte, fu
probabilmente gettata in una fossa comune, come si evince da alcuni versi: E si nun mi cridi
a la matrici vai, dintre lu zubbiu, dda, la truvirai: chine di vermi la gula
sciacquata dunni luceva la ricca ciannaca: nido di surci la so' capiddera ca
d'oro e perni cuncignata era: e rusicata li so' nichi manu, sfunnatu rocchiu
gazzu, juculanu. Deturpata
da un precoce processo diagenetico e in fine traslata per pietà in chiesa
Madre, come scrisse Giuseppe Maria Abbate, ('Carini Nella Storia Di
Sicilia" rif pag 759) probabilmente, secondo le visite pastorali di
Antonio Lombardo, ad opera della Compagnia di Gesù, viene nascosta agli occhi
del mondo per eliminare l'onta della vergogna caduta inesorabilmente sui Lanza
Di Trabia.
 Donna
Laura e il Vernagallo furono quindi probabilmente sepolti, senza funerale e nottempo,
nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Una
chiesa che era distante circa 59 m dal castello e raggiungibile in appena 1
minuto.
UN DOCUMENTO
INEDITO DI LUDOVICO VERNAGALLO ATTESTA LA SUA PRESENZA A MONTELEPRE:
È QUI CHE
AVVENIVANO GLI INCONTRI SEGRETI CON
LA BARONESSA DI
CARINI? Lo
storico e ricercatore Dott. Giovanni Filingeri, nelle sue ricerche sul castello
di Montelepre, trovo nel 2019(?) nell’Archivio Storico di Palermo un documento,
di tre pagine, che attesta la presenza di Ludovico Verganallo proprio a
Montelepre.
Si
tratta finora dell'unica testimonianza archivistica su uno dei principali
protagonisti del tragico “caso” della Baronessa di Carini. Un testo
interessante che potrebbe aprire nuovi scenari sul “caso”, così come l'abbiamo
appreso. È un contratto di vendita di legname risalente
al 1559 i cui contraenti sono il Vernagallo e altri quattro carbonai di Carini. Dalla
lettura del manoscritto emerge con chiarezza che il diritto del legnatico degli
acquirenti si racchiudeva tra due “molette” e le contrade Passo Carrozza, Acqua
Alvani, San Bartololomeo (oggi S. Bartolo) e il passo che si va alla turrj
(Ventimiglia), tutte località nel territorio di Montelepre. Ma
non è l'unico riferimento a Montelepre contenuto nel testo: il contratto
sarebbe stato scritto nelle sale della torre Ventimiglia il 20 gennaio del
1559, lasciando presumere che l'antica fortificazione (donjon edificato nel
1433-34) sia stata la residenza abituale del Vernagallo. Tra
le pagine risulta inserito un biglietto vergato e sottoscritto sempre dal
Ludovico ed indirizzato al notaio, nel quale si fa riferimento ad una minuta
notarile difforme dalle intenzioni contrattuali manifestate dal mandatario; ciò
spinge l’avvenente giovane a redigere, con difficoltà, il citato atto, non
senza imponendo al notaio che: "…me rimanderete questa forma
per non havere unaltra volta a rompermi la testa a metterla in carta che, per
non esser offizio mio, ci timpestai un pezzo." «Dal
punto di vista storico si tratta di un documento di straordinaria importanza
perché è l'unico testo, finora rinvenuto, vergato di proprio pugno da Ludovico
Vernagallo e inviato al notaio per la sua registrazione” spiega Giovanni
Filingeri, che ne ha mostrato una copia al pubblico, ieri sera, per la prima
volta, nel corso dell'iniziativa culturale dedicata alla Torre Ventimiglia,
organizzata dall'associazione “BC Sicilia”, con il patrocinio del Comune di
Montelepre. "La
lettura dell’atto - ha proseguito Filingeri - è la conferma che Ludovico
Vernagallo, figlio di Alvaro, ha vissuto a Montelepre, un elemento di cui
finora non si era trovata alcuna traccia, e che collaborava col padre Alvaro
nella gestione delle risorse economiche del feudo di Munchilebi." "Dallo
studio del documento - conclude lo storico - potrebbero emergere altri
particolari interessanti con il ricorso alla grafologia, la tecnica che
consente di dedurre presuntivamente alcune caratteristiche psicologiche di un
individuo attraverso l’analisi della sua grafia; anche se è un campo che
richiede molta cautela, resta un tentativo fantasioso, di certo affascinante,
per delineare alcuni tratti distintivi della personalità di Ludovico Vernagallo,
uno dei protagonisti dell’efferato caso, di cui si conosce bene poco." Il
nuovo documento apre dunque la strada ad una altra ipotesi del tutto nuova fino
ad adesso: ovvero che Ludovico e Laura Lanza per coltivare la loro relazione
adultera potrebbero essersi incontrati più volte a Montelepre, nei saloni della
torre dislocata a tre miglia da Belvedere di Carini, residenza estiva del
casato La Grua. La
ricerca ancora continua e ci aspettiamo nuovi sviluppi su uno dei casi più noti
di “femminicidio” avvenuto nel 1563, che conserva tutt’oggi la sua drammatica
attualità.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=2281767642136965&set=pcb.2281767658803630 The
etc.
Io
Lodpvico Vcrnagallo o/ venduta ad simonj grasscllinj, grigorj gincmi, ct
vincenso de patti, joanni lixandrillo quilla lignamj chi est in quilli duj
moletti de terra chi sonno in menzo delli infrascripti seminati ecceptuati per
li albori de li olivi, li imiti, li ogliastri, li carobbi, li mendoli e Ij
pirayni chi ince seranno da insitarsi lontano trenta palmi l'uno da l'altro, et
quilli troffi di ogliastri, charobbi, pirayenj ct mendolj chi saranno più folti
de li supradetti trenta palmi digiano xiparli subta ct supra in modo che non
gettano più vid[elicet]: in mcnzo lo siminato allo piano del margio calando lavinaro
lavinaro undi est la calcara et arrivando allo siminato delo pezzo della carroza
rt achianando alla trista trista alo siminato de Jacobo Bivilaqua caronisi undi
est lo lino supra dillo n.ro lino
tirando suso ali olivi gaitanj ct nexcndo poi alo taglio dclo siminato
di Stefano Guastanclia giungendo allo passo chi va allaqua de li alvanj et tira
alo taglio de li siminati ca sonno sobto san Bartolomeo chi siminamo nuj de la
partj de subta verso ditti moletti ct nexcndo alli olivi chiamati li inclasto et
tirando lo taglio taglio de lo supra nominato siminato dello chiamo dello
margio fina alo passo che si va alla turrj et incc lo fraxino dummodo chi
trasendo qualchi punta di siminato intra ditti duj moletn infrascripti loco
collo patto ince ti abiano ad farj lignamj pirchi non si intendi in ditta
vcnditione ct cxcepto quilli terri forti tantum chi sonno in le supraditti moletti ct quisto per lo prezio di unzi
quatto in dinari ct quattro carichi de carboni da pagarmeli omne misi una paga
intendendo primo in quilli misi atti ad farj disto scrvizio et quisto in lo
modo infrascripto vid[e licet]: di li supra ditti accataturi si obbgano in
solidum ad nettarmi tutta quella terra che si contenj in li sopra notati
moletti de ognj natura de lignarni li erbi blanchi croveeri camarronj et simili
troffi rovettj ct altra frascamj simili subta et supra in modo che non segnano
più chi se limano liberamente operarj da arato ditti torri senza impedimento
nixono ecceptuarj sempri li albori di li olivi li insiti li ogliastri da
insitarsi ad trenta palmi lontano lun dall'altro li charobbi mcndolj et
piraycnj li quali supra nominati arbori tanto domestici quanto da domesticarsi
si obligano ditti accaptaturi accettarli dc supra smargiarli ad tomo ad torno
ci struponigarli dc supta in modo chi non nochiano allarvoro, et per incherlj
poi della sua tetra dc quisto intra termino di quatordici misi da contarsi da
lo primo de febraro proximo da veniri innanzi da venivi ad
lo
primo de febraro prossimo da veniri innanzi da veniri at finiri per tutto marzo
dello anno 4 ind[izione] ct non havendo spedito in ditto tempo ditto servizio
come si obligano ditti accaptaturi zoc venditori poza liberamenti senza altra
licentia metteri hoc ad danno et interesse loro per farmi spediri dietto
servizio et sonno obligati ct pozali stringeri in beni et in persona/ Item che
tutti quilli rovctti frascami ct rimundatini chi loro non corrranno operari
siano tenuti abrugiarli in parti chi non nc fazano danno et facendo me danno
siano obligati cum danno et interessi in li beni et indi li personi loro/ item
chi li fossi dello carobnj chi ferrano lagiano ad fari ad parti chi non fazano
danno ct facendo me danni siano obligati
ut sopra et si declara per cos de supra si è detto chi siano obligati xipari
omne natura di lignamj rovetti frascami etc. ecceptuati sempre li albori di li
olivi ect. subta ct supra in modo chi non vegnano più di quisto non vegnano più
seu non tornano ad naxeri più non se intenda per li rovetti dunmmodo chi ipsi
accattatori poi chi hareranno tagliati ditti rovetti cu la runca li smargiano
scu xipano radicati: cum lo czapuni et quisto se declara per chi loro dicino
chi non obstanti, chi se xipano cu lo czapuni sempri torneranno ad gettarj et
in quisto se obligano ct promettino in solidum come è di supra/ ltem processi
de patto chi habiano de incomenzarsi lo servizio dundi piacera ad me in ditti
dui mioletti, pero ct sempre chi gira lo olivito caricato ad tempo chi casca la
oliva nullo patto pozano fari servizio ad paru chi me fazano danno ma se
remetti in arbitrio mio/ Il loco da disignarsi lo servizio chi hanno da fari et
contravenendo in questo siano obligati ad tutti danni et interesse e ut supra
permettendo ce farce vera et bona ditta lignamj; ct defendercela da omni
calunnianti persona. Egregio not. Vincentio Lo Vecchio perchee ho venduto come
di sopra havete visto la prenominata legnami ali sopradicti con li patti e
condizioni sopradetti pertanto mando a Gioffre Spina che contratti c prometti
de rato per me e si bisognerà ratificare passerò un giorno per loco e
ratificherò, voi vorrete stipularui per me e publicare e me ni farrette levar
subito la copia e mandarmela con detto Gioffre che lui paghera tutto e Dio di
mal mi guardi. Da la torre a di XX di gennaio nel 59. Me
rimanderete questa forma per non havcre unaltra volta a rompermi la testa a
metterla in carta che, per non esser offizio mio, ci tempestai un pezzo, 1559 Ad. Lodovico
Vernagalli
La
“Baronessa di Carini” nel Teatro e nel Cinema La
triste storia della Baronessa di Carini ebbe molto risalto tanto che ispirò
molti scrittori con poemetti e scritti storici.
Il medico e folclorista palermitano Salvatore Salomone Marino (1847 –
1916) cercò con i suoi scritti di togliere questa bellissima figura femminile
dal mondo della leggenda. Una storia
siciliana del Cinquecento .. Anche se era
patente… che si trattava di un falso ottocentesco. Giuseppe
Mulè (Termini Imerese – Pa, 28 giugno 1885 – Roma, 10 settembre 1951),
compositore e direttore d’orchestra, scrisse la tragedia di un atto (Nota n. 5) Baronessa di
Carini L’opera
fu rappresentata al Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo il 16 aprile
1912.
Giuseppe Mulè
La
storia fu poi ripresa per la televisione nel 1975 nello sceneggiato Rai L’amaro caso della
Baronessa di Carini Diretto da Daniele
D’Anza ed interpretato da Ugo Pagliai e
Janet Agren
https://www.youtube.com/watch?v=KYGGYshJWDM
https://www.youtube.com/watch?v=KYGGYshJWDM
Nel
2007 fu eseguita una nuova serie televisiva che venne tramessa da Rai 1: La Baronessa di
Carini Con la regia di
Umberto Marino e con gli attori: Vittoria Puccini e
Luca Argentero nelle parti dei protagonisti.
 https://www.raiplay.it/video/2016/11/La-Baronessa-di-Carini-E1-1f4ce590-bd1f-4b75-90a4-b89683db38ef.html

CACCIATORI
DI FANTASMI OFFICIAL GROUP - La Baronessa di Carini Un castello a
Carini, in Sicilia, dove si aggira ancora la figura di una donna infelice che
vaga tra nel dolore di un antico delitto. Storia breve sulla morte di Laura
Lanza e dell'impronta della sua mano insanguinata, che il 4 dicembre di ogni
anno affiora in modo ben visibile...
Il
Castello – Architettura Le
mura mediale sono databili all’XI – XII secolo. Degli elementi
arabo-normani sono evidenti nella
seconda porta del castello dove è presente un arco a sesto acuto.
In
alto si trova lo stemma della famiglia Abbate. I portali sono sormontati da
alcuni scudi che rappresentano la casa dei La Grua con la raffigurazione di una
gru.
L’attuale
aspetto fu quello datogli nel Cinquecento dalla famiglia La Grua Talamanca,
signori della città dal 1397, ma altri ritocchi e cambiamenti, gli ultimi,
furono fatti ancora nel Settecento
Gli
altri stemmi evidenziano tre zolle di terra,
stemma dei Chiaramonte, mentre nel piano superiore si trova lo stemma
dei Lanza-La Grua con la presenza di due leoni rampanti.
Piano terreno
Entrando
nel piano terreno vi è una stanza con volta a crociera che originariamente
era un muro esterno. Un altro vano, privo del pavimento, mostra
le fondazioni di strutture precedenti. Un grande salone è diviso da
due arcate a sesto acuto con colonna centrale.
Nel
lato est del castello si possono vedere: in un locale un lavatoio in pietra
di Billiemi; una cappella affrescata a trompe-l'œil, una statua in
marmo raffigurante la Madonna di Trapani.
La cappellaLa cappella
gentilizia
Nella
cappella si ammira un artistico tabernacolo ligneo del primo decennio
del Seicento con colonnine corinzie che scandiscono
prospettivamente lo spazio. Un matroneo in legno permetteva la vista
dal piano superiore.
Il
matroneo o tribuna era un balcone o un loggato posto all’interno dell’edificio
e destinato ad accogliere le donne che assistevano alla funzione
religiosa. Matroneo deriva infatti da
“matrona”. L’androne
interno ha sulla sinistra una scala quattrocentesca che conduce al Salone delle
Feste e alla stanza dell’omicidio.
Piano superiore Al
piano superiore, all'ingresso di quella che era
l'ala quattrocentesca del castello, troviamo un portale marmoreo
dove, tra due fenici rinascenti dalle fiamme, è scritto Et nova sint omnia (E tutto
sia rinnovato), che
è la continuazione di un'altra dicitura presente su un secondo portale marmoreo
sempre nel lato sud-ovest dove si legge Recedant Vetera (Sia
cancellato il passato), probabilmente
collocate quando l'edificio, sotto la direzione dell'architetto netino Matteo
Carnalivari, cambiò la sua destinazione d'uso trasformandosi da caserma a
dimora signorile (seconda metà del Quattrocento).
Il
soffitto ligneo del salone delle feste Salone delle feste Dalla
porta accanto si accede al salone delle feste, caratterizzato da un soffitto ligneo cassettonato con
elementi stalattitici tutti decorati con stemmi nobiliari, salmi
dedicati alla Madonna e didascalie allegoriche, tra le quali quella sull'asse
centrale: In medio consistit
virtus (Nel bel mezzo sta
la virtù) e
quelle sulle mensole laterali: Et in estremis
labora. Il
soffitto ligneo fu realizzato in concomitanza con i lavori di riammodernamento
fatti quando i La Grua Talamanca si imparentarono con la famiglia
Ajutamicristo, un esempio simile si conserva infatti presso il palazzo
palermitano della stessa casata, capolavoro
dell'architettura gotico-catalana in Sicilia. Dalla
porta laterale sinistra della sala si entra nella stanza cara
alla baronessa di Carini, dove, si narra, avvenissero i suoi presunti
incontri con Ludovico Vernagallo. Dalla
porta laterale sinistra della sala si entra nella stanza cara
alla baronessa di Carini, dove, si narra, avvenissero i suoi presunti
incontri con Ludovico Vernagallo.
Sui
muri della quale non c’è traccia dell’impronta della sua mano insanguinata,
come mostrava invece lo sceneggiato della RAI (e che tutti i turisti cercano,
avidamente curiosi del particolare macabro). Eppure una manina scolpita sta sul
coronamento di una delle torri, visibile solo da occhi attenti, dalle terrazze,
non si sa se firma dell’architetto che ristrutturò la fortezza o se invece
omaggio del medesimo a Donna Laura.
Le altre stanze Interessanti sono le stanze affrescate, come quella in cui si
trova la pittura murale ritraente Penelope ed Ulisse. Una scaletta
conduce alle cucine. Un vano, infine, merita attenzione perché si caratterizza
per le vele e i pennacchi terminanti in pietra di Billiemi di
stile gotico-catalano. Riguardo alle varie epigrafi presenti sugli ingressi, Gioacchino
Lanza affermo come essi vadano messi in relazione ad una rinascenza culturale,
sociale e artistica, precedente all’assassinio.
Vincenzo
Badalamenti appoggiò invece la tesi più suggestiva secondo la quale il barone
avrebbe rinnovato tutto perché non vi fosse più nulla che gli ricordasse la
moglie fedifraga. Il restauro però fu compiuto nel 1562, come inciso nello
stemma marmoreo dei La Grua e l’atto di morte della sfortunata donna Laura fu
del 4 dicembre 1563. Dalla stanza fatale si accede ai bastioni e alle torri, da
cui si può ammirare un bel panorama.

Alcuni delitti “d’onore” del passato Le
donne del passato, sia di rango e non, erano costrette ad accettare matrimoni
combinati dai padri, fratello o tutori per motivi economici, accrescere il loro potere politico e
sociale.ma c’era anche un altro aspetto nei matrimoni combinati cioè Quello di
migliorare la discendenza Una
discendenza degenerata a causa di frequenti matrimoni consanguinei per non
disperdere il patrimonio, le ricchezze. Una
discendenza degenerata a causa di frequenti matrimoni consanguinei per non
disperdere il patrimonio, le ricchezze.
Nel
“Gattopardo” il principe Fabrizio di Salina assunse un atteggiamento
decisamente critico nei confronti di certe abitudini o consuetudini della
nobiltà.
Laura
Lanza non era probabilmente molto contenta del suo matrimonio, ancora
quattordicenne. Aveva amici sia nella famiglia La Grua c con i Vernagallo e con Ludovico Vernagallo
aveva sempre avuto un rapporto specile. Un rapporto che venne bruscamente
interrotto a causa del matrimonio con Vincenzo (II) La Grua Talamanca.
Tra
Laura e Ludovico c’erano forse state delle tenerezze e forse anche promesse di
matrimonio. Non sapremo mai dell’esistenza di questi aspetti nelle relazioni
tra i due giovani però è anche vero che l’amore, quello vero, non conosce
ostacoli.si narra come Ludovico rivolgesse alla sua amata delle serenate e
degli incontri tra i due nelle sale dell’alta nobiltà in occasione di riunione
festose.
Erano
veramente innamorati l’uno dell’altra? La
ballata siciliana cantava: na catinedda li
curuzzi strinci, battinu tutti dui supra ’na mota, e la felicità chi li dipinci
attornu, attornu d’oru e di rosa; ma l’oru fa l’invidia di centu, la rosa è
bedda e frisca pi un momentu. Una piccola catena
stringe (unisce) i piccoli cuori (dei giovani), battono tutti e
due sopra una nota, e la felicità che li dipinge attorno (la felicità li
circonda), d’oro e di rosa;
ma l’oro fa l’invidia di cento (persone), la rosa è bella e
fresca per un momento (perché poi appassisce). L’invidia
è una brutta malattia e può causare guerre, tragedie. Fu
infatti, come racconta la ballata, un monaco che rilevò al barone don Vincenzo,
appena tornato dalla caccia, la relazione amorosa tra la moglie e Ludovico. Il
barone pensò subito al delitto d’onore. Lu monacheddu
nisceva e ridia, e lu baruni susu sdillinia. Il piccolo monaco
(dopo aver rilevato la relazione) usciva (dalla sala) e rideva, e il barone
(comincio) su a farneticare. La
situazione si doveva risolvere ed era quindi necessaria una riunione di
famiglia. Don
Vincenzo andò dal suocero don Cesare Lanza ed entrambi si misero in camino per
Carini con al seguito dei bravi (anche se Don Cesare, secondo alcune fonti, si
sarebbe trovato a Mussomeli). I
due amanti furono sorpresi in un atto d’amore? Non
lo sapremo mai. Fu Don Cesare ad uccidere la figlia Laura. Nessuno accorse alle
grida delle povera donna.
Troppi
interrogativi,,, anche la stessa lettera di Don Cesare al re di Spagna Filippo
II per spiegare il movente della terribile azione sembra voler nascondere altre
motivazioni.
Don
Cesare era pretore di Palermo ed aveva altre cariche importanti nella citta,
allora una delle più grandi ed importanti d’Europa.. doveva essere protetto e lo
stesso Don Cesare Lanza sapeva come il re di Spagna l’avrebbe graziato
accettando le sue motivazioni.
Il
caso fu chiuso….. per la tranquillità delle nobile famiglie coinvolte.
Il
delitto d’onore era molto frequente in Sicilia, sempre nell’ambiente della
nobiltà, sin dalla seconda metà del Quattrocento per giungere all’ultimo
delitto d’onore, sempre in Sicilia, nel 1964 ( “la relazione tra il professore
universitario e Mariatena” – Nota N. 10).
Nel
Quattrocento la sfortunata Donna Aldonza Santapau, dei marchesi di Licodia
Eubea, fu calunniata a torto dai cognati invidiosi come “infedelissima”.
Il
marito Antonio Pietro Barresi, signore di Militello (in Val di Catania) uomo
molto violento ed esperto nell’arte militare, uccise la moglie ed il presunto
amante con azioni terribili. Un uomo violento malgrado la sua fama di amante
dell’arte. Furono i fratelli di don Antonio, per invidia e per vendicare dei
torti subiti per non avere avuto delle concessioni di denaro da parte di Donna
Aldonza, gli autori della tragedia.
Il
nome del presunto amante era Francesco Caruso ed era soprannominato il
“Bellopiede” per la sua bravura nel ballo.
Don
Antonio legò il corpo del Caruso alla coda del cavallo e lo trascinò per le vie
di Militello passando anche davanti alla casa della povera madre dell’ucciso,
costringendola a ridere…… scene di follia…
Dopo
questi tragici eventi famoso fu il caso che colpì il Regno di Napoli, sempre
nell’alta aristocrazia. Il
16 ottobre 1590 fu uccisa la bellissima Donna Maria D’Avalos, una delle
donne più celebri e conteggiate nell’Europa del tempo. Fu uccisa dal marito
(che era anche suo primo cugino) e dai
suoi sgherri.
 Maria
D’Avalos era figlia di Carlo d’Avalos, principe di Montesarchio, una delle più
nobili famiglie napoletane e di Sveva
Gesulado. A
tredici anni sposò il principe Federico Carafa e dal matrimonio nacquero due
figli/e: Ferdinando
che morì in età infantile e Beatrice che morì all’età di dodici anni. Rimase
quindi vedova a 19 anni (1581) e sposò
in seconde nozze il figlio maggiore di una nobile ed illustre famiglia
siciliana, Alfonso Gioieni. I
due si sposarono nel 1583 ma il marito morì appena due anni dopo, nel 1583. Maria
si ritirò, dopo la morte del secondo marito, nell’isola di Ischia dove rimase
fino a quando non trovò un nuovo corteggiatore da sposare. Donna
Maria d’Avalos sposò il principe Carlo Gesualdo di Venosa, il 28 aprile 1586. Era
più giovane di lei di quattro anni ed era anche suo cugino di primo grado. La
madre di Maria era sorella di Fabrizio Gesualdo, padre di Carlo. Una
relazione parentale molto stretta e per questo motivo era necessario una
dispensa papale di papa Sisto V. Donna
Maria all’età di ventiquattro anni era la donna più famosa di Napoli per la sua
straordinaria bellezza e per essere al centro di continui corteggiamenti da
parte dei nobili più influenti delle varie corti europee. Maria
era adatta per il principe di Venosa perchè , "avendo
avuto due mariti in precedenza, aveva dato sufficienti segni di fertilità" Il
poeta Torquato Tasso era strettamente imparentato con la famiglia d’Avalos e
quindi ebbe la possibilità di conoscere personalmente la donna. Il
poeta celebrò il matrimonio tra Maria e Carlo con un sonetto che terminava con
i seguenti versi: «Poi la vostra
cintura con maggior luce Fece il valore e la virtù feconda E cede a bella donna invitto duce.»
Dal
matrimonio nacque, nel 1587 o 1588, un figlio di nome Emanuele.
Alloggiavano a palazzo Sansevero, di fronte alla
Chiesa di San Domenico Maggiore.
 Napoli – Pazzo San
Severo Napoli – Pazzo San
Severo
 La
coppia visse felice nei primi due/tre anni del matrimonio con una vita mondana
molto intensa Quegli anni furono il limite in cui Maria riuscì a supportare
quell’unione e coincise con i primi anni di Emanuele.
Il
loro matrimonio non fu legato ad un forte sentimento d’amore ma ad un legame
creato per impedire che il patrimonio familiare finisse nelle grinfie del
papato.
A
prescindere dagli aspetti economici, la coppia non aveva nulla in comune.
Negli
anni a seguire sembra che il marito Carlo abbia addirittura iniziato ad
insultare e a picchiare la moglie.
Questi
aspetti erano indizi di un rapporto della coppia molto difficile. Il marito
cominciò ad avere dei sospetti sulla lealtà della moglie.
Subito
dopo la nascita di Emanuele, si narra come Maria abbia avuto una relazione adulterina con il
giovane duca d’Andria, Fabrizio Carafa, appartenente alla famiglia dei Carafa.
Carlo viveva per la musica e trascurava la moglie. Era un madrigalista di
grande talento. Un compositore che lasciò un notevole segno nella storia della
musica polifonica. Maria era sempre più infelice finché, durante una festa
danzante, conobbe Fabrizio Carafa, duca D’Andria, conosciuto con
l’appellativo di Arcangelo per la sua grande bellezza. Sposato anch’egli con la
nobildonna Maria Carafa, padre di quattro figli.
I due si innamorarono e divennero amanti, sempre più
imprudenti, nonostante ricorressero a ingegnosi stratagemmi per non farsi
scoprire.
Carlo
venne a sapere del tradimento della moglie grazie alla rivelazione di uno dei
suoi zii.
La bellezza di Maria, intanto, accendeva numerose
passioni, tra cui Giulio Gesualdo, uno zio di Carlo, che desiderava quella
meravigliosa creatura ricevendo sempre decisi rifiuti. Quando Giulio scoprì la
relazione tra Maria e Fabrizio, ne parlò con il nipote. Questi, allora, decise
di creare un’imboscata alla moglie. Un giorno, con la scusa di una battuta di
caccia, Carlo disse alla moglie che non sarebbe rientrato a casa. Maria fu
insospettita dal comportamento del marito, ma il desiderio prevalse sulla
prudenza. Diede ordine a una cameriera di vigilare le uscite e di non svestirsi,
ma questa cadde addormentata. Don Carlo assieme a un aiutante e con la
complicità di un monaco che viveva nel convento di fronte, sorprese i due
amanti e preso dalla furia, li massacrò nel palazzo San Severo dove la coppia
risiedeva, . Era la notte tra il 16 e il 17 ottobre 1590.
 La stanza dove avvenne il massacro (al secondo piano dell’angolo sinistro dell’edificio) La stanza dove avvenne il massacro (al secondo piano dell’angolo sinistro dell’edificio)
Si narra come
Carlo Gesualdo non agì nella brutale esecuzione della coppia ma furono i suoi
sgherri ad eseguire il massacro. Altre fonti invece rilevarono che furono
proprio don Carlo ad uccidere i due amanti con un pugnale. La
tragedia s’era compiuta e don Carlo, sporco di sangue e in preda alla follia
scese di corca in strada piangendo ed urlando. S’allontanò da Napoli per timore
di vendette da parte dei familiari dei
congiunti. La
tragedia fu ripresa grazie a tre diverse testimonianze: -
resoconti
delle indagini condotte dal Gran Tribunale del vicariato del Regno di Napoli; -
una
lettera di Silva Albana, la domestica di Maria d’Avalos; -
una
lettera di Pietro Malitiale, detto “Bardotto” servo di Carlo. Le
due ultime lettere conterrebbero dei dettagli molto importanti. «Su la mezza notte
ritornò al palaggio il Principe, accompagnato da una truppa di cavalieri amici
e parenti tutti armati; ed entrato dentro al Palaggio della Principessa, avanti
della quale camera stava di scorta a sentinella la fida di lei cameriera Laura
Scala, mezza addormentata su di un letto, che, sentendo il rumore gente, volle
gridare; ma minacciata della vita dal Principe si ritrasse più morta che viva,
il quale attendeva con un calcio la porta della camera e, tutto furibondo
entrando dentro di essa con la continua scorta, trovò che nuda in letto, ed in
braccia al Duca giaceva sua moglie (fra tanto la buona cameriera, visto il
tempo opportuno, essendo tutti entrati dentro la camera, se ne fuggì via, né si
seppe di lei più novella alcuna). A sì vista si può considerare come restasse
stupito il povero Principe, il quale scossosi dallo stordimento che l'avea
posto tal veduta, prima che li sonnacchiosi potessero rifiatare, si mirarono da
più pugnali trafitti. Questo misfatto successe nella notte che si seguiva il
giorno del 16 ottobre 1590». L’altra
versione: «[Bardotto,
servitore del principe] quando scese al cortiglio vidde che lo portiello dela
porta dela strada stava aperto ch'esso testimonio se ne maravigliò molto, che a
quella hora stesse aperto, et lo chiuse, tirò l'acqua dal puzzo, et la portò ad
alto al signor don Carlo, che lo trovò che si era vestito, et [...] [gli
chiese] dove voleva andare, ch'erano sei ore, e niente più, il quale Signor Don
Carlo li disse, che voleva andare a caccia, et esso testimoniali disse, che
quella ora non era ora di caccia, il Signor Don Carlo li rispose: «Vedrai, che
caccia farò io»[.] Si finì di vestire et ordinò ad esso testimonio, che
allumasse due torcie, che stavano alla camera [...] et allumate che furono,
detto signor Don Carlo cacciò da sotto il letto una [...] daga con pugnale, et
uno archibugetto da due palmi incirca, e pigliato ch'ebbe esto [...] trasì, e
salì per questo caracole ad alto (una scala a chiocciola segreta) ad alto che
saglie all'appartamento della signora Donna Maria d'Avalos, e sagliendo anche
detto Don Carlo disse ad esso testimonio: «Voglio andare ad ammazzare lo duca
d'Andria, e quella bagascia di Donna Maria!». E così sagliendo vide esso
testimonio tre uomini (tre bravacci) li quali portavano una alabarda per uno ed
un archebugetto! [...] Esplosero due colpi, oltre a vari insulti; i tre giovani
uscirono e poi fu la volta di Carlo Gesualdo, che aveva le mani coperte di
sangue. Chiese subito dove fosse Laura, l'intermediario, visto che era andata
via. Bardotto e Gesualdo tornarono quindi in camera da letto, dove quest'ultimo
aveva eliminato la coppia morente. » L’ultima
versione sarebbe quella più affidabile e
seguita. Alcuni dettagli sarebbero contradittori. L'analisi dettagliata dei verbali portò Cecil Gray a dubitare della veridicità
di alcuni elementi riportati, a cominciare dalla trappola tesa dal giovane
principe, che annunciò la sua intenzione di andare a caccia, che sembra ripresa
da una frase pronunciata dal sultano Shahriyār in “Le mille e una
notte”, la famosa opera frutto di pura fantasia. Inoltre, dettaglio di
non secondaria rilevanza, sarebbe plausibile ritenere che Carlo non uccise con
le sue mani i due, ma che avesse assoldato qualche mandante che lo facesse per
lui. Carlo dopo l’uccisione dei due amanti fuggì da Napoli e si
rifugiò a Gesualdo, nella provincia di Principato Ultra. Il processo non nacque sono l’egida della verità e
dell’imparzialità Venne archiviato il giorno dopo la sua apertura per ordine del
viceré stante la
notorietà della causa giusta dalla quale fu mosso don Carlo Gesualdo, Principe
di Venosa, ad ammazzare sua moglie e il duca d'Andria". Le deposizioni non lasciavano nel Regno di
Napoli dubbi: Maria d'Avalos era
l'amante di Fabrizio Carafa (cosa, del resto, da tempo risaputa da tutti, dallo stesso
magistrato, dall'avvocato e dal viceré). Il
Regno di Napoli seguì con molta attenzione la vicenda così come la nobiltà dello
Stato Pontificio. Le
testimonianze sarebbero chiare. Carlo
Gesualdo gridò ai suoi uomini: Uccideteli. Uccidete
questo vile e questa puttana. Corna alla
famiglia Gesualdo? Parole
, frasi che pronunciò prima di tornare dalla moglie Maria gridando.. Non deve essere
ancora morta! e gli procurò altre ferite all’addome mentre
altri aspetti rientrerebbero nella pura funzione e cioè fecero da sfondo a
leggende. Non
si sa se i corpi dei due amanti furono gettati per strada, se fossero stati
oggetto di violenza da parte di un monaco cappuccino o se fossero rimasti
impiccati fino a quando la putrefazione dei corpi fosse giunta a tal punto da
rendere necessario la sepoltura e quindi al restituzione delle salme alle
rispettive famiglie e quindi Lavate dalle loro
ferite, vestite di raso nero e velluto nero” Secondo i documenti d’archivio dal XVII secolo. Alcune fonti citarono come Maria fu atrocemente sgozzata e sventrata ed esposta
nuda in mezzo alle scale del palazzo. (Le
cronache citarono come i Regi Consiglieri ed i Giudici Criminali della Gran
Corte della Vicaria, si recarono nella
stanza da letto in cui avvenne il massacro. Trovarono il corpo straziato, senza
vita, di Fabrizio Carafa e a tre passi da lui giaceva il cadavere insanguinato
della povera Maria. Per
il disonore e lo scandalo arrecato alla nobiltà, i corpi degli
sfortunati amanti furono esposti nudi come monito, la mattinata
seguente in mezzo alle scale del palazzo e tutta la città
corse a vederli). I corpi furono sepolti secondo le disposizioni delle relative
famiglie: Maria d’Avalos, fu sepolta nel lato destro della Chiesa di S.
Domenico Maggiore, nella Cappella di Ferrante Carafa, suo primo marito, insieme
ai suoi figlioletti Ferdinando e Beatrice.
 Napoli – Chiesa di
San Domenico Maggiore
 Cappella Carafa Cappella Carafa

 Fabrizio
Carafa, invece, fu seppellito in una bara e consegnato al gesuita Don Carlo
Mastrillo su disposizione della moglie Donna Maria Carafa,
che per il disonore si ritirò a vita monastica.
Negli
anni ”90 l’Università di Pisa ricevette l’incarico di scoperchiare le tombe in
cui secondo ipotesi, riposavano gli scheletri dei due amanti. Vi erano dei
resti mortali: si ipotizzò per le lesioni ricevute quello di Fabrizio Carafa,
ma di Maria D’Avalos non vi era traccia. Forse lì non c’è
mai stata.
Si
dice che dalla notte della tragedia fino ai secoli
dopo, coloro che abitavano nei pressi del palazzo potevano
distinguere bene le urla strazianti di Maria D’Avalos.
In più, sul Palazzo Sansevero pendeva una sciagura: chi lo abitava era
maledetto fino alla settima generazione. Questo durò fino al 1889, quando
un’ala del palazzo crollò portando con sé la stanza del peccato e
dell’omicidio. Altre voci raccontano che tra l’obelisco di San Domenico
Maggiore e il portale del Palazzo di Sangro dei Principi di San Severo si
aggira una figura eterea, di tale bellezza che singhiozza: il fantasma di
Maria.https://grandenapoli.it/wp-content/uploads/2016/02/20151105_110428_8-maria-d-avalos-875x600.jpg Per
quei tempi la colpa di Maria era per il diritto non messa in discussione. Il
marito Carlo aveva goduto delle facoltà di ucciderli agendo al fine di
vendicare il suo onore e quella della sua famiglia.
Negli
ambienti spagnoli, così anche a Napoli, era usanza uccidere la donna adultera
ed anche il suo amante mentre al Nord Italia la tradizione prevedeva solo la
morte della moglie.
La
stessa famiglia Carafa criticò Carlo Gesualdo per aver fatto ricorso alla
servitù per uccidere il loro parente. Malgrado Carlo abbia agito secondo la
consuetudine del tempo, si rifugiò a Gesualdo, lontano dagli ambienti nobiliari
e dalla famiglia delle vittime di cui teneva le reazioni.
Visse
per ben diciassette anni nella sua residenza di campagna.
Il ritiro fu accompagnato da altri “ritiri” da
parte di alcuni membri della sua famiglia e questo nonostante l’intervento del
viceré di Napoli dell’epoca Juan de
Zuniga che cercò di contenere qualsiasi azione di vendetta nei confronti di Carlo Gesualdo e dei suoi
parenti.
Il
padre di Carlo, Fabrizio, morì il 2 dicembre 1591, anche lui lontano da
Napoli nel castello di Calitri. Durante l’esilio Carlo Gesualdo diventò,
all’età di 25 anni, capofamiglia ed uno dei proprietari terrieri più ricchi del
Mezzogiorno.
 Calitri Castello


Nel
1594 Carlo Gesualdo si sposò una secondo volta con Eleonora (Leonora) d’Este,
sorella di Cesare d’Este, erede apparente del duca Alfonso II.
La leggenda ci tramandò la visione di Carlo in
preda a crisi per il ritorno nel suo animo del passato per i suoi crimini.
La
scomparsa del secondo figlio, nato dal matrimonio con Eleonora d’Este, fu
considerata da don Carlo come una condanna divina per i suoi peccati e si fece
largo in lui la necessità di un percorso di espiazione.
Cero
don Carlo aveva dei rimorsi di conoscenza non
solo per i delitti ma anche per le sue strane abitudini che potrebbero
essere state la causa del tradimento di Maria. Comportamento che seguì, come un
modello ci vita, anche con la sua seconda moglie.
Non
si studia la vita intima dei compositori e degli scrittori che dovrebbe fare
parte della personalità e della creatività di un artista.
Infatti
l’espiazione di questo senso di colpa lo portò ad accettare le pratiche
masochistiche e per questo motivo reclutò dei giovani, in età adolescenziale,
per fustigarlo e scacciare da lui quei demoni che lo perseguitavano.
Si
tramandò come don Carlo Gesualdo amasse farsi incatenare da prestanti e fidati
schiavi e poi farsi frustare o preferisse farsi riscaldare la schiena a letto
dagli abbracci di un certo Castelvietro di Modena.
Mosso dai sensi di colpa commissionò nel 1609 al
pittore Giovanni Balducci una tela chiamata il “Perdono di Gesualdo”. Dipinto
ancora oggi conservato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Avellino.
Il Perdono di Gesualdo di Giovanni Balducci (1609). Il compositore è raffigurato inginocchiato, in basso a sinistra, davanti allo zio Carlo Borromeo in veste da cardinale
Il restauro del Perdono di Gesualdo ha rivelato il ritratto di Eleonora
d'Este (a destra), precedentemente "nascosto" da una clarissa (a
sinistra), nel XVII secolo
Tra gli
esercizi di mortificazione della carne, come la recita l’Atto di Dolore, furono
presenti le pratiche di penitenza, severe ed anche stravaganti, che erano
incoraggiate allora dalla Controriforma. Pratiche
legate ad una fervente devozione, che lo opprimeva, piuttosto che ad un piacere
morboso o perverso. Nel
1611, e nell'anno successivo, il principe ottenne le reliquie di Carlo
Borromeo, diventato suo ideale padrino e santi patrono. In
una lettera dell’1 agosto 1612, ringraziò il cugino Federico Borromeo.. «Non potevo aspettarmi o ricevere
oggi dalla gentilezza di Vostra Signoria Illustrata una grazia più preziosa, né
più desiderata di quella che si degnò di concedermi con il sandalo che il
glorioso San Carlo usava pontificamente. L'ho salutata e baciata con grande
gioia e consolazione, ma sarà preservata e trattenuta con il dovuto rispetto e
devozione». Nel
1619 fece stampare la sua opera
“Tenebrae Responsoria” dove la figura di Cristo martire fu espressa
musicalmente in modo molto toccante e assolutamente personale. Il 29
agosto 1613 il figlio Emanuele Gesualdo, avuto dalla prima moglie Donna Laura
d’Avalos, morì «per
esser in doi volte caduto da cavallo nella caccia», allo stesso modo dello zio, fratello di Carlo. La
moglie Eleonora era in stato di gravidanza ed aveva solo una figlia, Isabella
di due anni. Il
principe Carlo fu colpito dalla morte del figlio e si ritirò nell’anticamera
della “camera dello Zembalo” ovvero la camera da musica con il clavicembalo. In
questa camera, dopo diciotto giorni, si spense l’8 settembre 1613… si lasciò
andare come in un estremo suicidio.. «non havendo il
signor Prencipe di Venosa altro figliolo, sentette assai et in modo ch'oltre al
suo male ancho s'aggravò». Morì dopo atroci sofferenze e paranoie sull’incolumità
della sua vita. Grazie ai documenti ritrovati nell’archivio storico
del banco di Napoli, fu possibile ricostruire storicamente la vicenda. In base
a prelievi monetari che Gesualdo mosse, si potè dedurre che stava premeditando
una vendetta. All’epoca dei fatti, prima di erogare i soldi si esigeva il nome,
il motivo e infine la cifra consegnata La
nuora, Maria Polissena, diede alla luce una bambina poco dopo e la linea del
principe Carlo si estinse. Il
testamento del principe redato pochi giorni prima della sua morte da don Pietro
Cappuccio, costituì un ultimo tentativo per conservare tutti i titoli, le terre
ed i vasti domini feudali della famiglia in assenza di una discendenza maschile
diretta. «Verum se il
postumo che dovrà nascere da detta Donna Polissena serà femmina, in questo caso
istituisco mio herede universale sopra di tutti li miei beni la suddetta Donna
Isabella, mia nipote [...] ordino et comando a detta Donna Isabella mia nipote
che tanto restando herede quandocumque come di sopra, quanto essendo dotata
delli cento mille ducati, debba pigliare per marito il primogenito di Don
Cesare [Gesualdo] et in difetto del primo debba pigliare il secondo et in
difetto del secondo il terzo [i figli di Cesare], et così s'intende degli altri
per ordine, et mancando la linea dì detto Don Cesare, debba pigliare nello
stesso ordine uno dei figli, il più vicino della detta famiglia. et mancando la
linea dì detto Don Cesare, debba pigliare nello stesso ordine uno dei figli ». La
principessa Isabella (figlia di Emanuele e di Maria Polissena di Forstenber))
sposò nel 1622 don Nicolò Ludovisi, nipote di Gregorio XV, della nobiltà
romano-bolognese senza alcun legame diretto con la dinastia dei Gesualdo di
Venisa (dal matrimonio una figlia di nome Lavinia). Il
principe fu sepolto accanto al figlio Emanuele nella cappella di Santa Maria
delle Grazie, ma poi la salma venne trasferita nella chiesa del Gesù
Nuovo di Napoli, ai piedi dell'altare dedicato a Ignazio di Loyola,
la cui costruzione era stata progettata da Gesualdo prima di morire. Oggi
si conosce solo l'ubicazione della sua tomba. Dopo il terremoto del 1688,
i lavori di ricostruzione dell'edificio religioso rimossero la lapide. Il
rapido susseguirsi di eventi tragici, l'attività frenetica mostrata da Gesualdo
nei suoi ultimi giorni e le volontà espresse con autorevolezza nel testamento
sono incoerenti con l'immagine del nobile in preda alla pazzia. Le circostanze
della sua morte risultatono tuttavia oscure. Nel 1632, il cronista
Ferrante della Marra affermò nello scritto Rovine di case napoletane
del suo tempo: «Carlo Gesualdo fu
assalito ed offeso da gran moltitudine di demoni, li quali non lo feron per
molti giorni mai quietare se non dopo che dieci o dodici giovani, che ei tenea
a posta per suoi carnefici, non lo caricavano (ed ei sorrideva) tre volte il
giorno di asprissime battiture, ed in questo stato miserabilmente se ne morì in
Gesualdo ». Verosimilmente
colpito dall'immagine del principe torturato, Michele Giustiniani, di passaggio
a Gesualdo, scrisse in una lettera datata 10 ottobre 1674 (a oltre sessant'anni
dai fatti): «In
questo luogo, il dì 3 settembre del 1613, seguì la morte di Don Carlo Gesualdo,
Prencipe di Venosa, eccellentissimo musico, come dimostrano le sue opere
stampate, e suonatore di Arcileuto, accelerata da una strana infermità, la
quale gli rendeva soavi le percosse che si faceva dare nelle tempie e nelle
altre parti del corpo, con fraporvi un involto piccolo di stracci. » Prima leggenda nera La
nascita di Leonora, la seconda nipote di Gesualdo, fu accolta senza troppo
clamore dalla popolazione. La vedova del principe, Eleonora, di ritorno a
Venosa per assistere alla nascita della principessa Maria Polissena, riportò la
notizia al fratello Cesare con queste parole: «Ho battezzato la
bambina, e le sono stati dati i nomi Leonora e Emanuela. È bellissima e qui è
il mio passatempo poi che non vuole stare se non da me. Solo che dice mille
chiacchiere et mostra giudizio per non avere se non due anni. [...] è nata con
i centomila ducati di dote lasciatole dal principe, mio signore. Ma il
maggiore, che eredita da tutti gli stati, avrà in dote più di un milione in oro
senza contare il resto .» Eleonora d'Este morì nel 1637. Nel
frattempo, la perdita della fortuna e delle proprietà signorili fu accompagnata
da voci volte a "spiegare" tali grandi disgrazie per effetto di una
qualche punizione divina. Si credeva generalmente che la colpa fosse di
Carlo Gesualdo, il quale pareva aver perso la ragione e trattava i suoi
vassalli con avidità e lussuria, oltre che in modo tirannico, scatenando l'ira
di Dio contro di lui. Pochi
giorni dopo la morte di Gesualdo, un cronista modenese, Giovan Battista
Spaccini, inaugurò la "leggenda nera" che si concentrò sulla
memoria del principe caduto: «Tra tanto teneva
una bellissima concubina, la quale l'aveva affatturato di maniera tale che non
poteva vedere la principessa donna (Leonora) e quando lei vi stava lontano
moriva di passione di vederla, e poi mai più la guardava. Non poteva mai
dormire se uno non vi stesse con lui abbracciato e vi tenisse caldo le rene, e
per questo aveva un Castelvietro da Modona v'era molto caro, dormendo
continuamente con lui quando non stava la principessa sieco.» La
corte della famiglia Estense si era ritirata a Modena, cacciata
da Ferrara dalle truppe papali. Il ricordo della mancata trattativa
tra Alfonso II e il cardinale Alfonso Gesualdo, decano del Sacro
Collegio e zio del principe, generarono sicuramente risentimento nei
confronti del Gesualdo. Le
maldicenze si diffusero presto da Modena a Napoli, da Roma ad altre regioni
dell'Italia. Risultò strano e interessante, tuttavia, osservare che, anche nei
racconti più oscuri del tempo della "prigionia" di Gesualdo nel suo
castello, si faccia riferimento alla seconda consorte del principe ma mai alla
prima, Maria d'Avalos, il cui omicidio, già lontano, pareva sorprendentemente
dimenticato da tutti. Torquato
Tasso compose tre sonetti e un madrigale in cui magnifica la “colpa” dei due
amanti colpevoli. Il
tema diventò oggetto di studio da parte di critici storici ed umanisti
dell’epoca Si
diffuse anche la leggenda secondo la quale da allora a Napoli, a Palazzo
Sansevero, fosse possibile vedere il fantasma di Maria d’Avalos. Nel 1995 “Morte in cinque voci”, un documentario-dramma diretto da
Werner Herzog per la ZDF (televisione svizzera) che rievocò la vita tormentata,
la leggenda e l’opera visionaria del compositore in maniera più romanzata
unendo analisi storiche e testimonianze degli abitanti Napoli, Gesualdo, e dei discendenti delle famiglie
coinvolte nell'omicidio di Maria d'Avalos, tra cui il principe Francesco d'Avalos) che storicamente corretta o rigorosa. Maria venne
descritta come "una
donna molto fiera".
...............................................
Note
(1)
ABATE1 (di Trapani) – L’8.3.1234 Gilberto Abate,
tramite il fratello, il dominus Enrico
Abate
abitante a Trapani, acquistò per 1750 tarì dal dominus Nicoletto Asmundo
abitante di Calatafimi, falconiere dell’imperatore Federico, e dalla moglie
Margherita, col consenso di Benedetto loro figlio minorenne, il territorio con
terre lavorative, selva e foresta denominato Inichi (Inici), nel tenimento di
Calatafimi (Asp, Trabia serie A, 1449, 15). Lo stesso Gilberto, che al momento
della sua rivolta contro Carlo d’Angiò risultava signore del casale Ciminna,
ebbe confiscato quest’ultimo casale dal sovrano angioino che nel 1271-72 lo
concesse per metà agli eredi dell’Abate e per l’altra metà a Folque de Venellis
(RA, VIII, 68; RA, VIII, 184), il quale ebbe come successore nel 1280-81
Bartholomé de Venellis (RA, XXIV, 127). -
Il figlio di Gilberto, Palmerio Abate nel 1278-79 era titolare di imprecisati beni
feudali in Sicilia (RA, XXI, 266; Catalioto, 1995, 308) ed il 15.5.1292 fu
reintegrato come custode della foresta di Partinico, ruolo dal quale era stato estromesso
da Matteo di Termini (La Mantia, 1956, 183).
Nel
1292 risultava titolare del casale e feudo di Asinelli (l’odierno Isnello), dal
quale parte degli abitanti si erano allontanati per sottrarsi ai servizi
feudali cui erano obbligati (La Mantia, 1956, 233; Sciascia, 1993, 130).
Palmerio
morì nell’estate 1300 in seguito alle ferite riportate nella battaglia di
Ponza.
-
Gli successe il fratello miles Riccardo Abate, vivente
nell’aprile 1303, che dalla prima moglie ebbe i figli Nicola e Enrico, mentre
dalla seconda moglie Ricca ebbe il figlio Giacomo (Asp, Tab. S.M. Scale, 21:
2.4.1303).
-
Il dominus miles Nicola (I) Abate sposò la palermitana
Filippa de Milite, cugina di Matteo Sclafani. Dal matrimonio i maschi Riccardo e Palmerio e le
femmine Preziosa (che sposò Garsiolo de Yvar) e Albamonte (che
sposò Marino Capece). Abbiamo sue notizie dall’8.3.1309 (Asp, Misc. Arch. II,
127b, 199v) 2 al 6.12.1336 (Bresc, 1986, 908 e 883)3, mentre risulta già morto
il 7.4.1337 (Vind.) (Asp, ND, Rustico de Rusticis, I, 81, 36). Il 12.2.1330
Nicola Abate stipulò una transazione col monastero di S. Caterina di Palermo
per definire il confine tra il tenimento di Munkilebbi (ora Montelepre) di
proprietà del monastero e il suo casale di Carini (Asp, Monastero S. Caterina
di Palermo, 65, 17 ss).
2(In
questo atto Nicola Abate concede in gabella ad estalium ai fratelli Perrello
e Franchono de Cisario «dua tenimenta
terrarum
quorum unum dicitur casale Calidum
et alterum
Tirrasinum sita in territoriis Carini et Chinnisi iuxta tenimenta terrarum
Chinnisi qua tenet
heres domini Mattei Pipitoni et secus tenimenta terrarum Carini et
iuxta tenimentum
terrarum quod diciturMunchilebi et secus nemus Partinici via
publica mediante»
per
7 anni dal successivo primo settembre VIII ind. per 140 onze annue. 3
( Nel febbraio 1330 il milite Nicolò Abate era in lite con il monastero di S.
Caterina di Palermo sul possesso di un tenimento di terre chiamato Munkilebi.
Nel febbraio 1337 venne sancita l’appartenenza del tenimento Munkilebi al
monastero di S. Caterina (Garufi, 1902, 75-77, n. 166, 170). La
descrizione dei beni feudali posseduti da Nicola Abate nella D. F. del 1335
lascia adito a talune difficoltà interpretative, che possono essere sciolte dal
confronto fra le versioni riportate dalle due principali fonti della
Descriptio, che risultano nel caso in questione particolarmente tormentate, e
da altri coevi documenti. Il manoscritto della Bsp riporta: «Nicolaus Abbas
miles pro Asinello, Chifalo,
Carino roch-is, pro terra Chiminne, Terrasinis, casalis Callicuda et Inichi eris
symonis 600»; il
manoscritto della Bcp, invece, riporta: «Nicolaus Abbas
miles pro Asinello, Chifala, Carmorochis, Chiminne, Tirrasinis, casalis Cabis
Cudis, Inichi 600». Nicola
Abate
quindi ricavava 600 onze di reddito da Isnello (Asinello) 4, da Cefalà,
da Carini 5, da Terrasini, dal casale Cabiscudi (Callicuda, in ms Bsp; si
tratta di Cudia), da Inici , mentre con buona
verisimiglianza i due termini eris simonis che si trovano soltanto nel manoscritto
della Bsp costituiscono l’errata trascrizione del nome dei due tenimenti Umri
(ora Ummari) e Simeni, che si trovavano in vicinanza di Inici e che sappiamo
essere appartenuti alla famiglia Abate fin dal Duecento (Sciascia, 1993, pp.
115, 120, 132). Per
quel che attiene Ciminna, che certamente secondo la D. F. del 1335 era posseduta
da Matteo Sclafani (come entrambi i manoscritti della D. F. attestano in altra
parte del documento e come abbiamo potuto costatare da altre fonti per il
periodo compreso dal 1328 al 1349), la chiave interpretativa ci viene fornita
dal termine «roch-is» che segue la parola «Carino», e precede «Chiminne», poiché
certamente Nicola Abate possedette il tenimento delle Rocche in territorio di
Ciminna, probabilmente quello stesso che era stato lasciato in feudo da Carlo
d’Angiò nel 1271 agli eredi di Gilberto Abate, nonno dello stesso Nicola. 4 Isnello figura in
potere di Nicola Abate senior in un atto stipulato il 6.12.1336 (Asp, ND, S.
Pellegrino, I, 2). 5 Nel 1271 il
castello di Carini venne concesso da Carlo d’Angiò a Jean e Simon de Montfort
(RA, VI, 154). Solo
che già nel 1333 Nicola Abate risulta averlo ceduto al cugino della
moglie, Matteo Sclafani, che ne godeva i frutti e che, però, nel testamento
di quello stesso anno disponeva un lascito di 100 onze ai due figli di Nicola,
rispettivamente Palmerio e Riccardo, «in restauratione
fructum tenimenti terrarum que
dicuntur roccarum de Chiminna perceptarum dudum per eundem testatorem»
(Asp,
Moncada, 396, 57). Nel
successivo testamento del 2.4.1345 Matteo Sclafani dispose che quel tenimento
fosse restituito a Riccardo Abate, figlio del defunto Nicolò Abate, in
virtù della donazione irrevocabile fra vivi (Bcc, Tab. S. N. Arena, 331). Alla
luce di quanto detto in precedenza, il testo originario della D. F. relativo a Nicola
Abate potrebbe essere stato il seguente: «Nicolaus Abbas
miles pro Asinello, Chifalo, Carino, Rochis terre Chiminne, Terrasinis, casalibus Cudie, Inichi, Umris, Symenis unc. 600». -
Filippa De Milite, moglie di Nicola (I) Abate, nel testamento del 5.2.1348
disponeva delle terre di Inici, Racanziri e Bonagia (Asp, Tab. S. M. Scale,
133; Bresc, 1986, 678). Risulta morta il 13.1.1349
(Acfup, VIII, 64). -
Riccardo (I) Abate, figlio maggiore di Nicola, risulta sposato e quindi emancipato
dalla patria potestà in data 23.8.1336 (Acfup, VI, 299). Riccardo Abate,
signore di Isnello, Cefalà 6 e Carini, fu tesoriere del regno almeno
nell’ottobre 1351( 7), e maestro razionale almeno dal 12.1354 al 8.6.1358
(Cosentino, 1885, 130-132; Asp, P, 2, 338). Re Pietro II gli assegnò in data
imprecisata un reddito annuo di 100 onze con l’obbligo del servizio militare
(Asp, C, 7, 437). Nel
1340 risulta avere una controversia con Aloysia Maletta (Pasciuta, 2003, 194;
Acp, Senato, XIII, 1r-v), che verosimilmente si concluse con l’assegnazione ai
due figli di Nicola Abate, Palmerio e Riccardo, del feudo Misilcassimo, che risulta
in loro potere nel gennaio 1341 e che avevano ottenuto dalla M.R.C. come
corrispettivo di un debito non riscosso. Il loro proposito di vendere quel feudo
incontrò l’opposizione del milite Giovanni de Calvelli che su quello stesso
feudo rivendicava dei diritti (Acp, Senato, XIII, 38v, 16.2.1341).
Verosimilmente Misilcassimo fu poi venduto a Bernardo Raimondo di Monterubio, che
ne risulta possessore nel 1348 (Lentini-Scaturro, 1996, 37-38). Nell’adoa del
1345 Riccardo Abate fu chiamato a fornire sette cavalli armati (pari a 140 onze
di reddito). Morì nel febbraio 1359 a Salemi durante un’operazione militare (Fazello,
1992, 648). 6 Riccardo Abate il
20.8.1346 risulta feudatario del feudo Favarotta in territorio di Cefalà dato
in appalto a Bindo di Ser Lombardo (Asp, SN, 10N, 58), e del castello e del feudo
di Cefalà nel corso del 1349 (Acfup, VIII, 64; Asp, ND, Enrico de Citella, I,
79, 188v). 7 Bcp, ms Qq E 100,
n. 6-7, 172. Cosentino, 1885, 149. …………………………………. Nota
N. 2 Casato
: La Grua Talamanca Gilberto
(Gispert) Talamanca, barone di Vicari Nato:
1312 (?) Morto;
dopo il 1417 Marito
di: Ilaria La Grua, baronessa di Carini Padre:
Ubertino La Grua Talamanca ……………………. Ubertino
La Grua Talamanca Nato;
1360 (?) Morto:
(?) Figlio
di: Gilberto (Gispert) Talamanca, barone di Misilmeri e Vicari e di Ilaria
Talamanca, signora di Carini. Marito:
Diana La Grua Talamanca Padre:
Eufemia Alliata – Giovanni La Grua Talamanca, signore di Vicari Carini e
Misilmeri – Maria (Ilaria) Abbadellis ……………………………….. Giovanni
La Grua Talamanca, signore di Carini, Vicari e Misilmeri Nato:
1387 (?) Morto:
1464 Figlio
di: Ubertino La Grua Talamanca e Diana La Grua Talamanca Marito
di: Marghera La Grua Talamanca – Antonella Abbatellis Padre
di: Ilaria La Grua, baronessa di Monforte – Pietro La Grua Talamanca, barone di
Carini, Misilmeri e Vicati Fratello
di: Eufemia Alliata e Maria /Ilaria) Abbatellis. …………………………… Pietro
La Grua Talamanca, barone di Carini, Misilmeri e Vicari Nato:
1445 circa Morto:
15 marzo 1486 circa Figlio
di: Giovanni La Grua Talamanca, signore di Carini, Misilmeri e Vicari, e di Antonella Abbatellis Marito
di: Violante Bardi Mastrantonio Padre
di: Gerardo La Grua Talamanca - Vicenzo La Grua Talamanca , signore di Carini e
Misilmeri – Antonia Giovanella La Grua Talamanca – Utilia (Autilia) La Grua
Talamanca – Giulia La Grua Talamanca; Fratellastro
di: Ilaria La Grua, baronessa di Monforte ……………………………. Giovanni
Vincenzo La Grua Talamanca Nato:
1476 Morto:
Carini(Palermo), 29 maggio 1517 Figlio:
Pietro La Grua Talamanca, barone di Carini, Misilmeri e Vicari e di Violante
Bardi Mastrantonio Marito
di: Ilaria (Eulalia) Aiutamicristo e di Elisabetta Bracco e Calvello Padre
di: pietruccio La Grua, Barone di Carini – Elisabetta La grua Talamanca –
Elisabetta La Grua Talamanca – Giovanna La Grua Talamanca Fratello
di: Gerardo La Grua Talamanca e Antonia Giovannella La Grua Talamanca Fratellastro
di: Utilia (Autilia) La Grua Talamanca e Giulia La Grua Talamanca ……………………………….
Pietruccio
La Grua Talamanca Nato:
1490 circa Morto:
6 luglio 1535 Figlio:
di Giovanni Vincenzo La Grua, signore di Carini e Misilmeri e di Ilaria
(Eulalia) Aiutamicristo Marito
di: Eleonora Manriquez Padre
di: Vincenzo La Grua Talamanca, Signore di Carini Fratello
di : Elisabetta La Grua Talamanca - Elisabetta La Grua Talamanca Fratellastro
di: Francesco Del Bosco, VII barone di Baida e di Misilmeri - Federico del Bosco – Giovanna La Grua
Talamanca ……………….
Vincenzo
La Grua Talamanca - Signore di Carini Nato:
11 novembre 1527 Morto:
22 marzo 1592 Figlio
di Pietruccio La Grua, barone di Carini e di Eleonora Manriquez Marito
di Laura Lanza Padre
di Cesare La Grua Talamanca, Signore di Carini
Nota
– 3 Il
castello di Montelepre
Fino
alla prima parte del XV secolo la zona di Montelepre era conosciuta con il nome
di Munchilebbi, un antico insediamento in una zona ricchissima di acqua
divenuto successivamente un feudo appartenente al Monastero di Santa Caterina
al Cassaro di Palermo. La storia cambia nel 1429 quando il feudo venne
acquistato dalla Cattedrale di Monreale, all’epoca guidata dall’Arcivescovo
Giovanni Ventimiglia. L’Arcivescovo
fece impiantare un vasto oliveto che diede l’avvio ad una profonda trasformazione
del paesaggio rurale del feudo favorendo il sorgere di un piccolo centro
abitato ben prima della colonizzazione feudale moderna.
Dopo
aver ricevuto il consenso da parte di re Alfonso V il Magnanimo fece edificare
una fortificazione a scopi difensivi e di controllo poiché la zona era soggetta
alle scorrerie di predoni e briganti.
Il
primo nucleo di Montelepre mostra una serie di case monocellulari poste attorno
alla torre. Case costruite con materiali poveri (ciottoli e pietrame calcareo)
mentre il resto dell’abitato presenta una pianta ortogonale tipica delle nuove
fondazioni pianificate da parte del fondatore.
Quindi
siamo in presenza di una comunità che si svilupperà nel corso del tempo.
Nei
secoli il paese vedrà l’alternarsi di diversi esponenti di vario rango della
nobiltà siciliana tra cui Alvaro Vernagallo e il fratello Ludovico,
quest’ultimo passato alla storia per essere l’amante della Baronessa di Carini
Laura Lanza, assieme alla quale verrà ucciso dal di lei padre Cesare nel 1563. Nel
1812 il villaggio diventa definitivamente un comune acquisendo la sua
denominazione attuale: il Castello è una delle testimonianze storiche più
importanti della storia del paese. La “Torre Ventimiglia” venne ultimata nel
1435 divenendo uno dei riferimenti attorno al quale si strutturò
definitivamente la comunità di Montelepre ormai passato da luogo rurale a
centro feudale. Costruito in cima ad una collina il Castello di Montelepre
avvolge e quasi sovrasta il paese con i suoi 24 metri in altezza. La torre di
pianta rettangolare si sviluppa su tre piani e la sua facciata esterna
geometricamente massiccia e austera, in cui spicca un orologio installato molto
tempo dopo rispetto all’edificazione, ricalca lo stereotipo delle
fortificazioni medievali. L’ingresso era blindato da una bertesca e da un ponte
levatoio. La facciata esterna è caratterizzata dalla presenza di diverse
finestre a due o tre fori che illuminavano le stanze del palazzo ai piani
nobili mentre per il pian terreno, destinato ai servizi e all’alloggio dei
coloni la luce passava da piccole feritoie. Le chiavi di volta, seppur consunte
dal tempo, raffigurano ancora gli stemmi tra cui la mitra episcopale,
ricollegabile all’Arcivescovo Ventimiglia.
L’accesso
ai piani signorili avveniva tramite una scala situata in corrispondenza del
ponte levatoio, non sopravvissuto ai giorni nostri così come le mura
perimetrali: quelle interne sono state costruite con pietrame irregolare hanno
uno spessore che va dai due metri del pian terreno al metro e mezzo dei restanti
livelli. Gli interni dei piani signorili sono caratterizzati dalla presenza
volte a crociera costolonate e dalla presenza di chiavi; al secondo piano si
trovavano ambienti diversi tra loro inclusa la cappella del palazzo mentre il
terzo piano è completato dalla presenza di una terrazza merlata dalla quale è
possibile ammirare un panorama mozzafiato del paese.
Numerose
nicchie e finestre (bifore e una trifora) con sedili in pietra animano gli
ambienti residenziali mentre il pianoterra prende luce da feritoie strombate.
Ma lo sforzo decorativo si nota soprattutto nelle chiavi di volta tutte
sagomate e riproducenti degli stemmi, oggi illegibili, nei beccatelli di
variato disegno e nelle finestre con colonnine di esile struttura. I muri (m
2,10 di spessore) sono costruiti in modo irregolare con pietrame informe tranne
negli angoli e nelle finestre delimitati da pietre squadrate. La lunga scala
con il balconcino e la torretta d’ingresso laterale sono modifiche moderne per
le comodità di accesso. Infine, l’orologio solare posto sulla
terrazza ha modificato in parte la regolarità dei merli, ormai inutili. Il
torrione si trova in un buono stato di conservazione.
L’accesso
alla torre avveniva solamente dal primo piano, tramite una porta protetta sia
da una bertesca, sia da un ponte levatoio di cui rimangono le
fessure per il passaggio del braccio di leva.
Oggi
al Castello si trova il Museo Civico del paese all’interno del quale sono
custoditi i reperti archeologici rinvenuti negli scavi fatti sul territorio.
     Dal
punto di vista planimetrico la torre presenta i seguenti aspetti: -
pianta
rettangolare di (21 x 17)m che si sviluppa su tre piani con una terrazza
merlata; -
il
piano terra con quattro vani su due livelli diversi e coperti da volte a botte; -
Il
primo piano era originariamente formato da due saloni rettangolari coperti con
tre volte a crociera divise da un costolone; -
Il
secondo piano rispecchia la divisione del primo con la differenza che il lato
orientale è occupato da tre ambienti di dimensioni diverse: quello centrale
serviva da cappella. -
Una
cisterna è stata ricavata nello spessore del muro nord. ..............................................
Nota
N. 4
La
Cripta . Cappella dei Lanza di Trabia nella Chiesa di Santa Cita (San
Mamiliano) a Palermo
La Pietà  
L’inizio
della costruzione della chiesa di S. Cita, posta nel quartiere Castellamare di
Palermo, risalirebbe al XIV secolo. -
Nel
1369 sono documentati la chiesa e l’ospedale di S. Cita presso la “Porta
San Giorgio” ed edificata da una comunità lucchese; -
1428, i domenicani della vicina chiesa di San
Domenico chiesero la concessione di luogo più appartato a Nicolò Speciale,
viceré di Sicilia e a Ubertino de Marinis, arcivescovo di Palermo; -
1458, fu edificata la consorella Chiesa di San
Vincenzo Ferreri dei “Confettieri”; -
1586 – 1503, ebbe inizio la costruzione della nuova
chiesa di Santa Cita. Una costruzione diretta dall’architetto Antonio di Salco.
Ci fu un interruzione per la morte dello stesso architetto mentre si gettavano
le fondamenta. Grazie alle numerose commissioni di mercanti e
patrocinatori, Antonello Gagini realizzò nel preesistente luogo di culto
monumentali apparati funebri d'impianto rinascimentale. La ricostruzione
comportò lo smantellamento e spesso la perdita dei preziosi aggregati marmorei.
In molti casi i capolavori furono sapientemente ricollocati nella nuova
struttura. -
1586; La ripresa dei lavori diretti da Giuseppe Giacalone prevede lo spostamento del cantiere: la chiesa
dei Santi Quaranta Martiri Pisani al Casalotto intralcia
con la realizzazione dell'abside secondo il progetto; -
1603: Consacrazione del nuovo edificio, le vecchie colonne della primitiva
costruzione sono attualmente visibili nel chiostro; -
1781; la chiesa fu portata definitivamente a
termine; -
1943; I bombardamenti della seconda guerra
mondiale devastano la navata sinistra e le prime due cappelle della navata
destra. -
1945; Nel primo dopoguerra la chiesa è
utilizzata come deposito di derrate alimentari e aula di Tribunale. -
1952; riapertura e dedicazione a San Mamiliano La chiesa di San Mamiliano fu quindi costruita sul
preesistente sito della Chiesa di S. Cita, lavori che iniziarono agli inizi del
1600. Presenta degli aspetti di grandissima importanza dal
punto di vista storico e architettonico. Dietro l’altare si trova l’arco del Gagini che
raffigura storie della vita di Santa Cita, Sono presenti anche immagini di vescovi e prelati. Lateralmente, sulla
destra, si trova la Cappella del
Rosario realizzata con marmi policromi e bassorilievi di Gioacchino Vitagliano,
cognato del Serpotta. La Cappella fu eseguita su un modello in creta
del Serpotta ed affreschi di Pietro Dell’Aquila. Sempre sulla destra della
Cappella di Santa Rosalia si trova la statua della Madonna della Pietà,
attribuita a Giorgio da Milano nel tardo 1440
e l’arco del Gagini che raffigura l’imperatore Ottaviano e la Sibilla
cumana. La Cappella ospita anche la tomba di Caterina Platamone e di
Giuseppe Platamone.
   Cappella della Madonna del Rosario A Sinistra dell’altare, si trova la Cappella Lanza. Da
subito l’occhio cade sul maestoso sarcofago di Ottavio Lanza (simile a quello
di Federico II di Svevia).
 E’ in porfido rosso simbolo dell’imperatore mentre
quello di Ottavio Lanza in pietra grigia di Billiemi. Accanto ad Ottavio,
Dorotea, la figlia che aveva sposato il Principe di Valguarnera. Il
sarcofago è realizzato con marmo che non esiste più, il libeccio, che si
estraeva dalle cave di Custonaci (TP).
Di fronte al sarcofago di Dorotea è posto un altro
sarcofago, datato intorno al 500, ma ignoto. Completa la Cappella Lanza il
sarcofago di Ercole Branciforte, genero di Ottavio, perché aveva sposato
la figlia Agata, in seconde nozze.
Nella chiesa si trova la Cripta Lanza che è per molti aspetti misteriosa….
….. quando è avvenuto il ritrovamento ?
Nel 1997 degli operai stavano svolgendo lavori di
ristrutturazione nella chiesa. Durante i lavori s’imbatterono in qualcosa di straordinario
ed inaspettato
Il pavimento della cappella Lanza, durante i lavori e
le vibrazioni causate dall’uso degli attrezzi, subì un crollo con un cedimento
del pavimento.
Venne alla luce una scala ripida che conduceva in un
locale sotterraneo.
Due operai scesero i gradini, con un misto
di timore ed emozione, facendosi luce con l’uso di una torcia.
Si
presento un piccolo vano pieno di oggetti disposti in modo confuso o
disordinato, un altare rovinato in più punti a causa di colonnine che si erano
staccate, tessere di marmo sparse sul pavimento, dei puttini di marmo e una
statua della Madonna in un angolo. C’erano delle tombe nel vano del sottoscala e un
grande disordine di macerie. La cripta della famiglia Lanza riapparve
casualmente, dopo essere rimasta interrata per chissà quanto tempo.
Ma perché è scomparsa e quando? Conteneva opere di
pregio e di interesse artistico e culurale? A chi appartenevano le tombe
ritrovate?
“Gli enti competenti si mobilitarono
immediatamente per mettere in sicurezza e restaurare questo piccolo scrigno di
arte e bellezza, nascosto nelle viscere della terra, che sembrava
irrimediabilmente perduto. Probabilmente l’interramento della cripta avviene
nella notte tra il 28 Febbraio e il 1 Marzo del 1943, quando, durante una
incursione aerea delle forze alleate che bombardano a tappeto la città di
Palermo, una bomba precipitò sulla chiesa di Santa Cita (che era già stata
colpita il 22 Febbraio) causando il crollo della navata minore, di parte del
tetto e recando notevoli danni a tutta la struttura dell’edificio. L’ingresso
alla cripta venne murato da cumuli di macerie e detriti ed andò in oblio
per più di 50 anni. Si ripresenterà agli occhi dei primi visitatori (stupiti e
affascinati) fortemente danneggiata e degradata, a causa sia della mancanza di
aereazione che delle infiltrazioni di umidità.
Grazie all’opera di restauro è stato dunque
possibile ammirare la Cripta?
“Grazie all‘opera di restauro, rispose la
dott.ssa Maria Oliveri,, fu possibile recuperare in parte l’aspetto originario
della cripta, luogo sacro e cimiteriale: il soffitto e parti delle pareti si
presentono oggi affrescate a motivi geometrici; il pavimento in marmo, a scacchiera, bianco e nero;
l’altare, il paliotto e gran parte delle pareti sono decorate con marmi
policromi. Il tema dominante della decorazione è il ruolo salvifico di Maria,
Madre di Dio, quale Mediatrice nel rapporto tra l’uomo-peccatore e Dio-padre.
Nel 1689 (data scritta ai lati del paliotto d’altare) Suor Caterina Giudice,
Venero baronessa del Magazzinacci e terziaria domenicana, “devotissima di
questa Sacratissima Immagine” poiché “favorita dalla Vergine con grazie
straordinarie” pur non facendo parte della famiglia Lanza, ma solo “per grande
devozione e riconoscenza nei confronti” del simulacro della Madonna .”
Nel vano del sottoscala ci sono tre
sarcofagi del Cinquecento. Il primo, sulla sinistra appartiene a Blasco Lanza (
1466 – 1535 ): è una semplice cassa sepolcrale in bianco marmo con un breve
epitaffio. Sotto la cassa di Blasco vi è un sarcofago che non reca nessuna
lapide o iscrizione, su cui è raffigurata una nobildonna giacente, col capo
reclinato su due cuscini. Il sarcofago sulla sinistra invece è di Castellana
Centelles, seconda moglie di Cesare Lanza, conte di Mussomeli e figlio di
Blasco, morta nel 1574.
Perché la cripta è rimasta interrata per mezzo secolo,
senza che nessuno si ricordasse della sua esistenza?
Perché non esisteva più la memoria
popolare. I quartieri nei pressi del porto durante la seconda guerra mondiale furono
quasi rasi al suolo dai bombardamenti anglo americani. Negli anni
immediatamente successivi al dopoguerra, la Conca d’oro fu invasa dal cemento
delle nuove periferie che si estendevano a macchia d’olio. Gli abitanti dei
quartieri del centro storico, che avevano perduto le loro case, ridotte a
cumuli di macerie dalle bombe, si trasferirono in palazzoni di cemento armato
senza storia né anima. A poco a poco le tradizioni popolari, i giochi, le feste
patronali, le identità di ogni singolo quartiere vennero inghiottite nel nulla.
Tuttavia, “L’errore – come direbbe
Leonardo Sciascia – fu quello di cercare nelle memorie del popolo, mentre più
fondatamente si sarebbe dovuto cercare tra i manoscritti delle
biblioteche”.
Diversi autori attestarono infatti
l’esistenza della cripta: – Antonino Mongitore in “Palermo divoto di Maria
Vergine” 1719-1720; Gaspare Palermo nella sua “Guida istruttiva per potersi
conoscere con facilità tanto dal siciliano che dal forestiere tutte le –
magnificenze e gli oggetti degni di osservazione della città di Palermo” del
1816; – Girolamo Di Marzo Ferro “Guida istruttiva per Palermo e i suoi
dintorni” 1858 – Gioacchino di Marzo in “I Gagini e la scultura in Sicilia nei
secoli XV e XVI “1880-1883.
Quando fu creata la cripta e per quale scopo?
Antonino Mongitore, riferì come i Lanza
possedevano fin dal 1506 una cappella nella vecchia chiesa di Santa Cita, così
come fi attestato dal Testamento di Blasco Lanza, rogato dal notaio Matteo
Fallera. La chiesa vecchia di Santa Cita o Santa Zita, era stata fondata dal
mercante lucchese Michele Trentino nel Trecento; era poi stata donata dagli
eredi di Trentino ai padri domenicani nel Quattrocento; ma era stata distrutta
alla fine del Cinquecento per essere ricostruita più grande e più bella.
Ottavio Lanza, primo principe di Trabia, ottenne nel 1614 in concessione una
cappella nella nuova Chiesa e la possibilità di potere realizzare una cripta,
dove trovare collocazione alle casse sepolcrali (dei membri della famiglia
Lanza) che erano nella cappella della chiesa vecchia. Nel Medioevo si era
diffusa infatti la consuetudine della pratica del seppellimento all’interno dei
luoghi di culto, perché si riteneva che la santità del luogo fosse trasmessa
anche al defunto. I religiosi concedevano alle famiglie agiate l’uso di
cappelle destinate a sepolture all’interno delle chiese, garantendosi in cambio
rendite utili al loro sostentamento e opere d’arte che arricchivano e
impreziosivano il luogo sacro. Le famiglie più influenti e prestigiose,
sceglievano la loro cappella in prossimità dell’altare maggiore, cioè vicino al
luogo di maggiore santità, dove veniva celebrata la Messa e dove erano
conservate le reliquie dei santi.
A chi appartengono le tombe della cripta?
Nel vano del sottoscala ci sono tre
sarcofagi del Cinquecento. Il primo, sulla sinistra appartiene a Blasco Lanza (
1466 – 1535 ): è una semplice cassa sepolcrale in bianco marmo con un breve
epitaffio:
“D.O.M. Quem solum terries habuit lex utraque fulmen.
Conditur hoc Blascus Lancea sarcofago, vixit annos 69; obit 8 Octobris Ind. IX
1535.
Blasco Lanza fu giurista, giureconsulto,
giudice della Gran Corte, Deputato del Regno, Barone di Catania (1507) e Barone
di Trabia (1509). Nato a Catania nel 1466, secondo il giurista Cutelli era
figlio di uno scrivano di umili origini. Questa versione fu contestata dai
discendenti: affermarono che egli sarebbe nato da un Manfredi, cadetto di
Blasco Lancia barone di Longi.
L’affermazione sociale fu rapida sia
grazie al prestigio professionale che ai due matrimoni con ricche ereditiere.
Sotto la cassa di Blasco vi è un sarcofago che non reca nessuna lapide o
iscrizione, su cui è raffigurata una nobildonna giacente, col capo reclinato su
due cuscini. Il sarcofago sulla sinistra invece è di Castellana Centelles,
seconda moglie di Cesare Lanza morta nel 1574. Cesare Lanza, unico figlio
maschio di Blasco, barone di Trabia e Conte di Mussomeli, aveva educazione
militare e cavalleresca. Da qualche anno si suppone, risponde Maria Oliveri,
che la tomba sotto quella di Blasco Lanza potrebbe appartenere alla nipote Laura
Lanza, figlia di Cesare, più nota come la baronessa di Carini.
Nell’Ottocento la sua immagine di vittima
di un delitto d’onore tipicamente siciliano ebbe grande fortuna e attraverso i
cantastorie si diffuse per tutto il novecento fino a interessare lo stesso
Pasolini. In realtà la storia di sangue e mistero dell’affascinante nobildonna
ci è stata tramandata attraverso la tradizione orale in forme edulcorate che
divergono dagli eventi realmente accaduti.
Si deve al Marchese di Villabianca, nella
seconda metà del XVIII secolo la prima registrazione scritta della leggenda in
ottave siciliane. Salomone Marino, medico di Borgetto, si occupò invece per
primo di ricerche storiche sul caso sventurato della baronessa. Laura Lanza
(1529 – 1563) più nota come Baronessa di Carini, come il padre e il nonno fece
un matrimonio di convenienza, a soli quattordici anni andò in sposa al barone
Vincenzo La Grua Talamanca. Il marito, suo coetaneo, poteva vantare addirittura
sangue reale da parte di madre; ma le terre della baronia di Carini non
rendevano più come una volta e la nobile famiglia si trovava in difficoltà
economiche. Privo di capacità e di spirito di iniziativa, il barone si tenne
sempre lontano dalla vita pubblica siciliana. Dal loro matrimonio nacquero 6
figli. Il barone tuttavia trascurava la moglie, lasciandola spesso sola, per
gran parte dell’anno, nel castello di Carini. Laura aveva una relazione segreta
con Ludovico Vernagallo. Il 4 Dicembre del 1563, colta in flagranza di
adulterio, nel castello di Carini, venne uccisa insieme all’amante, secondo le
logiche del delitto d’onore, dal padre o dal marito o probabilmente da
entrambi.
L’atto di morte narra dei due infelici
amanti, trascritto nei registri della Chiesa Madre di Carini reca la data del 4
Dicembre 1563.
Probabilmente furono seppelliti nella
cripta della Chiesa Madre di Carini. Le ricerche dei RIS e dei periti non hanno
però rinvenuto significative prove che dimostrino la presenza dei resti di
Laura Lanza e Ludovico Vernagallo.
Potrebbe essere stata Laura seppellita nella cappella
di famiglia, nella chiesa vecchia di Santa Cita e poi trasferita nella cripta
insieme alle tombe della matrigna e del nonno?
Forse che si, forse che no, direbbe
Pirandello. La famiglia Lanza era molto potente e molto temuta. Non ci fu
nessun funerale per i due amanti, la notizia dell’assassinio per paura fu
tenuta segreta. Il Paruta scrive nel suo diario: “Sabato a 4 Dicembre. Successe
il caso della Signora di Carini”. Tuttavia il vicerè venne ugualmente a
conoscenza del violento fatto di sangue: Cesare Lanza e il barone di Carini
vennero banditi, i loro beni furono sequestrati ma entrambi si appellarono al
delitto d’onore e la Giustizia li assolse.
Memoriale presentato da Don Cesare Lanza
al Re Di Spagna Filippo II per discolparsi del delitto della figlia Laura.
Sacra Catholica Real Maestà, Don Cesare Lanza, Conte di Mussomeli, fa intendere
a vostra Maestà come essendo andato al castello di Carini a videre la baronessa
di Carini, sua figlia, come era suo costume, trovò il barone di Carini, suo
genero, molto alterato perché avia trovato in mismo istante nella sua camera
Ludovico Vernagallo, suo innamorato con la detta baronessa, onde detto
esponente mosso da iuxto sdegno in compagnia di detto barone andorno e trovorno
detti baronessa et suo amante nella ditta camera serrati insieme et cussì
subito in quello stanti foro ambodoi ammazzati. Don Cesare Lanza Conte di
Mussomeli
Una storia davvero avvincente!
Molti registi negli anni, infatti, ne hanno tratto dei film e commedie; un motivo
in più per visitare Palermo e i suoi” tesori nascosti”, come la Cripta Lanza.
Chiara Fici
    
......................................................... Nota
N. 5 Baronessa di
Carini Opera di Giuseppe
Mulè
Nato a Termini Imerese era il quarto di cinque figli. All’età di 20 anni conseguì il diploma di violoncello e successivamente quello di composizione, sotto la guida di Guglielmo Zuelli, presso il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo. Nel 1903, ancora non aveva finito gli studi accademici, compose un “Largo” per violoncello e pianoforte che fu utilizzato come sigla d’apertura nelle trasmissione radiofoniche nazionali “Eiar” e “Rai”. Quando concluse gli studi al Conservatorio, si dedico alla carriera di direttore d’orchestra. Fu direttore del Conservatorio di Palermo dal 1922 al 1825 e successivamente coprì la stessa carica presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma dal 1925 al 1945. Fu segretario nazionale del Sindacato Nazionale Fascista Musicisti e, insieme ad Adriano Lualdi, capofila dell'area più reazionaria della poetica musicale del regime fascista. Durante il Ventennio osteggiò strenuamente con tutti i suoi mezzi ogni movimento di avanguardia modernista. Era sposato con il soprano Lea Tumbarello (1893-1967). Morì a Roma nel 1951 e fu sepolto nella sua Termini Imerese. Il figlio, Francesco Mulè, fu un attore cinematografico e teatrale di successo. Baronessa di Carini è una tragedia lirica in un atto composta da Giuseppe Mulè su libretto del fratello Francesco Paolo Mulè. La prima rappresentazione si svolse al Teatro Massimo di Palermo, il 16 aprile 1912. L'opera, che rivelava il talento melodrammatico del compositore, fu accolta con grande entusiasmo dal pubblico siciliano. Personaggi - Caterina La Grua (interpretata da Claudia Muzio), figlia del barone di Carini. Donna sui venti anni. - Don Vincenzo La Grua, barone di Carini. Uomo sui cinquantacinque anni, di carattere rigido e duro; tenace ed irremovibile nei suoi rancori. Odia spietatamente la famiglia di Vernagallo. - Ludovico Vernagallo, cavaliere gagliardo e bello sui ventotto anni - Matteo, uomo sui quaranta anni, brutto e un po' gobbo. È stato messo dal barone a custodia della figlia nel Castello di Carini. Ipocrita e malvagio, porta un saio da frate per nascondere sotto la maschera della religione i suoi istinti perversi. - Violante, nutrice di Caterina, cinquantenne. Trama La vicenda si svolge nel 1563. Il castello di Carini, da sempre allegro e maestoso, è stato trasformato dal barone nella tetra prigione in cui rinchiude Caterina, sua figlia. La baronessa è colpevole unicamente di amare un giovane palermitano, Ludovico Vernagallo, di una casata nemica. Caterina è spiata da Matteo, malvagio lacchè del barone, che, invidioso del sentimento provato dai due amanti, decide di orchestrare un piano affinché Ludovico venga ucciso. Durante la notte, quest'ultimo riesce a intrufolarsi all'interno del castello e, con l'aiuto della nutrice Violante, a raggiungere le stanze di Caterina. I due trascorrono la notte insieme ma alle prime luci dell'alba, improvvisamente, odono il canto dei contadini, dapprima gioioso e di buon auspicio, diventare grave e angosciante. Violante scorge una figura muoversi nella pineta che circonda la tenuta: è il barone che, allertato da Matteo, si dirige furioso verso il palazzo. Ludovico si nasconde frettolosamente ma, al tempo stesso, preoccupato per il destino di Caterina. Nel frattempo, il barone, sopraggiunto nelle stanze della figlia, la minaccia affinché gli confessi dove si nasconde il suo amante. Ludovico si rivela, pronto a morire pur di salvare Caterina. Il barone gli si scaglia addosso ma Caterina si interpone tra i due uomini e rimane ferita. L'uomo, sconvolto dal parricidio appena commesso, si dilegua. La tragedia è stata commessa: e, allora, Violante e Ludovico, chiamato inutilmente aiuto, restano al fianco della baronessa sino al suo ultimo respiro. Titolo Originale: Baronessa di Carini Lingua originale: Italiano Genere: Tragedia Lirica Musica: Giuseppe Mulè Libretto: Francesco Paolo Mulè Atti: Uno Dedica: Al tuo nome santo, alla tua santa lacrimata memoria, povero diletto padre nostro Prima Rappresentazione: 16 aprile 1912 Teatro: Teatro Massimo – Palermo Personaggi: Caterina La Grua - soprano Don Vincenzo La Grua - basso Ludovico Vernagallo - tenore Matteo - baritono Violante - mezzosoprano
Barone di Carini (basso),
figurino di artista ignoto per Baronessa di Carini (1912),
Archivio Storico Ricordi






...............................................Nota
N. 6 "L'amaro caso della
baronessa di Carini" è uno sceneggiato del 1975 diretto
da Daniele D'Anza e trasmesso in 4
puntate sul Programma Nazionale (l'odierna
Rai 1) dal 23 novembre al 14 dicembre 1975.
Scritto
da Daniele D'Anza e Lucio Mandarà, si ispira a una ballata
popolare siciliana, che narra di un delitto realmente avvenuto
a Carini il 4 dicembre 1563: la baronessa di Carini,
donna Laura Lanza, moglie di don Vincenzo La Grua-Talamanca, fu uccisa,
ufficialmente per motivi d'onore, dal padre don Cesare Lanza. Nello
sceneggiato, la data della morte è stata anticipata di otto mesi, il 4 aprile
1563. Nella prima puntata, prima dell'inizio della storia, compare lo
sceneggiatore Lucio Mandarà insieme a Otello Profazio che spiega gli
eventi reali e le modifiche apportate alla vicenda, in immagini girate in
bianco e nero, intervistando gli abitanti di Carini. Lo sceneggiato venne
realizzato a colori su pellicola cinematografica, ma nella prima trasmissione
gli spettatori lo videro in bianco e nero; a colori venne trasmesso soltanto
nelle repliche successive dal 1º febbraio del 1977, dopo l'avvio ufficiale
delle trasmissioni col sistema Pal.
Venne
prodotto da Arturo La Pegna per la CEP Produzioni Cinematografiche in
collaborazione con la Rai. Paolo Stoppa, che impersona don Ippolito, oltre
ad interpretare quel ruolo, nelle quattro puntate ha anche la funzione di
narratore durante lo svolgimento della vicenda, rimanendo con gli abiti di scena
a differenza di Accadde a Lisbona. Il consulente per la lingua
siciliana è Andrea Camilleri.
Trama
Prima puntata
Sicilia, 1812.
Sta per entrare in vigore la prima costituzione liberale, che mette fine
ai privilegi dei grandi feudatari. Il rappresentante più autorevole del nuovo
corso politico è il Principe di Castelnuovo, ministro delle finanze, che
incarica un suo uomo, Luca Corbara, di svolgere indagini per accertare la
legittimità del possesso dei feudi.
Come
punto di partenza della sua ricerca, Luca sceglie il feudo Daina Sturi di Carini appartenente
ad un barone, don Mariano D'Agrò. Al suo arrivo, il giovane assiste a un
episodio di violenza: gli uomini di don Mariano percuotono un cantastorie, Nele
Carnazza, reo di aver cantato una canzone proibita dal barone, la ballata che
narra la tragica morte della baronessa di Carini, Caterina La Grua - Talamanca,
uccisa per motivi di onore dal marito tre secoli prima.
Dalla
gente del luogo, Luca è accolto con diffidenza e sospetto. I soli a
dimostrargli simpatia sono il suo ospite don Ippolito, un bizzarro e filantropo
amico del principe di Castelnuovo, e Cristina, la figlia del notaio di Carini.
Nella
canzone di Nele, Luca crede di trovare una traccia per le sue ricerche:
l'attuale feudo di Carini è probabilmente costituito in parte da terre usurpate
all'amante della baronessa, che venne ucciso assieme a lei, e la legittimità
del possesso del feudo da parte di don Mariano può forse essere messa in
discussione.
 I
protagonisti Janet Agren (donna Laura D'Agrò) e Ugo Pagliai (Luca
Corbara) I
protagonisti Janet Agren (donna Laura D'Agrò) e Ugo Pagliai (Luca
Corbara)
Il
barone, oscuramente minacciato da una misteriosa setta, i Beati Paoli,
sospetta di Luca, ritenendolo autore di un messaggio minatorio, e lo fa
rinchiudere nel castello abbandonato che fu teatro dell'assassinio della
baronessa. Luca è liberato da una donna misteriosa, che perde una preziosa
spilla nel cortile del castello. Il giovane crede d'identificare la sua
soccorritrice nella baronessa Laura, moglie di don Mariano. Invitato a una
battuta di caccia dal barone, Luca salva la vita alla baronessa. La donna nega
che la spilla trovata da Luca sia sua, nonostante appaia anche su un vecchio
ritratto di famiglia presente nel palazzo.
Luca,
recatosi successivamente a casa di Nele per avere altre informazioni
sull'antica canzone, lo trova assassinato. Sorpreso da Rosario, l'uomo di
fiducia del barone, il giovane si dà alla fuga e viene catturato da alcuni
misteriosi incappucciati.
Seconda puntata
Accusato
dai Beati Paoli dell'assassinio di Nele Carnazza e assolto dopo un
bizzarro processo, Luca viene rilasciato. Dopo una fugace visita amorosa a
Laura, il giovane si rifugia a Palermo, presso l'amico Enzo Santelia,
segretario del principe di Castelnuovo. Ricevuto dal principe, Luca apprende
che forse il Re dovrà rinunciare a promulgare la Costituzione e quindi la sua
missione potrebbe essere annullata.
Recatosi
all'interno di una chiesa, Luca scopre, leggendo un'iscrizione tombale, che la
baronessa di Carini fu uccisa non dal marito, come erroneamente si crede, ma
dal padre, don Cesare Lanza. Mentre Luca è preso dalle sue riflessioni, nella
chiesa entra Laura: gli comunica che il barone ha scoperto il suo rifugio e lo
invita a nascondersi in una torre sul litorale.
A
Carini, intanto, i Beati Paoli rapiscono don Mariano D'Agrò.
Terza puntata
Il
capo dei Beati Paoli offre a don Mariano la libertà, a patto che scagioni Luca
Corbara dall'accusa di omicidio: il barone accetta e viene rilasciato. Laura
informa quindi Luca che può tornare a Carini.
Tornato
a Carini, Luca è rimproverato da don Ippolito, che vede addensarsi sul giovane
amico alcuni nefasti presagi. Attorno all'amore tra Luca e la baronessa Laura
sembra crearsi una misteriosa atmosfera, in cui pare rivivere il passato
evocato dalla ballata: Laura è infatti una discendente della baronessa uccisa,
la quale si chiamava anch'ella Laura e non Caterina, anch'ella protagonista di
una segreta storia d'amore. Don Ippolito, temendo che la tragica vicenda possa
ripetersi, invita ripetutamente Luca a troncare la relazione.
Il
barone, rese pubbliche scuse a Luca, gli offre l'incarico di riordinare i suoi
documenti. Luca accetta nella speranza di trovare tra le carte del barone
qualche documento che provi l'usurpazione del feudo Daina Sturi.
Nel
frattempo il capo dei Beati Paoli, la cui identità è avvolta nell'ombra, impone
al barone di riconoscere Domenico Galeani, un suo figlio illegittimo, e di
legittimarlo come proprio erede. Luca scopre che Giuseppe Carnazza, il figlio
di Nele, è un membro della setta dei Beati Paoli e lo prega d'informarlo su
ogni mossa della setta. Tra i membri della setta serpeggia però il malumore in
seguito alla fuga di Rosario, l'assassino di Nele, che essi avevano catturato.
Giuseppe accusa il capo di tradimento e per questo viene da lui ucciso.
Intanto
Luca, approfittando dell'assenza del barone dal palazzo, trascorre con Laura
una notte d'amore.
Quarta puntata
Durante
una cena a palazzo, don Mariano organizza per il mattino seguente una visita al
castello di Carini, a cui partecipano lo stesso barone, la baronessa Laura,
Luca Corbara e Cristina, la figlia del notaio. Durante l'escursione i quattro
raggiungono il luogo in cui tre secoli prima fu assassinata la baronessa di
Carini. Sorta una controversia tra il barone e Luca circa la dinamica
dell'avvenimento, il nobiluomo illustra la propria tesi, costringendo la moglie
a inscenare con lui l'antico assassinio. Impaurita dalla spada estratta dal
marito, la giovane si tradisce invocando il nome di Luca e gettandosi tra le
sue braccia.
Luca
apprende da Ignazio Buttera della morte di Giuseppe e i due si accordano per
vendicare l'amico e sopprimere la setta dei Beati Paoli. Enzo Santelia si
presenta sotto falso nome a palazzo D'Agrò per parlare con Luca: don Mariano,
ascoltando di nascosto i loro discorsi, apprende dell'incarico governativo di
Corbara. Dietro suggerimento di don Ippolito, Luca comincia a sospettare che
Enzo Santelia sia in realtà Domenico Galeani, il figlio illegittimo del barone.
Recatosi a palazzo, Luca legge l'atto con cui il barone riconosce Domenico,
lasciato in bella vista proprio da don Mariano, che conta di servirsi di Luca
per sbarazzarsi sia del figlio che dei Beati Paoli.
 Il produttore
Arturo La Pegna, l'attore Paolo Stoppa (don Ippolito) e il
regista Daniele D'Anza in un momento di pausa sul set. Il produttore
Arturo La Pegna, l'attore Paolo Stoppa (don Ippolito) e il
regista Daniele D'Anza in un momento di pausa sul set.Incontratosi
con Laura, Luca la mette al corrente di tutto, anche del suo incarico di
ispettore governativo. Presentatosi in incognito alla riunione della setta a
Palermo, Corbara ne smaschera e fa arrestare dalle truppe del principe di
Castelnuovo il capo, che si rivela essere Enzo Santelia, ovvero Domenico Galeani. Tornato
a Carini, Luca sospetta che Laura, d'accordo col marito, abbia tramato alle sue
spalle ed è caldamente invitato da don Ippolito a troncare ogni rapporto con la
donna. Luca ammette di essere un discendente di Ludovico Vernagallo, l'amante
della baronessa di Carini, e di essere intenzionato a riprendersi ciò che gli
spetta: il feudo di Daina Sturi. Convocato
d'urgenza a palazzo D'Agrò per un grave malore della baronessa, Luca accorre
trovando la donna in perfetta salute. Luca l'accusa di averlo attirato in una
trappola e le mostra come prova le tante lettere anonime indirizzategli da una
mano femminile: Laura riconosce la scrittura di Cristina, che ha scoperto
essere l'amante di don Mariano. I
due iniziano a temere di essere le prossime vittime degli intrighi del barone.
Ma è troppo tardi: ormai è il 4 aprile e, come don Ippolito aveva previsto con
largo anticipo, il presagio di morte evocato dall'antica ballata finisce per
avverarsi. Laura è assassinata, e stessa sorte tocca a Luca, pugnalato da
Rosario. I corpi dei due sfortunati amanti, per ordine di don Mariano, sono
infine adagiati sul letto, come quelli dei loro antenati tre secoli prima. Lo
sceneggiato ebbe un grande successo in Spagna dove venne presentato alla
televisione spagnola con il titolo: El amargo caso de
la baronesa Carini Il
teso della “Ballata di Carini” fuu scritto da Otello Profazio, tratto da una
delle tante versioni del poemetto anonimo. Fu musicata da Romolo Grano e
cantata, in lingua siciliana, da Luigi Proietti: «Chianci Palermu, chianci Siracusa a Carini c'è lu luttu in ogni casa. Attorno a lu Casteddu di Carini, ci passa e spassa nu beddu
cavaleri. Lu Vernagallu di sangu gintili ca di la giuvintù l'onuri teni. "Amuri chi mi teni a tu'
cumanni, unni mi porti, duci amuri,
unni?" Vidu viniri 'na cavallaria. Chistu è me patri chi veni pi mmia, tuttu vistutu alla cavallarizza. Chistu è me patri chi mi veni a
'mmazza. Signuri patri, chi vinisti a fari? Signora figghia, vi vegnu a
'mmazzari. Lu primu corpu la donna cadiu, l'appressu corpu la donna muriu. Nu corpu a lu cori, nu corpu 'ntra
li rini, povira Barunissa di Carini.»
.......................................................
Nota N. 7 La
Baronessa di Carini Miniserie
TV – Anno 2007
Genere:
drammatico, giallo, in costume
Durata:
200 m
Lingua
Originale: Italiano
Regia:
Umberto Marino
Soggetto:
Lucio Mandarà, Anna Samueli:
Sceneggiatura:
Lorenzo Favella, Anna Samueli, Enrico Medioli;
Interpreti
e soggetti:
Vittoria
Puccini – Laura
Luca
Argentero: Luca
Enrico
Lo Verso: Don Mariano
Lando
Buzzanca: Don Ippolito
Alessandro
Dieli: capitano dei gendarmi
Simone
Gandolfo: Santelia
Lucia
Sardo: governante
Carmelo
Rosario Cannavò: Don Desi
Franco
Vella: contadino
Fotografia:
Giovanni Cavallini;
Montaggio:
Roberto Siciliano;
Musiche:
Paolo Vivaldi;
Prima
Visione dal 14 ottobre 2007 al 15 ottobre 2007
Rete
Televisiva: Rai 1
La miniserie è un remake dello sceneggiato TV
del 1975 L'amaro caso
della baronessa di Carini, con Ugo
Pagliai, Janet Agren, Adolfo Celi ed Enrica
Bonaccorti.
Trama
Sicilia, 1860.
Laura viene data in sposa al barone di Carini, don Mariano La Grua, uomo
violento e prepotente. La vita della giovane baronessa sembra destinata
all'infelicità fino all'incontro con Luca Corbara, il quale giunge in Sicilia
alla ricerca delle proprie origini, rappresentate da un medaglione sul quale è
inciso un nome dall'oscura provenienza (Vernagallo).
Accompagnato
a Carini da Enzo Santelia, suo vecchio amico, Luca viene a conoscenza della
vicenda avvenuta trecento anni prima nel castello abbandonato dove l'allora
baronessa venne uccisa dopo essere stata scoperta in compagnia del proprio
amante. Quella tragica storia sembra ossessionare Laura, la quale è spesso
preda di incubi e malesseri che le avvelenano l'esistenza. Luca la convince a
farsi curare da un medico, l'eccentrico don Ippolito, che la sottopone ad
alcune sedute d'ipnosi, durante le quali Laura sembra rivivere la tragica
sequenza della baronessa uccisa, come in preda a una reincarnazione. Luca rifiuta
l'idea che tra la “sua” Laura e quella donna uccisa tre secoli prima possa
esserci un legame e, innamorato della baronessa, decide di fuggire con lei.
In
procinto di lasciare Carini, Luca viene però catturato dai "Beati
Paoli", un'inquietante setta segreta capitanata da un misterioso individuo
che nasconde il proprio volto sotto un cappuccio nero. Accusato dell'omicidio
di un cantastorie, Luca si proclama innocente e riesce a fuggire rifugiandosi
presso l'amico Santelia. In occasione di un ballo, riesce finalmente a
riabbracciare Laura. Per i due giovani amanti si riaccende la speranza: forse
possono ancora fuggire imbarcandosi su una nave in procinto di salpare dal
porto di Palermo. Ma all'ultimo momento il piano va in fumo e Luca non può far
altro che tornare a Carini. Laura teme per la vita di entrambi ed insiste col
dire che anche loro verranno scoperti e uccisi come i due amanti del
cinquecento. Frattanto la dama di compagnia della baronessa, Cristina, scoperta
la passione tra Laura e Luca, tende una trappola alla donna inducendola a
dirigersi verso l'antico castello dei La Grua, inseguita di nascosto dal
marito. Luca invece, volendo scoprire cosa davvero fosse successo ai suoi
antenati, con l'aiuto di Ippolito viene sottoposto ad ipnosi, rivivendo così l'atto
dell'uccisione degli amanti. Dopo essersi svegliato dallo stato ipnotico, Luca,
ascoltando una breve discussione tra il parroco di Carini e il medico, apprende
la notizia che Laura sta dirigendosi verso il castello inseguita da don
Mariano, bramoso di vendetta, e decide così di scappare dallo studio di
Ippolito per salvare la donna amata: è il 20 maggio 1860, giorno in cui 300
anni prima si consumò la sanguinosa vicenda di Laura e Ludovico. Arrivata al
castello, Laura ritrova Luca ma, seguito dalla donna, entra Don Mariano che,
sguainata la spada per lavare il disonore, ingaggia con Luca un duello
all'ultimo sangue. Durante la lotta tra i due uomini, una torcia cade su di una
tenda della stanza dell'antica baronessa, facendo divampare così un incendio.
Luca riesce a colpire a morte il suo avversario che quindi cade sul pavimento
esanime. A seguito di ciò, i due giovani cercano di scappare ma l'uscita viene
bloccata dalla caduta delle travi del soffitto a causa dell'incendio. Memore
però della seduta ipnotica che l'ha visto protagonista, Luca trova, sul muro
dove la baronessa aveva lasciato la propria impronta insanguinata, una porta
segreta che doveva fungere da via di fuga per gli antichi amanti. Aprendo il
passaggio, i due riescono a sfuggire alla morte ritrovandosi in un corridoio
che li porterà oltre le mura del castello. Ormai liberi e sempre più
innamorati, Luca e Laura posso amarsi liberamente coronando allo stesso tempo
il sogno d'amore della povera baronessa e del suo amante.
Produzione
Le
riprese si sono svolte nel Lazio e in Sicilia utilizzando
diversi palazzi per ambientare tutte le ricchissime scene di palazzo La Grua,
dimora dei Baroni di Carini. Nel Lazio le riprese sono state effettuate a
Palazzo Massimo ad Arsoli, circa 60 chilometri da Roma, la cui struttura
risale al decimo secolo: era proprietà dei Benedettini ed è poi passato alla
famiglia romana dei Massimo. Lì è stata ricostruita parte del palazzo La Grua,
in particolare la camera da letto di Laura, il suo salottino, una veduta del giardino,
la foresteria. A Roma, negli studi di Cinecittà sono state
ricostruite invece le stanze e alcuni interni del castello cinquecentesco di
Carini per realizzare le scene dei flashback e alcune scene d'amore tra Laura e
Luca. Sempre nel Lazio, a Oriolo Romano e a Nepi, sono state
girate tutte le scene della caverna dei Beati Paoli.
Il
2 aprile sono iniziate le riprese in Sicilia in alcune delle più belle ville
dell'isola: Villa de Cordoba a Palermo, utilizzata come ingresso del
palazzo La Grua per la sua splendida facciata; Villa Palagonia a Bagheria,
dove sono ambientati alcuni corridoi; Villa Wirz a Partanna, usata per i
giardini particolarmente rigogliosi e per i viali usati dai cavalieri; lo
splendido Palazzo Mirto in cui sono state girate le scene della sala da pranzo
e del salone dei ricevimenti della sontuosa dimora dei Baroni di Carini. Il
castello di Mussomeli che tra l'altro è stato in passato proprietà di Cesare
Lanza, padre di Laura divenuta baronessa di Carini, è stato usato come immagine
e location del castello abbandonato dove nel '500 si compì il destino della
baronessa. Altre scene sono state girate nella chiesa dello Spasimo a Palermo e
nella chiesa della Martorana mentre alcuni degli splendidi esterni hanno come
sfondo la piana degli Albanesi e la campagna vicino alle rovine del
castello di Cefalà Diana. La troupe si è quindi trasferita
a Erice che è stata usata come set della città di Carini.
Nel
cast vi sono molti attori di origine siciliana non solo tra gli interpreti
principali (Buzzanca, Lo Verso), ma anche negli altri ruoli al fine di
sottolineare e mantenere il colore di questa regione così particolare. Tra gli
aneddoti, un'inaspettata neve primaverile caduta su Arsoli durante le
riprese e la carrozza della baronessa già utilizzata dal regista Luchino
Visconti nel Gattopardo.
.............................................
Nota:
N- 8
Le Chiese di Carini
indagate per la sepoltura di Donna Laura Lanza.
Chiesa delle Anime Sante
del Purgatorio
Secondo la tradizione carinese sarebbe la prima Chiesa
Madre, costruita entro la cinta muraria del Castello, e confusa nei secoli con
la vecchia chiesa di San Giuliano non più esistente. Nella realtà la chiesa del
Purgatorio (XV-XVI secolo) fu completata
agli inizi del 1600, ed intitolata al Gesù e alle Anime Sante del Purgatorio. A
unica navata, è ornata da stucchi e quadri riconducibili ai fratelli Manno e a
Giovanni Patricolo. A suo interno si custodisce ancora la statua di fine
Cinquecento che raffigura San Giovanni Battista, ancora oggi portata in
processione a fine giugno.
.........................................
Nota
Siti Archeologici
Data la storia della città e i molteplici insediamenti nel territorio, Carini presenta numerose aree archeologiche, in cui sono stati ritrovati reperti di varie epoche storiche: - Area Archeologica Baglio-Carburangeli: consiste in una fascia di terra, con estensione mediamente pari a 150 m, che a partire dal Baglio di Carini, si estende per circa un chilometro verso sud-ovest, costeggiando nel primo tratto la costa e poi proseguendo nell'entroterra fin presso la grotta di Carburangeli. All'interno delle tombe a fossa, oggi distrutte dalle costruzioni di alcuni edifici, sono stati rinvenuti reperti che rilevano l'occupazione del territorio sin dal III secolo a.C. I reperti, conservati in parte presso il Museo Nazionale di Palermo, consistono in fondi di anfore, macine in pietra lavica, frammenti di lucerne e una base di colonna di marmo di epoca tardo romana.
- Area archeologica contrada “S. Nicola”: durante gli scavi effettuati nella zona sono stati rinvenuti importanti reperti di epoca romana bizantina, fra cui un mosaico basilicale e una moneta bizantina dell'età di Giustiniano. Nei pressi della contrada, individuata come possibile sede della “Hyccara” descritta da Tucidide, nella costa ad est di Carburangeli, è stata scoperta una zona ricca di ceramiche del V sec. a.C.

-
Area
archeologica “Moscala”: vi sono presenti segni di un insediamento urbano, con
tracce di mura, massi di tufo lavorato, utensili e frammenti di ceramica del
III, IV e V sec. a.C.
-
Area
archeologica “Manico di Quarara”: è stata ritrovata una necropoli della civiltà
Elima.
- Area archeologica “Ciachea”: nei pressi del confine tra Capaci e Carini si estende una vasta necropoli, risalente all'eneolitico, dove è stata ritrovata la ceramica “Bicchiere di Carini”, unica nella sua fattura, datata nel 4.000 a.C.


Di
notevole importanza sono le catacombe rinvenute nei pressi di Villagrazia di
Carini, che si estendono per circa 3.500 m² e confermano l'esistenza di
una vasta comunità cristiana nel territorio e, probabilmente, di una sede
vescovile. Di notevole interesse sono le numerose grotte distribuite nel
territorio, che hanno permesso il ritrovamento di numerosi resti di fauna
preistorica.
.............................................
Nota
N. 10
L'ultimo delitto
d'onore fu in Sicilia nel 1964:
la relazione tra
il professore universitario e MariatenaNel 1964 un
maestro elementare uccise un professore del Magistero dopo aver scoperto che il
docente era stato il seduttore della figlia. L'opinione pubblica si schierò con
il padre Maria
Oliveri
Storica, saggista e operatrice culturale
2 aprile
2022
Catania, 20
ottobre 1964, ore 18.
In via Ofelia si ferma una automobile di
media cilindrata davanti all’Istituto Universitario di Magistero.
Dall’auto
scendono un uomo sulla quarantina ed una ragazza poco più che diciottenne. Lui
è magro, vestito di nero. Il suo nome è Gaetano Furnari, maestro elementare di
Piazza Armerina ed attivista comunista. La
ragazza è Maritena, Maria Catena, una studentessa inscritta al primo anno di
corso dello stesso Magistero. L' uomo, seguito dalla giovane, s' infila nel portone
dell' istituto, sale di corsa le scale ed entra nell'aula dove sta tenendo
esami il professore Francesco Speranza. L’aula è affollata da numerosi studenti per gli esami
della sessione autunnale. Il prof. Francesco Speranza ha 48 anni ed è titolare
della cattedra di geografia presso l’Istituto di Magistero e presiede la
commissione esaminatrice. I
docenti hanno appena finito di interrogare uno studente quando improvvisamente
la porta dell’aula si spalanca e tra lo stupore e la curiosità dei presenti un
uomo maturo si dirige con piglio deciso verso la cattedra. È magro, stempiato,
pallido… ha una mano in tasca. Si ferma di fronte a Speranza, estrae una
beretta 7,65 (che come si scoprirà veniva detenuta illegalmente) e la punta
contro il docente esclamando: “La
conosci questa?” Prima
che Speranza riesca anche solo a esclamare qualcosa, l’uomo preme il grilletto
e spara cinque colpi, uccidendo il docente. Gli studenti sono in preda al
panico: si odono grida, vi è un gran trambusto. Qualcuno cerca invano di soccorrere
il professore, che si è accasciato in un mare di sangue, ma ormai non c’è più
nulla da fare… Nella
confusione generale Furnari fugge a precipizio dal palazzo e poi vaga senza
meta per una decina di minuti; infine si costituisce in una caserma dei
carabinieri: “L’ho ucciso per
vendicare l’onore della mia figliola” dichiara
ai militari che cercheranno di ricostruire l’antefatto del delitto. L' omicida viene accompagnato in questura assieme a
Maritena, stordita e agitatissima. Interrogato sul movente del delitto,
dichiara di aver ucciso il docente perché questi gli ha sedotto la figlia, sua
allieva. La stessa Maritena, infatti, poche ore prima del delitto, in un'
esplosione di rabbia, aveva raccontato al padre di essere stata violentata con
l'inganno dal professore di geografia (ma si scoprirà poi che non c' è stato
nessun inganno, tant'è vero che lo stesso Furnari sbotterà con amarezza: «Se
l' avessi saputo, non l' avrei fatto!»). Ma come andarono realmente le cose? Furnari abita a Piazza
Armerina, in provincia di Enna, nella palazzina di famiglia dove sul portone vi
sono ancora le iniziali di suo padre: Filippo Furnari. Da due anni la
figlia diciannovenne Maria Catena, che tutti chiamano Maritena, si è trasferita
a Catania per poter proseguire gli studi all’Università e vive in una pensione. La
studentessa teme a causa di un ritardo del ciclo di aspettare un bambino e lei
stessa rivela al padre, di ritorno da scuola, di essere stata sedotta contro la
sua volontà dal professore Speranza. La ragazza parla di un unico episodio di
violenza. Il genitore rimane stravolto, piomba nella più cupa disperazione, si
mette le mani sul viso e poi le dice
“Vestiti e andiamo
a Catania. Dato che tu si stata posseduta dal professore Speranza è giusto che
io vada da lui e che ti consegni a lui perché si prenda cura di te.” I piani di Furnari
tuttavia sono diversi da quelli che espone alla figlia, probabilmente per non
metterla in allarme. Il maestro e la figlia
partono nel primo pomeriggio, prendono un’automobile a noleggio e chiedono
all’autista di dirigersi direttamente al Magistero, dove nel pomeriggio
Speranza deve fare gli esami. Poi l’arrivo in aula e la tragedia che la figlia
non aveva previsto né immaginato. L’imputato, che presta fede al racconto di
Maritena atteggiatasi a vittima di violenza carnale, durante il processo
scoprirà che i fatti sono andati diversamente e che la ragazza era
consenziente: tra il professore e la sua studentessa Maritena c'era una
relazione. Speranza
è un cinquantenne brizzolato e di bell'aspetto. Colto al punto giusto, elegante
nel portamento e signorile nei modi fare. Riscuote successo con le studentesse
che gli ronzano attorno compiacenti. Tra queste la bella Maritena, esuberante e
smaliziata, tutta presa dalla dolce vita catanese. L' alunna subisce il fascino
del professore. Cede volentieri alle sue avance. Sale a bordo della sua Appia.
E in una stanza del Paradiso dell' Etna soddisfa le voglie del docente-dongiovanni
in cambio di un trenta e lode. Col padre, taciturno e tutto d' un pezzo, la
ragazza ha poca confidenza. Anche perché Furnari è uno all' antica, un
ortodosso della morale, rigido coi figli e intransigente con sé e con gli
altri. Ma è anche un uomo buono - lo dicono tutti in paese - Un insegnante
equilibrato dalla condotta irreprensibile. Che però quel giorno di ottobre, di
fronte alla rivelazione della figlia, perde la testa. è un animale ferito a
morte che non controlla i suoi istinti.
Il
maestro di Piazza Armerina viene processato nel novembre del 1965 per omicidio
volontario. Furnari cerca di spiegare al processo la sua posizione:
“Quello che per me era
un dubbio il giorno successivo quando mia figlia mi ha fatto la confessione è
diventata una realtà… Mia figlia aveva 19 anni, era una signorina, era
l’ultimogenita, l’unica figlia femmina… era tutto per me! Era quella che
alimentavo direi quasi con il mio alito per portarla avanti. Avevo contato
nello studio perché si portasse avanti, senza pretese comunque: quando lo vuoi
fare l’esame lo fai, se non sei sufficientemente preparata ci rinunci, tanto il
tempo non ha valore nel raggiungimento di uno scopo.”
La
stampa mostra comprensione per l’assassino dai modi pacati e dalla voce
flemmatica. I giornalisti scrivono che Furnari è un insegnante severo ma buono
che viene guardato con rispetto a Piazza Armerina dove lo definiscono leale,
equilibrato, comprensivo. Persino il pubblico ministero, il giovane Lorenzo
Inserra, sembra cercare delle attenuanti al delitto e definisce il maestro
«l'unico vero galantuomo del processo», colpevole solo di non aver saputo
controllare la sua ira. Giuseppe Alessi che regge il collegio di difesa afferma in modo teatrale che “Il peccato e il
delitto sono nati ed esplosi nella scuola: insegnante è l'omicida; docente
universitario l'ucciso; studentessa del Magistero la sedotta; il banco, la
cattedra, gli esami sono stati l'occasione e la degradante condizione del
disonore e dell'omicidio! Ebbene, il Furnari, primo gradino della scala, ha
incarnato la norma morale; ai vertici di quella piramide il professore di
Università la ha infranto!». La
colpa moralmente più grave secondo la difesa è dunque quella di Speranza, che
ha abusato della sua
posizione per poter soddisfare le sue voglie. Alcuni giornali invece attaccano Maria Catena, definita “la ragazza trenta e
lode”, che avrebbe ceduto alle avances del professore solo per ottenere un buon
voto e che non ha esitato ad armare la mano dell’assassino, ricorrendo a una
menzogna: ai giornalisti non è sfuggito lo schiaffo del giovane Dario Speranza,
figlio del professore, alla studentessa nell’aula del processo. Del resto
quando di questione di onore trattasi è opinione diffusa che la donna non sia
mai esente da colpa… Il 23 dicembre 1965, dopo 12 udienze, l'imputato viene riconosciuto colpevole
ma i giudici gli concedono tutte le attenuanti del
delitto d’onore: Furnari viene condannato a due anni e undici mesi di
reclusione. Una pena mite, che fa del maestro di Piazza Armerina l' ultimo
giusto vendicatore dell' onore. Il pubblico applaude la sentenza eppure l'
avversione per l’art. 587 lentamente comincia a farsi strada. Nel clima
crescente di indignazione di una parte dell’opinione pubblica interviene anche
Leonardo Sciascia per esprimere un giudizio critico sull'assurdità e stupidità
del delitto d'onore e sulla inciviltà dell'articolo di legge che lo contempla. La sentenza Furnari del 1965 fu "l'ultima volta" del
delitto d'onore in Italia: l’art. 587 non verrà più applicato, nel 1981
finalmente verrà abolito.
 https://www.facebook.com/cantastorie.contastorie/photos/a.259224610925028/386882284825926/?type=3&locale=it_IT https://www.facebook.com/cantastorie.contastorie/photos/a.259224610925028/386882284825926/?type=3&locale=it_IT
Nel 1968 venne abrogato il reato di
adulterio:
nel 1970 fu introdotto il divorzio;
nel 1978 venne regolamentato
l’aborto;
il 5 settembre 1981, con la legge
442, vennero abrogate le disposizioni sul “Delitto d’Onore”.
 Arringa
dell'avvocato in «Divorzio all'italiana»
(Film di Pietro
Germi del 1981) https://www.youtube.com/watch?v=FewpiU54GTw&t=158s Il 5
settembre 1981 in Italia vengono aboliti il delitto d’onore
e il matrimonio riparatore, due lasciti legali del Codice Rocco di epoca
fascista. La loro abolizione è considerata un punto di svolta fondamentale per
i diritti della persona in generale e delle donne in
particolare. Il
delitto d’onore era un’espressione presente nel Codice
Penale per indicare un particolare tipo di omicidio che, causato per
difendere “l’onore”, risultava in una pena minore per l’assassino. Il Codice
Penale stesso all’articolo 587 recitava: “Chiunque
cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne
scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato
dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da
tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze,
cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col
coniuge, con la figlia o con la sorella.” L’art.
587 del Codice Penale Rocco in vigore dal ventennio fascista, fino al 1981,
concedeva in caso di omicidio per disonore, uno sconto della pena. In questo
modo lo stato giustificava parzialmente il delitto stesso. Il matrimonio riparatore era invece regolamentato dall’articolo 544, che recitava così: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il
matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il
reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è
stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Riassumendo,
per il colpevole di stupro il reato si estingueva se lo stesso si rendeva
disponibile a sposare la vittima, spesso minorenne. A sollecitare la richiesta
del matrimonio riparatore erano soprattutto i familiari della
vittima che non vedevano altra strada per ripristinare il loro onore
perduto. Ciò sia per non alimentare il vociare popolare in una società spesso
ancora di mentalità patriarcale e maschilista, sia perché la ragazza non
essendo più “illibata”(vergine) avrebbe avuto difficoltà, a causa della
mentalità sopra accennata, a trovare marito. A perdere l’onore, infatti, era
solo la vittima e non il criminale che l’aveva violentata. Lo stupratore
offrendosi di sposare la vittima accollandosi tutte le spese matrimoniali
evitava la pena detentiva, il tutto in una visione per cui la donna
era considerata un oggetto e una proprietà, ragion per cui se la si “rompeva”
violentandola, bisognava “tenersi i cocci” e pagare i “proprietari”, ossia la
famiglia di lei, sposandola. Va ricordato che all’epoca lo stupro viene infatti
ancora considerato un reato non contro la persona ma contro la moralità
pubblica e il buon costume. Solo nel 1996 lo stupro diventerà un reato
contro la persona.
https://www.paesesera.toscana.it/aboliti-delitto-donore-e-matrimonio-riparatore-in-italia/#:~:text=Il%205%20settembre%201981%20in,e%20delle%20donne%20in%20particolare. In quei
tempi (anni ’60) fu ancora la Sicilia, con una episodio che fece tanto clamore,
a sollecitare una revisione radicale del Codice Rocco.
Francia
Viola fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.
Il 26 dicembre 1965, all’età di 17
anni, fu rapita da Filippo Melodia, un mafioso locale, con
l’aiuto di 12 complici e quindi violentata, malmenata, lasciata a digiuno e
tenuta segregata per otto giorni, inizialmente in un casolare al di fuori del
paese, e poi in casa della sorella del Melodia.
Il
giorno di Capodanno, il padre della ragazza fu contattato dai parenti di
Melodia per la cosiddetta “paciata”, ovvero per un incontro volto a mettere le
famiglie davanti al fatto compiuto e far accettare ai genitori di Franca le
nozze dei due giovani. Il padre e la madre di Franca, d’accordo con la polizia,
finsero di accettare le nozze riparatrici e addirittura il fatto che Franca
dovesse rimanere presso l’abitazione di Filippo.
Il
giorno successivo, 2 gennaio 1966 la polizia intervenne all’alba
facendo irruzione nell’abitazione, liberando Franca ed arrestando Melodia ed i
suoi complici. Melodia fu infine condannato il 17 dicembre 1966 a 11
anni di carcere, ridotti il 10 luglio 1967 al processo di appello di Palermo a
10 anni con l’aggiunta di 2 anni di
soggiorno obbligato nei pressi di Modena. Sentenza confermata in Cassazione il
30 maggio 1969.
 Franca Viola,
prima donna in Italia a opporsi al matrimonio riparatore.
La sua vicenda
sollecitò il cambiamento nella legge relativa.
Franca Viola In Questura
La ragazza siciliana Franca Viola
viene interrogata dalla polizia dopo la liberazione dai suoi rapitori e stupratori.
Alcamo, 2 gennaio 1966 (Foto di Mondadori via Getty Images)
Le
disposizioni sul delitto d’onore e sul matrimonio riparatore vennero quindi
abrogate con la legge n. 442/1981. Un’abrogazione che arrivò quindi in un periodo
di grande fermento sociale, dopo il referendum sul divorzio del1974 e la
riforma del diritto di famiglia dell’anno dopo.
Il
codice Rocco fu quindi modificato ma sarebbe il codice penale tuttora in vigore
in Italia e nel 2018, in giorno a noi vicini dato che siamo nel 2023. Ci
fu una sentenza su un femminicidio della 46enne ecuadoregna Jenny Angela Coello
Reyes, avvenuto a Genova nel 2018 per mano del suo connazionale Javier Napoleon
Pareja Gamboa. Il
PM aveva chiesto 30 anni per l’assassino di Jenny Angela Coello Reyes, la donna
colpita con diverse coltellate al petto dopo che il suo compagno scoprì che non
aveva mantenuto la promessa di lasciare il suo amante. L’uomo
fu invece condannato a 16 anni. La
motivazione della condanna emessa dal giudice? L’omicida era
mosso “da un misto di
rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento” nei confronti di
lei. La
sentenza provocò forti e legittime reazioni di critica… .«Sebbene nessuno
abbia il coraggio di dirlo, con questa motivazione si sta riesumando il
delitto d’onore» «si sta assistendo
a un orientamento più culturale che giuridico, dove si motivano gli omicidi a
sfondo passionale in un circuito di tempesta emotiva». affermò
il legale (avv. Giuseppe Maria Gallo) della vittima. Il
delitto d’onore prevedeva, affinché venisse applicata l’attenuante, che vi
fosse uno stato d’ira per l’onore offeso una «illegittima
relazione carnale» riguardante
una delle donne della famiglia. Il
legale presentò istanza formale alla Procura di Genova per impugnare la
sentenza, ma il PM, nonostante l’iniziale richiesta di 30 anni, l’ha respinta «perché il
pronunciamento del giudice era ben motivato».
Non
fu una sentenza isolata. Nel
2019 la Corte d’Appello di Bologna dimezzò la pena a Michele Castaldo da 30
anni a 16 anni per il suo stato emotivo? Un
articolo del giornalista David Puente parlò di questione complessa e di
motivazioni diverse. La
Sentenza d’Appello nei confronti di un uomo di Riccione, Michele Castaldo
condannato per aver ucciso la compagna Olga Matei. La sentenza suscitò molte
critiche- La
pena sarebbe stata dimezzata perché l’assassino era in preda ad una Tempesta emotiva. Fu
condannato in primo grado nel 2017 a 30 anni di reclusione. In
Appello l’avvocato difensore chiese l’esclusione delle aggravanti o del
riconoscimento delle attenuanti generiche
con l’obiettivo di ridurre la pena. La
Corte di Bologna, con sentenza del 14 novembre 2018 e depositata l’8 febbraio
2019, ridusse la pena da 30 anni a 16 anni di reclusione e riportò le
motivazioni che portarono i giudici al riconoscimento delle attenuanti
generiche. Citò la “tempesta emotiva” che tuttavia non fu, secondo altre
critiche, la motivazione determinante. La
Sentenza d’Appello I
giudici hanno rigettato la richiesta d'appello della difesa in merito
all'esclusione delle aggravanti dei futili motivi, confermandoli a
pieno non ritenendo in alcun modo lo «stato di gelosia»
incompatibile con la aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. È stata proprio la
gelosia a scatenare il litigio nella coppia, come l'imputato stesso ha
affermato prima e durante il processo. Erano bastati dei messaggi sul cellulare
di lei da parte di alcuni uomini per scatenare in lui una situazione di rabbia
iniziale che lo portarono ad andarsene di casa in segno di protesta. Tornato
nell'abitazione, dopo diversi via e vai, lui le aveva confidato le sue
insicurezze senza ottenere una risposta positiva da lei tanto che,
dimostrandosi indifferente, lo invitò ad andarsene. A quel punto Michele Castaldo
aveva perso la testa, come dichiarato durante il processo ai giudici: «lei
non voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun
altro. L 'ho stretta al collo e l'ho strangolata». Le
Attenuanti Generiche In
Appello, rispetto alla prima sentenza del Tribunale di Rimini, furono invece
accolte le circostanze attenuanti generiche: -
La
confessione dell’imputato, sia per il delitto sia per l’ammissione delle
circostanze che portarono all’aggravante per futili motivi; -
Il
tentativo da parte sua di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima,
un gesto che portava a considerare il fatto che riconoscesse ancora di più la
gravità del delitto da lui commesso. Il
giornalista mise anche il risalto come fosse strano sostenere cge lo stato
emotivo dell’assassino risulti, nello stesso processo, un elemento a sostegno
dell’aggravante (assassinio della giovane donna) e nello stesso tempo anche un
elemento utile per riduzione della pensa. Si
fece riferimento alla letteratura giuridica e in particolare alla rivista
giuridica “Giurisprudenzapenale.com” che
riportò un articolo in merito alla sentenza: Quanto
al tipo di valutazione richiesta al giudice, in giurisprudenza è ricorrente il
principio secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle
generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione. Da
ciò se ne ricava che la Corte sarebbe potuta giungere alla medesima conclusione
cui è effettivamente giunta – ossia una rideterminazione della pena sulla base
del riconoscimento delle attenuanti generiche che erano state negate in primo
grado – anche senza pronunciarsi sulla rilevanza degli stati emotivi o
passionali e giustificando il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla
base di altre circostanze quali, ad esempio, l’assenza di precedenti penali o
la confessione dell’imputato. Secondo
la rivista giuridica la corte poteva fare a meno d’esprimere o pronunciare gli
stati emotivi dell’imputato per giustificare il riconoscimento delle attenuanti
generiche. Vennero
citati a riconoscimento delle attenuanti generiche, il forte stato di
gelosia e la “soverchiante tempesta
emotiva e passionale” dell’imputato. Ma
questi “stati emotivi o passionali” non vanno per nulla ad incidere
sull’impunibilità ai sensi dell’articolo 90 del Codice Penale: Articolo
90 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Stati emotivi o passionali (La
disposizione in esame si riferisce agli stati emotivi e passionali che sono
verificabili in una persona sana e, come tale, ritenuta idonea a controllare la
propria affettività (si pensi alla gelosia). Questi non possono escludere o
diminuire l'imputabilità in quanto possono assumere rilevanza come cause di
esclusione o attenuazione dell'imputabilità solo quegli stati emotivi e
passionali che dipendono da una vera e propria infermità di mente. Di qui la
considerazione di inutilità della norma, espressa da larga parte della dottrina). Ratio
Legis - Nonostante larga parte della dottrina reputi
tale norma di vana utilità, si coglie comunque un preciso intento del
legislatore, ovvero quello di evitare che possa essere considerato non punibile
qualunque delitto impulsivo, indipendentemente da uno stato di menomazione
della lucidità del soggetto agente. Spiegazione
dell'art. 90 Codice Penale Gli stati emotivi o passionali, pur potendo
incidere in maniera più o meno massiccia sulla lucidità mentale di un soggetto,
sono per espressa disposizione legislativa inidonei ad escludere l'imputabilità. Affinché possano assumere rilevanza vi è bisogno di un quid
pluris, rappresentato da un fattore determinante che si traduca in un vero
e proprio stato patologico, sia pure momentaneo e pur senza assumere i tratti
di una patologia clinicamente nominata. Gli stati emotivi e passionali devono quindi
degenerare in un vero e proprio squilibrio mentale al fine di escludere o
diminuire l'imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89. Esemplificativamente, la gelosia, classico esempio di stato passionale, non
può di per sé incidere sulla imputabilità, ma se provoca disordine nelle
funzioni della mente e perturbazioni in quelle della volontà diventando un
fuoco divoratore, una forza cieca dello spirito, può costituire una forma
morbosa diagnosticabile che esclude o diminuisce la capacità
di intendere e di volere. Massime
relative all'art. 90 Codice Penale Cass.
pen. n. 9843/2013 Ai
fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali,
salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di
"infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere
concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o
scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la
specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente
determinato dal disturbo mentale. Cass.
pen. n. 37020/2006 La
gelosia quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea
generica portatrice di inquietudine, non diminuisce e tanto meno esclude la
capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa derivi da un
vero e proprio squilibrio psichico il quale deve presupporre uno stato
delirante tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione. Cass.
pen. n. 24696/2004 In
tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta
dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di
modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di
ordine etico, religioso ed educativo che, afferendo ed integrandosi nel nucleo
della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello
autocritico, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e
dell'impulsività. Ne consegue che l'indebolimento dei freni inibitori, non
dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di
intendere e di volere e quindi sull'imputabilità. Cass.
pen. n. 24614/2003 In
tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e
di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze
celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni
cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte,
queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli
tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità. Ne consegue
che esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette
abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative
di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti
ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura
transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e
costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali. Cass.
pen. n. 967/1998 Gli
stati emotivi o passionali, per loro stessa natura, sono tali da incidere, in
modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che
ciò, tuttavia, per espressa disposizione di legge, possa escludere o diminuire
l'imputabilità, occorrendo a tal fine un quid pluris che, associato allo stato
emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio
stato patologico, sia pure in natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito
di una precisa classificazione nosografica. L'esistenza o meno di detto fattore
va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale,
tuttavia, nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di
supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di
attribuire carattere di “infermità” (come tale rilevante, ai sensi degli artt.
88 e 89 c.p., ai fini della esclusione e della riduzione della capacità
d'intendere e di volere), ad alterazioni transeunti della sfera
psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati
emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza. Cass.
pen. n. 1435/1996 La
falsa opinione sul tradimento del coniuge può atteggiarsi o come idea
portatrice di inquietudini, di per sé sole ininfluenti, o come stato delirante
che, nell'incidere sul processo di determinazione e di inibizione, travolge
l'agente in una condotta abnorme e automatica. Solo in questa seconda ipotesi
può parlarsi di infermità mentale dipendente da causa patologica e idonea ad
escludere o ad attenuare fortemente la capacità di intendere e di volere.
(Fattispecie relativa a uxoricidio). Cass.
pen. n. 11373/1995 In
tema di imputabilità, affinché una reazione «a corto circuito» costituisca
manifestazione di una vera e propria malattia che comprometta la capacità di
intendere e di volere del soggetto, è necessario che essa si inquadri in una
preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità
mentale. Quando la reazione a corto circuito si ricolleghi a semplici
manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni comportamentali prive di
substrato organico, essa si configura come situazione di turbamento psichico
transitorio, qualificabile come stato emotivo o passionale, tale da non
escludere né diminuire l'imputabilità a norma dell'art. 90 c.p. Cass.
pen. n. 4954/1993 In
tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale
natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e
volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di
rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi,
il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che
influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè
le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze
stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o
croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici
che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non
per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità
psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno
stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera
affettiva, non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne
consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a
particolari tensioni psichiche si determini un'accentuazione di alcuni tratti
del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto
circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di
malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui
all'art. 90 c.p. Cass.
pen. n. 1347/1991 Gli
stati emotivi e passionali, che a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono
l'imputabilità, possono in via eccezionale influire su questa solo quando,
esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio
squilibrio mentale con disordine e perturbazioni nelle funzioni della mente e
della volontà, sì da eliminare o attenuare le capacità intellettive e volitive. Cass.
pen. n. 6710/1983 Gli
stati emotivi e passionali, che, a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né
diminuiscono la imputabilità, possono eccezionalmente avere rilievo
sull'anzidetta imputabilità allorquando travalichino la sfera puramente
psicologica e degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio
mentale. Ne deriva che la gelosia, la quale costituisce uno stato passionale
privo delle anzidette caratteristiche degenerative, è inoperativa ai fini della
imputabilità. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è
disattesa la censura della difesa, secondo cui i giudici di merito non
avrebbero tenuto conto della incidenza del prorompente sentimento di gelosia
dell'imputato, rifiutandosi di considerare l'automatismo dell'azione, la
obliquità dei colpi inferti sulla superficie addominale della vittima e
soprattutto la significativa incertezza nel racconto inerente alle modalità di
esecuzione della condotta delittuosa). Cass.
pen. n. 3171/1981 Il
semplice stato di agitazione non determina infermità che faccia escludere la
capacità di intendere e di volere, non essendo un vero e proprio stato morboso. Durante
il processo si ritenne che il sentimento provato sia «certamente
immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione
dell’imputato», escludendo dunque l'eventuale infermità mentale: Alla
luce di tali emergenze processuali il giudice, rilevando che gli stati emotivi
e passionali che non si inseriscano in un quadro di infermità sono ininfluenti
ai fini della imputabilità, riteneva sussistente la responsabilità del Castaldo
e sussistente l'aggravante dei motivi abietti e futili, sostanzialmente ammessi
dallo stesso imputato, che aveva spiegato il gesto col fatto che la donna non
lo voleva ascoltare e aveva manifestato l'intenzione di lasciarlo. Conclusioni Castaldo
fu condannato all'ergastolo in primo grado, ma con rito abbreviato, dunque ha
avuto accesso a un primo sconto di pena a 30 anni. In secondo grado, la pena
comminata avrebbe dovuto essere pari a 24 anni, tenendo conto delle attenuanti
generiche, ma per effetto del rito abbreviato scese a 16 anni. Affermare che la
pena sia stata dimezzata per il riconoscimento di una «tempesta emotiva»
risulta errato. La reale motivazione del passaggio da 30 a 16 anni di
reclusione fu dovuta alle attenuanti generiche riconosciute in secondo
grado, ossia la confessione dell'imputato – sia per il delitto sia per
l'ammissione delle circostanze che hanno portato all'aggravante per futili
motivi – e il tentativo da parte sua di iniziare a risarcire la figlia minore
della vittima.
.........................................

............................................
………………………………………………….
…………………………………………………….. MONTE PELLEGRINO (RNO) (Palermo):
“Il Promontorio più bello al mondo…”
Parte Terza:
La Palazzina Cinese – Le Statue del Parco della Favorita (Parte
integrante della Riserva di Monte Pellegrino) –
Museo Etnografico Giuseppe Pitrè - Le Scuderie Reali –
Nella Palazzina Cinese c’è l’anima della Regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena (Enciclopedia delle Donne).
https://sicilianaturacultura.blogspot.com/2019/08/monte-pellegrino-rno-il-promontorio-piu_15.html …………………………………
……………………………………….
…………………………………
|
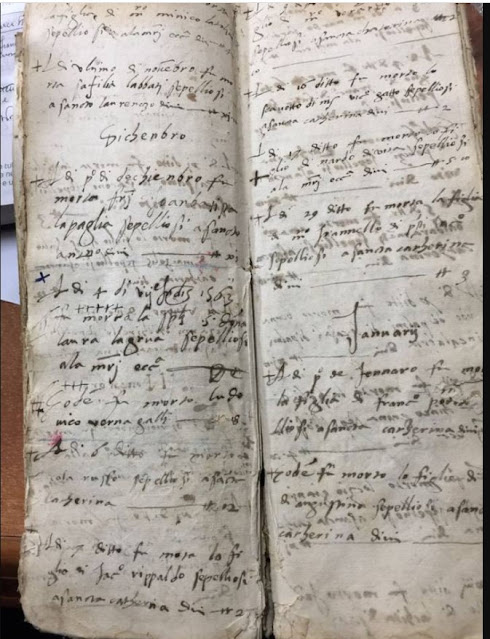






















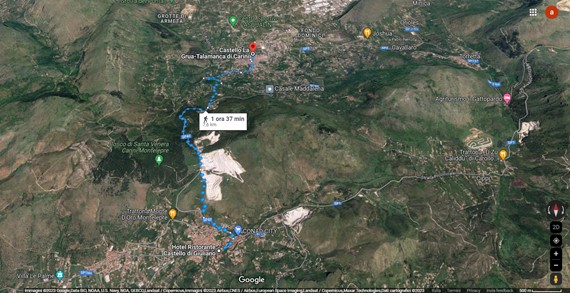



























































































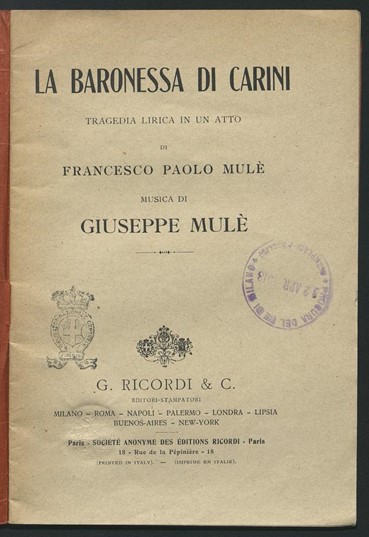















































































Commenti
Posta un commento